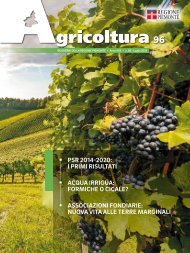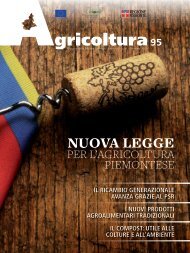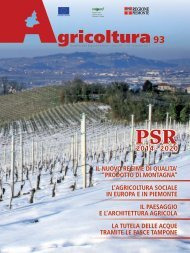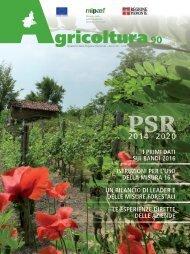n. 81 Ottobre 2013
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>81</strong><br />
Quaderni della Regione Piemonte - Collana “Agricoltura” - Anno XVII - n.<strong>81</strong> - <strong>Ottobre</strong> <strong>2013</strong><br />
PAC<br />
2014 - 2020<br />
Un quadro completo<br />
Gli ultimi bandi PSR 2007-<strong>2013</strong> per giovani,<br />
diversificazione ed health check<br />
Una strategia regionale<br />
per la promozione agroalimentare
PER TELEFONARE<br />
DIRETTAMENTE AGLI UFFICI<br />
COMPORRE IL NUMERO<br />
011 432 SEGUITO<br />
DALL’INTERNO DESIDERATO<br />
ASSESSORE<br />
CLAUDIO SACCHETTO<br />
Ufficio di comunicazione 1680<br />
CARRANO Annunziata 3937<br />
FRANCHINO Alberto 3875<br />
QUATTROCCHI Tina 2587<br />
DIREZIONE AGRICOLTURA<br />
DIRETTORE<br />
DE PAOLI Gaudenzio 2696<br />
Segreteria 1482<br />
ANICITO Francesca 5548<br />
BERTO Alessandra 3924<br />
BIANCO Roberto 6072<br />
CARACCIOLO Daniela 5997<br />
DOMINICI Claudia 4652<br />
FAVATA' Paola 4711<br />
FERRERO Ezio 4874<br />
FOTIA Angela 2055<br />
FRASCELLA Patrizia 3436<br />
GALLUZZI Marco 24<strong>81</strong><br />
GUASCO Claudia 6427<br />
MARTINA Piera 2683<br />
MAZZA Silvana 4311<br />
SAVIO Cecilia 4342<br />
TESTA Fabrizio 5216<br />
TORASSO Susanna 4754<br />
TROMBETTA Laura 5675<br />
VALSANIA Maria 4367<br />
VILLANO Antonia 4297<br />
VIZZARI Vincenzo 4602<br />
ZOLA Enrico 4355<br />
OSSERVATORIO REGIONALE<br />
SULLA FAUNA SELVATICA<br />
PICCO Luca 4603<br />
AIRAUDO Dario 2093<br />
CARISIO Loredana 2394<br />
SETTORE 11.11<br />
TUTELA E GESTIONE DELLA<br />
FAUNA SELVATICA ED ACQUATICA<br />
Responsabile di settore<br />
DI BISCEGLIE Carlo 4557<br />
Segreteria 1507<br />
APROSIO Paola 5060<br />
AUCIELLO Paola 5697<br />
BRESSO Enzo 2890<br />
CANE Silvana 2152<br />
CANNIZZARO Alberto 4704<br />
LAVAGNO Mauro 5147<br />
MARCHETTO Sabrina 5018<br />
PAOLUCCI Giorgio 2678<br />
RAGNO Assunta 2379<br />
ZAMBRUNO Gian Paolo 5950<br />
SETTORE 11.13<br />
PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE<br />
DEL SISTEMA AGROALIMENTARE<br />
Responsabile di settore<br />
SOSTER Moreno 4375<br />
Segreteria 1474<br />
AMBROSIO Dora 4398<br />
ARCHIMEDE Valentina 2801<br />
BOASSO Franco 4954<br />
CACCIAPAGLIA Cristina 4716<br />
CONVERTINI Stefania 4892<br />
GIACOMELLI Paolo 2830<br />
MARELLI Andrea 2832<br />
MORRI Fabrizio 4<strong>81</strong>0<br />
PETROSINO Giovanna 5770<br />
PETRICIG Valentina 4569<br />
SCARZELLO Daniela 5246<br />
VICENTINI Iside 4325<br />
VULLO Salvatore 3938<br />
SETTORE 11.14<br />
TUTELA DELLA QUALITA’<br />
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI<br />
Responsabile di settore<br />
CAPRIOGLIO Alessandro 2573<br />
ANNICCHIARICO Claudio 5332<br />
BAMBINO Grazia Maria 5469<br />
DE FAZIO Rosetta 2189<br />
GIAIERO Prisca 3<strong>81</strong>1<br />
GIMONDO Maria 2962<br />
FALLANCA Domenica 2029<br />
LAZZARO Denis 5248<br />
PALMISANO Angela 3448<br />
PASQUALE Barbara 5409<br />
VARETTO Giuseppina 4336<br />
RUO BERCHERA Giovanna 2927<br />
SETTORE 11.15<br />
PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE E<br />
COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO<br />
RURALE<br />
Responsabile di settore<br />
BROCARDO Riccardo 4835<br />
Segreteria 1468<br />
BRUNO Wanda 2850<br />
CONSOGNO Franco 4601<br />
MANCASTROPPA Rosanna 4638<br />
MASIERO Donatella 4374<br />
MICHELOTTI Daniele 4370<br />
MONERO Rosanna 2434<br />
PEROSINO Mario 4369<br />
TOFFETTI Francesca 5979<br />
VENTURELLO Irene 2460<br />
SETTORE 11.16<br />
SISTEMA AGROINDUSTRIALE,<br />
COOPERATIVISTICO E FILIERE<br />
AGROALIMENTARI<br />
Responsabile di settore<br />
CONTI Loredana 2848<br />
Segreteria 1475<br />
BANDA Laura 2415<br />
BERTORELLO Rosanna 4376<br />
BOLDRINO Laura 5413<br />
BOETTI Roberto 4327<br />
BOTTARO Silvia 4308<br />
FAVOT Adriano 2846<br />
FERRO Sonia 3699<br />
GAGLIANO Flavio 4371<br />
LODATO Salvatrice 4293<br />
MORTARA Guido 6168<br />
MORONE Maria Carla 5682<br />
NIZZA Luigi 4607<br />
PISTILLO Silvana 3090<br />
SATTANINO Giuseppina 4728<br />
VERDUCI Leandro 43<strong>81</strong><br />
SETTORE 11.17<br />
PRODUZIONI ZOOTECNICHE<br />
Responsabile di settore<br />
CUMINO Paolo 4385<br />
Segreteria 1470<br />
BASSANINO Monica 4223<br />
BESSOLO Pierluigi 4305<br />
FERRERO Luigi 4328<br />
MARLIANI Rodolfo 3629<br />
MORATTO Martina 3482<br />
PALMIERI Aurora 5359<br />
PARZANESE Emanuele 5117<br />
RASETTO Paola 3775<br />
RIGONI Miriam 3117<br />
TERMINI Gianfranco 4372<br />
VIZZANO Carmen 4332<br />
SETTORE 11.18<br />
COLTURE AGRARIE<br />
Responsabile di settore<br />
FREIBURGER Gualtiero 4318<br />
Segreteria 1471<br />
ANSALDI Nadia 3929<br />
CELLINO Andrea 2809<br />
DE SIMONE Amelia 5173<br />
LATINO Gianfranco 4642<br />
OTTONELLO Mara 3997<br />
PIVA Elena 4323<br />
TRAVAGLIA Daniela 2429<br />
VITTONE Eugenio 4927<br />
SETTORE 11.19<br />
FITOSANITARIO<br />
Responsabile di settore<br />
MICHELATTI Giacomo 3723<br />
Segreteria 1473<br />
ALESSI Bruno 3737<br />
BALLADORE Pallieri Lorenzo 3707<br />
BISCARDI Maria Teresa 3461<br />
BOSIO Giovanni 3721<br />
BOURLOT Giancarlo 4698<br />
CHERSI Catarina 3289<br />
COTRONEO Alba 3718<br />
CRAVERO Sergio 3702<br />
CROSETTO Mirko 8632<br />
DAVI' Danilo 3705<br />
DOLZAN Stefano 3062<br />
ELIA Irene 5568<br />
FIORE Anna Rita 3712<br />
GALEOTTI Gabriella 3733<br />
GALLO Sergio 2188<br />
GAROFALO Maria Cristina 3715<br />
GIACHINO Pier Mauro 4900<br />
GIANETTI Giannetto 3729<br />
GOTTA Paola 3716<br />
GREMO Francesco 3722<br />
GUARINO Barbara 3738<br />
GULLINO Clotilde 4361<br />
LOVISCO Carmela 5956<br />
LOVISETTO Mariangela 5941<br />
MASON Giovanna 5067<br />
MASSOBRIO Viola 5217<br />
MAZZAROTTO Elisabetta 3711<br />
MORONE Chiara 3726<br />
OGLIARA Silvia 5415<br />
RAZIONALE Felicita 3719<br />
ROSSI Andrea 4352<br />
SCAVARDA Giovanni 5709<br />
SANTANGELO Corrado 3703<br />
SPANNA Federico 4770<br />
VENANZIO Davide 4108<br />
SETTORE 11.20<br />
SERVIZI ALLE IMPRESE<br />
Responsabile di settore<br />
RONCO Caterina 3720<br />
Segreteria 1466<br />
ACETO Paolo 6161<br />
CIOCE Silvana 2254<br />
CLERICO Massimo 4100<br />
CORDOLA Piero 4303<br />
DE CARO Sergio 4343<br />
FEMIA Tiziana 5495<br />
LAVINA Ester 4722<br />
MELLA Clara 4344<br />
PASTERIS Marco 4861<br />
QUARTERO Natascia 6051<br />
RICCI Luisa 2917<br />
SANGUINETTI Mario 3849<br />
TURLETTI Alberto 3749<br />
SETTORE 11.21<br />
AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED<br />
INFRASTRUTTURE IRRIGUE<br />
Responsabile di settore<br />
OLIVERO Franco Antonio 2903<br />
Segreteria 1483<br />
ANGELETTI Alessandro 5295<br />
BOSSER PEVERELLI Vittorio 4347<br />
CAPPELLA Mariella 4551<br />
CASSINELLI Laura 3809<br />
FARAUDELLO Edoardo 4348<br />
FILA-MAURO Elena 4036<br />
GENTILE Angelantonio 2847<br />
LEGGERO Barbara 2468<br />
LIZZI Massimo 2653<br />
LOMBARDO Fortunata 4670<br />
LUCA’ Stefania 5569<br />
MADONIA Silvana 3751<br />
MARGARIA Claudio 4972<br />
MASANTE Carlo 4708<br />
PELASSA Giorgio 3073<br />
POSSIEDI Emanuele 3165<br />
ROMANO Maria Rosaria 2713<br />
SCANABISSI Giovanni 2714<br />
TOSIN Germano 4837<br />
VENTURA Bianca 4472<br />
SETTORE 11.22<br />
CALAMITA’ ED AVVERSITA’ NATURALI<br />
IN AGRICOLTURA<br />
Responsabile di settore<br />
LAVAZZA Fulvio 4317<br />
Segreteria 1501<br />
BARROERO Claudio 4341<br />
BATAZZI Marco 4380<br />
COMBA Daniela 3971<br />
COMPAGNONE Giuseppe 5953<br />
FENZI Pier Giuseppe 5442<br />
FOLLIS Maria Teresa 2790<br />
PELLISTRI Gabriella 3991<br />
RODOFILE Stefania 2453<br />
SALIERNO Antonio 5693<br />
UFFICI DECENTRATI<br />
del Settore Fitosanitario<br />
CUNEO - 12100<br />
C.so Kennedy 7 bis<br />
Tel. 0171/6.70.21<br />
CEVA - 12073<br />
Via Regina Margherita 2<br />
Tel. 0174/70.17.62<br />
ALESSANDRIA - 15100<br />
Via Einaudi 32 Zona Scalo D 4<br />
Tel. 0131/24.<strong>81</strong>.04<br />
VERCELLI - 13100<br />
Via Goito 12<br />
Tel. 0161/28.31.39<br />
CASALE MONFERRATO - 15033<br />
Tr. Valenza 4<br />
Tel. 0142/46.26.11
editoriale<br />
L’agricoltura<br />
è l’arte di saper aspettare?<br />
In alcuni casi le citazioni possono essere utile strumento per generare<br />
approfondite riflessioni. Penso a Giacomo Agostinetti, scrittore<br />
e fattore italiano a cavallo tra il 1500 e 1600, il quale enunciò il<br />
proprio pensiero nei seguenti termini: “Quando considero che non<br />
c’è al mondo un’attività più antica dell’agricoltura e nello stesso<br />
tempo indispensabile perché ci fornisce da mangiare e da vestire, mi<br />
stupisco che oggigiorno gli uomini l’apprezzino tanto poco”.<br />
Claudio Sacchetto<br />
Assessore all’Agricoltura,<br />
Foreste, Caccia e Pesca<br />
Regione Piemonte<br />
L’attualità di tale affermazione, seppur cronologicamente antichissima, è<br />
dimostrata dalla poca considerazione che spesso, ancora oggi, viene dedicata<br />
al mondo rurale. Con questo non si vuol negare che esistano molti enti,<br />
organizzazioni, amministrazioni e persone che quotidianamente dedichino<br />
sforzi e passione per migliorare le condizioni di lavoro degli agricoltori, ma il<br />
riferimento va alla fatica attraverso la quale tutti i giorni si lotta per ottenere<br />
ogni singolo risultato, anche il più scontato e apparentemente ovvio.<br />
Forse una porzione di cittadinanza non indifferente, compresa anche parte della<br />
classe dirigente che decide su importanti tematiche agricole, non ha ancora<br />
compreso la centralità dell’agricoltura per la crescita e il buon funzionamento<br />
della società, proprio per questo motivo gli agricoltori sono spesso e<br />
volentieri ostacolati o perlomeno messi in difficoltà senza troppi scrupoli.<br />
A livello nazionale e spesso europeo il carico burocratico e la pressione<br />
fiscale continuano a insistere sul comparto, si attendono provvedimenti<br />
utili a superare il momento di difficoltà, ma nonostante “l’agricoltura sia<br />
l’arte di sapere aspettare” (per dirla come Riccardo Bacchelli, scrittore e<br />
drammaturgo), questa attesa infruttuosa rischia di mettere seriamente<br />
in difficoltà l’intero settore, con tutte le ricadute che ne conseguono.<br />
Non è un inno al pessimismo, ma un appello, un allarme che<br />
deve servire da stimolo: l’agricoltura regge, e lo fa meglio di altri<br />
ambiti economici, ma urgono risposte di sostegno concrete.
<strong>81</strong><br />
in questo numero:<br />
notiziario<br />
5 Moscato e Gavi: accordi per la vendemmia <strong>2013</strong><br />
5 Per la terza volta raggiunto l’obiettivo dell’anticipo PAC<br />
6 1,5 milioni di euro supplementari per la misura 214 “Agroambiente”<br />
6 Investimenti non produttivi (mis. 216): novità e modifiche<br />
6 Nasce tavolo interprofessionale per la pioppicoltura<br />
7 Precisazione su patenti per macchine agricole<br />
7 La mostra Ri-scatti della terra è diventata itinerante: 5 tappe sul territorio<br />
7 Una nuova Vetrina web per i dati di monitoraggio e valutazione PSR<br />
8 Commissione regionale pari opportunità. Donne e imprese agricole<br />
9 pubblicazioni<br />
programma di sviluppo rurale 2007-<strong>2013</strong><br />
10 PAC 2014-2020. Al via nel 2015 gli aiuti diretti<br />
14 Nuovi bandi per giovani, diversificazione e investimenti di stampo ambientale.<br />
16 DOP e IGP non si vendono da sole. Orientamenti per una strategia regionale della promozione agro-alimentare<br />
19 Il Piemonte a Cheese - Bra, 20-23 settembre <strong>2013</strong><br />
22 Raccontare per immagini che cosa fa il PSR per noi<br />
25 Focus 6° Censimento dell’agricoltura: i canali di commercializzazione dei prodotti di origine vegetale<br />
documenti<br />
29 L’agricoltura piemontese: congiuntura e tendenze di medio periodo<br />
32 La batteriosi dell’actinidia: strategie di contenimento in Piemonte<br />
36 Direttiva Nitrati nel settore orticolo: un workshop internazionale a Torino<br />
38 uno sguardo sull'europa<br />
informazione tecnica<br />
39 Come ridurre l’azoto in zootecnia: primi spunti dal progetto LIFE + “AQUA”<br />
43 Nuove tecnologie per ridurre il consumo delle risorse idriche in agricoltura<br />
47 Varieta’ di orzo e frumento tenero in Piemonte nell’annata agraria 2012-<strong>2013</strong>
notiziario<br />
Moscato e Gavi:<br />
accordi per la vendemmia <strong>2013</strong><br />
Nei primi giorni di settembre, a poche ore dall’inizio della vendemmia,<br />
è stato raggiunto l’accordo sul Moscato da parte della Commissione<br />
Paritetica, organo composto da una parte industriale e<br />
dalla rappresentanza agricola, e presieduto, con il ruolo di mediatore,<br />
dall’Assessore regionale all’Agricoltura Claudio Sacchetto.<br />
L’accordo prevede per il <strong>2013</strong> una resa di 95 quintali per ettaro,<br />
con la possibilità di applicazione del meccanismo blocagedeblocage<br />
per ulteriori 5 quintali: lo sbloccaggio potrà essere<br />
effettuato per tutta o parte della quantità bloccata sulla base<br />
di una richiesta del Consorzio di tutela corredata di dati oggettivi<br />
di imbottigliamento e vendita (e sentite le esigenze<br />
delle case spumantiere) previo parere favorevole e vincolante<br />
delle organizzazioni ed associazioni professionali agricole<br />
nell’ambito della Commissione Paritetica.<br />
Il compenso delle uve pattuito corrisponde a 104,50 € netti al<br />
quintale (106,50 € lordi). Nell’accordo sono previsti in primo<br />
luogo un contributo di 1,00 €/quintale per il fondo di parte<br />
agricola costituito nel 2010, di cui 0,70 € sono indirizzati ai<br />
produttori per la gestione dell’accordo ed i restanti 0,30 €<br />
sono destinati ai vigneti con particolari difficoltà di coltura individuati<br />
dall’apposita commissione (sorì); in seconda istanza<br />
un ulteriore contributo pari a 1 € al quintale da destinare al<br />
Consorzio per le attività istituzionali di promozione e tutela.<br />
Assessore regionale all’Agricoltura Claudio Sacchetto:<br />
“Con l’approssimarsi della vendemmia è prevalsa la consapevolezza<br />
di quanto fosse indispensabile siglare l’intesa con il fine di<br />
tutelare il comparto Moscato. Un atteggiamento di responsabilità<br />
importante, le trattative si sono prolungate molto, giungendo<br />
all’accordo ai limiti del tempo a disposizione, ma alla fine ha<br />
prevalso il buonsenso degli attori componenti la Paritetica”.<br />
Anche per il Gavi Docg nella serata del 12 settembre il confronto<br />
all’interno della Commissione paritetica è giunto a termine<br />
con il raggiungimento dell’intesa tra parte agricola e<br />
industriale. I punti cardine dell’accordo consistono in una resa<br />
superiore a quella dello scorso anno, pari al disciplinare di<br />
produzione (95 quintali a ettaro); la discussione in paritetica<br />
si è conclusa inoltre con un soddisfacente punto di incontro<br />
in merito ai prezzi delle uve, con un interessante incremento<br />
rispetto alla vendemmia 2012, compensi suddivisi in tre fasce<br />
determinate dalla gradazione alcolica.<br />
Compenso minimo delle uve intere Cortese bianco destinate<br />
alla D.O.C.G. Gavi:<br />
Gradazione alcolica<br />
9,50 – 11,20 72,50<br />
11,21 – 12,40 76,50<br />
> 12,40 (da uve selezionate) 92,00<br />
€ /quintale<br />
Compenso minimo delle uve intere Cortese bianco destinate<br />
alla D.O.C.G. Gavi con una delle menzioni aggiuntive riferite<br />
ai comuni o alle frazioni:<br />
Gradazione alcolica<br />
9,50 – 11,20 91,50<br />
11,21 – 12,40 95,50<br />
€ / quintale<br />
> 12,40 (da uve selezionate) 112,00<br />
Assessore regionale all’Agricoltura Claudio Sacchetto:<br />
“Il dibattito ha richiesto tempo e un’ampia fase di trattative,<br />
molti i termini al centro della discussione, altrettanto numerose<br />
le aspettative sia da parte agricola che industriale. Il raggiungimento<br />
dell’accordo, naturalmente, rappresenta di per<br />
sé già un successo, l’aver chiuso la commissione paritetica<br />
riportando un arrotondamento verso l’alto del prezzo delle<br />
uve a favore degli agricoltori non può che essere visto come<br />
un ulteriore elemento che impreziosisce il risultato complessivo<br />
dell’intesa”.<br />
Per la terza volta<br />
raggiunto l’obiettivo<br />
dell’anticipo PAC<br />
Per il terzo anno consecutivo l’Assessorato regionale<br />
all’Agricoltura è riuscito ad erogare l’anticipo<br />
sul premio della domanda unica PAC. Un<br />
risultato ottenuto con impegno e applicazione, nonostante la<br />
delicata situazione economica. “Negli ultimi anni siamo riusciti<br />
a migliorare situazioni critiche che perduravano dal passato, sicuramente<br />
si sono accorciati i tempi di pagamento, nel 2010 le<br />
erogazioni a favore degli agricoltori erano in ritardo di un anno”<br />
commenta l’Assessore Sacchetto “Le difficoltà attuali, che coinvolgono<br />
anche la Regione, hanno però evidenziato la necessità<br />
di un aiuto tangibile alle imprese per sostenere i livelli di liquidità<br />
finanziaria e supportare la quotidiana attività aziendale. Un ringraziamento<br />
per il raggiungimento del risultato va alla costruttiva<br />
collaborazione di Arpea”.<br />
Agricoltura <strong>81</strong><br />
5
notiziario<br />
La Giunta Regionale ha autorizzato il pagamento del 50% dei<br />
contributi previsti dalla Politica Agricola Comune, l’erogazione<br />
sarà attuata in due differenti passaggi: una prima fase compresa<br />
tra il 29 luglio e il 2 agosto ha previsto il versamento,<br />
attingendo a fondi regionali, di una somma pari a circa il 20%<br />
del premio complessivo. Successivamente, alla fine di ottobre,<br />
verrà erogato il restante 30% attraverso risorse comunitarie.<br />
Infine è calendarizzato il saldo conclusivo nel periodo delle<br />
festività natalizie, compatibilmente con il ciclo di refresh. La<br />
Regione Piemonte, anche per il <strong>2013</strong>, raggiunge dunque l’obiettivo<br />
dell’anticipo PAC, portando a 3 le annualità consecutive<br />
durante le quali l’impegno preso con gli agricoltori è stato<br />
mantenuto. In Italia solo l’Ente piemontese e la Lombardia riescono<br />
a portare a termine questa operazione.<br />
La soddisfazione per questi risultati non cancella l’impegno preso<br />
per ottimizzare ulteriormente il sistema delle erogazioni.<br />
1,5 milioni di euro<br />
supplementari<br />
per la misura 214<br />
“Agroambiente”<br />
Nell’ultimo anno di programmazione 2007-<br />
<strong>2013</strong>, gli uffici regionali hanno verificato che le<br />
risorse inizialmente attribuite dal Programma di sviluppo rurale<br />
(PSR) ad alcune misure non sarebbero state completamente<br />
utilizzate. E’ stato perciò deciso di trasferire tali risorse a favore<br />
di altre misure del PSR, tra le quali la misura 214, che avrebbero<br />
potuto concretamente utilizzarle. La proposta di modifiche al<br />
PSR, avanzata dalla Regione Piemonte ai Servizi della Commissione<br />
europea, è stata approvata in data 12 agosto <strong>2013</strong>. Le<br />
risorse aggiuntive assegnate alla misura 214, pari a 1,5 milioni<br />
di euro, consentiranno di scorrere le graduatorie delle domande<br />
presentate nel <strong>2013</strong> per lo svolgimento del 7° anno di impegno<br />
e, in pochi casi, del 6° anno di impegno, finanziando così<br />
ulteriori domande.<br />
Le azioni interessate sono le seguenti:<br />
• 214.1 “Applicazione delle tecniche di produzione integrata”,<br />
• 214.2 “Applicazione delle tecniche di produzione biologica”<br />
• 214.8/1 “Conservazione delle razze minacciate di abbandono”<br />
Le graduatorie verranno rielaborate e rese note mediante la pubblicazione<br />
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.<br />
i<br />
Investimenti<br />
non produttivi<br />
(mis. 216):<br />
novità e modifiche<br />
Sono state introdotte integrazioni e modifiche alle<br />
disposizioni applicative della misura 216 (investimenti<br />
non produttivi), rispetto a quanto definito nella determinazione<br />
dirigenziale n. 771 del 14/8/2012 e s.m.i. In particolare, sono<br />
state introdotte nei costi standard (allegato B) voci del prezzario<br />
regionale riconducibili alla realizzazione di zone umide e riguardanti<br />
l’impianto di formazioni vegetali, per evitare disomogeneità nella<br />
quantificazione delle spese. Inoltre sono state apportate integrazioni<br />
all’allegato A, inserendo specificazioni e modelli già contenuti in<br />
recenti circolari regionali, in modo da includerli in un unico testo.<br />
Su proposta della Regione, la Commissione Europea ha inoltre<br />
approvato una modifica del PSR che elimina l’obbligo di presentare<br />
una domanda 214.7/1 collegata alla realizzazione delle formazioni<br />
vegetali e delle aree umide (tipologia 1). Dovranno essere<br />
comunque rispettati gli impegni decennali di manutenzione degli<br />
investimenti. La modifica del PSR non riguarda tuttavia la tipologia<br />
2 della misura (installazione di nidi artificiali), per la quale permane<br />
il vincolo di presentazione di una domanda 214.1 o 214.2.<br />
E’ stata infine pubblicata sul Bollettino Regionale la determinazione<br />
dirigenziale n. 820 del 24/9/<strong>2013</strong>, con cui è stato approvato<br />
uno scorrimento della graduatoria delle domande. Gli agricoltori<br />
divenuti finanziabili dovranno presentare alle Province, nei<br />
casi previsti, i progetti definitivi/esecutivi e la relativa documentazione<br />
entro lunedì 28/10 (il 26/10 cade di sabato).<br />
Le modifiche, approvate con determinazione dirigenziale n. 742 del<br />
23/8/<strong>2013</strong>, sono pubblicate sul bollettino regionale del 29 agosto:<br />
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/<strong>2013</strong>/35/siste/00000003.htm<br />
Per lo scorrimento della graduatoria:<br />
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/<strong>2013</strong>/39/siste/00000014.htm<br />
Nasce tavolo interprofessionale<br />
per la pioppicoltura<br />
Con apposita delibera di Giunta è stato istituito in estate il tavolo<br />
interprofessionale per la pioppicoltura, venendo incontro alle esigenze<br />
di un comparto tutt’altro che trascurabile nell’ambito del<br />
panorama agricolo piemontese. La filiera del pioppo rappresenta la<br />
principale realtà produttiva nel campo della arboricoltura da legno,<br />
6 Agricoltura <strong>81</strong>
notiziario<br />
sviluppando sul territorio un apprezzabile insediamento di industrie<br />
di trasformazione. Mirati gli obiettivi del nuovo tavolo di confronto:<br />
provvedimenti necessari allo sviluppo armonico della pioppicoltura,<br />
diffusione delle conoscenze scientifiche, tecniche ed economiche<br />
tra gli operatori del settore, sostenere la trasparenza del mercato,<br />
sollecitare accordi interprofessionali tra produttori e utilizzatori, favorire<br />
il coordinamento delle iniziative regionali.<br />
Assessore regionale all’Agricoltura Claudio Sacchetto: “Il<br />
tavolo è uno strumento necessario ad un settore che dimostra di<br />
avere ancora ampi margini di sviluppo se sostenuto concretamente.<br />
Sarà utile, in questa fase, sfruttare il consesso per dar vita ad<br />
un dibattito costruttivo su proposte e iniziative interne al comparto<br />
nell’ottica della futura programmazione rurale 2014 – 2020”.<br />
La pioppicoltura, se gestita mediante una programmazione snella<br />
e organizzata, garantisce rilevanti ricadute di natura economica<br />
assicurando al contempo più che soddisfacenti parametri di<br />
sostenibilità ambientale.<br />
Precisazione su patenti<br />
per macchine agricole<br />
Sono recentemente pervenute richieste di chiarimento in riferimento<br />
all’articolo comparso sul numero 80 di aprile <strong>2013</strong> de “I<br />
Quaderni della Regione Piemonte – Agricoltura”, dedicato alla<br />
sicurezza delle macchine agricole e riportante nella parte finale<br />
indicazioni in merito alle categorie di patenti richieste per la guida<br />
delle macchine agricole. Si precisa che per la guida delle macchine<br />
agricole (trattrici agricole, macchine agricole operatrici semoventi<br />
o trainate - escluse quelle con conducente a terra) è richiesta la<br />
patente di categoria A1 quando le stesse non superano i limiti di<br />
sagoma e di peso stabiliti dall’art. 53, comma 4 del Codice della<br />
strada, mentre è richiesta la patente di categoria B se le stesse<br />
superano i limiti indicati dall’art. 53. Per le macchine operatrici è<br />
richiesta la patente di categoria B, eccetto quelle di dimensioni eccezionali;<br />
per queste ultime è richiesta la patente di categoria C1.<br />
divenuta itinerante, compiendo un percorso in cinque tappe sul<br />
territorio della nostra regione. Le tappe sono state, dopo la prestigiosa<br />
Reggia di Venaria: Casale Monferrato (AL) nel cortile di<br />
Palazzo Langosco, Saluzzo (CN) alla Castiglia, Nizza Monferrato<br />
nel Foro Boario, Portacomaro (AT) alla Casa dell’Artista, Novara<br />
a Palazzo Natta, tra maggio e ottobre <strong>2013</strong>.<br />
Sono oltre 80 le fotografie che documentano con sguardo innovativo<br />
l’evoluzione del mondo agricolo: non più solo produzione<br />
e trasformazione di prodotti, ma una realtà che si confronta con<br />
i mercati globali, più attenta all’ambiente e promotrice di opportunità<br />
sociali e culturali. La Regione Piemonte ha infatti voluto<br />
cogliere la nuova identità culturale dell’agricoltura che sta emergendo,<br />
un’identità ancora poco conosciuta. Tra le iniziative pensate<br />
per coinvolgere i cittadini, sia come protagonisti attivi sia come<br />
spettatori, ha lanciato nel corso del 2012 un concorso fotografico<br />
aperto a tutti, per raccontare, attraverso le immagini, l’agricoltura<br />
di oggi. Oltre 130 partecipanti al concorso e circa 60 classi scolastiche<br />
di ogni grado hanno inviato materiale fotografico che,<br />
selezionato da una giuria tecnica, ha dato vita alla mostra.<br />
i<br />
www.riscattidellaterra.com.<br />
La mostra<br />
Ri-scatti della terra<br />
è diventata itinerante:<br />
5 tappe sul territorio<br />
Dopo la Reggia di Venaria, la mostra Ri-scatti<br />
della terra, risultato del concorso fotografico<br />
promosso dalla Regione Piemonte nel 2012 come attività di<br />
comunicazione del Programma di sviluppo rurale 2007-<strong>2013</strong>, è<br />
Una nuova Vetrina<br />
web per i dati<br />
di monitoraggio<br />
e valutazione PSR<br />
Il servizio “Vetrina Monitoraggio e Valutazione<br />
dello sviluppo rurale” nasce con l’intento di valorizzare<br />
e rendere fruibile in modo semplice ed intuitivo l’enorme<br />
patrimonio di informazioni sul Programma di sviluppo rurale<br />
Agricoltura <strong>81</strong><br />
7
notiziario<br />
ottenuto attraverso le attività di monitoraggio e valutazione. E’<br />
un’iniziativa della specifica unità che opera nell’ambito del PSR,<br />
formata da Regione Piemonte e CSI Piemonte, e che vede la collaborazione<br />
di Nuval Piemonte, Ires Piemonte, Ipla s.p.a..<br />
Lo strumento utilizza un linguaggio immediato, in grado di catturare<br />
l’attenzione attraverso immagini, grafici, cartogrammi, indicatori<br />
semplici, ma allo stesso tempo invita l’utente ad approfondire, indirizzando<br />
ai servizi disponibili on-line dal sito della Regione Piemonte<br />
(Datawarehouse, cruscotti decisionali) o ai rapporti ufficiali ed ai<br />
documenti tecnici di monitoraggio e valutazione elaborati da diversi<br />
soggetti (Regione Piemonte, valutatore indipendente, altri soggetti).<br />
Il servizio è ad accesso libero e l’utente può raggiungere facilmente<br />
le informazioni contenute attraverso molteplici sistemi di<br />
navigazione (navigazione articolata; navigazione tematica; navigazione<br />
attraverso tag).<br />
i<br />
http://vetrinepsr.sistemapiemonte.it/vetrinapsr/home.do<br />
Commissione regionale<br />
pari opportunità<br />
Donne e imprese agricole<br />
La Commissione Regionale Pari Opportunità (CRPO) in collaborazione<br />
con il consorzio Il Nodo – Formazione Consulenza e Ricerca<br />
c.s.c.s. ha avviato un progetto di valorizzazione delle imprese<br />
agricole e agroalimentari a titolarità femminile, che si propone di:<br />
• aiutare le imprese agroalimentari e agricole femminili a migliorare<br />
la performance economica<br />
• offrire nuove opportunità di sviluppo congiunto nel territorio piemontese<br />
e dell’Unione Europea<br />
• rendere evidenti criticità, bisogni, opportunità delle imprese al<br />
femminile ai/lle cittadini/e e agli/lle attori/trici degli enti pubblici.<br />
Il progetto prevede la creazione di una piattaforma collaborativa<br />
tra le imprese agricole a titolarità femminile, le associazioni<br />
di categoria e le istituzioni; la produzione di un vademecum di<br />
impresa; momenti di dialogo e confronto nelle scuole e nelle manifestazioni<br />
del territorio. Nel mese di marzo si è costituito un Tavolo<br />
di lavoro permanente in cui sono coinvolte, oltre alla CRPO,<br />
le principali associazioni di categoria (Confcooperative Fedagri<br />
Piemonte, Commissione Regionale Dirigenti Confcooperative<br />
Piemonte, Coldiretti Piemonte Donne Impresa, Confagricoltura<br />
Donna Piemonte, CIA Piemonte Donne in Campo).<br />
Il progetto prevede di creare una banca dati delle realtà agricole del<br />
territorio al femminile, consultabile on line sul sito della Regione<br />
Piemonte, in modo da condividere la rete, entrare a far parte di un<br />
progetto con una forte rappresentanza intersettoriale, ricevere aggiornamenti<br />
e comunicazioni tempestive attraverso la newsletter.<br />
i<br />
Per saperne di più e aderire alla banca dati potete contattare<br />
crpo@regione.piemonte.it<br />
http://www.regione.piemonte.it/pariopportunita/cms/index.php/<br />
commissione-pari-opportunita<br />
8 Agricoltura <strong>81</strong>
pubblicazioni<br />
Ricerca applicata<br />
in frutticoltura<br />
(sintesi dei<br />
risultati 2012)<br />
Il settore frutticolo piemontese è caratterizzato<br />
da produzioni apprezzate<br />
anche all’estero grazie alle capacità<br />
imprenditoriali di numerose aziende<br />
specializzate, attente alle innovazioni<br />
tecniche e all’evoluzione dei mercati. La<br />
Regione Piemonte ha finanziato nel 2012 un programma di ricerca<br />
e sperimentazione coordinato dal CReSO (Consorzio di Ricerca Sperimentazione<br />
e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura Piemonte) che ha<br />
svolto le attività in collaborazione con numerose istituzioni scientifiche.<br />
I risultati dei progetti sono stati raccolti in questa pubblicazione<br />
suddivisa in due parti. La prima è dedicata all’innovazione varietale<br />
e riporta le osservazioni fatte su melo, pesco e albicocco; la seconda<br />
parte riguarda la tecnica colturale e fornisce un aggiornamento delle<br />
strategie di difesa attuali o la definizione di nuove tecniche occupandosi<br />
anche del miglioramento della qualità delle produzioni mediante<br />
la messa a punto delle tecniche agronomiche.<br />
Ricerca applicata<br />
in corilicoltura<br />
(sintesi dei<br />
risultati 2012)<br />
La corilicoltura piemontese rappresenta<br />
da ormai un decennio un settore in<br />
continua crescita: aumentano le superfici<br />
investite con produzioni caratterizzate<br />
dai elevati pregi merceologici.<br />
La Regione Piemonte ha finanziato<br />
progetti di ricerca e sperimentazione nel settore corilicolo al fine di<br />
ottenere innovazioni sia nei processi produttivi che nelle avversità<br />
che colpiscono il nocciolo. Tali attività sono state affidate al CReSO<br />
(Consorzio di Ricerca Sperimentazione e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura<br />
Piemontese) che le ha svolte in collaborazione con numerose<br />
istituzioni scientifiche. I temi di ricerca trattati riguardano<br />
vari argomenti come l’aggiornamento delle strategie di difesa, le<br />
tecniche di gestione del sottofila e il miglioramento della qualità<br />
delle produzioni.<br />
Ricerca applicata<br />
in orticoltura<br />
(sintesi dei<br />
risultati 2012)<br />
La Regione Piemonte, nell’ambito delle<br />
attività di ricerca e sperimentazione<br />
promosse nel settore agricolo, ha finanziato<br />
delle prove di confronto varietale<br />
in orticoltura per individuare i materiali<br />
più idonei alla coltivazione nelle nostre<br />
aree approfondendo anche gli aspetti di ordine agronomico e fitoiatrico.<br />
L’attività e’ coordinata e realizzata dal CReSO (Consorzio di Ricerca<br />
Sperimentazione e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura Piemontese), in<br />
collaborazione con altre istituzioni scientifiche e con il coinvolgimento<br />
dei tecnici orticoli del nostro territorio. Si è pertanto ritenuto importante<br />
raccogliere in una pubblicazione i risultati ottenuti dalle prove svolte nel<br />
2012 riportando le valutazioni per le colture orticole di maggior interesse<br />
per il Piemonte, indicando le possibili estensioni del calendario di produzione<br />
e valutando l’adozione di nuove tecniche di coltivazione.<br />
Ipotesi di<br />
introduzione del<br />
suino medio pesante<br />
nel settore suinicolo<br />
piemontese<br />
e nazionale<br />
La Regione Piemonte ha approvato nel<br />
2010 il “Piano strategico regionale di indirizzo<br />
per lo sviluppo e la valorizzazione<br />
della suinicoltura piemontese” in cui si<br />
individua, tra le diverse linee strategiche, la necessità di attivare studi e<br />
ricerche per lo sviluppo di una filiera del suino medio-pesante di qualità<br />
(kg 135-140), con destinazione diversa dal circuito delle DOP.<br />
La pubblicazione in oggetto propone dunque i risultati emersi dallo<br />
“Studio relativo all’ipotesi di introduzione di un suino medio pesante<br />
nel settore suinicolo piemontese e nazionale e ricerca di mercato per<br />
le carni e i salumi derivati da suini medio pesanti”. Il progetto ha visto<br />
la partecipazione di Regione Piemonte, APS Piemonte (Organizzazione<br />
produttori suini Piemonte) e i Dipartimenti di Scienze Zootecniche<br />
e di Scienze Merceologiche dell’Università di Torino ed è stato realizzato<br />
in due anni di attività, concludendosi nel 2012.<br />
i<br />
Le pubblicazioni sono disponibili in download dalla banca dati “Pubblicazioni”, categoria “agricoltura e ricerca”:<br />
www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/pubblicazioni/pub/index.cgi<br />
Agricoltura <strong>81</strong><br />
9
PAC 2014-2020<br />
Al via nel 2015 gli aiuti diretti<br />
Gianfranco Latino - Direzione Agricoltura<br />
Il 26 giugno <strong>2013</strong> le tre principali istituzioni dell’Unione Europea<br />
(Parlamento, Consiglio e Commissione), seguendo la procedura<br />
prevista dal Trattato di Lisbona, hanno raggiunto l’accordo sulla<br />
PAC 2014-2020. Nel mese di settembre sono stati definiti alcuni<br />
ulteriori dettagli che la Presidenza irlandese aveva ritenuto opportuno<br />
includere nella discussone sul Quadro Finanziario Pluriennale<br />
(QFP). Tali decisioni riguardano i seguenti aspetti: digressività<br />
e capping (riduzione degli aiuti diretti per i maggiori percettori),<br />
flessibilità tra i pilastri (possibilità di trasferimento di risorse dai pagamenti<br />
diretti allo sviluppo rurale), disciplina finanziaria (solo per i<br />
pagamenti diretti superiori ai 2000 €), riserva finanziaria (fondo destinato<br />
ad affrontare le situazioni di crisi nel settore agricolo), criteri<br />
di riparto delle risorse tra gli Stati membri (convergenza esterna),<br />
modalità di revisione della PAC (a partire dal 2018) sulla base dei<br />
risultati raggiunti.<br />
I termini dell’accordo dovranno ora tradursi nei regolamenti che<br />
dovrebbero essere approvati entro l’anno in corso.<br />
Occorre però osservare che l’applicazione delle norme comunitarie<br />
potrà essere fortemente condizionata dalle numerose ed importanti<br />
scelte che l’Unione Europea demanderà agli Stati membri.<br />
Pur alla luce di queste premesse è comunque possibile osservare che:<br />
la PAC continuerà a disporre di risorse consistenti seppur ridotte<br />
rispetto all’attuale periodo di programmazione;<br />
l’Italia subirà una riduzione dei fondi destinati agli aiuti diretti,<br />
pari al 6,5% del plafond precedente, parzialmente compensata da<br />
una maggior assegnazione di risorse per lo sviluppo rurale.<br />
Considerate le proposte da cui partì la Commissione alla fine del<br />
2011 il nostro Paese si può dire ragionevolmente soddisfatto dei<br />
risultati negoziali ottenuti e, quindi, del lavoro svolto dal governo<br />
(nell’ambito del Consiglio) e dal Parlamento europeo. Quest’ultimo,<br />
ricordiamolo, per la prima volta nella storia dell’Unione Europea,<br />
ha concretamente partecipato alla definizione dell’accordo.<br />
Probabilmente i tempi di approvazione si sono allungati, ma certamente<br />
è accresciuto il livello di partecipazione democratica. Sin<br />
da questo momento emerge però un risultato piuttosto deludente<br />
di questo negoziato: la nuova PAC doveva essere più semplice, ma<br />
appare invece più complessa di quella attuale. Certamente anche<br />
in questo caso Stato e Regioni potranno migliorare o peggiorare la<br />
situazione che Bruxelles si appresta a consegnarci.<br />
Ciò detto, per quanto riguarda gli aiuti diretti, il 2014 non sarà<br />
10 Agricoltura <strong>81</strong>
l’anno di avvio bensì quello delle scelte nazionali. I cambiamenti<br />
diverranno tangibili nel 2015, quando i nuovi titoli all’aiuto andranno<br />
incontro ad un processo di livellamento, chiamato convergenza<br />
interna, che potrà essere più o meno evidente e più o meno rapido.<br />
Nei paragrafi che seguono si è cercato di focalizzare l’attenzione<br />
sui punti salienti dell’accordo che porteranno alla definizione dei<br />
nuovi titoli all’aiuto<br />
Agricoltore attivo<br />
Prima di assegnare gli aiuti occorrerà stabilire chi ne avrà diritto.<br />
La platea dei possibili beneficiari, infatti, è destinata a diminuire.<br />
Fin dall’avvio del dibattito sulla nuova PAC vi è stata un’ampia<br />
convergenza su un punto: gli aiuti diretti devono essere erogati<br />
solo a coloro che esercitano realmente l’attività agricola. Questo<br />
per evitare che soggetti completamente estranei al settore primario<br />
continuino, come hanno fatto sino ad oggi, a percepire una parte<br />
consistente di questi fondi. La mancanza di regole in tal senso,<br />
infatti, ha consentito a compagnie aeree od a gestori di campi da<br />
golf di essere annoverati tra i maggiori percettori di aiuti diretti.<br />
Dall’accordo del 26 giugno è emersa una lista di soggetti automaticamente<br />
esclusi: aeroporti, servizi ferroviari, opere idrauliche,<br />
servizi immobiliari, terreni sportivi ed aree ricreative permanenti. Lo<br />
Stato membro potrà integrare l’elenco ed introdurre limitazioni in<br />
modo da ridurre ulteriormente il numero dei beneficiari.<br />
Le organizzazioni di categoria, pur con sfumature diverse, sostengono<br />
decisamente quest’ultima ipotesi, partendo dalla constatazione<br />
che solo chi vive di agricoltura debba essere aiutato dalla PAC.<br />
Sono comunque salvaguardati i piccoli percettori. Le predette regole,<br />
infatti, non si applicheranno a coloro che incassano meno<br />
di 5.000 € all’anno. Somma che può essere abbassata dallo Stato<br />
membro.<br />
non ne hanno ricevuti ma provano che nel <strong>2013</strong> svolgevano attività<br />
agricola;<br />
hanno ricevuto titoli da riserva nazionale nel 2014.<br />
Lo Stato, tra l’altro, potrà:<br />
limitare l’aumento dei titoli assegnati rispetto a quelli posseduti<br />
nel 2009 a + 35% o + 45%<br />
escludere dalle superfici su cui attribuire i titoli i vigneti ed i seminativi<br />
in serra<br />
I nuovi titoli<br />
Gli attuali diritti all’aiuto, che decadranno il 31 dicembre 2014, saranno<br />
sostituiti da nuovi titoli il cui valore sarà pari alla somma di<br />
diverse “componenti”: tre obbligatorie ed altre quattro attivabili a<br />
discrezione dello Stato membro.<br />
COMPONENTI OBBLIGATORIE<br />
Pagamento di base<br />
(dall’8 al 70% del massimale)<br />
Molto probabilmente circa la metà degli aiuti diretti confluirà in<br />
questo pagamento.<br />
Il calcolo potrà essere fatto suddividendo il plafond nazionale tra<br />
tutti gli ettari ammissibili. In alternativa si potrà suddividere il plafond<br />
tra regioni omogenee (non necessariamente uguali alle regioni<br />
amministrative) sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.<br />
Questa seconda ipotesi consentirebbe di ridurre l’impatto della riforma<br />
in quanto permette di limitare il travaso di aiuti da aree che<br />
percepiscono più aiuti ad aree che ne percepiscono di meno.<br />
Fatta la scelta tra applicazione nazionale o regionale lo Stato dovrà<br />
Soglia minima<br />
e assegnazione dei titoli<br />
Come già avviene oggi lo Stato membro ha facoltà di decidere se<br />
non erogare i pagamenti diretti sotto la soglia di 100 € o di 1 ettaro<br />
di superficie ammissibile. L’Italia potrà comunque variare questi parametri<br />
portandoli sino a 400 € o 0,5 ettari di superficie.<br />
Per ottenere i titoli, gli agricoltori attivi dovranno presentare domanda<br />
nel 2015 e li otterranno solo se:<br />
hanno ricevuto pagamenti diretti nel <strong>2013</strong>, oppure<br />
non ne hanno ricevuti ma producevano ortofrutta, patate, piante<br />
ornamentali o vite su una superficie minima che lo Stato dovrà<br />
definire;<br />
Agricoltura <strong>81</strong><br />
11
adottare una delle seguenti opzioni:<br />
1. il valore dei titoli diviene uguale, a livello di<br />
stato o regione omogenea, nel 2015;<br />
2. il valore dei titoli si avvicina progressivamente<br />
a partire dal 2015 e diviene uguale nel<br />
2019 (convergenza interna);<br />
3. il valore dei titoli si avvicina progressivamente a partire dal 2015<br />
ma nel 2019 permarranno ancora delle differenze (convergenza<br />
interna secondo il cosiddetto “modello irlandese”. In questo caso<br />
tutti i titoli, sempre nel 2019, dovranno avere un valore almeno pari<br />
al 60% della media nazionale o regionale. Lo Stato membro, inoltre,<br />
può decidere che la perdita in valore dei titoli non superi il 30%.<br />
Greening<br />
(30% del massimale)<br />
Le regole del greening devono essere rispettate da tutti i percettori<br />
di aiuti diretti. A partire dal 2017, infatti, coloro che non dovessero<br />
adeguarsi, oltre a perdere la componente verde, vedrebbero decurtato<br />
anche il pagamento di base.<br />
Lo Stato, se applica la convergenza interna, può decidere che il<br />
30% sia calcolato sul valore dei titoli del singolo agricoltore. Opzione<br />
certamente interessate per paesi in cui il valore iniziale dei titoli<br />
è fortemente diversificato (l’Italia è tra questi).<br />
Le disposizioni da rispettare sono quelle proposte dalla Commissione,<br />
ma sono state modificate durante il negoziato ed oggi paiono<br />
più compatibili con l’agricoltura italiana. Eccole in sintesi.<br />
Diversificazione<br />
Interessa solo le aziende che investono più di 10 ettari a seminativo,<br />
con esclusione delle colture sommerse (riso). Per quelle con<br />
superficie a seminativo tra 10 e 30 ettari comporta la realizzazione<br />
di almeno due colture e la principale deve riguardare meno del<br />
75% della superficie aziendale. Se i seminativi superano i 30 ettari<br />
le colture devono essere almeno tre, la più importante non deve<br />
rappresentare più del 75% della superficie e la minore non meno<br />
del 5%. Se il 75% della superficie aziendale è destinata alla produzione<br />
di foraggio, oppure é a riposo, la diversificazione si applica<br />
solo se i seminativi superano i 30 ettari investiti.<br />
Prati e pascoli permanenti<br />
Le superfici a prato o pascolo permanente, se situate nelle aree<br />
sensibili dal punto di vista ambientale (aree individuate ai sensi delle<br />
direttive “habitat” e “uccelli selvatici” o comunque definite sensibili<br />
dallo Stato membro), non possono essere convertite in altre<br />
coltivazioni. In ogni caso il rapporto (calcolato a livello nazionale o<br />
regionale o aziendale) tra superfici a prato o pascolo e la superficie<br />
agricola totale, nel periodo 2012-2015, non deve subire riduzioni<br />
superiori al 5%.<br />
Aree di interesse ecologico<br />
Interessa solo le aziende con più di 15 ettari a seminativo. Qualora<br />
il 75% della superficie aziendale sia destinata alla produzione di foraggio,<br />
a colture sommerse, a leguminose o sia a riposo la soglia di<br />
esenzione aumenta a 30 ettari di seminativi. Le aziende interessate,<br />
a partire dal 2015, dovranno destinare il 5% (la Commissione potrà<br />
elevarla al 7% dal 2017, previa valutazione d’impatto) della superficie<br />
seminata ad aree di interesse ecologico. La definizione dell’area<br />
di interesse ecologico è demandata allo Stato membro anche<br />
se il regolamento prevederà un elenco di tipologie. Tra queste sono<br />
comprese le terre a riposo e le colture azoto-fissatrici. Quest’ultima<br />
rappresenta una possibilità di assoluto interesse per l’Italia e per la<br />
filiera zootecnica, tenuto conto del fatto che siamo forti importatori<br />
di proteine vegetali destinate agli allevamenti.<br />
12 Agricoltura <strong>81</strong>
Pagamenti per i giovani<br />
(fino al 2% del massimale)<br />
Saranno destinati agli agricoltori attivi con meno di 40 anni, che si<br />
insediano in azienda o che si sono insediati negli ultimi 5 anni. Chi<br />
possiede questi requisiti potrà ricevere, per i primi cinque anni, un<br />
pagamento supplementare calcolato come segue:<br />
valore medio (dei titoli posseduti dal giovane agricoltore oppure,<br />
del pagamento di base a livello nazionale oppure del valore medio<br />
del pagamento nazionale) x 25% x titoli attivati (al massimo 25).<br />
COMPONENTI FACOLTATIVE<br />
Pagamento redistributivo<br />
(fino al 30% del massimale)<br />
Si tratta di una delle maggiori novità emerse durante il negoziato<br />
(non era previsto nella proposta iniziale della Commissione) ed ha lo<br />
scopo di spostare risorse dalle grandi aziende a quelle di piccole dimensioni.<br />
Costituisce un’alternativa al capping, tanto che quest’ultimo<br />
non potrà essere applicato negli Stati che vi destineranno più<br />
del 5%. Il pagamento redistributivo può riguardare, al massimo, i<br />
primi 30 titoli attivati, su cui può essere concessa una maggiorazione<br />
pari al 65% del premio medio nazionale o regionale.<br />
Aree con vincoli naturali<br />
(fino al 5% del massimale)<br />
Riguarda le aree soggette a vincoli naturali ed individuate come tali<br />
dallo nell’ambito dello sviluppo rurale. L’aiuto annuale ad ettaro<br />
viene calcolato dividendo la somma disponibile per il numero degli<br />
ettari ammissibili. Lo Stato membro può determinare il numero<br />
massimo di ettari ammissibili per azienda.<br />
Pagamenti accoppiati<br />
Sostituiscono sostanzialmente le misure accoppiate che sono state finanziate<br />
sino ad oggi ai sensi del regolamento n.73/2009 articolo 68.<br />
L’Italia ha molto puntato su questo strumento, ritenendo che potesse<br />
contribuire ad attutire l’impatto della convergenza tra i valori dei titoli.<br />
La notevole disomogeneità che caratterizza i titoli all’aiuto nel nostro<br />
Paese e la necessità di puntare ad una drastica riduzione di queste<br />
differenze, è destinata a ripercuotesi sui settori che oggi percepiscono<br />
di più e quindi sulle aziende che vi operano. Le conseguenze potrebbero<br />
essere tali da determinare un altrettanto drastico ridimensionamento<br />
dei settori più colpiti. Attraverso il sostegno accoppiato si ha<br />
la possibilità di agire selettivamente, per settori e per regioni, in modo<br />
da evitare che questo fenomeno sia troppo evidente e troppo rapido.<br />
In Piemonte alcune simulazioni prodotte dall’IRES hanno evidenziato<br />
come la risicoltura e l’allevamento bovino (soprattutto quello da carne),<br />
rappresentino i comparti maggiormente a rischio.<br />
La cifra potenzialmente disponibile è di una certa consistenza anche<br />
grazie agli esisti del negoziato (si era partiti da una proposta iniziale della<br />
Commissione che prevedeva un massimale pari al 5% del plafond),<br />
ma è ipotizzabile che non sia comunque sufficiente ad intervenire in<br />
tutte le situazioni di sofferenza. Sarà quindi importante governare attentamente<br />
questo strumento, monitorando attentamente gli sviluppi<br />
della situazione e fruendo anche della possibilità di intervenire, entro<br />
il 1° agosto 2017, per correggere l’impostazione che sarà individuata<br />
nella fase di avvio. Da sottolineare ancora l’opportunità di utilizzare<br />
il 2% del plafond per le colture proteiche (peraltro coltivabili anche<br />
nella aree di interesse ecologico previste dal greening), che potrebbe<br />
certamente contribuire a risolvere l’annoso problema della carenza di<br />
proteine vegetali nel nostro paese.<br />
Piccoli agricoltori<br />
(fino al 10% del massimale)<br />
L’adesione delle aziende è volontaria, ma potenzialmente potrebbe<br />
interessarne moltissime contribuendo a semplificare significativamente<br />
la gestione degli aiuti diretti. Per accedervi l’agricoltore<br />
non deve superare un certo livello di pagamento che può essere<br />
pari al 25% del pagamento medio nazionale per azienda od al<br />
pagamento medio nazionale di 5 ettari ammissibili. In ogni caso la<br />
soglia deve essere compresa tre 500 e 1.250 €. Gli aderenti sono<br />
tenuti a rispettare le norme sulla condizionalità ma non quelle del<br />
greening. Tuttavia il pagamento per i piccoli agricoltori, in alternativa<br />
alle opzioni sopra evidenziate, può essere calcolato facendo<br />
la somma di tutte le componenti (obbligatorie e facoltative)<br />
descritte in precedenza. In questo caso anche i piccoli agricoltori<br />
sarebbero assoggettati al greening. Il pagamento calcolato al momento<br />
dell’adesione rimane costante negli anni, pertanto l’agricoltore<br />
deve continuare a possedere una superficie ammissibile<br />
pari a quella indicata nella domanda iniziale.<br />
Va ancora detto che la maggior parte delle scelte nazionali andranno<br />
fatte entro il 1° agosto 2014, termine entro il quale si potrà sfruttare<br />
la notevole flessibilità che caratterizzerà la Politica Agricola Comune<br />
2014-2020. Flessibilità talmente ampia da rendere fuorviante, secondo<br />
alcuni osservatori, il termine “Comune”. Di fatto gli Stati membri<br />
vedono certamente accresciuto il loro ruolo e la loro responsabilità<br />
in questo particolare e delicato ambito. Sarà quindi indispensabile<br />
ponderare attentamente le scelte da operare, valutandone preventivamente<br />
gli effetti con tutti gli strumenti a disposizione.<br />
Agricoltura <strong>81</strong><br />
13
Nuovi bandi per giovani,<br />
diversificazione e investimenti<br />
di stampo ambientale<br />
Gli ultimi sul PSR 2007-<strong>2013</strong>, con scadenze ravvicinate<br />
Massimo Clerico - Settore Servizi alle imprese<br />
Il costante monitoraggio effettuato sulla gestione del PSR 2007-<br />
<strong>2013</strong> ha evidenziato un margine di fondi non ancora utilizzati che<br />
consente di riaprire le opportunità di finanziamento sulle misure<br />
112 (insediamento di giovani agricoltori), 311 (diversificazione in<br />
attività non agricole), 121 “Health check” (investimenti che corrispondono<br />
a finalità ambientali). I nuovi bandi dovranno tuttavia<br />
tenere conto del ridottissimo tempo a disposizione delle Province<br />
per l’istruttoria delle domande ed a disposizione dei richiedenti<br />
per la realizzazione di insediamenti ed investimenti, poiché, per<br />
disposizione dei Regolamenti comunitari, i contributi ed i premi<br />
erogati dovranno essere rendicontati all’Unione Europea improrogabilmente<br />
entro il 2015.<br />
Sono stati così recentemente approvati dalla Giunta Regionale i criteri<br />
e le disposizioni per l’emanazione dei bandi sulle misure elencate<br />
(DGR 28- 6474 per la misura 112; DGR 29- 6475 per la misura<br />
121; DGR 27- 6473 per la misura 311, tutte del 7 ottobre <strong>2013</strong>),<br />
che prevedono la concessione dei seguenti aiuti in conto capitale:<br />
Misura 112 (risorse disponibili: 9.888.020 euro): premi di insediamento<br />
fino a 30.000 euro destinati a giovani al di sotto dei 40 anni che<br />
si insediano per la prima volta in qualità di titolari di azienda agricola.<br />
Misura 121 (risorse disponibili: 4.119.832,91 euro): contributi<br />
per l’ammodernamento delle aziende agricole riferiti alle<br />
seguenti azioni (l’importo massimo per azienda è indicato nei<br />
bandi per ciascuna azione e sottoazione):<br />
• Azione 1 - “Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione<br />
dei relativi effetti”. Operazione 1.1 Risparmio energetico<br />
• Azione 1 - “Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione<br />
dei relativi effetti”. Operazione 1.2.a Reti antigrandine<br />
• Azione 1 - “Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione<br />
dei relativi effetti”. Operazione 1.2.b Opere idriche e<br />
sistemazioni del terreno finalizzate a prevenire smottamento<br />
ed erosione<br />
• Azione 2 - “Gestione delle risorse idriche” Operazione Risparmio<br />
idrico - Investimento 2.1.a Invasi e altre opere per<br />
l’accumulo di acqua<br />
• Azione 2 - “Gestione delle risorse idriche” Operazione Risparmio<br />
idrico - Investimento 2.1.b Interventi di razionalizzazione<br />
dei sistemi irrigui finalizzati a ridurre le dispersioni e le<br />
perdite idriche<br />
14 Agricoltura <strong>81</strong>
• Azione 2 - “Gestione delle risorse idriche” Operazione Risparmio<br />
idrico - Investimento 2.1.c Sistemi di irrigazione a<br />
basso utilizzo di acqua (pioggia, goccia, spruzzo e simili) in<br />
luogo dell’irrigazione a scorrimento<br />
• Azione 2 - “Gestione delle risorse idriche” Operazione Risparmio<br />
idrico - Investimento 2.2 Miglioramento della qualità<br />
dell’acqua.<br />
• Nuova sfida “Sostegno agli investimenti connesso alla<br />
produzione lattiero casearia”, riservato esclusivamente alle<br />
aziende che già precedentemente alla emanazione del bando<br />
siano produttrici di latte bovino.<br />
• La nuova sfida “Sostegno agli investimenti connesso alla<br />
produzione lattiero casearia” è suddivisa in quattro sottoazioni:<br />
• Sottoazione h-1 Riduzione dei costi di produzione e incremento<br />
della competitività delle aziende<br />
• Sottoazione h-2 Miglioramento del livello di sicurezza e<br />
della qualità dei prodotti<br />
• Sottoazione h-3 Riconversione e diversificazione della<br />
produzione<br />
• Sottoazione h-4 Trasformazione e commercializzazione<br />
diretta di prodotti aziendali (ammissibile solo in alcune<br />
aree, per aziende con meno di 30 vacche da latte e prodotti<br />
DOP, IGP o biologici)<br />
i<br />
Provincia competente entro i 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione<br />
per via telematica, completa delle documentazioni (relazione<br />
tecnica, progetti, autorizzazioni, ecc…) specificate dai bandi.<br />
I beneficiari devono ultimare completamente gli insediamenti e<br />
gli investimenti richiesti entro il termine assegnato dalla Provincia<br />
e comunque non oltre il 31 gennaio 2015. Non potranno essere<br />
riconosciuti gli investimenti effettuati oltre tale data e le spese<br />
non sostenute e non rendicontate dal beneficiario oltre tale data.<br />
Non possono essere erogati contributi per lavori/investimenti<br />
e/o spese effettuati prima della presentazione della domanda.<br />
Non saranno erogati anticipi e/o acconti ad avanzamento lavori.<br />
Le graduatorie (formate sulla base dei criteri di selezione riportati nei<br />
bandi) saranno gestite dinamicamente, erogando i premi e contributi<br />
in ordine di ultimazione lavori, fino ad esaurimento delle risorse. E’<br />
quindi interesse del richiedente ultimare la realizzazione degli investimenti<br />
il più rapidamente possibile e l’inserimento in posizione utile<br />
nella graduatoria provvisoria non garantisce l’effettivo ottenimento<br />
del contributo. Non si procederà nella fase iniziale né all’istruttoria<br />
né alla definizione delle domande, adempimenti che sono posticipati<br />
alla fase successiva alla realizzazione degli investimenti.<br />
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet<br />
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/psr2007_13<br />
oppure rivolgersi alle Province o agli sportelli informativi del Programma<br />
di Sviluppo Rurale.<br />
Misura 311 (risorse disponibili 1.4<strong>81</strong>.795,41 euro): contributi<br />
per interventi di diversificazione delle aziende agricole<br />
riferiti ad attività quali l’agriturismo, i servizi educativi ed i servizi<br />
sociali e per il tempo libero (importo massimo per azienda<br />
120.000 euro).<br />
Si riassumono a titolo informativo i principali elementi del bando<br />
(fanno fede comunque le DGR 28- 6474 per la misura 112;<br />
DGR 29- 6475 per la misura 121; DGR 27- 6473 per la misura<br />
311, tutte del 7 ottobre <strong>2013</strong>, disponibili sul sito internet della<br />
Regione Piemonte a cui si rimanda per una trattazione più<br />
approfondita).<br />
Le domande devono essere presentate per via telematica (rivolgendosi<br />
ad un CAA - Centro Abilitato di Assistenza Agricola<br />
oppure in proprio con le modalità precisate dalla DGR n.<br />
130-9454 del 1.08.2008 e s.m.i.) dal 14 ottobre <strong>2013</strong> al 31<br />
gennaio 2014 (salvo chiusura anticipata automatica in caso di<br />
esaurimento delle risorse).<br />
La domanda dovrà essere consegnata anche in forma cartacea alla<br />
Agricoltura <strong>81</strong><br />
15
DOP e IGP<br />
non si vendono da sole<br />
Orientamenti per una strategia regionale<br />
della promozione agro-alimentare<br />
La Regione Piemonte mette a disposizione<br />
il container Piemonte PIE3 – 40 per la<br />
realizzazione di iniziative puntuali di<br />
informazione e promozione dei prodotti<br />
agro-alimentari regionali<br />
Moreno Soster - Settore Programmazione e valorizzazione del sistema agro-alimentare<br />
Nel linguaggio economico, la promozione è l’incentivo o stimolo<br />
che tende a far conoscere e apprezzare un servizio, un prodotto<br />
o un’idea. Operativamente consiste nello strumento, prevalentemente<br />
comunicativo, che usiamo per rendere percepibile un<br />
prodotto, con l’obbiettivo di farlo “apprezzare” e quindi rendere<br />
compiuto il cammino della sua valorizzazione, coniugando la soddisfazione<br />
del consumatore con quella del produttore-venditore.<br />
In agricoltura questo legame tra il momento della valorizzazione<br />
e quello della promozione appare ancora più stretto a causa della<br />
peculiarità del settore economico e della sua politica.<br />
Il legame tra valorizzazione<br />
e promozione<br />
L’agricoltura è laboratorio a cielo aperto, strettamente legato al<br />
territorio, sviluppata (nei paesi ad economia avanzata) da un relativamente<br />
piccolo gruppo di imprese che tuttavia producono<br />
alimenti e servizi destinati all’intera comunità, nell’ambito di un<br />
percorso culturale collettivo che chiamiamo tradizione. Lo stretto<br />
legame agricoltura-territorio si è tradotto quindi in politiche di<br />
valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari che esaltano<br />
il valore dell’origine: si pensi al D.P.R. n. 930/1963 che ha istituito<br />
le DOC-DOCG nei vini italiani, le norme comunitarie del 1987 sui<br />
VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate) che si sono<br />
poi diffuse agli altri prodotti agro-alimentari con i regolamenti del<br />
1992 sulle DOP (denominazione d’origine protetta) e IGP (indicazione<br />
geografica protetta) non enologiche, per giungere alle IG<br />
(indicazioni geografiche) delle bevande spiritose.<br />
Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche offrono ai<br />
produttori un’opportunità di rendere riconoscibile e di commercializzare<br />
un prodotto di alta gamma che è sottoposto al loro controllo,<br />
nella misura in cui definiscono i contenuti del disciplinare di produzione<br />
e scelgono l’organismo di certificazione. Sono quindi un<br />
mezzo importante per formalizzare le conoscenze e le competenze<br />
dei produttori, assicurandone l’incorporamento nel prodotto che è<br />
tutelato attraverso un marchio collettivo. Ma le denominazioni d’origine<br />
e le indicazioni geografiche non si vendono da sole. Ossia la<br />
loro valorizzazione non può prescindere dalla forza e dalla portata<br />
delle iniziative di promozione che i produttori e l’intera filiera commerciale<br />
sono in grado di sviluppare per aumentarne la conoscenza<br />
e la riconoscibilità agli occhi del consumatore.<br />
16 Agricoltura <strong>81</strong>
Il mercato è il mondo<br />
Il consumatore a cui oggi facciamo riferimento si trova in ogni<br />
parte del mondo. E’ quindi indispensabile promuovere il prodotto<br />
legato all’origine in una maniera tale da renderlo distintivo proprio<br />
in virtù delle specificità del territorio di provenienza. Questo<br />
elemento è particolarmente forte per il prodotto agro-alimentare<br />
le cui caratteristiche dipendono fortemente dalle condizioni ambientali<br />
correlate con il know how stratificato nel tempo dagli<br />
imprenditori per trovare il miglior equilibrio economico tra ambiente,<br />
coltura/allevamento e prodotto da commercializzare. Evidentemente<br />
la capacità del consumatore di riconoscere un prodotto<br />
agro-alimentare di origine tende a ridursi all’aumento della<br />
sua distanza dai luoghi di produzione. Poiché le nuove frontiere<br />
del mercato sono quelle più lontane, occorre elaborare strategie<br />
regionali di promozione e comunicazione che tengano ben presente<br />
questo aspetto.<br />
I prodotti di origine piemontese sono “specialità” e quindi si collocano<br />
su una fascia medio-alta di mercato. Questo è coerente<br />
con la complessità produttiva, la garanzia qualitativa, la presenza<br />
di valori immateriali attribuiti che si devono tradurre in una predisposizione<br />
del consumatore al pagamento di un prezzo più elevato<br />
che sia remunerativo per l’impresa senza ridurne la capacità<br />
competitiva in un mercato ampio e concorrenziale.<br />
Integrazione dei diversi<br />
livelli comunicativi<br />
Le strategie regionali per la promozione devono essere sviluppate<br />
integrando differenti livelli comunicativi esistenti:<br />
a) il nome PIEMONTE, che è un valore riconosciuto all’area geografica<br />
(territorio) sulla base di un patrimonio di significati (country image)<br />
legato alle caratteristiche naturali, sociali, culturali, stratificatesi nel<br />
tempo e di cui il consumatore è a conoscenza spesso in maniera<br />
superficiale o attraverso stereotipi, positivi o negativi, che devono<br />
essere gestiti nella forma più opportuna. Peraltro questo quadro di<br />
significati dovrebbe essere coerente con l’insieme dei valori in cui<br />
effettivamente si riconoscono le istituzioni e le imprese e la comunità<br />
che vivono quel luogo. Teniamo anche conto che la regione assume<br />
sempre più un ruolo di ambito territoriale privilegiato dalle convenzioni<br />
commerciali, in particolare per i prodotti agro-alimentari;<br />
b) i marchi collettivi di valorizzazione dell’origine (DOC, DOCG,<br />
DOP, IGP, IG), o di specifici processi produttivi (BIO), che agiscono<br />
generalmente su ambiti territoriali sub-regionali, rendendo<br />
maggiormente apprezzabile la specificità locale alla quale si attribuiscono<br />
le caratteristiche del prodotto e nella quale si amplia<br />
il senso di appartenenza dei produttori; un ruolo prioritario nella<br />
loro gestione è svolto dai Consorzi di tutela che, in Piemonte,<br />
sono numerosi ma soprattutto controllano la maggior parte dei<br />
marchi collettivi e – recentemente – lo fanno in forme aggregate<br />
anche complesse come il consorzio Piemonte Land of perfection<br />
per il comparto vinicolo e l’Assopiemonte DOP e IGP per molte<br />
denominazioni d’origine non enologiche;<br />
c) i marchi aziendali (corporate brand) o di prodotto (brand) che sono<br />
specifici della sensibilità e della strategia commerciale di ogni azienda.<br />
Una promozione di sistema<br />
La promozione deve sviluppare la conoscenza del prodotto nel<br />
consumatore con l’obbiettivo di farglielo acquistare, sollevandone<br />
l’interesse e agendo sulla sua curiosità, gestendo la sua propensione<br />
all’acquisto e fidelizzandolo con la qualità. Quindi la promozione<br />
deve essere fatta dalle imprese che conoscono, creano,<br />
detengono e commercializzano il prodotto. Siccome i prodotti<br />
di origine sono tutelati da un marchio collettivo, l’azione aziendale<br />
non può prescindere da una strategia condivisa in sede di<br />
Consorzio. Analogamente i Consorzi devono sviluppare strategie<br />
originali a sostegno del marchio collettivo che non possono non<br />
tenere conto della country image del Piemonte in quanto valore<br />
percepito che deve essere mantenuto e sostenuto in risposta al disorientamento<br />
del consumatore rispetto ad un’offerta ridondante<br />
di soluzioni proposte dalla globalizzazione dei mercati.<br />
Fatti salvi alcuni importanti esempi di aziende regionali che hanno<br />
raggiunto una loro “autonomia promozionale” in quanto detentrici<br />
di marchi aziendali ormai affermati ovunque, nella maggior parte<br />
Figura 1. La recentissima IGP “Mela Rossa Cuneo” sarà oggetto di<br />
particolare attenzione nel pacchetto promozionale del settore ortofrutticolo<br />
(Foto: Provincia di Cuneo).<br />
Agricoltura <strong>81</strong><br />
17
dei casi occorre lavorare per una promozione<br />
condivisa del marchio collettivo e, per i mercati<br />
più lontani, del sistema dei marchi collettivi<br />
nell’ambito di una dimensione regionale.<br />
Diventa prioritario quindi sostenere il ruolo<br />
collettivo dei Consorzi di tutela, favorire forme<br />
di aggregazione tra aziende (ATS e ATI), sviluppare attività di collaborazione<br />
pubblico-privato al fine di massimizzare le sinergie, valorizzare<br />
le competenze di ognuno e ottimizzare i costi nell’ottica del servizio<br />
reso al sistema regionale nel suo complesso. In questo senso deve<br />
essere intensificata la collaborazione tra Regione, Sistema camerale,<br />
CEIP e le forme aggreganti dei Consorzi di tutela e delle imprese.<br />
La strategia regionale di promozione deve inoltre assicurare, in un<br />
periodo particolarmente critico per il mercato italiano ed europeo,<br />
una continuità propositiva onde evitare assenze comunicative e<br />
la rinuncia al presidio delle posizioni di mercato acquisite o la ricerca<br />
di nuovi sbocchi. E’ necessario, peraltro, non sottovalutare<br />
la ridotta disponibilità finanziaria che la Regione può dedicare al<br />
sostegno dell’azione promozionale regionale per i prossimi mesi,<br />
che tuttavia deve consentire di giungere alla nuova fase di programmazione<br />
comunitaria 2014-2020.<br />
La strategia regionale<br />
Alla luce di tali considerazioni, con la D.G.R. n. 28-6194 del 29<br />
luglio <strong>2013</strong>, è stata approvata una strategia regionale della durata<br />
di 18 mesi, a partire da luglio <strong>2013</strong> fino a dicembre 2014, che<br />
nell’ambito dell’applicazione della misura 133 del Programma di<br />
sviluppo rurale 2007/<strong>2013</strong> individua le seguenti linee:<br />
a) un elenco prioritario di manifestazioni promozionali alle quali<br />
si ritiene debba essere rivolta l’attenzione delle imprese regionali;<br />
si tratta principalmente di eventi nazionali rilevanti per i diversi<br />
comparti (Vinitaly, Cibus, Cheese, Salone del Gusto, Macfrut,<br />
Sana) ai quali sono stati uniti alcuni appuntamenti in Germania<br />
(Anuga, Prowein, Fruit Logistica) che è mercato interessante in cui<br />
presidiare le quote raggiunte e possibilmente ampliare gli sbocchi;<br />
b) una progettualità basata su “pacchetti promozionali” per<br />
comparto (ortofrutta, vino,ecc,), ossia sull’insieme integrato di<br />
3-4- manifestazioni principali con alcune iniziative collaterali, in<br />
cui sono proposte insieme alle produzioni a denominazione del<br />
comparto anche le altre specialità regionali;<br />
c) lo sviluppo ed il sostegno prioritario a forme di aggregazione<br />
dei Consorzi di tutela, del mondo cooperativo e delle aziende,<br />
che assicurino una partecipazione coordinata alle diverse manifestazioni,<br />
al fine di maturare una strategia complessiva sinergica<br />
che ottimizzi i costi e migliori la percezione del sistema Piemonte;<br />
d) la volontà regionale di supportare senza costi per le imprese,<br />
con proprio personale e con strumenti e materiali divulgativi,<br />
l’attività promozionale sviluppata; in questo ambito si collocano,<br />
ad esempio, la messa a disposizione del container Piemonte PIE3<br />
– 40 per la realizzazione di iniziative puntuali di informazione e<br />
promozione o l’implementazione del sito www.piemonteagri.it;<br />
e) una particolare attenzione al percorso di avvicinamento all’EXPO<br />
2015 “Nutrire il pianeta. Energia per la vita” che, per la tematica<br />
trattata e la rilevanza mondiale dell’evento, merita di essere seguita<br />
puntualmente in quanto preziosa opportunità per fare conoscere il<br />
nostro territorio, l’agricoltura e l’agro-industria e le loro eccellenze<br />
innovative, la ricca eno-gastronomia, nonché la peculiarità e qualità<br />
dei nostri prodotti e delle tradizioni culturali che ad essi sottendono.<br />
La strategia regionale definisce obbiettivi e metodi di lavoro di<br />
carattere generale, sostenendoli in questo periodo con un finanziamento<br />
di 1,8 milioni di euro che corrispondono ad un investimento<br />
complessivo tra i 2,6 ed i 3,5 milioni. A partire da tali basi<br />
saranno i Consorzi di tutela e le imprese che dovranno sviluppare<br />
progetti promozionali integrati e collettivi, con l’esperienza maturata<br />
e con la creatività indispensabile per questo tipo di azioni,<br />
ma soprattutto con la sensibilità orgogliosa di portare le specialità<br />
agroalimentari regionali sulle tavole del mondo.<br />
Figura 2. La Germania ha un mercato interessante in cui consolidare le<br />
quote raggiunte e possibilmente ampliare gli sbocchi dei prodotti agroalimentari<br />
regionali (Foto: www.prowein.de).<br />
18 Agricoltura <strong>81</strong>
Il Piemonte a Cheese<br />
Bra, 20-23 settembre <strong>2013</strong><br />
Si è svolta dal 20 al 23 settembre a Bra Cheese, la kermesse internazionale<br />
sui formaggi, alla sua 9° edizione biennale, organizzata<br />
da Slow Food. Anche per questo importante appuntamento la<br />
Regione è stata protagonista grazie al rapporto di collaborazione<br />
con le principali organizzazioni dei produttori, attuatori dei progetti<br />
di promozione agroalimentare finanziati dal Programma di<br />
sviluppo rurale, un metodo virtuoso che nasce dagli obiettivi di<br />
fare sistema, di dare la massima ricaduta e utilità agli interventi,<br />
ancor più necessari in tempi di grave crisi economica. In tal senso<br />
a Cheese, oltre ai tanti produttori e aziende espositori nelle varie<br />
aree mercatali della città, ha svolto un ruolo di aggregazione Assopiemonte<br />
Dop & Igp, che raggruppa i 6 formaggi piemontesi<br />
a DOP (Bra, Castelmagno, Murazzano, Raschera, Robiola di Roccaverano,<br />
Toma Piemontese), oltre che il Crudo di Cuneo dop e<br />
il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese dop, in un’area espositiva<br />
collettiva di 1800 metri quadri in piazza Spreitenbach a Bra.<br />
Quest’anno, per la prima volta, all’evento ha partecipato anche l’Assessorato<br />
regionale all’Economia montana, oltre all’Assessorato Agricoltura,<br />
con uno stand dedicato ai formaggi di alpeggio e ai margari<br />
piemontesi, ma anche alle attività turistiche, sportive e di outdoor.<br />
Nell’area istituzionale, si è svolta un’intensa attività promozionale<br />
e divulgativa, con presentazioni e degustazioni delle produzioni<br />
eccellenti, che Assopiemonte ha svolto in collaborazione con l’Assessorato<br />
all’Agricoltura della Regione Piemonte, l’Assessorato<br />
all’Economia montana, e con la compartecipazione di IMA Piemonte,<br />
ASCOM Bra, Confcooperative Fedagri Piemonte, Enoteca<br />
Regionale del Barolo, Associazione delle Casare e dei Casari,<br />
Consorzio di tutela del Gorgonzola, ONAF, Consorzio Piemonte<br />
Land of Perfection e con l’ARAP, che ha gestito i box espositivi di<br />
alcuni capi delle principali razze lattifere. Un ricco calendario di<br />
eventi e incontri che hanno proposto i temi, i problemi, le novità<br />
del comparto lattiero-caseario zootecnico.<br />
Agricoltura <strong>81</strong><br />
19
Assessore Regionale all’Agricoltura Claudio<br />
Sacchetto: “Cheese rappresenta un grande<br />
evento in grado di rilanciare la città di Bra, e<br />
il Piemonte sulla scena mondiale. I visitatori<br />
hanno avuto l’opportunità di scoprire i formaggi<br />
del Piemonte e il loro valore aggiunto<br />
espresso dalla ricchezza della biodiversità animale, dalle favorevoli<br />
condizioni pedoclimatiche, dalla applicazione dei progetti per il<br />
benessere animale, dai virtuosi sistemi di allevamento e di alimentazione;<br />
tutto è la diretta conseguenza del duro e prezioso lavoro<br />
degli allevatori e dei produttori piemontesi”.<br />
Assessore Regionale all’Economia montana Gian Luca Vignale: “Per<br />
la prima volta viene riservato uno spazio per promuovere i formaggi<br />
e i produttori delle vallate piemontesi. L’obiettivo è di mettere in vetrina<br />
tutti i sapori, tradizioni enogastronomiche e attività outdoor che<br />
la montagna piemontese offre. La kermesse di Bra diventa duqnue<br />
un’ occasione gradita per i visitatori di gustare le bontà delle nostre<br />
montagne appassionandosi a tutte le attività all’aperto, e un momento<br />
di promozione e valorizzazione di tutti i prodotti montani”.<br />
Presidente di Assopiemonte dop e igp, Gianni Siccardi: “L’organizzazione<br />
dell’evento di Cheese, comprese le numerose iniziative<br />
collegate, è una sfida che abbiamo colto, “forti” della squadra che<br />
ha partecipato al lavoro, sempre assistita da Slow Food.”<br />
20 Agricoltura <strong>81</strong>
IL PIEMONTE LATTIERO CASEARIO<br />
in cifre<br />
19.000 aziende con allevamenti<br />
160.000 vacche da latte, su circa 900.000 capi bovini, che<br />
producono circa 7,6 milioni di quintali di latte all’anno (circa l’8% del<br />
latte prodotto in Italia). Le razze lattifere principali sono: Frisona Italiana,<br />
Piemontese, Valdostana, Bruno Alpina, Pezzata Rossa d’Oropa.<br />
7,6 milioni di quintali di latte prodotto in Piemonte: il 20% circa si<br />
consuma come latte alimentare; il 20% si trasforma in latte in polvere; il 60%<br />
si trasforma in formaggi, di questa quota (circa 3 milioni di quintali di latte) si<br />
trasforma in formaggi DOP.<br />
340 milioni di euro è il valore del latte a prezzi di base agricoli (ex P.L.V.),<br />
corrispondente al 10% del valore dell’intera produzione agricola piemontese.<br />
250 milioni di euro, circa, il valore dell’export di formaggi piemontesi nel 2012,<br />
corrispondente al 10% dell’export formaggi Italia e a circa il 6% dell’export<br />
agroalimentare Piemonte. 75 le società agroindustriali piemontesi che<br />
raccolgono e trasformano il latte, di cui 36 cooperative agricole.<br />
500 circa i “Margari” che in estate portano circa 50.000 capi sugli<br />
alpeggi che hanno una superficie complessiva di 290.000 ettari.<br />
60 gli altri formaggi piemontesi, riconosciuti dalla Regione Piemonte<br />
come Prodotti Agroalimentari Tradizionali del Piemonte (PAT), tra cui:<br />
Maccagno, Montebore, Ossolano, Bettelmatt, Toma Biellese, Toma della Val<br />
Sesia, Cevrin di Coazze, Seirass del Fen, Toma di Lanzo, Tomino di Melle,<br />
Robiola d’Alba, Robiola di Cocconato, ecc.<br />
9 i formaggi piemontesi DOP (Denominazione d’Origine Protetta) su 46 DOP<br />
nazionali, di cui 6 esclusivamente piemontesi (Bra, Castelmagno, Murazzano,<br />
Raschera, Robiola di Roccaverano, Toma piemontese), le altre 3 (Gorgonzola,<br />
Grana Padano, Taleggio), divise con altre regioni. Tra i formaggi piemontesi in<br />
fase di istruttoria per il riconoscimento DOP, c’è il formaggio Ossolano.<br />
Agricoltura <strong>81</strong><br />
21
Raccontare per immagini<br />
che cosa fa il PSR per noi<br />
Valentina Archimede - Settore Programmazione e valorizzazione del sistema agroalimentare<br />
Le immagini in movimento riescono a restituire con concretezza<br />
e immediatezza una situazione, un ambiente, i cambiamenti<br />
stagionali, il lavoro delle persone, i processi che stanno dietro ai<br />
prodotti. Abbiamo scelto le immagini in movimento montate in<br />
brevi filmati per raccontare quello che si è fatto con il Programma<br />
di sviluppo rurale nell’ambito dell’agricoltura piemontese.<br />
Il piano di comunicazione a supporto del PSR 2007-<strong>2013</strong> si è sviluppato<br />
nel corso degli ultimi anni descrivendo obiettivi, finalità e<br />
azioni cardine del Programma. Giunti a fine programmazione, ci<br />
sembrava opportuno parlare di risultati, di cose fatte e non solo di<br />
obiettivi e strategie. Per questa ragione i video realizzati scelgono<br />
volutamente esempi reali e concreti, prodotti o interventi che, al<br />
di là del caso singolo, possano rappresentare un esempio di quello<br />
che in campo agricolo si può realizzare o migliorare anche grazie<br />
al sostegno dei fondi comunitari.<br />
Abbiamo cercato inoltre di raccontare storie, di intervistare il più<br />
possibile i protagonisti e gli agricoltori in prima persona, andandoli<br />
a riprendere nel loro ambiente e durante il loro lavoro. Non<br />
tutti i passaggi saranno perfettamente istituzionali, ognuno parla<br />
a suo modo con la sua inflessione, ma è un linguaggio che tutti<br />
possono capire e che racconta l’esperienza vera.<br />
I video di questa serie sono infatti dedicati al pubblico che non<br />
conosce l’agricoltura, che in gran parte vive in città e spesso non<br />
coglie la differenza tra un prodotto del suo territorio e uno standardizzato<br />
sullo scaffale del supermercato. Uno degli obiettivi che<br />
l’Unione Europea indica con forza alle Regioni nelle iniziative di<br />
comunicazione che riguardano i propri programmi è l’informazione<br />
nei confronti del grande pubblico, non solo a scopo di educazione<br />
alimentare e ambientale, ma anche per spiegare come vengono<br />
utilizzati i cospicui finanziamenti che il bilancio comunitario<br />
riserva all’agricoltura dei Paesi membri. E’ un comparto che assorbe<br />
circa il 40% delle risorse comunitarie, un tempo sotto forma<br />
di sovvenzione e sostegno, ora sempre più in chiave di sviluppo<br />
e spinta verso il rafforzamento della competitività delle aziende.<br />
Le ragioni di questo si rintracciano proprio in quello che abbiamo<br />
cercato di mostrare attraverso i video PSR: l’agricoltura fornisce<br />
l’alimentazione per tutti noi, gestisce e salvaguarda il territorio e<br />
le risorse naturali, può avere un ruolo determinante nel mantenere<br />
l’equilibrio naturale dell’ecosistema e della nostra salute.<br />
In linea con questo taglio e questi destinatari, i video saranno fruibili<br />
prevalentemente online, attraverso il sito istituzionale Regione<br />
Piemonte, i canali youtube, facebook e twitter, con la speranza e<br />
la consapevolezza di poter raggiungere un pubblico nuovo, che<br />
non conosce il nostro settore.<br />
22 Agricoltura <strong>81</strong>
QUESTI I TEMI DEI VIDEO REALIZZATI NEL CORSO DEL <strong>2013</strong><br />
E DIFFUSI ATTRAVERSO LA RETE:<br />
Discovering Leader<br />
Una serie articolata, composta di sette segmenti video, oltre a<br />
una sigla iniziale animata che fornisce alcuni “numeri” del progetto<br />
e un quadro di che cos’è l’esperienza Leader, dedicata alle<br />
aree montane e collinari del Piemonte. Leader è di fatto un programma<br />
dentro il Programma di sviluppo rurale, dalla struttura<br />
complessa, che tocca molti ambiti di intervento, non solo strettamente<br />
agricoli ma che spaziano dalle infrastrutture all’animazione<br />
culturale, dal sostegno alle filiere al paesaggio.<br />
La serie di video Discovering Leader mira a restituire questa<br />
complessità, raccontando le esperienze di diversi GAL (i Gruppi<br />
di Azione locale, partenariati pubblico-privati che gestiscono<br />
gli interventi sui territori) nei diversi settori. La scelta è stata<br />
fatta con l’obiettivo di rappresentare geograficamente aree<br />
differenti della regione e di dare spazio agli esempi più interessanti<br />
per ogni tipologia di progetto, ma sempre con taglio<br />
esemplificativo generale.<br />
Produttori in rete racconta l’esperienza del GAL Giarolo nell’alessandrino,<br />
che ha sostenuto l’attività di un birrificio artigianale<br />
che utilizza prodotti del territorio (in particolare la ciliegia e altri<br />
frutti) per rafforzare la filiera e produrre birre aromatizzate. La<br />
birra stessa, in un circolo virtuoso, è essa stessa alla base della<br />
lavorazione di salumifici e pasticcerie.<br />
Filiere produttive, girato nel monregalese sull’esperienza del<br />
GAL Mongioie, segue in tutte le sue fasi la filiera della carne,<br />
dall’allevamento, alla macellazione, al confezionamento, fino<br />
alle consegne ad agriturismi locali e a gruppi di acquisto cittadini.<br />
Più imprese di piccole dimensioni si sono aggregate per<br />
rendere possibile l’intero processo a filiera corta.<br />
Architettura e paesaggio mostra gli splendidi ambienti di Langhe<br />
e Roero, candidati al riconoscimento Unesco, illustrando<br />
come attraverso Leader si siano costruiti manuali del paesaggio<br />
che, oltre alla tutela del patrimonio esistente, forniscono linee guida<br />
su come intervenire nella ristrutturazione di edifici e strutture.<br />
Servizi alla popolazione ci porta nelle Valli Gesso Vermenagna<br />
Pesio per raccontare un’esperienza di animazione sociale e culturale<br />
svolta con ragazzi che lavorano sulla musica popolare del<br />
luogo e sull’integrazione.<br />
Con Servizi alle imprese andiamo in Valle di Lanzo dove sono<br />
sorti agriturismi e strutture ricettive grazie al GAL e ai progetti della<br />
Provincia che sostengono le piccole aziende nel mettersi in proprio.<br />
Turismo rurale, girato in Valsesia, mostra i percorsi di trekking<br />
nel suggestivo ambiente montano della valle, dove italiani e stranieri<br />
apprezzano le strutture e le proposte turistiche di abitazioni<br />
tradizionali riadattate.<br />
Il Turismo rurale è anche protagonista nel Basso Monferrato<br />
Astigiano, che dimostra come una realtà tradizionalmente meno<br />
organizzata per accogliere turisti può proporre opportunità di<br />
grande interesse per conoscere il mondo delle nostre colline.<br />
Agricoltura <strong>81</strong><br />
23
Glocal Challenges<br />
Le grandi sfide ambientali promosse dall’Unione<br />
Europea attraverso il PSR vengono<br />
sintetizzate attraverso i quattro elementi<br />
fondamentali Terra Aria Acqua Fuoco.<br />
Cartelli introduttivi fotografano l’attuale situazione<br />
ambientale in Italia e in Europa in tema di emissioni, consumo<br />
idrico, consumo di suolo, bilancio energetico e indicano gli<br />
obiettivi su cui il PSR ha cercato di lavorare soprattutto negli ultimi<br />
anni di programmazione.<br />
Terra racconta la corretta gestione del suolo, attraverso l’esempio<br />
dei pascoli, spiegando come si può preservare l’ecosistema<br />
attraverso pratiche agronomiche corrette.<br />
Aria parla di emissioni e di come, a titolo di esempio, un’azienda<br />
zootecnica possa sfruttare l’energia prodotta da liquame e<br />
letame dei propri animali, riducendo l’impatto sull’atmosfera e<br />
sull’ambiente.<br />
Acqua illustra il risparmio idrico: anche il mais, tradizionalmente<br />
una delle colture a più forte dispendio di acqua, può introdurre<br />
la subirrigazione, mirata e sostenibile nei costi.<br />
Fuoco mostra i pannelli solari e il loro possibile uso per produrre<br />
energia in un’azienda frutticola, che compie anche esperimenti<br />
intressanti di risparmio idrico.<br />
Accompagnati dal giornalista Luca Iaccarino che, con aria scanzonata,<br />
ha visitato i produttori e girato il Piemonte da Vercelli<br />
alla Langa, andiamo a scoprire come si produce il Castelmagno<br />
(re dei formaggi DOP piemontesi), che cosa significa fare sistema<br />
per far conoscere i vini DOC e DOCG della nostra regione al<br />
mondo intero, qual è la filosofia del riso biologico, che mantiene<br />
le proprietà nutritive ed elimina le sostanze chimiche.<br />
Il cibo non è solo alimentazione ma salute e qualità.<br />
Backstage PSR<br />
L’ambizione è quella di raccontare il “dietro le quinte” del Programma<br />
di sviluppo rurale: come funziona la “macchina”, che<br />
spesso agricoltori e cittadini non conoscono e che, pur complessa<br />
e ricca di passaggi burocratici, garantisce il funzionamento di una<br />
procedura estremamente articolata. Vorremmo raccontare la burocrazia<br />
anche per i suoi aspetti positivi, di garanzia nei confronti<br />
di tutti gli utenti e di standardizzazione delle procedure. Dietro un<br />
Programma come il PSR ci sono molti enti, un sistema di monitoraggio<br />
e valutazione, un sistema informativo, un sistema dei pagamenti,<br />
e molte regole fissate innanzitutto dall’Unione Europea.<br />
Per raccontare tutto questo, sperando di non essere noiosi, abbiamo<br />
adottato un fumetto e qualche metafora, abbiamo intervistato<br />
i colleghi al lavoro e parlato attraverso la voce di un’imprenditrice<br />
agricola.<br />
Quality<br />
Il PSR al servizio dei prodotti di qualità e delle certificazioni DOP,<br />
IGP, DOC, DOCG, biologico, i marchi di livello comunitario che<br />
hanno permesso ai nostri prodotti di diventare conosciuti in tutto<br />
il mondo per le loro eccellenze. Marchi e certificazioni che<br />
non sono solo disegnati sulla carta o sulle confezioni, ma che<br />
portano con sé fatiche e incertezze del lavoro, forti investimenti<br />
iniziali e la ricchezza dei saperi tradizionali.<br />
Sceneggiatura, riprese e produzione sono state affidate a Fulvio<br />
Montano e Mattia Plazio (Azul Film), che hanno lavorato per mesi alla<br />
preparazione delle sceneggiature, all’approfondimento dei temi PSR,<br />
e poi hanno girato il Piemonte per settimane per i sopralluoghi e le<br />
riprese, curando infine montaggio e postproduzione.<br />
24 Agricoltura <strong>81</strong>
Focus 6° Censimento dell’agricoltura:<br />
i canali di commercializzazione<br />
dei prodotti di origine vegetale<br />
Mario Perosino - Direzione Agricoltura. Responsabile dell’Ufficio regionale di censimento<br />
Lorena Cora - Csi Piemonte<br />
Le strategie di commercializzazione dei prodotti sono uno dei principali<br />
fattori di successo dell’impresa. Per questo motivo i censimenti<br />
generali dell’agricoltura prevedono la rilevazione dei canali di commercializzazione<br />
dei prodotti aziendali. Il 6° censimento, in particolare,<br />
ha rilevato non soltanto i tipi di canali utilizzati dall’azienda per la<br />
commercializzazione dei principali gruppi di prodotti agricoli – come<br />
avveniva nei censimenti precedenti - ma anche il loro peso. Sulla base<br />
di tali informazioni è dunque possibile ricostruire i percorsi di commercializzazione<br />
seguiti dai principali prodotti agricoli delle aziende<br />
piemontesi. Nel presente articolo saranno presi in considerazione i<br />
canali di commercializzazione dei principali prodotti di origine vegetale:<br />
i cereali (distintamente per riso, mais e altri cereali), la frutta<br />
fresca e l’uva da vino, sia trasformata in azienda che venduta come<br />
tale (vedere la nota metodologica).<br />
Innanzitutto una considerazione generale sul numero di canali<br />
utilizzati dalle aziende agricole piemontesi per commercializzare<br />
i prodotti vegetali presi in esame: delle 67 mila aziende agricole<br />
rilevate in Piemonte, 45 mila hanno dichiarato di aver commercializzato<br />
almeno uno fra i prodotti vegetali sopra elencati. Di<br />
queste ultime, oltre i ¾ hanno utilizzato un solo canale di commercializzazione,<br />
il 20% ne ha utilizzati due e il 3% tre. Soltanto<br />
130 aziende (tre su mille) hanno utilizzato più di tre canali. Tendenzialmente,<br />
più le aziende sono grandi, maggiore è il numero<br />
di canali utilizzati.<br />
Nota metodologica<br />
Attraverso il questionario del 6° censimento dell’agricoltura è stata rilevata<br />
l’importanza (in termini percentuali) dei seguenti canali di commercializzazione<br />
distintamente per i principali gruppi di prodotti agricoli:<br />
• vendita diretta al consumatore (sia in azienda che fuori azienda, ad<br />
es. nei mercati rionali);<br />
• vendita ad altre aziende agricole;<br />
• vendita a imprese industriali;<br />
• vendita a imprese commerciali;<br />
• vendita o conferimento a organismi associativi (ad es. cooperative<br />
e loro consorzi).<br />
I volumi commercializzati attraverso i diversi canali sono stati stimati,<br />
per ciascuna azienda agricola e per ogni prodotto preso in considerazione,<br />
moltiplicando le superfici delle coltivazioni dichiarate al censimento<br />
per le rese produttive pubblicate dall’Istat. Nel caso dell’uva da<br />
vino, invece, è stato possibile utilizzare il dato della produzione raccolta<br />
rilevato direttamente con il questionario del censimento. I volumi<br />
di commercializzazione così ottenuti sono risultati sostanzialmente<br />
coerenti con i risultati delle statistiche Istat sulle produzioni vegetali.<br />
Per gli aspetti generali del censimento si rimanda agli articoli dal titolo<br />
6° Censimento generale dell’agricoltura pubblicati sui numeri 74<br />
(settembre 2011) e 78 (settembre 2012) di Agricoltura - Quaderni<br />
della Regione Piemonte. Anche i numeri 75, 76, 77 e 80 della rivista<br />
hanno ospitato articoli su temi particolari legati al censimento.<br />
Informazioni più ampie sui censimenti dell’agricoltura sono reperibili<br />
nel sito web della Regione Piemonte (http://www.regione.piemonte.<br />
it/agri/area_statistica/6censimento/index.htm).<br />
Agricoltura <strong>81</strong><br />
25
I cereali<br />
In Piemonte, i canali di commercializzazione<br />
più importanti per i cereali nel complesso<br />
sono le imprese commerciali (alle quali<br />
le aziende cerealicole hanno venduto il<br />
38% della produzione) e quelle industriali<br />
(37%). Seguono gli organismi associativi (19%) e le aziende<br />
agricole (6%); la vendita diretta da parte del produttore è del<br />
tutto marginale (1%). A livello provinciale si registrano sensibili<br />
differenziazioni, prevalentemente a causa dell’importanza<br />
assunta dai diversi cereali in ciascuna provincia. Se le Province<br />
di Vercelli, Torino, Cuneo e Alessandria, infatti, presentano un<br />
peso grosso modo equivalente nella commercializzazione di<br />
cereali nel complesso, ciò deriva dalla compensazione di caratterizzazioni<br />
territoriali spiccate: a Vercelli è preponderante<br />
il riso (62% della produzione commercializzata regionale), a<br />
Torino e Cuneo il mais (37% e 29% rispettivamente) e ad Alessandria<br />
il frumento tenero (41% del totale regionale).<br />
La vendita alle imprese industriali è il canale prevalente per<br />
quando riguarda il riso (<strong>81</strong>% del totale); seguono le imprese<br />
commerciali e gli organismi associativi (entrambi al 9%). Il peso<br />
dei diversi canali di commercializzazione varia a seconda della<br />
provincia di produzione. A Vercelli, che come anticipato è la provincia<br />
più importante dal punta di vista produttivo, la vendita a<br />
imprese industriali riguarda l’85% dei volumi commercializzati.<br />
A Novara e ad Alessandria, che rappresentano rispettivamente<br />
il 29% e il 7% della produzione commercializzata regionale,<br />
questo canale ha incidenze minori, per quanto sempre elevate<br />
(rispettivamente 78% e 63%) e assumono una certa importanza<br />
la vendita a imprese commerciali (rispettivamente 16% e 17%)<br />
e il conferimento a organismi associativi (19% ad Alessandria).<br />
Figura 1. Mais commercializzato dalle aziende agricole secondo i principali<br />
canali di commercializzazione per classi di produzione aziendale<br />
di mais. Valori assoluti (grafico in alto) e distribuzione percentuale (grafico<br />
in basso).<br />
Figura 2. Cereali diversi da riso e mais (“altri cereali”) commercializzati<br />
dalle aziende agricole secondo i principali canali di commercializzazione<br />
per classi di produzione aziendale di altri cereali. Valori assoluti (grafico<br />
in alto) e distribuzione percentuale (grafico in basso).<br />
26 Agricoltura <strong>81</strong>
Il mais è venduto principalmente a imprese commerciali (53%<br />
della produzione maidicola totale) e secondariamente a organismi<br />
associativi (22%, con punte del 30% in Provincia di Torino) e a<br />
imprese industriali (14%), ma anche la vendita ad altre aziende<br />
agricole assume una certa importanza (9% nel complesso e 16%<br />
in Provincia di Cuneo). Il peso dei diversi canali di commercializzazione<br />
cambia al variare dei quantitativi aziendali di mais commercializzato<br />
(figura 1). Premesso che la distribuzione dei volumi<br />
commercializzati in funzione dei quantitativi venduti a livello<br />
aziendale è sostanzialmente omogenea (con un valore minimo<br />
del 20% in corrispondenza della classe “da 500 a 1.000 quintali”<br />
e massimo del 32% per la classe “2.000 quintali e oltre”), il peso<br />
dei canali più importanti dal punto di vista quantitativo (vendita a<br />
imprese commerciali e conferimento a organismi associativi) risulta<br />
in linea di massima indipendente dai quantitativi commercializzati.<br />
La vendita a imprese industriali, invece, cresce di importanza<br />
con l’aumentare dei quantitativi commercializzati e, all’opposto, il<br />
peso della vendita diretta o ad altre aziende agricole diminuisce<br />
con l’aumento dei quantitativi commercializzati.<br />
Anche gli altri cereali (rappresentati in Piemonte prevalentemente<br />
dal frumento tenero 1 ) sono venduti principalmente<br />
a imprese commerciali (53% della produzione commercializzata<br />
regionale) e a organismi associativi (28%). La provincia<br />
più importante è Alessandria, con il 42% della produzione<br />
commercializzata regionale, seguita da Cuneo (22%), Torino<br />
(21%) e Asti (10%). A differenza del mais, nel caso degli<br />
altri cereali sono le aziende più piccole (in termini di produzione<br />
venduta) a rappresentare la parte maggiore dei volumi<br />
commercializzati, con il 43% del totale (figura 2). Anche nel<br />
caso degli altri cereali, però, i canali più importanti lo sono<br />
per tutte le classi dimensionali e la dinamica degli altri canali<br />
(vendita diretta e vendita ad altre aziende agricole) è la stessa<br />
già descritta per il mais.<br />
La frutta fresca<br />
La frutta fresca in Piemonte è prodotta e commercializzata prevalentemente<br />
da aziende situate in Provincia di Cuneo (quasi<br />
l’80% dei volumi commercializzati) 2 . Segue la Provincia di Torino<br />
con l’11% e quella di Alessandria con il 4%. Il canale di<br />
commercializzazione più importante in termini quantitativi è la<br />
vendita a imprese commerciali, che rappresenta oltre la metà dei<br />
volumi commercializzati. Segue il conferimento a organismi associativi<br />
(29%) e la vendita diretta da parte delle aziende agricole<br />
(11%). La produzione commercializzata proviene per oltre la<br />
metà da aziende con almeno 10 ettari a coltivazioni frutticole, le<br />
quali rappresentano meno del 7% delle aziende che commercializzano<br />
frutta fresca. L’importanza dei diversi canali di commercializzazione<br />
varia in funzione delle dimensioni aziendali espresse<br />
in termini di superficie a coltivazioni frutticole (figura 3). Il<br />
conferimento a organismi associativi vede crescere il suo peso<br />
con l’aumento delle dimensioni aziendali, mentre una dinamica<br />
opposta caratterizza il canale della vendita diretta, sia in azienda<br />
che fuori azienda. Infine, la vendita a imprese commerciali (il<br />
canale più importante per tutte le classi dimensionali) mantiene<br />
un peso sostanzialmente costante nelle diverse classi.<br />
Figura 3. Frutta fresca commercializzata dalle aziende agricole secondo<br />
i principali canali di commercializzazione per classi di superficie<br />
aziendale a coltivazioni frutticole (frutta fresca). Valori assoluti (grafico<br />
in alto) e distribuzione percentuale (grafico in basso).<br />
L’uva e il vino<br />
Delle circa 20 mila aziende produttrici di uva da vino rilevate in<br />
Piemonte al 6° censimento dell’agricoltura, quasi 6 mila (pari al<br />
29% del totale) hanno dichiarato di non aver commercializzato<br />
uva (che dunque hanno autoconsumato come tale o trasformata<br />
in vino). L’uva prodotta dalle aziende restanti è stata venduta<br />
o conferita interamente come tale da 11 mila aziende (il 54%<br />
del totale) o interamente vinificata da 2 mila aziende (11% del<br />
totale). Le 1.300 aziende restanti (pari al 6% del totale) in parte<br />
hanno venduto l’uva come tale e in parte l’hanno vinificata.<br />
L’uva non autoconsumata è stata per ¾ commercializzata come<br />
tale e per il quarto restante vinificata direttamente dalle aziende.<br />
Agricoltura <strong>81</strong><br />
27
L’uva non trasformata proviene principalmente<br />
dalle aziende viticole della Provincia<br />
di Asti (39% dei volumi complessivi), seguite<br />
da quelle ricadenti nelle Province di Cuneo<br />
(33%) e Alessandria (26%). Le restanti province<br />
hanno un peso marginale (2%). Nel<br />
caso dell’uva vinificata direttamente dalle aziende agricole, i volumi<br />
più importanti sono relativi alla Provincia di Cuneo (43%),<br />
mentre Asti e Alessandria hanno all’incirca lo stesso peso (rispettivamente<br />
27% e 25%) e le restanti province raggiungono il 4%.<br />
Il conferimento a organismi associativi è il principale canale di<br />
commercializzazione dell’uva non trasformata in azienda<br />
(esso rappresenta il 43% del totale, che sale al 65% in Provincia<br />
di Alessandria; per le aziende della Provincia di Asti questo canale<br />
rappresenta il 41% del totale e per quelle della Provincia di<br />
Cuneo soltanto il 26%). La vendita a imprese commerciali pesa<br />
per il 23% in Piemonte nel complesso ma il 38% in Provincia<br />
di Cuneo, il 16% ad Asti e il 13% ad Alessandria. La vendita a<br />
imprese industriali è il terzo canale per importanza (22% per il<br />
Piemonte nel complesso, ma il 31% ad Asti, il 20% a Cuneo e<br />
il 14% ad Alessandria). I restanti canali di commercializzazione<br />
dell’uva sono assai meno importanti: 6% sia per la vendita ad<br />
altre aziende agricole (ma l’11% a Cuneo) che per la vendita<br />
diretta (di cui 4% in azienda e 2% fuori azienda).<br />
Oltre che in funzione delle localizzazione geografica, il peso relativo<br />
dei diversi canali di commercializzazione varia anche a seconda<br />
delle dimensioni aziendali. Ad esempio, l’importanza del<br />
conferimento a organismi associativi diminuisce al crescere della<br />
superficie aziendale a vite: è massima nelle aziende con meno<br />
di un ettaro a vite (per le quali rappresenta il 50% sul totale dei<br />
canali) e minima nelle aziende con 10 ettari a vite e oltre (per le<br />
quali rappresenta comunque il 36% del totale). Stessa dinamica<br />
presentano i canali di vendita diretta o ad altre aziende agricole,<br />
mentre il peso della vendita a imprese commerciali o industriali<br />
cresce con l’aumentare della superficie vitata aziendale.<br />
Per quanto riguarda, infine, la vendita dell’uva trasformata in<br />
vino direttamente dalle aziende agricole, il principale canale di<br />
commercializzazione è rappresentato dalla vendita a imprese<br />
commerciali (40% del totale in Piemonte e oltre il 50% in Provincia<br />
di Cuneo), seguito dalla vendita diretta in azienda (27%)<br />
e fuori azienda (25%, ma 38% in Provincia di Asti). Dunque la<br />
vendita diretta di vino da parte delle aziende agricole rappresenta<br />
il primo canale per ordine di importanza se si sommano<br />
le due modalità della vendita diretta in azienda e fuori azienda.<br />
Anche nel caso del vino, il peso relativo dei diversi canali di commercializzazione<br />
dipende dalle dimensioni aziendali. La vendita<br />
diretta è il canale preponderante per le piccole aziende, mentre<br />
l’incidenza della vendita a imprese commerciali è direttamente<br />
proporzionale alla dimensione aziendale (il peso relativo di questo<br />
canale sale dall’8% nel caso delle piccole aziende al 49% per<br />
le aziende più grandi), come illustrato in figura 4, dalla quale si<br />
evince inoltre che la produzione enologica è concentrata nelle<br />
aziende più grandi. Da queste ultime, che rappresentano soltanto<br />
il 15% del totale delle aziende agricole che trasformano le<br />
proprie uve, deriva infatti la metà del vino prodotto in Piemonte<br />
dalle aziende agricole.<br />
Figura 4. Vino commercializzato dalle aziende agricole secondo i principali<br />
canali di commercializzazione per classi di superficie aziendale a<br />
vite per uva da vino. Valori assoluti (grafico in alto) e distribuzione percentuale<br />
(grafico in basso).<br />
1. Il frumento tenero rappresenta il 79% della produzione piemontese di cereali diversi da riso e mais. Gli altri<br />
cereali sono, per ordine di importanza della produzione, l’orzo (14,4% del totale dei cerali diversi da riso e<br />
mais), il frumento duro (3,0%) e il sorgo (1,4%). I restanti cereali (segale, avena, farro, grano saraceno, miglio,<br />
panico ecc.) rappresentano nel complesso il 2,3% della produzione piemontese di cereali diversi da riso e mais.<br />
2. Le coltivazioni di frutta fresca prese in considerazione sono (per quota della superficie piemontese<br />
in produzione): actinidia (29%), melo (24%), pesco (16%), nettarina (13%), susino (6%), pero (6%),<br />
albicocco (4%) e ciliegio (2%).<br />
28 Agricoltura <strong>81</strong>
documenti<br />
L’agricoltura piemontese<br />
congiuntura e tendenze di medio periodo<br />
Stefano Aimone, Marco Adamo, Stefano Cavaletto - Ires Piemonte – Progetto PROSPERA<br />
La pubblicazione da parte dell’Istat dei dati di dettaglio sulle performance<br />
economiche dell’agricoltura a scala regionale avviene<br />
generalmente a metà dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono<br />
tali cifre. Sebbene queste preziose informazioni arrivino<br />
quando la nuova campagna è già entrata nel vivo, può comunque<br />
essere utile presentare informazioni complete sulla stagione<br />
agricola già conclusa, cogliendo l’occasione per proporre alcune<br />
riflessioni su importanti fenomeni di medio periodo.<br />
Il quadro generale<br />
Il 2012 per l’agricoltura europea è stata un’annata interlocutoria.<br />
Il valore della produzione agricola in termini reali è cresciuto<br />
dell’1,8%, con un aumento più consistente nel comparto zootecnico<br />
(+3,8%) e uno più attenuato per le coltivazioni (+0,5%).<br />
Il reddito agricolo pro-capite è anch’esso sostanzialmente stazionario<br />
(+1,0%) mentre nel periodo 2005-2012 tale indicatore<br />
ha segnato un incremento del 29,7% a fronte di un calo del<br />
numero di addetti pari al 20%.<br />
A livello nazionale la leggera ripresa registrata nel 2011 si è arrestata.<br />
Il valore aggiunto dell’agricoltura a valori correnti nel 2012<br />
è stato sostanzialmente stabile (+0,8%): Tuttavia, osservando<br />
tale indicatore espresso in valori concatenati, quindi in pratica<br />
“sterilizzando” l’effetto legato all’aumento dei prezzi, emerge<br />
una contrazione del 4,4% in valori concatenati. La scorsa annata<br />
ha dovuto far fronte anche a numerose emergenze climatiche<br />
e ad una diminuzione della redditività delle aziende causata<br />
dall’aumento dei costi produttivi (+2,8%) superiore a quello dei<br />
prezzi all’origine (+2,1%.).<br />
Secondo le stime del Centro Studi Federalimentare, nell’anno<br />
appena concluso il fatturato dell’industria alimentare italiana<br />
ha raggiunto i 130 miliardi di euro, con un aumento del +2,3%<br />
sul 2011 legato esclusivamente all’effetto prezzi. La produzione<br />
in termini quantitativi, infatti, è calata (-1,4%) sull’anno<br />
precedente. La crisi dei consumi interni ha colpito il settore<br />
in modo più pesante rispetto alla media del paese: i consumi<br />
alimentari, infatti, hanno registrato una flessione del 3%, un<br />
Agricoltura <strong>81</strong><br />
29
documenti<br />
caseario e alla zootecnia bovina da carne. Sono cresciuti anche i<br />
prezzi dei mezzi di produzione, proseguendo un trend iniziato a<br />
metà del 2010. In particolare si osserva un incremento del costo<br />
di concimi, mangimi e prodotti energetici. In generale, si conferma<br />
la tendenza verso una spiccata volatilità dei prezzi agricoli e<br />
il costante incremento del costo dei fattori, meccanismo che nel<br />
tempo tende a tradursi, come mostrato più avanti, in un uno<br />
svantaggio generale per il comparto primario.<br />
Figura 1: Indice dei prezzi agricoli alla produzione tra il 2009 e il<br />
2012 (indice con base 2005 = 100). Fonte: Ismea<br />
segnale preoccupante della difficoltà economica delle famiglie.<br />
Migliori le notizie sul fronte dell’export con una crescita per<br />
l’agroalimentare del 5,4% a fronte di una lieve diminuzione<br />
delle importazioni (-2,4%).<br />
L’andamento dei prezzi agricoli nel 2012 ha avuto una ripresa<br />
durante l’estate e negli ultimi mesi dell’anno (fig. 1), in particolare<br />
per quanto riguarda le coltivazioni, mentre il settore zootecnico<br />
si è mantenuto sostanzialmente stabile. Tra le coltivazioni si<br />
segnala un’ulteriore impennata dei prezzi dei cereali a partire da<br />
aprile con valori elevati fino alla fine dell’anno. Tra i settori della<br />
zootecnia sono rimasti invariati gli indici relativi al settore lattiero<br />
Il Piemonte<br />
Nella nostra regione l’annata 2012, dal punto di vista climatico,<br />
è stata inizialmente segnata da una gelata straordinaria a cavallo<br />
tra gennaio e febbraio che ha causato danni soprattutto<br />
alle coltivazioni permanenti in pianura. Nel complesso, tuttavia,<br />
l’annata è stata mediamente calda con una primavera fresca e<br />
piovosa ed un’estate molto calda e asciutta. Diversi fenomeni<br />
siccitosi si sono osservati nel mese di agosto e le riserve idriche<br />
dei mesi precedenti si sono rivelate insufficienti soprattutto nelle<br />
province meridionali.<br />
La distribuzione delle superfici ha visto una lieve diminuzione dei<br />
cereali (-1%) tra i quali cresce solo il frumento tenero (+4,1%)<br />
mentre arretra pesantemente l’orzo. Il mais ha visto incrementare<br />
i volumi produttivi del 5,5%, in controtendenza rispetto ai<br />
dati nazionali su cui hanno pesato maggiormente alcuni fenomeni<br />
siccitosi e la diffusione della diabrotica .<br />
Il riso ha leggermente diminuito la propria produzione ma in<br />
misura minore rispetto ad altre regioni. I prezzi del risone dopo<br />
30 Agricoltura <strong>81</strong>
documenti<br />
Figura 2: Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell’agricoltura<br />
in Piemonte dal 2005 al 2012 (valori a prezzi correnti; dati in<br />
migliaia di Euro). Fonte: elaborazione Ires Piemonte su dati Istat.<br />
una serie di annate su buoni livelli hanno iniziato una discesa<br />
negli ultimi mesi del 2011 raggiungendo quotazioni molto basse<br />
nel primo trimestre 2012. L’attenzione ora è rivolta soprattutto<br />
ai cambiamenti nella distribuzione degli aiuti comunitari, di cui il<br />
riso è storicamente un grosso percettore.<br />
L’annata vitivinicola si segnala per un’ottima vendemmia favorita<br />
dal caldo di fine estate. Meno buone le notizie sul fronte della<br />
produttività a causa della prolungata siccità estiva. L’andamento<br />
dell’export, fondamentale per il comparto, ha mostrato una<br />
sostanziale tenuta.<br />
Il settore ortofrutticolo è probabilmente quello che maggiormente<br />
ha sofferto le estreme condizioni meteorologiche del mese di<br />
febbraio. In molte zone di pianura le gelate hanno letteralmente<br />
dimezzato la produzione. Oltre a questi imprevisti l’annata si è<br />
contraddistinta anche per i problemi causati dalla batteriosi del<br />
kiwi che per il secondo anno ha colpito duramente le nostre<br />
coltivazioni e costretto molti frutticoltori all’estirpazione.<br />
Nel settore della zootecnia si registra un calo degli allevamenti<br />
bovini (-3,9%) nel solco del processo di concentrazione delle<br />
aziende ormai avviato da oltre un decennio. Nel 2012 si è assistito,<br />
inoltre, ad una sensibile riduzione dei capi (-3,1%) ascrivibile<br />
in misura maggiore alle razze da carne. In regione è ormai maggioritario<br />
l’allevamento della razza Piemontese (41% dei capi<br />
totali ma circa il 60% tra le razze da carne). La salita repentina<br />
dei prezzi di alcune materie prime insieme alla stagnazione dei<br />
prezzi all’origine hanno frenato la ristrutturazione in atto nella<br />
filiera e accresciuto la preoccupazione anche in vista del riassetto<br />
della PAC con possibili ripercussioni sul settore.<br />
Dopo una serie di annate positive il settore lattiero-caseario regionale<br />
ha vissuto un 2012 difficile, con forti tensioni contrattuali<br />
tra gli attori della filiera a causa degli andamenti contrastanti<br />
dei prezzi delle materie prime (in notevole aumento) e del<br />
prezzo del latte sui mercati internazionali (in calo). Il processo di<br />
concentrazione aziendale è proseguito anche nel 2012 con una<br />
diminuzione del 2,9% del numero di aziende e un aumento del<br />
4,1% della produzione commercializzata salendo così ad una<br />
produzione media aziendale di 371,6 tonnellate annue. Questo<br />
aumento ha, di fatto, portato la produzione regionale oltre la<br />
quota produttiva prevista del 2,6%.<br />
Per il settore suinicolo si segnala un andamento positivo dei<br />
prezzi dopo numerose annate commercialmente difficili. Nel<br />
settore avicolo le cifre sul numero di allevamenti evidenziano<br />
la relativa tenuta della sottofiliera delle uova nonostante i costi<br />
di adeguamento alle nuove norme comunitarie sul benessere<br />
animale. Tale tenuta è stata poi premiata da un aumento generalizzato<br />
delle quotazioni. Gli allevamenti di polli da carne<br />
sono, invece, cresciuti (+1,7%) così come il numero di capi<br />
macellati (+3,9%).<br />
Per quanto concerne i risultati economici complessivi, i dati forniti<br />
dall’Istat mettono in evidenza nel 2012 un incremento del<br />
valore della produzione agricola piemontese del 4% rispetto<br />
all’anno precedente, espresso in termini correnti (figura 2).<br />
L’incremento è in gran parte dovuto alla crescita dei prezzi<br />
agricoli. Purtroppo l’impennata dei costi intermedi è stata ancora<br />
più intensa (+5,6%), comprimendo l’aumento del valore<br />
aggiunto entro il 2%; il dato del Piemonte risulta comunque<br />
migliore rispetto a quello nazionale (+ 0,8% sempre a prezzi<br />
correnti). Includendo nel campo di osservazione gli anni a<br />
partire dal 2005, l’andamento dei costi e il suo effetto depressivo<br />
sul valore aggiunto si conferma un elemento di costante<br />
preoccupazione.<br />
Fortunatamente, la bilancia commerciale aggregata del settore<br />
agroalimentare piemontese conferma anche nel 2012<br />
il suo storico saldo positivo e segna un incremento delle<br />
esportazioni (+5,6%).<br />
i<br />
Per approfondimenti è possibile consultare il sito internet<br />
dedicato al rapporto annuale Piemonte Economico Sociale 2012<br />
recentemente presentato dall’IRES Piemonte:<br />
http://www.regiotrend.piemonte.it.<br />
Altre informazioni sull’agricoltura e lo sviluppo rurale in Piemonte<br />
sono disponibili sul sito del progetto PROSPERA: http://www.<br />
irespiemonte.it/prospera<br />
Agricoltura <strong>81</strong><br />
31
documenti<br />
Figura 4:<br />
Infezione di Psa da lenticelle<br />
La batteriosi dell’actinidia<br />
strategie di contenimento in Piemonte<br />
Matteo Monchiero - Agroinnova<br />
Luca Giordani, Luca Nari, Graziano Vittone - CReSO<br />
Chiara Morone, Silvio Grosso, Giovanna Mason, Elena Ortalda - Settore Fitosanitario Regione Piemonte<br />
La batteriosi causata da Pseudomonas syringae pv. actinidiae<br />
(PSA) provoca, su diverse specie di actinidia (Actinidia deliciosa,<br />
A. chinensis e A. arguta), cancri sul tronco e sui rami che producono<br />
un essudato di colore variabile, maculature fogliari angolari<br />
di colore marrone scuro circondate da un alone clorotico e imbrunimento<br />
e cascola dei fiori (Scortichini, 1994).<br />
Attitudine prevalente di Psa<br />
La diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae sta compromettendo<br />
la coltivazione di kiwi nelle più importanti aree di<br />
produzione, rendendone problematica la coltivazione. Il Piemonte,<br />
in qualità di regione italiana più fredda tra quelle in cui si<br />
coltiva l’actinidia, risulta ulteriormente danneggiata dalla documentata<br />
sinergia tra il batterio e gli sbalzi termici. Non sono le<br />
temperature estreme di –20°C a favorire il batterio perché in<br />
questo caso il danno del gelo ai tessuti è diretto (foto 1).<br />
La pericolosa sinergia tra batterio e basse temperature si instaura<br />
con temperature poco sotto lo zero ma altalenanti (come spesso si<br />
presentano in Piemonte a fine inverno). In questa situazione, l’effetto<br />
spugna del gelo-disgelo trasloca più velocemente in corteccia<br />
le cellule batteriche che con le piogge autunnali si sono dislocate<br />
sulle ferite fogliari, sui peduncoli e sulle lenticelle (foto 2, 3, 4).<br />
Tali sintomi che a fine gennaio risultavano così iniziali a metà febbraio<br />
si sono evoluti in 70 centimetri di necrosi corticale. Le condizioni<br />
autunno-invernali del Piemonte sono così predisponenti alla<br />
diffusione e alla manifestazione del batterio sugli organi legnosi<br />
da rendere ininfluente la presenza o meno del batterio sulle foglie<br />
vale a dire che alla ripresa vegetativa PSA si è manifestato in tutta<br />
la sua gravità sia nel 2011 preceduto da un 2010 in cui erano<br />
evidenti numerose macchie fogliari sia nel <strong>2013</strong> preceduto invece<br />
dal 2012 in cui le macchie fogliari sono state rare.<br />
L’efficacia dei prodotti<br />
Le difficoltà incontrate nel contenimento degli attacchi di questo<br />
batterio sono legate soprattutto alla mancanza di prodotti<br />
dotati di specifica attività battericida e alla ridotta disponibilità<br />
di principi attivi registrati sulla coltura. Nella pratica di campo la<br />
lotta per via chimica è affidata quasi esclusivamente ai prodotti<br />
rameici, molti dei quali sono da tempo autorizzati per l’impiego<br />
sul bruno (Spadaro et al., 2011). Alcuni di questi prodotti<br />
sono stati ammessi, in deroga per il 2011 e il 2012, anche per<br />
un numero limitato di trattamenti sul verde, da effettuare ogni<br />
volta che si creino ferite sulla pianta causate da grandinate e da<br />
operazioni di potatura verde (Vittone et al., 2011). Le limitazioni<br />
d’uso dei prodotti rameici sono legate alla possibile fitotossicità,<br />
benché l’actinidia tolleri abbastanza bene le nuove formulazioni<br />
a basso contenuto di rame, e al rischio di selezione di ceppi del<br />
patogeno resistenti al rame (Scortichini et al., 2012).<br />
32 Agricoltura <strong>81</strong>
documenti<br />
In questi ultimi anni, sono stati offerti numerosi nuovi prodotti a<br />
base di rame formulato in combinazione con acidi umici o amminoacidi<br />
e a base di batteri antagonisti come Bacillus amyloliquefaciens<br />
subsp. plantarum e Bacillus subtilis. Accanto a questi<br />
sono stati proposti preparati ad azione disinfettante a base di<br />
acido acetico, perossido di idrogeno e acido cloridrico e altri ad<br />
azione ricoprente come chitosano e zeoliti. Sono inoltre oggetto<br />
di attenzione e verifiche prodotti considerati in grado di stimolare<br />
la resistenza della pianta, come il fosetyl Al e l’acibenzolar-Smethyl,<br />
già registrati e utilizzati su altre colture.<br />
Tabella 1 - Prodotti impiegati<br />
Principio attivo<br />
g/ha p.c.<br />
1 - -<br />
2 Ossicloruro rameico 3000<br />
3 Rame idrossido 2000<br />
4 Cu ossicloruro + Cu idrossido 1100<br />
5 Cu ossicloruro + Cu idrossido 1000<br />
6 Cu ossicloruro + Cu idrossido 3000<br />
7 Acibenzolar-S-metile 200<br />
8 Acibenzolar-S-metile 400<br />
9 Glutatione+Sali di K+Cu 3000<br />
10 Fosetyl Al 2000<br />
11 Olio di santoreggia 1000<br />
12 Olio di timo 1000<br />
13 Propoli 2000<br />
14 Silicato di Na 100<br />
15 Solfato di zinco, Ipoclorito di sodio, Ac. 2500<br />
peracetico<br />
16 Bacillus subtilis 4000<br />
17 Bacillus amyloliquefaciens 1500<br />
18 Glucoumati per via fogliare 6000<br />
19 Glucoumati per via radicale 6000<br />
20 Glucoumati per via fogliare e radicale 5000+5000<br />
21 Silicato di K 100<br />
22 Chelato di rame 400<br />
23 Zeolite sintetica 10.000<br />
24 Miscela di terriccio e compost 1 (20%) -<br />
25 Miscela di terriccio e compost 2 (20%) -<br />
Prove in ambiente protetto. Per verificare l’efficacia di questi<br />
prodotti e di altri, nel 2011 e nel 2012 sono state condotte presso<br />
il Centro Agroinnova, in ambiente protetto, prove su piante in<br />
vaso, nelle quali sono stati messe a confronto 25 tesi diverse (Tab.<br />
1). Sulle piante sono state effettuati due trattamenti con i diversi<br />
formulati a distanza di sette giorni e poi è stato inoculato artificialmente<br />
il batterio distribuendo sulle foglie una miscela di ceppi<br />
diversi contenente 1x10 8 CFU. Dopo 7 giorni dall’inoculazione,<br />
alla comparsa dei primi sintomi fogliari, i trattamenti sono stati<br />
ripetuti e poi sono proseguiti con interventi ogni 2 settimane fino<br />
all’inizio dell’estate, quando a causa del forte innalzamento delle<br />
temperature, i trattamenti sono stati sospesi. Nel corso delle prove<br />
sono stati valutati la diffusione e la gravità dei sintomi, l’effetto<br />
del prodotto sullo sviluppo delle piante e l’eventuale fitotossicità.<br />
Foto 1: Gemma annerita colpita<br />
da gelo invernale<br />
Foto 3: Infezione di Psa da<br />
peduncolo<br />
Foto 2: Infezione di Psa da<br />
cicatrice fogliare<br />
In queste prove, i migliori risultati<br />
nel contenimento della<br />
malattia sono stati ottenuti con<br />
un nuovo formulato a base di<br />
rame e da acibenzolar-S-metile.<br />
Quest’ultimo prodotto, però,<br />
ha mostrato una forte attività<br />
depressiva sullo sviluppo delle<br />
piante causandone la quasi<br />
completa defogliazione. Buoni<br />
risultati sono stati ottenuti<br />
anche utilizzando idrossido di rame, da solo e in miscela con<br />
ossicloruro, con fosetyl Al, con un chelato di rame e con un induttore<br />
di resistenza a base di glutatione, sali di potassio e rame.<br />
Questi due ultimi prodotti hanno dato però evidenti sintomi di<br />
fitotossicità. Sufficiente è stato anche il risultato ottenuto da un<br />
nuovo prodotto a base di glucoumati distribuito per via fogliare,<br />
sia per quanto riguarda il contenimento della malattia, sia per<br />
l’effetto favorevole sullo sviluppo delle piante. Risultati meno<br />
interessanti sono stati ottenuti con lo stesso prodotto distribuito<br />
per via radicale, con ossicloruro di rame, Bacillus subtilis e B.<br />
Agricoltura <strong>81</strong><br />
33
documenti<br />
Figura 1: Efficacia di differenti strategie nei confronti di Pseudomonas syringae pv. actinidiae a circa<br />
60 giorni dalla inoculazione artificiale (2012).<br />
amyloliquefaciens e con diversi prodotti disinfettanti e di copertura,<br />
di origine naturale e di sintesi chimica, che sono riusciti<br />
a limitare solo in parte la diffusione e la gravità della malattia<br />
rispetto al testimone non trattato (fig. 1).<br />
Prove di semicampo. A seguito degli screening effettuati in laboratorio<br />
sui prodotti più promettenti ad azione preventiva, si è proceduto<br />
a testarne alcuni in condizioni di semi-campo. Sono state<br />
quindi costituite due batterie di prove in modo da valutare l’efficacia<br />
dei prodotti nel contenimento dell’infezione batterica in quegli<br />
stage di sviluppo della pianta che ad oggi sembrano essere cruciali<br />
per l’ingresso del Psa nei tessuti. La prima batteria, composta da<br />
36 astoni di actinidia varietà Hayward, 18 maschi e 18 femmine<br />
provenienti da materiale vivaistico sano, è stata inoculata allo stadio<br />
fenologico 08 della scala BBCH (apertura gemme: primo apice del<br />
Tabella 2: prodotti saggiati nelle prove di semi-campo, dosaggio e meccanismo d’azione<br />
germoglio visibile), mentre la seconda<br />
composta da 72 astoni, 36 maschi e 36<br />
femmine è stata inoculata alla fase 19<br />
della BBCH scale (sviluppo fogliare: prima<br />
foglia completamente sviluppata). I<br />
prodotti saggiati sono stati suddivisi in<br />
due gruppi in base al meccanismo d’azione.<br />
Il primo gruppo comprende tutti<br />
i prodotti caratterizzati da un meccanismo<br />
d’azione basato sull’attivazione di<br />
difese di tipo SAR (systemic activated<br />
resistance) della pianta, mentre il secondo<br />
gruppo è composto dai prodotti che<br />
grazie all’azione batteriostatica, filmante<br />
e battericida delle molecole utilizzate<br />
hanno un meccanismo di azione di tipo preventivo, vale a dire che<br />
impediscono l’ingresso del batterio negli stomi (tab. 2).<br />
Il momento dell’applicazione dei prodotti è stato definito in base al<br />
meccanismo di azione. Infatti per permettere una adeguata diffusione<br />
nei tessuti dei prodotti induttori di resistenza e allo stesso tempo la<br />
completa attivazione dei meccanismi SAR si è proceduto ad applicare i<br />
prodotti induttori di resistenza una settimana prima dell’inoculazione,<br />
mentre i prodotti ad azione preventiva sono stati applicati 24 h prima.<br />
Le inoculazioni sono state effettuate per mezzo di una nebulizzazione<br />
sulla pianta di una sospensione di 108 cellule batteriche<br />
in soluzione fisiologica allo 0.9%. Come consigliato dalla letteratura<br />
neozelandese si è proceduto a mantenere le piante in<br />
condizioni di umidità prossime al 100% per 3 giorni, in modo<br />
Principio attivo g o ml/ha di formulato commerciale Meccanismo di azione<br />
Acibenzolar-S-metile 100 Induttore di resistenza<br />
Estratti naturali ad azione battericida 3000 Battericida<br />
Induttore di resistenza con fosfito di K 6000 a pH 5,5 (soluzione acidificata con acido citrico) Induttore di resistenza<br />
Laminarina 750 Induttore di resistenza<br />
Bacillus amyloliquefaciens 1500 Antagonista<br />
Ossido di rame 75% 700 (525 g di rame metallo) Batteriostatica<br />
Ossido di rame 75% +<br />
Zeolite sintetica 700 (525 g di rame metallo) +<br />
1000 Batteriostatica/Filmante<br />
Chelato di rame + microelementi 3000 Batteriostatica<br />
Zeolite sintetica 1000 Filmante<br />
da creare le condizioni ideali per l’ingresso del batterio negli stomi.<br />
Successivamente le<br />
piante sono state messe<br />
in pieno campo e monitorate<br />
ogni due giorni<br />
in modo da registrare<br />
e quantificare l’entità<br />
dell’infezione tramite la<br />
comparsa dei caratteristici<br />
macchie fogliari. Per<br />
completare la valutazione<br />
dei prodotti utilizzati<br />
si è proceduto, inoltre a<br />
monitorare<br />
l’eventuale<br />
comparsa di fitotossicità<br />
sulle foglie.<br />
34 Agricoltura <strong>81</strong>
documenti<br />
Per l’inoculazione effettuata nella fase fenologica<br />
08 BBCH scale, i risultati hanno evidenziato<br />
come dal 21 marzo sia stata rilevata<br />
su quasi tutte le tesi la comparsa di macchie<br />
fogliari mostrando come nessun prodotto sia<br />
stato in grado di prevenire completamente<br />
l’ingresso del batterio nelle piante. La PCR<br />
effettuata sulle foglie sintomatiche ha confermato<br />
che le macchie fogliari corrispondevano<br />
effettivamente alla presenza del patogeno<br />
all’interno della pianta. Nella tesi trattata con<br />
il solo ossido di rame (Nordox), invece, alcune<br />
piante che non mostravano sintomi; le successive analisi PCR hanno<br />
evidenziato che in queste piante l’infezione non era avvenuta.<br />
Per l’inoculazione effettuata in fase fenologica 19 BBCH scale,<br />
i risultati hanno evidenziato come il 29 maggio siano state rilevate<br />
su tutte le tesi, ad eccezione di quella trattata con acibenzolar-S-metile<br />
la comparsa delle caratteristiche macchie fogliari<br />
con una percentuale di germogli colpiti a fine prova abbastanza<br />
elevata (fig. 2). Come nella prova precedente si è proceduto a<br />
prelevare i campioni vegetali in tutte le tesi e, grazie alle successive<br />
analisi PCR, è stato possibile confermare l’avvenuta infezione.<br />
Ad eccezione delle tesi trattate con ossido di rame, ossido di<br />
rame più zeoliti sintetiche e acibenzolar-S-metile, il 100% delle<br />
piante hanno evidenziato sintomi fogliari. Il monitoraggio della<br />
fitotossicità ha evidenziato come nelle tesi in cui si sono utilizzati<br />
prodotti dotati attività sistemica, come l’acibenzolar-S-metile e il<br />
chelato di rame + microelementi, si sia determinato un elevato<br />
grado di stress nelle piante, i prodotti rameici hanno causato<br />
una leggera/media fitotossicità, mentre le altre tesi sono state<br />
caratterizzate da una ridotta fitotossicità.<br />
Discussione<br />
Dalle prove condotte, si possono trarre delle indicazioni importanti<br />
che permettono di gettare le basi di una strategia di difesa<br />
contro il Psa. In entrambi gli ambienti (ambiente protetto e<br />
semi-campo) i prodotti rameici sono riusciti a contenere l’infezione<br />
degli stomi facendo registrare una percentuale di germogli<br />
colpiti relativamente bassa. Per quanto riguarda le zeoliti sintetiche,<br />
caratterizzate da un’azione filmante, si è evidenziato che da<br />
sole non riescono a creare una barriera impermeabile al batterio<br />
(numero medio di macchie per pianta di 6 rispetto alle 9,6 del<br />
testimone, non differente statisticamente) tuttavia, l’applicazione<br />
con prodotti rameici crea una sinergia positiva tra i due prodotti<br />
Figura 2: Percentuale di germogli infetti a fine prova<br />
tale da ridurre sia la percentuale di piante infette sia il numero di<br />
germogli infetti rispetto all’applicazione del solo prodotto rameico<br />
(fig 2). L’acibenzolar-S-metile ha dato ottimi risultati evidenziando<br />
la potenzialità di questo prodotto. In aggiunta il prodotto, o la<br />
resistenza da esso indotta, hanno mostrato un’ottima persistenza<br />
nel tempo: a tre settimane dal trattamento il testimone non inoculato<br />
mostrava il 3% di germogli colpiti dovuti ad una probabile<br />
infezione secondaria, mentre le piante trattate con acibenzolar-Smetile<br />
continuavano a non presentare sintomi di infezione batterica.<br />
Per quanto riguarda l’efficacia degli altri prodotti saggiati, purtroppo<br />
si è osservata un’infezione del 100% delle piante trattate,<br />
sottolineando come nelle condizioni sperimentali in oggetto essi<br />
non si siano differenziati statisticamente dal testimone.<br />
Un ultimo commento è tuttavia necessario sull’effetto fitotossico<br />
dei prodotti. Tralasciando le tesi che non hanno evidenziato<br />
un interesse nel contenimento del patogeno, bisogna sottolineare<br />
che l’acibenzolar-S-metile ha mostrato non solo un’ottima<br />
efficacia nel contenere il patogeno, ma anche causato sintomi<br />
di fitotossicità sia a livello fogliare che di sviluppo della pianta. I<br />
prodotti a base di ossido di rame invece sono stati caratterizzati,<br />
come peraltro è noto, da una fitotossicità media evidenziata da<br />
uno stress dei tessuti fogliari, mentre lo sviluppo dei germogli è<br />
stato in linea con quello del testimone. Concludendo, la sperimentazione<br />
in oggetto getta delle ottime basi per la definizione<br />
di prodotti validi nel contenimento della malattia; tuttavia, la variabilità<br />
delle condizioni climatiche e dei cicli infettivi del batterio<br />
nell’agroecosistema rendono necessaria una sperimentazione in<br />
pieno campo in grado di definire una strategia di difesa efficace.<br />
Ringraziamenti<br />
Lavoro svolto con un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio<br />
di Torino e della Regione Piemonte.<br />
Agricoltura <strong>81</strong><br />
35
documenti<br />
Direttiva Nitrati nel settore orticolo:<br />
un workshop internazionale a Torino<br />
Monica Bassanino - Regione Piemonte, Settore Produzioni zootecniche<br />
Stefano Monaco, Silvana Nicola, Carlo Grignani - Università di Torino, Dip. Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari<br />
Emanuela Fontana - Agronoma Libera Professionista<br />
La Direttiva Nitrati (91/676/EEC) mira a ridurre l’inquinamento<br />
delle acque causato direttamente o indirettamente dall’agricoltura.<br />
L’indubbia rilevanza ambientale di questa norma è però<br />
contrapposta a difficoltà applicative e di adeguamento ai vincoli<br />
previsti. In particolare, la Direttiva Nitrati è nata per disciplinare<br />
soprattutto il carico animale delle aziende zootecniche,<br />
introducendo vincoli all’utilizzo degli effluenti di allevamento<br />
nelle aree a maggior fragilità ambientale (Zone Vulnerabili ai<br />
Nitrati, o ZVN). Tuttavia, gli obiettivi della Direttiva riguardano<br />
anche altre attività agricole, per le quali il rischio di dispersione<br />
d’azoto nell’ambiente, dovuto perlopiù alla fertilizzazione,<br />
può essere elevato. In tal senso, alcuni areali europei destinati<br />
all’orticoltura intensiva devono essere oggetto di particolare<br />
attenzione: l’elevato grado di intensificazione colturale (alti<br />
livelli di concimazione ed irrigazione) e le caratteristiche dei<br />
terreni (suoli sabbiosi, falde superficiali) possono generare un<br />
significativo impatto ambientale sulle risorse idriche.<br />
In Piemonte la produzione orticola, diffusa su circa 10.000<br />
ettari (Tab. 1 e Fig. 1), interessa per oltre il 50% territori designati<br />
Zone Vulnerabili (in particolare nell’Alessandrino, ma<br />
anche nel Cuneese e nell’Altopiano di Poirino).<br />
Per affrontare da un punto di vista tecnico-scientifico gli<br />
aspetti critici relativi all’applicazione della Direttiva Nitrati alle<br />
produzioni orticole emersi nei diversi Paesi europei, l’Università<br />
di Torino in collaborazione con la Commissione Europea<br />
ha organizzato a Torino (15-17 aprile <strong>2013</strong>) il Workshop Internazionale<br />
“NEV<strong>2013</strong> - Nitrogen, Environment and Vegetables”.<br />
Il convegno ha visto la partecipazione di un centinaio<br />
tra ricercatori, funzionari amministrativi, rappresentanti di<br />
ditte di fertilizzanti, agronomi, tecnici ed agricoltori, con la<br />
presentazione di oltre 60 lavori scientifici. Le visite tecniche<br />
in alcune aziende orticole in provincia di Torino hanno poi<br />
consentito di avere una base di discussione applicativa. I principali<br />
temi affrontati hanno riguardato in generale la gestione<br />
della concimazione azotata in orticoltura, e in particolare la<br />
relazione tra azoto, acqua irrigua ed altri elementi nutritivi, la<br />
gestione dei residui colturali e delle rotazioni, le tecniche del<br />
monitoraggio agro-ambientale.<br />
36 Agricoltura <strong>81</strong>
documenti<br />
Un settore diversificato<br />
e complesso<br />
Il settore orticolo è molto complesso: esistono sistemi colturali<br />
estremamente diversi (in coltura protetta o in pieno campo;<br />
in suolo o in fuori suolo), moltissime specie, varietà, tipologie<br />
di prodotto raccolto (foglie, frutti, tuberi) e destinazioni commerciali<br />
(mercato locale, GDO, industria di trasformazione,<br />
export) nonché una forte variabilità pedoclimatica tra le aree<br />
di coltivazione (Mediterraneo, Nord Europa).<br />
Le ortive presentano differenze molto forti in termini di efficienza<br />
nell’assimilazione dell’azoto che viene fornito con le<br />
fertilizzazioni. Le strategie di fertilizzazione dipendono però<br />
principalmente dagli obiettivi commerciali: sebbene la resa<br />
continui a rappresentare il primo obiettivo per il produttore,<br />
anche le caratteristiche qualitative, commerciali ed igienicosanitarie<br />
del prodotto sono importanti, soprattutto per le filiere<br />
avanzate che destinano il prodotto alla GDO e all’export.<br />
Sul fronte nitrati esistono poi vincoli comunitari al contenuto<br />
di nitrati in alcune ortive da foglia (es. spinaci, rucola, insalate),<br />
volti a tutelare il consumatore dall’assunzione di eccessi<br />
di nitrati, che come noto vengono ingeriti principalmente<br />
con l’acqua, alcune ortive e i salumi. Ulteriori vincoli sono poi<br />
spesso imposti dalla GDO, non soltanto per la salubrità del<br />
prodotto, ma anche per le conseguenze negative sulla conservabilità<br />
dei prodotti.<br />
dall’ammendante. Esistono oggi molti strumenti che possono<br />
favorire una migliore gestione della fertilizzazione; dovrebbero<br />
essere semplici, informativi ed affidabili, ma purtroppo al<br />
momento nessuno sembra soddisfare contemporaneamente<br />
tutte queste caratteristiche. In molti casi ci si basa sul bilancio<br />
input – output; nonostante l’apparente superficialità del<br />
metodo, questo resta ancora l’indicatore di efficienza azotata<br />
più diffuso. In alcuni Paesi si utilizza la misura a inizio e fine ciclo<br />
colturale del contenuto di azoto minerale del suolo. Hanno<br />
grande interesse anche in orticoltura gli indicatori basati<br />
sul colore fogliare o sulle caratteristiche ottiche delle foglie<br />
(es.: Spad, Nitra-test, Canopy Reflectance); sono da preferire i<br />
metodi che analizzano un’ampia porzione del manto vegetale,<br />
piuttosto che piccole porzioni di foglia. In generale, è stata<br />
sottolineata l’importanza di combinare gli indicatori colturali<br />
con altre informazioni disponibili producendo modelli colturali<br />
o, con maggiore significato applicativo, sistemi empirici<br />
di supporto alle decisioni (Decision Support Systems – DSS;<br />
es.: KNS system, Veg-Sys, Well-N, EU-Rotate). In ogni caso,<br />
sarebbe auspicabile che ogni grande areale orticolo europeo<br />
disponesse di un proprio metodo, testato localmente.<br />
In conclusione, per il settore orticolo un’attenta ed efficiente<br />
gestione della fertilizzazione ha un ruolo fondamentale non<br />
solo per le rese, ma soprattutto per la commercializzazione<br />
del prodotto, e i vincoli agro-ambientali in questo senso dovrebbero<br />
concorrere a sviluppare un approccio di “concimazione<br />
integrata”, analogamente alla difesa integrata delle<br />
colture, in cui gli stretti rapporti tra suolo, acqua, coltura ed<br />
elementi nutritivi vengano ottimizzati.<br />
Tabella 1: Diffusione delle colture orticole in Italia (ISTAT, 2010)<br />
In pieno campo In coltura protetta<br />
ha<br />
ha<br />
Italia 588.000 35.000<br />
di cui nel Nord Italia 126.000 8.500<br />
di cui in Piemonte 9.800 800<br />
Figura 1: Colture orticole (ha) nelle Zone Vulnerabili in Piemonte<br />
(Regione Piemonte, 2012)<br />
Il settore orticolo spesso impiega elevate quantità di materiali<br />
organici (compost e letame) per migliorare la qualità fisica<br />
dei suoli. Molto importante in questi casi è l’effettiva contabilizzazione,<br />
nel piano di concimazione, dell’azoto fornito<br />
Agricoltura <strong>81</strong><br />
37
uno sguardo sull'europa<br />
a cura di Andrea Marelli<br />
Presentato il rapporto<br />
sugli alimenti pericolosi<br />
La nuova relazione annuale sul Sistema di allarme rapido europeo<br />
per alimenti e mangimi (RASFF) rivela che nel 2012 quasi il<br />
50% delle notifiche ha riguardato il respingimento alle frontiere<br />
dell’UE di alimenti e mangimi che presentavano rischi per la sicurezza<br />
alimentare.<br />
Varato 30 anni fa, il Rasff è uno strumento informatico che semplifica<br />
il flusso transfrontaliero di informazioni tra le Autorità<br />
nazionali di tutti gli Stati membri preposte alla sicurezza alimentare.<br />
Quando viene individuato un prodotto a grave rischio, il<br />
Rasff informa il Paese terzo interessato affinché adotti gli opportuni<br />
correttivi e impedisca che il problema si ripresenti.<br />
Nel 2012, le notifiche sono state 8.797, in diminuzione del 3,9%<br />
rispetto al 2011. 526 notifiche di allarme hanno riguardato rischi<br />
gravi riscontrati in prodotti sul mercato (-14% rispetto al 2011).<br />
Cina, India e Turchia sono in cima alla classifica, rispettivamente<br />
con 540, 338 e 310 segnalazioni, mentre l’Italia si posiziona al<br />
7° posto con 112 segnalazioni. Tra le categorie merceologiche<br />
più frequenti negli allerta, la carne e i suoi derivati (83), seguita<br />
da pesce e prodotti ittici. Le cause che hanno fatto scattare<br />
la notifica sono principalmente la presenza di pesticidi, metalli<br />
pesanti, aflatossine, plastificanti, diossine e contaminazioni microbiologiche.<br />
i<br />
Per scaricare il Rapporto Rasff:<br />
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm<br />
6,5 miliardi per il Fondo<br />
europeo per la pesca<br />
La Commissione Pesca del Parlamento europeo ha approvato le<br />
regole operative che determineranno il futuro del nuovo Fondo<br />
europeo per le attività marittime e della pesca (Feamp), destinato<br />
a un modello di attività sostenibile e competitiva nel settore<br />
per il periodo 2014-2020. Il Feamp, che ha attivato risorse per<br />
6,5 miliardi di euro, dovrebbe tracciare un confine chiaro tra<br />
piccola pesca artigianale, che diventa la principale destinataria<br />
delle risorse previste dal Fondo, e la grande pesca industriale.<br />
Tali risorse andranno a sostenere anche l’acquacoltura al fine<br />
di produrre di più e superare il gap esistente tra la produzione<br />
e il consumo europeo. Una funzione importante viene, inoltre,<br />
conferita alla pesca-turismo come integrazione al reddito dei<br />
pescatori in crisi, nell’ambito di un percorso legato alla diversificazione<br />
delle attività, intese come complementari a quella<br />
del pescatore stesso. Il Feamp si inserisce all’interno delle nuove<br />
regole previste dalla prossima Politica Comune della Pesca, che<br />
attende ad ottobre l’approvazione del Consiglio europeo del testo<br />
revisionato dal Parlamento.<br />
Contraffazione alcolici,<br />
patto UE-Cina<br />
Il Commissario europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale,<br />
Dacian Ciolos, ha incontrato a Pechino il Ministro cinese per il<br />
controllo della qualità, le ispezioni e la quarantena, Zhi Shuping<br />
per la sottoscrizione di una lettera di intenti al fine di contrastare<br />
il fenomeno della contraffazione nel commercio di bevande<br />
alcoliche. Nel documento, le due parti si impegnano a<br />
condividere informazioni utili sui prodotti abusivi, così da poter<br />
adottare misure più efficaci e inoltre a individuare le pratiche di<br />
contraffazione, incluse quelle per certificati e marchi d’origine,<br />
nonché per altri documenti di accompagnamento sui rispettivi<br />
territori. Prevista infine anche l’introduzione di misure più adeguate<br />
per contrastare l’abusività, che includono opzioni come<br />
la creazione di sistemi per il controllo e la tracciabilità, l’organizzazione<br />
di corsi di formazione per gli operatori del settore e<br />
l’autenticazione attraverso analisi di laboratorio.<br />
Premio FAO al programma<br />
“EU Food Facility”<br />
Il presidente della Commissione, Manuel Barroso, ha ritirato il<br />
15 giugno scorso il premio Jacques Diouf per la sicurezza alimentare,<br />
consegnato dalla Fao (l’organizzazione delle Nazioni<br />
Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) all’Unione Europea per<br />
“Food Facility”, il fondo da un miliardo di euro, istituito nel 2008<br />
durante la crisi alimentare che ha colpito il Corno d’Africa ed il<br />
Sahel e volto ad assicurare un sostegno efficace e veloce alle<br />
persone maggiormente colpite dalle carestie. “Food Facility” ha<br />
sin’ora fornito un sostegno indiretto a 93 milioni di persone, ha<br />
vaccinato oltre 44,6 milioni di capi di bestiame e ha contribuito<br />
ad istruire 1,5 milioni di persone, facendo aumentare la produzione<br />
agricola sostenibile di piccoli agricoltori e il loro reddito<br />
e facilitando il loro accesso ai mercati. ll Commissario europeo<br />
per lo Sviluppo, Andris Piebalgs, ha successivamente annunciato<br />
nuovi finanziamenti pari a 3,5 miliardi di euro tra il 2014-2020,<br />
volti a incrementare la nutrizione nei Paesi in via di sviluppo.<br />
38 Agricoltura <strong>81</strong>
informazione tecnica<br />
Come ridurre l’azoto in zootecnia:<br />
primi spunti dal progetto LIFE + “AQUA”<br />
Centro Ricerche Produzioni Animali - CRPA spa, Reggio Emilia<br />
Il progetto LIFE + “AQUA”, acronimo di “Achieving good water<br />
Quality status in intensive animal production areas” è finanziato<br />
dalla Commissione Europea e da numerosi co-finanziatori<br />
pubblici e privati; è condotto da una rete di partner e collaboratori<br />
coordinata da CRPA, Centro Ricerche Produzioni Animali<br />
S.p.A. di Reggio Emilia, e si realizza nelle regioni a maggiore<br />
intensità zootecnica dell’Italia del Nord: Piemonte, Lombardia,<br />
Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.<br />
Il progetto è finalizzato a dimostrare come sia possibile ridurre<br />
la quantità di azoto immesso nell’ambiente dagli allevamenti.<br />
I principali obiettivi tecnici del progetto Aqua sono:<br />
• ridurre il contenuto di azoto degli effluenti zootecnici,<br />
applicando diete per gli animali allevati che consentano un’elevata<br />
efficienza d’uso dell’azoto. Nel caso dei suini vengono<br />
utilizzati mangimi a ridotto contenuto proteico, con appropriata<br />
integrazione di aminoacidi essenziali. Nel caso dei bovini da<br />
latte e da carne vengono attuate strategie di alimentazione<br />
volte ad assicurare una ottimale funzionalità del rumine, per<br />
garantire la produzione di proteine ed energia necessarie ad<br />
assicurare alte produzioni, riducendo nel contempo l’escrezione<br />
di azoto;<br />
• aumentare l’efficienza fertilizzante dell’azoto e del fosforo<br />
contenuti negli effluenti zootecnici. I liquami delle aziende<br />
dimostrative sono utilizzati per fertilizzare colture ad elevata<br />
asportazione di azoto e lunga stagione di crescita, come i prati<br />
e le doppie colture (colture primaverili-estive seguite da colture<br />
autunno-vernine). Vengono inoltre impiegate tecniche innovative<br />
per distribuire i liquami su colture in fase vegetativa (ad<br />
esempio la fertirrigazione con frazioni chiarificate dei liquami<br />
per mezzo di ali gocciolanti o l’interramento poco profondo<br />
Agricoltura <strong>81</strong><br />
39
informazione tecnica<br />
tra le file). Ciò permette inoltre di risparmiare sull’acquisto dei<br />
concimi di sintesi;<br />
• ridurre la dispersione dei nutrienti dai terreni alle acque<br />
attraverso misure agro-ambientali;<br />
• limitare le pressioni e gli impatti nelle aree ad elevata<br />
densità di allevamenti, attraverso la separazione e il trasferimento<br />
di frazioni solide degli effluenti zootecnici. Allo scopo è<br />
stato istituito un consorzio di gestione degli effluenti zootecnici<br />
che provvederà alla separazione solido/liquido dei liquami e<br />
al trasporto della frazione solida ad aziende agricole non zootecniche<br />
caratterizzate da ridotto contenuto di sostanza organica<br />
nei terreni, come possono essere quelle ad alta vocazione<br />
frutticola della Romagna;<br />
• migliorare e semplificare i controlli aziendali, con la messa<br />
a punto di un sistema per la tracciabilità e la certificazione<br />
delle buone pratiche nella gestione dei nutrienti (dall’alimentazione<br />
animale alla produzione ed uso degli effluenti), che aiuti<br />
gli allevatori a ridurre l’impegno per la raccolta e la gestione dei<br />
dati e che possa anche essere utilizzato dalle autorità competenti<br />
per le verifiche di conformità alle norme;<br />
• valutare la sostenibilità economica e ambientale delle<br />
strategie di gestione proposte. È importante infatti definire se<br />
e in quale misura la loro adozione può modificare sia i costi di<br />
produzione e la remunerazione del lavoro, sia gli impatti ambientali<br />
del processo produttivo.<br />
Giornate dimostrative<br />
per i primi risultati<br />
Con la campagna agricola 2011/2012 il progetto AQUA ha<br />
fornito i suoi primi risultati. Le tecniche innovative applicabili<br />
alla gestione attenta e razionale delle deiezioni animali sono<br />
state illustrate con una nutrita serie di eventi e di giornate dimostrative<br />
destinate principalmente ad agricoltori e allevatori<br />
(visionabili sul sito web del progetto all’indirizzo aqua.crpa.it).<br />
Il partner piemontese è IPLA (Istituto per le Piante da Legno<br />
e l’Ambiente S.p.A.), che svolge il lavoro nelle aziende dimostrative<br />
con il supporto tecnico e scientifico dell’Università di<br />
Torino (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari<br />
- DISAFA, gruppi di ricerca Agronomia Ambientale e Zootecnica).<br />
Cardine del progetto sono le aziende dimostrative, nelle<br />
quali si utilizzano per gli animali diete che migliorano l’efficienza<br />
d’uso della proteina degli alimenti e contestualmente si<br />
applicano tecniche colturali per il massimo sfruttamento dell’azoto<br />
degli effluenti nelle rotazioni agronomiche.<br />
Le aziende dimostrative sono distribuite nelle 5 regioni che partecipano<br />
al progetto: la specie e il tipo di allevamento rispecchiano<br />
la zootecnia presente in ogni specifico territorio (tabella<br />
1).<br />
Tabella 1 - Aziende dimostrative del progetto “AQUA”<br />
Specie<br />
zootecnica<br />
Bovini<br />
da latte<br />
Bovini<br />
da carne<br />
Regione Azienda Destinazione<br />
produttiva<br />
Lombardia<br />
Emilia-Romagna<br />
Veneto<br />
Friuli VG<br />
Piemonte<br />
Veneto<br />
Pinotti Luigi e<br />
Alberto, Pizzighettone<br />
(CR)<br />
Mori Carlo, Gattatico<br />
(RE)<br />
Sgambaro Mario,<br />
Villa del Conte (PD)<br />
Bolzon Ernesto e<br />
Figli, Bicinicco (UD)<br />
Sevega Bruno e<br />
Dario, Cervere (CN)<br />
Cagnin Gianfranco<br />
e Luciano, Piombino<br />
Dese (PD)<br />
Suini Piemonte Mana Stefano,<br />
Genola (CN)<br />
Lombardia<br />
Emilia-Romagna<br />
Soc. Agr. Biagi Romeo<br />
SS, Borgoforte<br />
(MN)<br />
Zambelli F.lli,<br />
Guastalla (RE)<br />
Formaggio<br />
Grana Padano<br />
Formaggio<br />
Parmigiano-<br />
Reggiano<br />
Latte alimentare<br />
Latte alimentare<br />
Carne bovina,<br />
razza specializzata<br />
Piemontese<br />
Carne bovina,<br />
da maschi di<br />
razza Frisona<br />
Circuito dei<br />
prosciutti DOP<br />
Circuito dei<br />
prosciutti DOP<br />
Circuito dei<br />
prosciutti DOP<br />
Sul sito web del progetto ogni azienda dimostrativa ha una sezione<br />
dedicata, dove vengono illustrati obiettivi e risultati delle<br />
attività specifiche che si realizzano; infatti, pur nel rispetto delle<br />
linee progettuali, per ogni realtà produttiva si è pianificato<br />
un percorso dimostrativo che rispecchia le peculiarità della tradizione<br />
agricola e zootecnica del territorio.<br />
Nel caso del Piemonte il progetto tratta le aziende zootecniche<br />
da carne, con bovini e suini, localizzate in un’area a forte densità<br />
zootecnica qual è la provincia di Cuneo. I prodotti che rappresentano<br />
la Regione sono infatti la razza bovina Piemontese<br />
e i suini pesanti per la produzione di prosciutti a DOP.<br />
Nel corso del primo anno di progetto sono state svolte una<br />
serie di attività per valutare le modalità di conduzione ordinaria<br />
delle aziende, le quantità e l’uso dell’azoto nelle aziende. Questo<br />
monitoraggio ha riguardato l’azienda zootecnica nel suo<br />
40 Agricoltura <strong>81</strong>
fabbisogni nutritivi (proteici ed energetici) di soggetti molto<br />
diversi nelle esigenze alimentari a causa del diverso assetto ormonale.<br />
I risultati dell’applicazione di questa tecnica saranno<br />
disponibili e illustrati nelle attività dimostrative che partiranno<br />
dalla primavera/estate del <strong>2013</strong>.<br />
Dal punto di vista del bilancio complessivo aziendale dell’azoto,<br />
la quota maggiore di azoto in ingresso è costituita dagli<br />
alimenti acquistati, in quanto i prodotti vegetali coltivati sui<br />
terreni in conduzione non vengono reimpiegati nell’allevamento<br />
ma ceduti all’esterno. Quando i prodotti vegetali coltivati<br />
sui terreni in conduzione non sono reimpiegati nell’allevamento<br />
ma vengono venduti all’esterno. Ciò incrementa l’efficienza<br />
d’uso dell’azoto a livello aziendale (output/input tra 0,5 e<br />
0,6), per mancata allocazione interna dei prodotti vegetali ai<br />
fini delle produzioni animali, che sono meno efficienti di quelle<br />
vegetali in termini di utilizzo dell’azoto. Gli effluenti prodotti<br />
sono destinati in parte a terreni extra-aziendali, ma il surplus di<br />
N espresso per unità di superficie (calcolato come la differenza<br />
tra gli ingressi di N in azienda e le uscite di N dall’azienda)<br />
resta comunque piuttosto elevato, anche per le integrazioni<br />
fertilizzanti che vengono fatte con concimi minerali, in modo<br />
particolare su mais in copertura.<br />
L’Azienda Sevega, alleva bovini di razza Piemontese a Cervere<br />
(CN), cioè al centro del territorio dove è concentrata questa<br />
razza che produce carni di alta qualità. L’allevamento a ciclo<br />
chiuso e conta 320 capi in linea vacca-vitello, parte in stabulainformazione<br />
tecnica<br />
complesso, cioè dall’alimentazione degli animali all’impiego<br />
dell’azoto in campo, considerando quindi il ciclo completo di<br />
tale elemento nutritivo nell’azienda zootecnica che deve finire<br />
con l’uso agronomico. Sulla base dei risultati raccolti, sono<br />
state pianificate le azioni di miglioramento dell’efficienza d’uso<br />
dell’azoto che, sia per l’alimentazione animale che per l’impiego<br />
agricolo, saranno oggetto della dimostrazione del <strong>2013</strong>.<br />
L’azienda Mana, situata a Genola (CN), alleva suini pesanti ed<br />
è iscritta al circuito tutelato per la produzione di cosce destinate<br />
alle DOP prosciutti di Parma e di San Daniele. L’allevamento<br />
dispone di 1600 posti ingrasso e di 35 ha di terreno in pianura<br />
irrigua. Il riparto colturale prevede la rotazione di mais, loiessa,<br />
soia e frumento venduti sul mercato. Gli effluenti prodotti<br />
vengono utilizzati per fertilizzare tutti i terreni in proprietà e in<br />
parte sono destinati a 15 ha extra-aziendali. Durante la prima<br />
annualità di progetto, dedicata al monitoraggio della conduzione<br />
ordinaria delle aziende dimostrative, l’azienda Mana ha<br />
fatto registrare una efficienza d’uso dell’azoto alimentare dei<br />
suini pari al 29%, rilevata in un ciclo di accrescimento/ingrasso<br />
di 208 giorni, per un incremento di peso di circa 136 kg.<br />
L’azienda ha avuto parametri produttivi molto soddisfacenti,<br />
anche grazie alle buone condizioni sanitarie che il sistema di<br />
allevamento tutto pieno/tutto vuoto permette. La strategia di<br />
miglioramento dell’uso dell’azoto scelta per l’azienda Mana è<br />
l’allevamento a sessi separati: alimentare le femmine intere e<br />
i maschi castrati separatamente permette di seguire meglio i<br />
Agricoltura <strong>81</strong><br />
41
informazione tecnica<br />
zione fissa, parte in stabulazione libera. L’ingrasso dei vitelloni<br />
avviene utilizzando alimenti prodotti direttamente in 42 ha di<br />
terreno di pianura in proprietà, il cui riparto colturale prevede<br />
rotazioni di mais di primo e secondo raccolto, loiessa e orzo,<br />
interamente reimpiegati nell’allevamento. Gli effluenti prodotti<br />
vengono utilizzati per fertilizzare i terreni aziendali. Il monitoraggio<br />
delle modalità di alimentazione durante la fase di ingrasso<br />
dei vitelli (prevista dai 400 kg ai 600 kg circa, con un incremento<br />
atteso di 1,2 kg al giorno) ha indicato una efficienza<br />
d’uso dell’azoto alimentare del 21% e ha permesso di calcolare<br />
livelli di escrezione per posto/anno in linea con quanto riportato<br />
dalla normativa per i bovini da carne (33,6 kg di N al campo<br />
/capo/anno, tabella 2 del D.M. 7 aprile 2006). Per l’azienda<br />
Sevega è stata pianificata un’azione di miglioramento dell’efficienza<br />
dell’azoto alimentare che, unendo un abbassamento<br />
della proteina grezza e strategie per il buon funzionamento del<br />
rumine, potranno condurre a miglioramenti nel bilancio complessivo<br />
dell’azoto a livello aziendale. Dal punto di vista complessivo<br />
dell’azienda, l’ingrasso dei vitelloni avviene utilizzando<br />
in prevalenza alimenti di produzione aziendale; ciò riduce l’efficienza<br />
d’uso dell’azoto (output/input) a un valore inferiore a<br />
0,2, per allocazione interna dei prodotti vegetali, ma il surplus<br />
di N espresso per unità di superficie risulta il più basso di tutte<br />
le aziende dimostrative del progetto (165 kg N/ha).<br />
Conclusioni<br />
L’attività di monitoraggio condotta nel primo anno del progetto<br />
ha consentito di effettuare una fotografia puntuale delle diverse<br />
situazioni aziendali prima dell’introduzione di qualsiasi modifica<br />
della razione e delle tecniche agronomiche. A partire dal secondo<br />
anno è stato messo in pratica un “percorso”, specificamente<br />
studiato per ogni azienda, volto a migliorare l’efficienza d’uso<br />
dell’azoto, a livello sia di allevamento che del campo, con interventi<br />
mirati sulla razione, sulle colture e sulle tecniche di utilizzazione<br />
agronomica degli effluenti di allevamento.<br />
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto si sta verificando come<br />
può essere concretamente possibile inserire nelle aziende le pratiche<br />
che consentono di aderire alla deroga al limite dei 170 kg<br />
N/ha previsto per le Zone Vulnerabili da Nitrati, portandolo sino<br />
a 250 kg N/ha come concesso all’Italia con la decisione della<br />
Commissione Europea n. 721 del 3 novembre 2011. Fondamentale<br />
è avere colture con stagioni di crescita prolungate ed elevato<br />
grado di assorbimento di azoto e tecniche di distribuzione che<br />
consentano di ampliare il calendario degli spandimenti.<br />
42 Agricoltura <strong>81</strong>
informazione tecnica<br />
Nuove tecnologie per ridurre il consumo<br />
delle risorse idriche in agricoltura<br />
Alberto Cugnetto, Alberto Gennaro, Augusto Marchesini - Osservatorio piemontese di frutticoltura (Alberto Geisser)<br />
Il cambiamento climatico manifestatosi negli ultimi anni ha promosso<br />
un riscaldamento che in Europa è stato particolarmente<br />
evidente nelle zone mediterranee, con aumento dei valori medi<br />
delle temperature e delle ondate di calore sia in estate che in primavera.<br />
Negli ultimi decenni la precipitazione media è diminuita,<br />
almeno fino a metà degli anni ‘90, facendo contemporaneamente<br />
registrare un aumento degli eventi estremi (UNASA, 2006).<br />
In ambito agrario, l’aumento delle temperature determina un incremento<br />
dell’evapotraspirazione delle colture. Nelle coltivazioni<br />
non irrigue il cambiamento del clima può condurre a fenomeni<br />
di stress idrico di diversa entità, con conseguenti diminuzioni<br />
quali-quantitative delle produzioni agricole.<br />
Lo studio delle relazioni esistenti tra la disponibilità idrica del<br />
terreno ed il potenziale idrico delle piante (grado di idratazione),<br />
quali ad esempio erpicature e lavorazioni mirate del suolo (Atkison,<br />
Thomas, 1985), risulta oggi una valida tecnica per ottimizzare<br />
la risorsa idrica disponibile nel terreno non irriguo. A tale<br />
scopo oggi, per ottenere in tempi brevi informazioni necessarie<br />
a programmare interventi colturali che consentono la riduzione<br />
dei costi di gestione agraria ed il risparmio idrico (Hawkins,<br />
1985), è necessario sperimentare l’impiego delle tecniche elettroniche<br />
di rilevamento del contenuto idrico presente nei suoli.<br />
I dati raccolti in continuo sono accumulati in memorie elettroniche<br />
e disponibili per l’elaborazione computerizzata. Queste<br />
nuove tecniche, affiancandosi all’esperienza dell’agricoltore,<br />
consentono di applicare una proficua agricoltura di precisione<br />
che assicura la produzione e la protezione delle piante, evitando<br />
d’incorrere in deficienze o eccessi dei fattori colturali.<br />
Di seguito vengono presentati i risultati ottenuti grazie al monitoraggio<br />
in continuo dei parametri idrici del suolo utilizzando<br />
due diverse sonde Watermark e Soilmoisture, allo scopo di confrontare<br />
i dati ottenuti dell’umidità del suolo, con i risultati delle<br />
precipitazioni giornaliere dell’evapotraspirazione e le misure di<br />
potenziale idrico di base delle piante di melo e della vite.<br />
Materiali e metodi<br />
Le ricerche sul melo sono state effettuate presso il meleto sperimentale<br />
A. Geisser gestito dall’Osservatorio di Frutticoltura Piemontese,<br />
presso il centro Bonafous di Chieri, mentre le indagini<br />
sulla vite sono state eseguite in un vigneto a pergola nel Canavese,<br />
sito nel comune di Settimo Vittone, presso una azienda<br />
agricola locale.<br />
Agricoltura <strong>81</strong><br />
43
informazione tecnica<br />
Il meleto è posto ad un’altitudine di 350 m s.l.m. Impiantato nel<br />
2001, ha una superficie di 3000 m 2 circa e riunisce undici incroci<br />
interspecifici per studiare le resistenze o le tolleranze delle piante<br />
di melo resistenti alle malattie fungine. I meli sono innestati su<br />
Figura 1: Sintesi delle determinazioni effettuate nelle annate 2008, 2010 e 2011 nel meleto Geisser.<br />
Confronto tra il bilancio idrico (differenza tra precipitazioni giornaliere ed evapotraspirazione<br />
effettiva) espresso in mm, andamento dell’umidità degli strati del suolo (kPa) monitorato con le sonde<br />
Watermark e andamento del potenziale idrico di base delle piante (MPa), nei periodi considerati.<br />
‘M9’ e ‘M26’. Il frutteto, privo di irrigazione, presenta una pendenza<br />
del 3-5 % ed una esposizione prevalente a Sud-Est.<br />
suolo è franco argilloso ed è impiantato a rittochino con distanze<br />
di 3 m sulla fila e 4 m tra le file. L’interfilare è perennemente inerbito<br />
e sono presenti 10 filari composti<br />
da 25 piante cadauno per un totale di<br />
250 piante. Il meleto è gestito secondo<br />
un programma di agricoltura biologica.<br />
All’interno del meleto è stata individuata<br />
una pianta dove sono state inserite<br />
tre sonde per la misura in continuo del<br />
contenuto idrico del suolo.<br />
Il vigneto, anch’esso privo di irrigazione,<br />
è sito a 260 m s.l.m., è stato impiantato<br />
nel 2006 con il clone di Nebbiolo<br />
CVT 142, innestato su Kober 5bb<br />
ed ha una superficie totale di 2000 m 2<br />
circa. Il sistema di allevamento è a pergola<br />
ed i filari sono disposti in terrazzi<br />
con muri di contenimento in pietra. Il<br />
suolo è franco-sabbioso con presenza<br />
diffusa di scheletro e l’interfilare è perennemente<br />
inerbito. Le distanze di<br />
impianto sono di 1 m sulla fila e, circa,<br />
2,70 m tra le file. All’interno di un filare,<br />
sono state individuate 2 piante poste<br />
a distanza di 20 m e ad ogni pianta<br />
scelta sono state inserite due sonde<br />
elettroniche per la misura in continuo<br />
del contenuto volumetrico percentuale<br />
di acqua nel suolo (VWC).<br />
Per misurare direttamente lo stato idrico<br />
del meleto e del vigneto, 20 piante<br />
di melo per il triennio estivo 2008,<br />
2010 e 2011 e 10 piante di vite nell’estate<br />
del 2012, sono state periodicamente<br />
sottoposte alla misura fogliare<br />
del potenziale idrico (ψb ,valori espressi<br />
in MPa). La determinazione è avvenuta<br />
con la camera a pressione (Scholander<br />
et al., 1965): ψb è misurato prima<br />
dell’alba, quando la pianta è in equilibrio<br />
idrico con il suolo poiché ha ancora<br />
gli stomi chiusi. Le piante utilizzate per<br />
Il<br />
44 Agricoltura <strong>81</strong>
informazione tecnica<br />
la determinazione di ψb erano tutte vicine al punto di inserzione<br />
delle sonde, alla medesima quota altimetrica. Si ritengono valori<br />
soglia -0,4 MPa al di sotto dei quali le piante sono in stress idrico<br />
(Williams et al. , 2002).<br />
Grazie alla presenza di una centralina meteo adiacente ad entrambi<br />
gli appezzamenti è stato possibile compilare i bilanci idrici<br />
giornalieri calcolati come differenza tra la precipitazione giornaliera<br />
espressa in mm e l’evapotraspirazione effettiva in mm<br />
(ETE), parametri che possono essere utili per definire i volumi<br />
idrici utilizzabili per una irrigazione di precisione. L’evapotraspirazione<br />
effettiva è stata calcolata usando la formula proposta da<br />
Blaney-Criddle (Allen et al. , 1986).<br />
Nel meleto per il triennio di indagini estive, sono state utilizzate<br />
le sonde tipo Watermark che forniscono dei valori di potenziale<br />
idrico del suolo espressi in kPa. Valori intorno allo 0 kPa indicano<br />
che il suolo è saturo d’acqua mentre valori intorno a 200 Kpa<br />
indicano che il suolo è secco. Le sonde sono state poste a tre<br />
livelli di profondità, 0,20 m, 0,35 m e 0,50 m ed eseguivano una<br />
lettura ogni ora.<br />
Nel vigneto, per l’annata 2012, sono state utilizzate delle sonde<br />
tipo Soilmoisture che riportano valori del contenuto idrico<br />
volumetrico percentuale del terreno (VWC). In un suolo franco<br />
sabbioso è normale trovare valori compresi tra 0, asciutto e<br />
35%, ritenzione idrica massima (http://weather.nmsu.edu/models/irrsch/soiltype.html).<br />
In tutti i casi i valori letti in continuo<br />
venivano registrati da un datalogger esterno.<br />
Risultati<br />
La figura 1 riporta tre grafici delle annate 2008, 2010 e 2011<br />
relative al meleto sperimentale. I tre diagrammi esposti mostrano<br />
un buon riscontro dei dati relativi all’andamento triennale<br />
dell’evapotraspirazioni giornaliere, dell’umidità del suolo ed il<br />
potenziale idrico della piante. Nell’ambito di ogni anno si verifica<br />
una corrispondenza tra l’umidità del suolo ed il potenziale<br />
idrico delle piante.<br />
La figura 2, riporta due grafici dell’anno 2012. I diagrammi presentano<br />
una buona riproducibilità dei dati ottenuti dalle due<br />
sonde Soilmoisture e poste su due diverse viti. Il confronto della<br />
umidità del suolo negli strati a 20 e 40<br />
cm forniti dalle due sonde ed i risultati<br />
del potenziale idrico di base della<br />
piante mostra un buon accordo sul<br />
valore del grado di idratazione delle<br />
viti. Inoltre i due grafici della figura 2<br />
presentano risultati ripetibili ottenuti<br />
dalle due sonde impiegate.<br />
Figura 2: Sintesi delle determinazioni effettuate nell’ annata 2012 nel vigneto. Confronto tra le precipitazioni<br />
giornaliere espresse in mm, andamento dell’umidità % degli strati del suolo (VWC) nei 2<br />
siti monitorati con le sonde Soilmoisture e andamento del potenziale idrico di base (MPa), espresso<br />
come valore medio di 5 piante limitrofe al punto di inserzione delle sonde, nel periodo considerato.<br />
Conclusioni<br />
La determinazione contemporanea dei<br />
parametri climatici del meleto mediante<br />
la compilazione dei bilanci idrici e<br />
lo studio dell’umidità del suolo a differenti<br />
profondità (0,20-0,50 m) ha<br />
permesso di rilevare le dinamiche del<br />
movimento dell’acqua nel suolo. In<br />
base a questo risultato è possibile concludere<br />
che eventi piovosi distribuiti in<br />
più giorni (50 mm in 2-3 gg.), sono<br />
sufficienti ad idratare gli strati più<br />
profondi del suolo, mentre lo strato<br />
superficiale (0,20 m) si umidifica con<br />
piogge giornaliere di almeno 10-20<br />
mm. La determinazione del potenziale<br />
Agricoltura <strong>81</strong><br />
45
informazione tecnica<br />
idrico di base dei meli (ψb) ha messo in evidenza che piogge sia<br />
intense e distribuite in poco tempo (>30mm/g), sia frequenti ma<br />
con volumi limitati, non sono sufficienti a garantire un adeguato<br />
stato idrico dei meli nelle condizioni colturali considerate.<br />
Nelle condizioni colturali indicate, il monitoraggio dell’umidità<br />
degli strati superficiali (0,20-0,35m) permette di individuare le<br />
soglie d’intervento con maggior precisione.<br />
Interpolando i valori di potenziale idrico del melo e della vite (ψb)<br />
con i relativi valori delle sonde Watermark e Soilmoisture è stato<br />
possibile studiare le correlazioni tra i metodi in studio (fig. 3). Ciò<br />
ha permesso di individuare le soglie di intervento, necessarie per<br />
programmare opportune lavorazioni del suolo (erpicature) utili a<br />
conservare l’umidità del terreno e a limitare lo stress idrico, o nel<br />
caso si abbia a disposizione un impianto di irrigazione a goccia,<br />
a programmare turni di adacquamento.<br />
La nostra sperimentazione ha permesso di validare un metodo<br />
alternativo alla determinazione classica del potenziale idrico delle<br />
piante, fornendo parametri di facile utilizzo. Il valore della soglia<br />
di intervento riferito al meleto risulta di 100-120 kPa quando si<br />
utilizzano sonde del tipo Watermark, mentre per le sonde del tipo<br />
Soilmoisture, utilizzate nel vigneto, la soglia di intervento viene<br />
stabilita quando si scende al di sotto di valori compresi tra 10-15<br />
% del contenuto idrico volumetrico teorico del terreno (VWC). I<br />
due diversi sensori da noi verificati presentano una buona affidabilità<br />
e ripetibilità nella registrazione dell’umidità del terreno.<br />
Attualmente questo tipo di studi richiede una ricerca sistematica<br />
sulle diverse classi dei suoli. La ricerca da noi effettuata indica un<br />
positivo sviluppo dell’agricoltura di precisione.<br />
Figura 3: Correlazione tra il metodo che utilizza la camera a pressione<br />
ed i valori riscontrati con le sonde Watermark (sopra) e Soilmoisture a<br />
20 cm di profondità (p 0,05). I valori sono espressi in kPa.<br />
46 Agricoltura <strong>81</strong>
informazione tecnica<br />
Varieta’ di orzo e frumento tenero<br />
in Piemonte nell’annata agraria 2012-<strong>2013</strong><br />
Ricerca Finanziata dalla Regione Piemonte<br />
Carlo Ferrero, Andrea Pilati - Capac<br />
Roberta Pons - Cooperativa Agrovalli<br />
Nell’annata agraria 2012-<strong>2013</strong> si sono svolte in Piemonte le prove<br />
di confronto varietale cereali a paglia (orzo e frumento tenero),<br />
nell’ambito delle reti nazionali coordinate dal Consiglio per la Ricerca<br />
e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) attraverso le Sezioni<br />
competenti. L’attività fa parte di una realtà ormai consolidata che è<br />
di supporto agli operatori, tecnici e agricoltori, nelle scelte colturali<br />
nel settore dei cereali a paglia.<br />
Impostazione delle prove<br />
Le prove di frumento tenero sono state condotte nelle<br />
località di Cigliano (VC), Poirino (TO) e Cuneo (fraz.<br />
San Pietro del Gallo). Le prove orzo sono state realizzate<br />
nelle località di Cigliano e Cuneo. Sono state<br />
poste a confronto 36 varietà di frumento tenero e 24<br />
varietà di orzo comuni a tutta la rete nazionale.<br />
Le prove parcellari sono organizzate in uno schema<br />
a blocchi randomizzati con 3 repliche. Ogni parcella<br />
sperimentale è stata seminata utilizzando una seminatrice<br />
parcellare a 12 file con interfila di 13,6 cm. Le<br />
parcelle sperimentali, lunghe circa 6,5 m, hanno una<br />
superficie media di 10,6 m2 e sono separate tra loro<br />
da uno stradino di circa 1 m. Sono state rilevate: la<br />
data di spigatura, l’altezza della pianta, l’allettamento<br />
in spigatura e a maturazione, l’incidenza delle malattie:<br />
septoriosi fogliare e fusariosi della spiga per il frumento<br />
tenero ed elmintosporiosi fogliare per l’orzo, nella sola località<br />
di Cuneo è stato fatto un ulteriore rilievo per l’oidio su frumento<br />
tenero e rincosporiosi su orzo. Per il frumento tenero è stata determinata<br />
la densità colturale di alcune cultivar mediante il conteggio<br />
delle spighe per m2. Alla raccolta sono state rilevate la resa unitaria,<br />
l’umidità, il peso ettolitrico e il peso dei mille semi; mediante stru-<br />
Tab. 1: Principali caratteristiche delle località di prova e della tecnica colturale adottata<br />
CIGLIANO (VC) POIRINO (TO) CUNEO<br />
Altezza (m slm) 250 250 500<br />
Suolo : tessitura franco sabbioso franco limoso medio impasto<br />
Precessione colturale mais granella mais granella mais granella<br />
Data di semina orzo 07/11/12 03/11/12<br />
f. tenero 07/11/12 25/10/12 03/11/12<br />
Numero semi germinabili<br />
frumento 450 450 450<br />
/ m 2 orzo 350<br />
350<br />
Concimazione presemina<br />
Concimazione copertura<br />
N (kg/ha)<br />
N (kg/ha) 15 0 0<br />
P2O5 (kg/ha) 40 0 0<br />
K2O (kg/ha) 80 115 125<br />
data 11/03/13 12/03/13 21/03/13<br />
f. tenero 140 140 100<br />
orzo 70 50<br />
Diserbo Logran Hussar maxx Logran<br />
data 15/03/13 18/03/13 22/03/13<br />
Trattamento fungicida f. tenero Tiptor Ultra Tiptor Ultra<br />
spigatura<br />
Raccolta orzo 26/06/13 12/07/13<br />
f. tenero 04/07/13 08/07/13 19/07/13<br />
Agricoltura <strong>81</strong><br />
47
informazione tecnica<br />
Tab. 2: Caratteristiche produttive medie delle 24 cultivar di orzo in prova in parcella nel 2012-<strong>2013</strong>.<br />
Cultivar<br />
Spiga*<br />
Produzione<br />
(q/ha al 13%<br />
di um.)<br />
CIGLIANO (VC) CUNEO MEDIA<br />
Peso ettolitrico<br />
(kg/hl)<br />
Altezza<br />
pianta (cm)<br />
Produzione<br />
(q/ha al 13%<br />
di um.)<br />
Peso ettolitrico<br />
(kg/hl)<br />
Altezza<br />
pianta (cm)<br />
Produzione<br />
(q/ha al 13%<br />
di um.)<br />
Peso ettolitrico<br />
(kg/hl)<br />
ATLANTE P 64,0 59,6 86 74,9 54,7 82 69,5 57,2 84<br />
ALIMINI P 65,0 56,6 86 67,4 56,0 84 66,2 56,3 85<br />
AZZURRO P 57,7 61,8 84 72,8 59,4 83 65,3 60,6 83<br />
DINGO P 66,7 61,6 86 62,1 59,5 82 64,4 60,6 84<br />
KETOS P 61,3 60,6 84 65,4 59,9 83 63,4 60,3 84<br />
CALANQUE D 60,7 64,3 83 64,7 61,1 87 62,7 62,7 85<br />
ORTILUS D 63,0 62,4 68 61,2 59,7 75 62,1 61,1 72<br />
ESTIVAL P 68,0 60,1 78 55,5 57,6 78 61,8 58,8 78<br />
CLARICA D 60,3 65,1 84 62,8 62,8 78 61,6 64,0 <strong>81</strong><br />
AQUIRONE D 54,7 65,2 75 67,7 62,8 76 61,2 64,0 76<br />
COMETA D 48,0 62,5 74 73,6 61,9 <strong>81</strong> 60,8 62,2 78<br />
CALLAS D 61,0 64,0 80 59,6 60,9 84 60,3 62,4 82<br />
LISBONA D 57,0 65,1 67 62,2 61,5 73 59,6 63,3 70<br />
FLANELLE D 61,3 65,6 77 54,2 63,3 72 57,8 64,5 75<br />
PANDORA D 45,3 62,4 74 68,8 61,7 83 57,1 62,0 79<br />
SIRIO D 51,7 66,6 74 60,6 64,1 72 56,2 65,3 73<br />
LAVERDA P 42,0 59,8 88 69,8 58,5 86 55,9 59,2 87<br />
SHANGRILA P 51,0 58,8 84 59,8 57,4 84 55,4 58,1 84<br />
ATOMO D 54,3 64,3 85 56,2 61,7 89 55,3 63,0 87<br />
SFERA D 57,3 65,5 72 51,2 61,3 74 54,3 63,4 73<br />
MARTINO P 45,0 59,3 <strong>81</strong> 60,1 58,2 80 52,6 58,7 <strong>81</strong><br />
PANAKA D 57,7 63,5 77 45,2 59,4 77 51,5 61,5 77<br />
GIGGA P 40,7 60,5 96 55,3 59,4 85 48,0 60,0 91<br />
MATTINA P 31,0 61,1 86 63,0 59,4 87 47,0 60,2 87<br />
MEDIA 55,2 62,3 80 62,3 60,1 <strong>81</strong> 58,7 61,2 <strong>81</strong><br />
* P = Polistica, D = Distica<br />
Altezza<br />
pianta (cm)<br />
mentazione “Infratec 1241 Grain Analyzer”, con metodologia NIR,<br />
su frumento tenero è stato analizzato il contenuto proteico, la percentuale<br />
sulla sostanza secca di glutine umido e l’indice di Zeleny.<br />
Le prove di frumento tenero di Cigliano e Poirino sono state trattate<br />
con fungicida in fase di spigatura, pratica ormai abituale nelle<br />
aziende che puntano a massimizzare le rese della coltura preservandone<br />
la sanità. Sono stati impiegati prodotti fungicidi efficaci<br />
nel controllo della fusariosi della spiga. Nella località di Cuneo non<br />
è stato effettuato il trattamento per valutare la sensibilità delle cultivar<br />
alle malattie fungine.<br />
Le principali caratteristiche ambientali e la tecnica coltura adottata<br />
nelle tre località di prova sono sintetizzate nella tabella 1.<br />
Andamento climatico<br />
Le operazioni di semina si sono svolte regolarmente dalla metà<br />
di ottobre, concludendosi nella prima decade di novembre.<br />
Durante l’inverno si è avuto un buon sviluppo delle colture sin dalle<br />
prime fasi, permettendo di avere un buon investimento ed un ottimo<br />
affrancamento. Al momento della ripresa vegetativa i frumenti<br />
erano in fase di accestimento e in ottime condizioni sanitarie.<br />
La primavera è stata caratterizzata da abbondanti e continue precipitazioni,<br />
ben al di sopra delle medie stagionali, associate a temperature<br />
relativamente basse. Nei mesi di marzo-aprile-maggio si<br />
sono concentrate circa il 50-60 % delle precipitazioni totali cadute<br />
tra ottobre e giugno, che sono state pari a 690 mm a Cigliano,<br />
poco più di 500 mm a Poirino e oltre 700 mm a Cuneo. Il decorso<br />
climatico primaverile ha ritardato o, nel caso di terreni pesanti, impedito<br />
le normali operazioni colturali quali concimazioni azotate<br />
e diserbo. Il perdurare delle piogge anche durante tutto il mese di<br />
maggio ha ritardato o impedito i trattamenti fungicidi in fase di<br />
spigatura, mentre le temperature al di sotto della media stagionale<br />
hanno leggermente ritardato il ciclo di sviluppo.<br />
Le temperature fresche del mese di maggio e giugno, se da un<br />
lato hanno rallentato la maturazione, allo stesso tempo hanno<br />
48 Agricoltura <strong>81</strong>
informazione tecnica<br />
Tab. 3: Caratteristiche produttive medie delle 36 cultivar di frumento tenero in prova nel 2012-<strong>2013</strong>.<br />
CULTIVAR CLASSIFICAZIONE * Produzione q/ha al 13% di um. Peso ettolitrico<br />
(kg/hl)<br />
Cigliano<br />
(VC)<br />
Poirino<br />
(TO)<br />
Cuneo<br />
permesso ai grani di chiudere il ciclo in modo graduale, senza<br />
risentire del fenomeno della stretta, ottenendo ottimi pesi ettolitrici<br />
e buone rese, ad eccezione delle colture in terreni particolarmente<br />
pesanti che hanno sofferto i ristagni primaverili.<br />
Gli attacchi di septoria e di fusariosi della spiga, nonostante le condizioni<br />
di umidità molto favorevoli, sono stati in linea con gli anni<br />
precedenti, probabilmente contenuti dalle basse temperature.<br />
Media delle<br />
3 località<br />
Media delle<br />
3 località<br />
ALTAMIRA FP 79,1 90,5 96,0 88,5 79,3 11,7<br />
SOLEHIO FP 83,1 88,2 92,6 88,0 77,9 10,8<br />
SY ALTEO FB 77,9 89,0 95,1 87,3 76,5 11,1<br />
ALTEZZA FP 77,1 78,6 102,5 86,1 76,9 11,2<br />
CARRACCI FP 75,8 86,0 92,1 84,6 78,9 11,3<br />
GUAPPO FP 78,2 82,9 92,4 84,5 78,3 10,9<br />
ANDALUSIA FP 78,5 88,9 84,2 83,9 77,6 11,7<br />
FORBLANC FP 73,0 83,2 94,9 83,7 78,9 11,7<br />
FARINELLI FP 75,8 80,8 91,7 82,8 77,1 11,5<br />
ADELANTE FP 76,5 <strong>81</strong>,9 88,6 82,3 76,1 11,8<br />
JAGUAR FB 74,4 78,5 93,8 82,2 74,4 10,9<br />
AGAPE FP 77,6 75,2 92,7 <strong>81</strong>,8 77,2 11,4<br />
MIROIR FP 78,2 85,2 80,1 <strong>81</strong>,2 78,0 11,5<br />
CARAVAGGIO FP 69,6 87,7 85,0 80,8 76,6 12,0<br />
ACAPULCO FP 73,2 80,2 88,8 80,7 80,1 11,9<br />
BORA FPS 67,3 82,8 91,7 80,6 78,2 12,5<br />
PR22R58 FP 74,0 <strong>81</strong>,2 85,8 80,3 76,3 10,8<br />
TERRAMARE FP 70,9 77,6 91,2 79,9 77,1 11,9<br />
BRAMANTE FB 69,8 76,6 90,9 79,1 77,8 12,0<br />
AUBUSSON FP 77,3 76,9 83,0 79,1 75,6 11,1<br />
PALEOTTO FP 72,3 74,7 83,8 76,9 79,6 11,4<br />
RAFFAELLO FP 65,2 82,8 82,0 76,7 79,9 12,3<br />
NOGAL FF 71,1 79,3 77,8 76,1 77,2 11,5<br />
BLASCO FPS 68,3 78,6 79,0 75,3 <strong>81</strong>,6 12,6<br />
ELETTA FPS 69,9 73,5 77,4 73,6 80,5 12,3<br />
MICHELANGELO FP 62,4 75,1 82,6 73,4 80,5 12,6<br />
CERERE FPS 64,6 74,1 80,6 73,1 78,0 12,3<br />
ARABIA FB 69,6 73,7 75,2 72,8 79,4 11,7<br />
BOLOGNA FF 66,1 72,6 76,7 71,8 79,7 12,1<br />
AQUILANTE FP 61,6 71,0 79,2 70,6 80,2 12,3<br />
REBELDE FF 68,6 65,9 75,9 70,1 80,6 12,5<br />
SMERALDO FF 71,7 68,1 70,3 70,0 79,7 12,2<br />
STENDAL FPS 57,5 67,6 82,9 69,3 78,9 12,9<br />
CALIFA FF 59,5 62,5 74,7 65,6 78,1 12,9<br />
EXUMA W WX 61,5 66,5 66,1 64,7 76,6 11,7<br />
PROJECT W WX 58,3 58,2 63,8 60,1 77,4 12,0<br />
MEDIA 71,0 77,7 84,5 77,7 78,2 11,8<br />
* FF (frumento di forza), FPS (frumento panificabile superiore), FP (frumento panificabile), FB (frumento biscottiero),<br />
FAU (frumento altri usi)., WX (waxy) * Fonte: CRA-SCV Sant’Angelo Lodigiano.<br />
Contenuto<br />
proteico (%)<br />
Media delle 3<br />
località<br />
Risultati dell’orzo<br />
Nella tabella 2 sono evidenziate le<br />
produzioni medie delle singole varietà<br />
nelle prove di Cigliano e di Cuneo.<br />
La produzione media è stata di 58,7<br />
q/ha, in calo rispetto all’anno scorso,<br />
associata a un peso ettolitrico<br />
medio di 61,2 kg/hl. La spigatura<br />
è avvenuta mediamente a inizio<br />
maggio a Cigliano e nella seconda<br />
decade di maggio a Cuneo. Non<br />
si sono verificati fenomeni di allettamento<br />
in entrambe le località. Le<br />
minori rese sono probabilmente imputabili<br />
alle abbondanti piogge di<br />
aprile e maggio, che hanno influito<br />
negativamente sulla fioritura e sul<br />
successivo riempimento della spiga.<br />
Le varietà più produttive, ma con<br />
un peso ettolitrico al di sotto della<br />
media, sono state le polistiche<br />
Atlante, Alimini, Azzurro, Dingo e<br />
Ketos, tutte di ciclo e altezza media.<br />
Per Alimini è una conferma del<br />
potenziale evidenziato negli anni<br />
precedenti, mentre Atlante e Azzurro<br />
sono al primo anno di prova.<br />
Tra le varietà distiche i migliori risultati<br />
sono stati forniti da Calanque,<br />
Ortilus, Clarica e Aquirone. Ad eccezione<br />
di Ortilus (al primo anno di<br />
prova), le altre varietà confermano<br />
le buone rese dell’anno precedente.<br />
Il peso ettolitrico è risultato<br />
elevato per Clarica e Aquirone e<br />
medio per le altre due cultivar. La<br />
taglia è contenuta per Ortilus e<br />
Aquirone, al contrario Clarica e Calanque sono di taglia medio-alta.<br />
Risultati del frumento tenero<br />
I risultati produttivi medi e le caratteristiche agronomiche delle<br />
varietà in prova sono esposti nella tabella 3 e 4.<br />
La produzione media più elevata si è ottenuta a Cuneo con un<br />
valore medio di 84,5 q/ha, un peso ettolitrico di 78,8 kg/hl e un<br />
Agricoltura <strong>81</strong><br />
49
informazione tecnica<br />
Tab. 4: Caratteristiche agronomiche medie delle 36 cultivar di frumento tenero in prova nel 2012-<strong>2013</strong>.<br />
CULTIVAR Data Spigatura (gg da 1° aprile) Altezza<br />
pianta (cm)<br />
Cigliano<br />
(VC)<br />
Poirino<br />
(TO)<br />
peso dei 1000 semi di 45,6 grammi, mentre la località di Cigliano<br />
ha fornito i valori più bassi, rispettivamente 71 q/ha, 77,3 kg/<br />
hl e 43,6 grammi. La prova di Poirino ha confermato lo stesso<br />
potenziale ottenuto nella precedente campagna con una produzione<br />
media di 77,7 q/ha, un peso ettolitrico di 78,5 kg/hl e un<br />
peso dei 1000 semi di 39,1 grammi, quest’ultimo sensibilmente<br />
più basso rispetto alle altre due località.<br />
Cuneo<br />
Media delle<br />
3 località<br />
Media delle<br />
3 località<br />
A Poirino e a Cuneo si è registrato un contenuto proteico medio del<br />
Septoria fogliare<br />
(0-9)<br />
Media delle<br />
3 località<br />
ACAPULCO 42 43 54 46 76 4 2<br />
ADELANTE 42 42 56 47 76 4 3<br />
AGAPE 45 45 57 49 71 4 1<br />
ALTAMIRA 44 45 57 49 83 4 1<br />
ALTEZZA 43 45 56 48 107 3 0<br />
ANDALUSIA 41 42 55 46 79 4 3<br />
AQUILANTE 39 43 54 45 74 5 2<br />
ARABIA 42 42 55 46 82 5 3<br />
AUBUSSON 44 45 57 49 79 4 1<br />
BLASCO 41 43 54 46 76 5 1<br />
BOLOGNA 44 45 56 48 73 4 1<br />
BORA 42 43 54 46 78 4 2<br />
BRAMANTE 45 45 58 49 75 5 1<br />
CALIFA 36 36 49 40 68 5 5<br />
CARAVAGGIO 40 40 52 44 77 5 2<br />
CARRACCI 43 42 54 46 79 5 3<br />
CERERE 47 49 57 51 91 4 0<br />
ELETTA 43 44 56 48 78 5 2<br />
EXUMA W 39 41 53 44 75 5 4<br />
FARINELLI 45 47 58 50 84 5 0<br />
FORBLANC 47 48 58 51 85 5 0<br />
GUAPPO 47 47 58 51 80 4 0<br />
JAGUAR 44 46 57 49 71 5 1<br />
MICHELANGELO 39 39 53 44 90 4 4<br />
MIROIR 45 45 57 49 86 5 1<br />
NOGAL 43 44 56 48 80 5 1<br />
PALEOTTO 44 44 55 48 73 4 2<br />
PR22R58 46 46 58 50 74 4 1<br />
PROJECT W 45 45 57 49 71 6 2<br />
RAFFAELLO 39 40 52 44 79 6 2<br />
REBELDE 46 46 56 49 74 4 0<br />
SMERALDO 44 44 57 48 91 4 3<br />
SOLEHIO 43 45 56 48 86 4 1<br />
STENDAL 40 40 53 44 89 3 4<br />
SY ALTEO 46 46 57 50 92 4 0<br />
TERRAMARE 43 43 55 47 83 5 1<br />
MEDIA 43 44 55 47 80 5 2<br />
Fusariosi della<br />
spiga (0-9)<br />
Media delle 3<br />
località<br />
12,1 %, contro l’11,1 % di Cigliano.<br />
Si segnala la presenza di septoriosi<br />
fogliare in tutte le località, patologia<br />
che si è manifestata tardivamente<br />
e con valori medi attorno a<br />
4 e 5 in una scala di valutazione da<br />
0 a 9. Sono risultati ovunque contenuti<br />
gli attacchi di fusariosi, sia nelle<br />
due località trattate con fungicida<br />
(Poirino e Cigliano), che nella prova<br />
di Cuneo, non trattata. I valori medi<br />
sono compresi tra 1 e 3, sempre in<br />
una scala di valutazione da 0 a 9.<br />
Non vi sono da segnalare danni da<br />
freddo o fenomeni significativi di allettamento<br />
precoce o tardivo.<br />
Le varietà più produttive nelle tre località<br />
di prova sono state: Altamira, Solehio,<br />
SY Alteo e Altezza (le ultime due<br />
al primo anno di prova), tutte classificate<br />
come panificabili, ad eccezione di<br />
SY Alteo, che è un frumento biscottiero.<br />
Solehio e Altamira confermano<br />
gli ottimi risultati forniti nel 2011 e nel<br />
2012. Solehio ha un tenore proteico<br />
più basso della media, mentre al contrario<br />
le altre varietà citate presentano<br />
livelli medi. Solo Altamira ha evidenziato<br />
un peso ettolitrico al di sopra<br />
della media di campo.<br />
Queste cultivar hanno un ciclo medio<br />
o medio-tardivo e sono di taglia<br />
medio-alta, in particolar modo<br />
Altezza avendo superato i 100 cm,<br />
manifestando nella sola località di<br />
Poirino un lieve allettamento.<br />
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del<br />
presente lavoro, e in particolare le aziende agricole che hanno ospitato<br />
le prove parcellari: Regis Silvio di Cigliano (VC), Molino Giuseppe e<br />
Appendino Michelino di Poirino (TO), Arneodo Roberto di S. Pietro del<br />
Gallo (frazione di Cuneo).<br />
50 Agricoltura <strong>81</strong>
Quaderni della Regione Piemonte<br />
AGRICOLTURA <strong>81</strong><br />
Collana di informazione socio-economica per gli agricoltori<br />
Diffusione gratuita ad aziende agricole, tecnici, organizzazioni professionali, sindacali e cooperativistiche, associazioni di produttori, operatori dell’informazione, amministratori<br />
pubblici, istituti universitari e scolastici.<br />
Redazione presso:<br />
Regione Piemonte<br />
C.so Stati Uniti, 21 - 10128 Torino<br />
Tel. 011 – 4324722 - Fax 011 - 537726<br />
Indirizzo Internet: www.regione.piemonte.it/agri<br />
e-mail: quaderni.agricoltura@regione.piemonte.it<br />
Direttore Responsabile<br />
Luciano Conterno<br />
Vice Direttore<br />
Valentina Archimede<br />
Segreteria<br />
Ester Lavina<br />
Stampa: Stamperia Artistica Nazionale S.p.a. - Trofarello (TO)<br />
Progetto grafico e impaginazione: Carism srl<br />
Tiratura: 60.000 copie<br />
Questo numero è stato chiuso il 14 ottobre <strong>2013</strong><br />
Hanno collaborato a questo numero<br />
Per i testi:<br />
Marco Adamo, Stefano Aimone, Valentina Archimede, Monica Bassanino, Alessandra Brogliatto, Stefano Cavaletto, Massimo Clerico, Lorena Cora, Alberto Cugnetto, Carlo<br />
Ferrero, Emanuela Fontana, Alberto Franchino, Alberto Gennaro, Luca Giordani, Carlo Grignani, Silvio Grosso, Gianfranco Latino, Augusto Marchesini, Andrea Marelli,<br />
Giovanna Mason, Stefano Monaco, Matteo Monchiero, Chiara Morone, Luca Nari, Filomena Nardacchione, Silvana Nicola, Cinzia Orlandini, Elena Ortalda, Mario Perosino,<br />
Andrea Pilati, Roberta Pons, Maria Rosaria Romano, Michela Sigliano, Giovanni Scanabissi, Moreno Soster, Graziano Vittone, Salvatore Vullo, Centro Ricerche Produzioni<br />
Animali – CRPA spa<br />
Per le immagini:<br />
Valentina Archimede, Franco Boasso, Giovanni Boccafogli, Pino Iannò, Andrea Mastrantuono, Fulvio Montano, Mattia Plazio, Settore Fitosanitario Regionale, Archivio Provincia<br />
di Cuneo, Archivio prowein.de, Osservatorio piemontese di frutticoltura (Alberto Geisser)<br />
Registrazione del Tribunale di Torino, n. 4184 del 5 Maggio 1990<br />
Spedizione in abbonamento postale, PT/Magazine NAZ/205/2008<br />
Attività di informazione realizzata nell’ambito del piano di comunicazione del Programma di sviluppo rurale 2007-<strong>2013</strong> (Reg. CE n. 1698/2005 e Reg. CE n. 1974/2006)<br />
Agricoltura è prodotta e stampata rispettando l’ambiente.<br />
Q uaderni<br />
della Regione Piemonte<br />
INSERIMENTO (1)<br />
ANNULLAMENTO (2)<br />
VARIAZIONE (3)<br />
COGNOME<br />
NOME<br />
VIA<br />
FRAZIONE<br />
CITTÀ<br />
CODICE POSTALE<br />
NUMERO<br />
PROVINCIA<br />
RITAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA<br />
(1) Fate una crocetta su questa casella se segnalate un nuovo nominativo.<br />
(2) Fate una crocetta su questa casella se non siete più interessati a ricevere “Quaderni della Regione Piemonte Agricoltura”.<br />
(3) Fate una crocetta su questa casella se la rivista arriva con un indirizzo sbagliato o se avete cambiato abitazione.<br />
Si prega di allegare l’etichetta - Riportare l’indirizzo e il codice utente<br />
Questo tagliando va spedito a “Quaderni della Regione Piemonte - Agricoltura” - Corso Stati Uniti, 21 - 10128 Torino Q.A. <strong>81</strong>/<strong>2013</strong><br />
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati personali del sottoscrittore, forniti con questa richiesta, è finalizzato<br />
unicamente all’espletamento delle attività intese all’attivazione dell’abbonamento o a sue modifiche, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento.
ISSN 1972 - 9405<br />
Per tutte le informazioni su pagamenti e politiche agricole<br />
risponde il numero verde della Regione Piemonte<br />
800.333.444<br />
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, festivi esclusi<br />
GRATUITO DA TELEFONO FISSO E MOBILE<br />
Per richiedere informazioni tramite e-mail:<br />
infoagricoltura@regione.piemonte.it