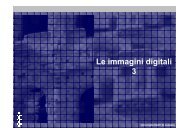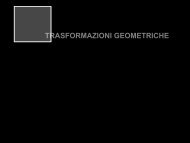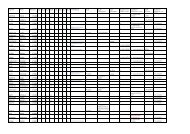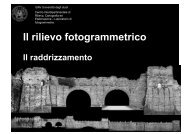134/04 Giornale 24_Maffioletti - Circe - Università IUAV di Venezia
134/04 Giornale 24_Maffioletti - Circe - Università IUAV di Venezia
134/04 Giornale 24_Maffioletti - Circe - Università IUAV di Venezia
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Iuav : 59 3Progettare facciate,creare architetturaAndrea GuerraNella vasta e articolata opera <strong>di</strong> AndreaPalla<strong>di</strong>o (1508-1580) le chiese rappresentanoun corpus <strong>di</strong> architetture omogeneoe circoscritto, concentrato nellacittà <strong>di</strong> <strong>Venezia</strong>. La sua riconoscibilitàè data dalle facciate, tutte dotate <strong>di</strong>uno schema compositivo simile: unor<strong>di</strong>ne maggiore <strong>di</strong> semicolonne sormontateda timpano, corrispondentealla più alta navata centrale, fiancheggiatoda un or<strong>di</strong>ne minore <strong>di</strong> pilastricon semitimpani, corrispondenti allepiù basse navate o cappelle laterali.Questo schema è applicato per la primavolta da Palla<strong>di</strong>o in San Francesco dellaVigna (1564-65), la cui facciata è interamenterealizzata sotto la sua <strong>di</strong>rezione,ma è ripreso con varianti anche nelRedentore (dal 1577), in San Pietro <strong>di</strong>Castello (progetto del 1559 realizzatocon mo<strong>di</strong>fiche nel 1594-96) e in SanGiorgio Maggiore (progetto del 1565,realizzato con mo<strong>di</strong>fiche nel 1597-1611).La soluzione adottata era la risposta piùcoerente a un problema secolare, emersoin età umanistica con il recupero dellinguaggio antico degli or<strong>di</strong>ni: comeconciliare le altezze <strong>di</strong>fferenti dellenavate interne con un prospetto esternounitario, dotato <strong>di</strong> colonne o pilastricon precisi rapporti proporzionali?La facciata si poteva rivestire con ununico or<strong>di</strong>ne, ma le colonne, per rispettareil vincolante rapporto fra base ealtezza, avrebbero dovuto avere un <strong>di</strong>ametromolto grande; oppure si potevanoinserire or<strong>di</strong>ni sovrapposti. Nessunadelle due soluzioni, tuttavia, permetteva<strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nare in modo coerente lastruttura esterna con gli spazi <strong>di</strong>fferenziatidell’interno.Palla<strong>di</strong>o inventa una composizione originale:interseca un or<strong>di</strong>ne maggioree uno minore, e stabilisce fra loro unachiara gerarchia che corrisponde aquella degli spazi interni. Questa intersezioneriesce a creare anche una forteinter<strong>di</strong>pendenza fra tutti gli elementidella facciata stessa. Le basi, i capitelli,le trabeazioni sono rilegati fra loro dasottili ma visibili risalti, che permettono<strong>di</strong> leggere la continuità tra le singoleparti e, insieme, la loro <strong>di</strong>stinzione.L’aspetto complessivo è una sequenzaorganizzata <strong>di</strong> elementi principali esecondari, <strong>di</strong>sposti secondo una accuratasintassi.Questa or<strong>di</strong>nata composizione è anchel’esito delle tecnica grafica sempre utilizzatada Palla<strong>di</strong>o nella fase <strong>di</strong> progetto,ossia il <strong>di</strong>segno in proiezione ortogonale.Esso consente <strong>di</strong> verificare lacorrispondenza delle quote fra internoed esterno, ma permette anche <strong>di</strong> proiettaree vedere sullo stesso piano strutturee spazi posti a <strong>di</strong>verse profon<strong>di</strong>tà –or<strong>di</strong>ni architettonici, navate, cappelle –e<strong>di</strong> immaginare volumi laddove c’è soltantoun segno bi<strong>di</strong>mensionale.Il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong>venta uno strumento altamentecreativo, in grado <strong>di</strong> trasfiguraregli elementi costitutivi del progetto:Palla<strong>di</strong>o lo utilizza per manipolare congrande <strong>di</strong>sinvoltura le fonti romaneantiche, alcune ben note, come il pronao<strong>di</strong> tempio o l’arco trionfale, altrepiù rare e ricercate, come la soluzionedei semitimpani. La profonda conoscenzadel linguaggio romano gli permette<strong>di</strong> liberarsi dalla <strong>di</strong>ttatura deimodelli, e <strong>di</strong> ricomporli, attraverso il<strong>di</strong>segno, in qualcosa <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>calmentenuovo.Come in ogni altra sua architettura, sipensi all’impianto delle ville in terraferma,anche nelle facciate delle chieseveneziane la semplicità dello schemanasconde una composizione <strong>di</strong>fficile.È storicamente significativo che la ricezionedell’architettura ecclesiastica <strong>di</strong>Palla<strong>di</strong>o si sia trasmessa in via prevalenteattraverso lo stu<strong>di</strong>o dei prospetti.A partire dal Settecento essi sonostati spesso raffigurati come un elementoautonomo, staccato dal restodell’e<strong>di</strong>ficio. La loro rappresentazionecome lastre in pietra, senza relazionealla struttura retrostante né al contestourbano, ha accentuato la percezione<strong>di</strong> composizioni chiuse in se stesse,sciolte da legami con l’intorno. Il‘capriccio’ <strong>di</strong> Canaletto, con SanFrancesco della Vigna in una ambientazionefantastica, esprime precisamentequesto predominio assolutodella facciata: la sua sola presenzabasta a creare l’architettura e il suo contesto.La celebre e geniale interpretazionedata da Rudolf Wittkower (1949) dellafacciata <strong>di</strong> San Francesco della Vigna,vista come l’interpenetrazione <strong>di</strong> duefronti <strong>di</strong> tempio, si inserisce in questopercorso storico e critico <strong>di</strong> lungo periodo.Che l’architettura delle facciate sipotesse leggere come un tema autonomo,del resto, era suggerito dallostesso Palla<strong>di</strong>o: il progetto per SanPietro <strong>di</strong> Castello (1559) e quello perSan Francesco della Vigna erano staticoncepiti come semplice rivestimento<strong>di</strong> chiese preesistenti.I nuovi rilievi laser-scanner permettonoora <strong>di</strong> confrontare l’intera serie dei quattroprospetti. La riproduzione a grandescala consente <strong>di</strong> apprezzare le singoleparti, fino al montaggio e alle giunzionidei conci, dei capitelli, delle basi: sipuò scendere nel dettaglio delle modanature,e valutare l’apporto degli scalpellinialla composizione dell’insieme.Al <strong>di</strong> là dell’uniformità dello schema,dalle facciate emergono molte <strong>di</strong>fferenze,che raccontano del mutare <strong>di</strong>capomastri e lapici<strong>di</strong>, e <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi committentie <strong>di</strong>verse risorse finanziarie.Nella successione dei quattro cantieriè già visibile il processo <strong>di</strong> <strong>di</strong>vulgazionedei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> Palla<strong>di</strong>o: a pochi annidalla sua morte si riprendono i suoi stilemi,e inizia già in <strong>Venezia</strong> il fenomenodel cosiddetto ‘palla<strong>di</strong>anesimo’, chetanta fortuna avrà in Europa e negliStati Uniti nel corso dei successivi duesecoli.Per tali motivi i rilievi vanno letti conattenzione, quasi con lentezza. Le molteinformazioni in essi contenute ne fannoun documento unico e in<strong>di</strong>spensabileper quanti intendono approfon<strong>di</strong>re l’operae la tecnica <strong>di</strong> Palla<strong>di</strong>o.Riportare lo sguardo sul dettaglio <strong>di</strong>queste straor<strong>di</strong>narie composizioni è ilfine non ultimo dell’esposizione: lamodanatura, come ci ricorda chi benconosceva l’arte <strong>di</strong> vedere, resta sempre“la pietra <strong>di</strong> paragone dell’architetto”.immagininella pagina accantoModello dell’or<strong>di</strong>ne maggiore<strong>di</strong> San Francesco della Vignain questa paginaSan Francesco della VignaRedentore, capitello compositoRudolf Wittkower, Schema dell’intersezione<strong>di</strong> due fronti <strong>di</strong> tempio
Iuav : 59 4Rilievi e conoscenza delle facciatepalla<strong>di</strong>ane fra Sette e OttocentoPaola ModestiLa ricostruzione della chiesa <strong>di</strong> SanGiorgio Maggiore, sull’isola-monastero<strong>di</strong> fronte al Palazzo Ducale (dal 1566),e l’innalzamento del tempio votivo delRedentore, rivolto verso la città lungoil canale della Giudecca (dal 1577), incidonoprofondamente sull’aspetto urbano<strong>di</strong> <strong>Venezia</strong>. Le imponenti massebianche con gigantesche colonne delledue facciate <strong>di</strong>ventano elementi <strong>di</strong>spicco nel profilo della celebre città fondatasull’acqua. Ma, al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> una facilee superficiale notorietà, per più <strong>di</strong>un secolo la conoscenza della loroarchitettura non sembra avere superatol’ambito locale.L’originale soluzione architettonica concepitada Palla<strong>di</strong>o non è infatti illustratanei Quattro libri dell’architettura(<strong>Venezia</strong>, 1570). E fino al Settecentopochi architetti e intendenti intraprendonoun viaggio per vedere <strong>di</strong> personale opere palla<strong>di</strong>ane.Anche l’esecuzione dei primi rilievi sembrarisalire al Settecento, e in particolareall’arrivo a <strong>Venezia</strong> <strong>di</strong> architetti e<strong>di</strong>lettanti stranieri, innanzitutto inglesi.Nel 1719 Lord Burlington, gentiluomoe architetto (1694-1753), commissionasul luogo <strong>di</strong>segni degli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong>Palla<strong>di</strong>o. Egli stesso si sofferma su SanGiorgio Maggiore, e in particolare sullafacciata, tracciandone uno schizzo(riprodotto nella mostra, I.1). In seguitofa incidere e pubblicare il prospetto,la pianta e le due sezioni della chiesanel volume de<strong>di</strong>cato all’opera <strong>di</strong>Inigo Jones, l’artista che nel secolo precedenteaveva introdotto la tra<strong>di</strong>zionearchitettonica rinascimentale e palla<strong>di</strong>anain Inghilterra (The Designs ofInigo Jones, 1727). Le incisioni si <strong>di</strong>mostranoaccurate e dettagliate nel contestodei <strong>di</strong>segni settecenteschi. Quellacon la facciata, visibile in mostra (I.2<strong>di</strong>segno preparatorio, e I.3 tavola incisa),può essere ora accostata a un <strong>di</strong>segnoautografo ine<strong>di</strong>to <strong>di</strong> AntonioVisentini (II. 3), e le analogie induconoa chiedersi se non sia stato questoartista veneziano a eseguire il rilievooriginale perduto.All’inizio degli anni venti Visentini concepisceun ambizioso progetto e<strong>di</strong>toriale,che presuppone forse i rilievirichiesti da Lord Burlington e <strong>di</strong> certola presenza, in città, <strong>di</strong> viaggiatori interessatiall’architettura: fare stamparepiante, prospetti e sezioni dei migliorie<strong>di</strong>fici veneziani su suo <strong>di</strong>segno. È aquesto progetto rimasto incompiutoche possono essere ricondotti i <strong>di</strong>segniautografi delle quattro facciate resi notiin questa mostra, singolari per l’impaginazione,il grado <strong>di</strong> dettaglio e la resapittorica delle ombre (II. 1-5). Il primodei due prospetti <strong>di</strong> San Francesco dellaVigna, considerato rispetto alla precisionedei nuovi rilievi fotogrammetrici,risulta straor<strong>di</strong>nariamente fedele all’e<strong>di</strong>ficio,ma gli altri <strong>di</strong>segni alterano leproporzioni delle facciate, e in tuttisono stati mo<strong>di</strong>ficati alcuni dettagli.Le “inesattezze” sono comprensibiliconsiderando che Visentini è pittore e<strong>di</strong>segnatore prima che architetto e chei <strong>di</strong>segni sono copie, e non meccaniche,<strong>di</strong> materiale preparato per unapubblicazione non specialistica.Negli stessi anni anonimi <strong>di</strong>segnatoririproducono le facciate per un mercatoamatoriale in maniera molto piùschematica e libera, come evidenzial’accostamento <strong>di</strong> sette prospetti <strong>di</strong> SanFrancesco della Vigna. Queste tavoleappartengono a raccolte omogenee <strong>di</strong><strong>di</strong>segni compiuti per il Console britannicoa <strong>Venezia</strong> Joseph Smith (1673/4?-1770) e probabilmente, tramite questi,per viaggiatori suoi connazionali (III.1-7). Al ritorno dal Grand Tour, i gentiluominiinglesi potevano sfogliarlericordando il viaggio e conversando sull’architettura,una <strong>di</strong>sciplina appresain modo elementare in Italia.Accanto alla sostanziale uniformitàdelle tavole create per i <strong>di</strong>lettanti risaltala varietà dei grafici eseguiti dagliarchitetti, inglesi e francesi.Nella mostra sono esposte riproduzioni<strong>di</strong> schizzi abbozzati sul posto daJames Stuart (IV.1-3), tavole elaboratea posteriori da Pierre-Adrien Pâris (IV.4-5), e infine <strong>di</strong>segni ricalcati da CharlesBarry dalle incisioni delle Fabbriche piùcospicue <strong>di</strong> <strong>Venezia</strong> (1820) (IV. 6-7).Roma, non <strong>Venezia</strong>, è il luogo della formazionedegli aspiranti architetti europei.Di solito essi visitano il Veneto egli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> Palla<strong>di</strong>o lungo la via delritorno. Pochi sembrano avere personalmenterilevato le facciate palla<strong>di</strong>ane,forse perché l’opera del maestro cinquecentescoè ora giu<strong>di</strong>cata rispettoagli exempla antichi.Del resto, dalla metà del secolo le facciatepossono essere conosciute tramitela stampa, grazie alle incisioni e aitesti pubblicati nell’Architettura <strong>di</strong>Andrea Palla<strong>di</strong>o vicentino <strong>di</strong> nuovoristampata <strong>di</strong> Francesco Muttoni (1743)e nelle Fabbriche e i <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> AndreaPalla<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Ottavio Bertotti Scamozzi(1783). Muttoni rileva la necessità <strong>di</strong>riprodurre fedelmente a uso dei “viaggiatoriintendenti” gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> Palla<strong>di</strong>onon compresi nei Quattro Libridell’Architettura, ma il suo concetto <strong>di</strong>“esattezza”, come emerge dalle tavolein mostra (V.1-5), è vago e non corrispondea quello <strong>di</strong> esigenti architettie stu<strong>di</strong>osi suoi contemporanei, qualiTommaso Temanza e Ottavio BertottiScamozzi. Finalmente, nelle Fabbriche ei <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> Andrea Palla<strong>di</strong>o, lo stessoBertotti Scamozzi rende <strong>di</strong>sponibili rilievicorredati <strong>di</strong> misure (V.6-8).Il confronto con i rilievi fotogrammetricirivela che i prospetti apparsi successivamentenella lussuosa pubblicazionerealizzata dall’Accademia veneziana<strong>di</strong> Belle Arti con la <strong>di</strong>rezione delconte Cicognara, le già ricordateFabbriche più cospicue <strong>di</strong> <strong>Venezia</strong> (V.9, 11, 13), sono meno precisi <strong>di</strong> quelli<strong>di</strong>segnati da Bertotti Scamozzi.Gli Accademici sembrano essere statipiù interessati alla registrazione accuratadegli or<strong>di</strong>ni e delle modanature,proposti in gran dettaglio come“modelli” (V. 10, 12). Ma i loro prospettisono stati i più riprodotti fino ai nostrigiorni negli stu<strong>di</strong> palla<strong>di</strong>ani, un successoverosimilmente dovuto alla scelta<strong>di</strong> rinunciare alle ombre a favore <strong>di</strong>“puri contorni”.Fra tutte le immagini sette-ottocenteschequi esposte, quelle uscite dall’Accademiaappaiono le più “oggettive”,ma sono anche le più astratte nel nonfornire in<strong>di</strong>cazioni sulla consistenza esugli spessori delle facciate. Sonosegno tanto “puro” da risultare in fondole più <strong>di</strong>stanti dalla realtà del paesaggioveneziano, nel quale le masse bianchedelle architetture palla<strong>di</strong>ane dasempre risaltano e si trasformano almutare della luce.immagini1 San Giorgio Maggiore, prospetto dellafacciata, incisione in William Kent, The Designsof Inigo Jones: Consisting of Plans and Elevationsfor Publick and Private Buil<strong>di</strong>ngs… with SomeAd<strong>di</strong>tional Designs, London 1770, vol. II, tav. 592 San Francesco della Vigna, prospetto e piantadella facciata con profili della cornice delportale e del basamento, incisione in OttavioBertotti Scamozzi, Le fabbriche e i <strong>di</strong>segni <strong>di</strong>Andrea Palla<strong>di</strong>o, Vicenza 1783, tomo IV,tav. XVII3 Redentore, prospetto della facciata,incisione in Le fabbriche più cospicue <strong>di</strong><strong>Venezia</strong> misurate, illustrate, ed intagliatedai membri della Veneta Reale Accademia<strong>di</strong> Belle Arti, <strong>Venezia</strong> 1820, vol. II132
Iuav : 59 10Il rilievo allo Iuav: il laboratorio <strong>di</strong>fotogrammetria del Sistema deiLaboratoriFrancesco Guerra e Luca PilotIl rilievo assume una importanza deltutto particolare nel campo delle analitichedell’architettura in quanto si presentain una duplice veste: da una parteè una delle possibili analitiche, dall’altraè lo strumento <strong>di</strong> correlazione e supportoper le altre.Quale analitica, il rilievo stu<strong>di</strong>a la formadell’architettura attraverso le <strong>di</strong>mensionie le geometrie della fabbrica, geometrieche hanno un ruolo essenzialenei processi <strong>di</strong> concezione, costruzionee comprensione del costruito.La geometria è uno degli strumenti cheil progettista utilizza per il concepimentodella fabbrica e attraverso lageometria <strong>di</strong>segnata traduce la suaidea a chi costruisce. Il costruttore a suavolta usa la geometria: tracciare e<strong>di</strong>mensionare sono azioni che necessitano<strong>di</strong> categorie geometriche affermatee riconosciute che fanno da pontetra chi progetta e chi costruisce. Anchechi approccia la fabbrica con volontà<strong>di</strong> conoscenza, tenta una interpretazionericorrendo a logiche geometriche:il rilievo fornisce dati e informazioniper questa interpretazione.È evidente che nel processo <strong>di</strong> rilievonon si possono ricostruire le geometriedel progetto e della costruzione; esistonoinfatti dei punti <strong>di</strong> frattura insormontabilirappresentati dai passaggitra il continuo e il <strong>di</strong>screto: dal continuodel pensiero <strong>di</strong> chi progetta al <strong>di</strong>scretodelle linee che egli <strong>di</strong>segna sullacarta; dal <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> progetto allamateria costruita; dalla fabbrica allarappresentazione del rilievo. A ciò siaggiunge che nella fabbrica sono presentidelle geometrie “accidentali”,<strong>di</strong>verse dalle geometrie “volontarie”ricercate dai progettisti, causate daacca<strong>di</strong>menti volontari o involontari succedutisinel tempo (interventi parziali,aggiunte, ce<strong>di</strong>menti, trasformazioni...).Queste geometrie accidentali sonoanalizzabili e conoscibili con gli strumentidella geometria, ma ci portanoinevitabilmente a costruire modelli(interpretazioni dal punto <strong>di</strong> vista geometrico)che non sono quelli che hannocontribuito al concepimento e allacostruzione. Non si può dunque ricostruireil pensiero progettuale usandocome chiave interpretativa la geometria.Il percorso che va dal progetto allafabbrica nel momento in cui noi la avviciniamo,non è reversibile.Resta però il fatto che il rilievo è unostraor<strong>di</strong>nario strumento <strong>di</strong> analisi:anche se le geometrie che in<strong>di</strong>viduiamonon sono quelle utilizzate da chi è intervenutosulla fabbrica prima <strong>di</strong> noi, restail fatto che lo strumento è lo stesso, cisi muove nello stesso ‘universo geometrico’:il rilievo ci può fornire in<strong>di</strong>cazioni<strong>di</strong> regolarità o <strong>di</strong> trasgressioni geometriche.Le regolarità ci danno unachiave interpretativa generale dellafabbrica, le trasgressioni (geometrieaccidentali) ci danno in<strong>di</strong>cazioni sualcuni fenomeni particolari.Ma il rilievo non è solo analisi delle geometrieper la definizione della formadella fabbrica: esso è strumentale allealtre analitiche in quanto fornisce labase metrica e topologica su cui collocarespazialmente i fenomeni che sivanno stu<strong>di</strong>ando. Spesso, infatti, fenomenimolto <strong>di</strong>fferenti tra loro sono correlatidal fatto che hanno la stessa posizioneo sono reciprocamente collocatisecondo logiche loro proprie. Il servizioche il rilievo rende alle altre <strong>di</strong>sciplineva da quello minimo <strong>di</strong> supportonella creazione delle mappe tematichenella loro espressione grafica, doveviene utilizzato il prodotto finale cartaceodel rilievo (il <strong>di</strong>segno in proiezioneortogonale), a quello più complesso<strong>di</strong> base cartografica numerica deisistemi informativi per la geo-referenziazionedei fenomeni.Tenendo ben presente le considerazionisopra riportate, si sono realizzati irilievi delle quattro facciate delle chiesepalla<strong>di</strong>ane <strong>di</strong> <strong>Venezia</strong>; i rilievi sono inprima istanza la registrazione e la rappresentazionedella forma delle facciate,e su <strong>di</strong> essi si possono svolgereimme<strong>di</strong>atamente tutti quegli stu<strong>di</strong> chetendono a riconoscere costruzioni geometriche,proporzioni e impianti compositivi.Ma come già detto, il rilievo è anchesupporto spaziale <strong>di</strong> ogni altro possibilestu<strong>di</strong>o e per questo deve essere a<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> coloro che stu<strong>di</strong>ano estu<strong>di</strong>eranno le fabbriche <strong>di</strong> Palla<strong>di</strong>o.Si è scelto quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> mettere a <strong>di</strong>sposizionedella comunità scientifica i rilievirealizzati, non solo i <strong>di</strong>segni finalima anche i dati del processo <strong>di</strong> rilievoe <strong>di</strong> elaborazione. La scientificità delrilievo non è solo nella precisione(metricamente intesa) del <strong>di</strong>segno finale.ma è anche e soprattutto nel rigoremetodologico della produzione <strong>di</strong> quel<strong>di</strong>segno. Il metodo scientifico si caratterizzainfatti per la <strong>di</strong>chiarazione deimeto<strong>di</strong> e degli strumenti, per la <strong>di</strong>sponibilitàdei dati e per la possibilità <strong>di</strong>ripetizione <strong>di</strong> ogni fase. Non containsomma solo il risultato, ma anche ilpercorso.Dato che i rilievi realizzati dalLaboratorio <strong>di</strong> Fotogrammetria delSistema dei Laboratori Iuav sono l’ultimopasso <strong>di</strong> una lunghissima sequenza<strong>di</strong> rilievi e rappresentazioni dellechiese palla<strong>di</strong>ane <strong>di</strong> <strong>Venezia</strong>, che comeillustrato costituiscono una storia dell’interpretazionee della <strong>di</strong>ffusionedelle opere <strong>di</strong> Palla<strong>di</strong>o, si è scelto <strong>di</strong>utilizzare gli strumenti e i mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>vulgazionedei nostri tempi: accanto allepubblicazioni a stampa e alla mostrasarà pubblicato e reso liberamenteaccessibile il lavoro via web: i rilievi etutti i materiali prodotti sono infatti a<strong>di</strong>sposizione degli stu<strong>di</strong>osi in un sitoweb de<strong>di</strong>cato al progetto.Tale operazione è stata sicuramentefacilitata dal fatto che i rilievi, comeillustrato nell’articolo seguente, sonosvolti per la totalità con strumenti e tecnologie<strong>di</strong>gitali, ma resta il fatto cheoggi tale scelta <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione del lavoronon è comunque scontata; ne fannotestimonianza, per contrapposizione,le richieste <strong>di</strong> pagamento per l’utilizzazione<strong>di</strong> qualsiasi immagine provenienteda qualsiasi fondo archivistico.La realizzazione della sequenza rilievorappresentazione-<strong>di</strong>ffusionein formatotalmente <strong>di</strong>gitale, ovvero nei mo<strong>di</strong>e con i sistemi del nostro tempo (cfrBalletti, cfr Borgherini), è stata possibileper l’eccellente livello tecnicoscientificodel Sistema dei Laboratori,che riunisce in una unica struttura tuttii laboratori dell’Ateneo, mantenendonele caratteristiche specifiche, anche inrelazione ai settori <strong>di</strong>sciplinari <strong>di</strong> riferimento,ma realizzando sinergie ed economieproprie <strong>di</strong> un sistema.In questo ambito, il rilievo delle facciatepalla<strong>di</strong>ane ha visto l’impegno delLaboratorio <strong>di</strong> Fotogrammetria e delLaboratorio Multime<strong>di</strong>ale MeLa, coor<strong>di</strong>natirispettivamente da FrancescoGuerra e da Malvina Borgherini.In questi Laboratori l’aggiornamentotecnologico e scientifico è continuo,sia in termini <strong>di</strong> conoscenze che <strong>di</strong> strumenti:per lo svolgimento del rilievo edelle rappresentazioni (<strong>di</strong>segni ed elaborazioni)sono stati fatti significativiinvestimenti strumentali che contribuisconoa mantenere il Sistema deiLaboratori Iuav ai più alti livelli nelpanorama nazionale e internazionale.Il Laboratorio <strong>di</strong> Fotogrammetria ha unadotazione hardware e software per lafotogrammetria analitica e <strong>di</strong>gitalecompleta; in particolare preme ricordareche la strumentazione analogica eanalitica (fotocamere metriche e restitutorianalitici), se pur superata dall’evoluzioneverso il <strong>di</strong>gitale, è in perfettaefficienza ed è spesso ancora utilizzata.Questa attenzione verso le tecnologiedel passato è parte significativadel ruolo che l’università deve svolgerein qualità <strong>di</strong> memoria storica anchedelle tecniche. Inoltre il mantenimentovivo <strong>di</strong> alcuni saperi permette <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>carecon cognizione le nuove propostee <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere tra nuovo e nuovismo.Oltre agli aspetti tecnico scientifici, untratto significativo dell’organizzazionedel Laboratorio <strong>di</strong> Fotogrammetria è lapartecipazione alle attività <strong>di</strong> ricerca e<strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> tutte le componentiumane presenti nell’Ateneo: docenti,tecnici, docenti a contratto, assegnisti,dottoran<strong>di</strong> e studenti. In questo modoè facile e naturale il trasferimento <strong>di</strong>conoscenze tra ricerca e <strong>di</strong>dattica,essendo gli attori <strong>di</strong> queste coinvoltiin entrambi i fronti.Per il rilievo delle facciate palla<strong>di</strong>anesono state coinvolte tutte le componenti.Nello specifico, la squadra <strong>di</strong> rilievoha visto la partecipazione <strong>di</strong>:Francesco Guerra, Luca Pilot, SilviaMander, Andrea Adami, Paolo Vernier.Le restituzioni fotogrammetriche sonostate svolte da Luca Pilot. L’e<strong>di</strong>ting dei<strong>di</strong>segni è stato fatto da Andrea Adamiper San Pietro <strong>di</strong> Castello, da CaterinaBalletti per San Francesco della Vigna,da Giovanna Fanello per il Redentoree da Silvia Mander per San Giorgio.Le elaborazioni dei dati da laser scannersono state eseguite da Paolo Vernier.Il lavoro <strong>di</strong> queste persone, finalizzato auna operazione complessa e articolatacome quella effettuata, in cui saperi,competenze, strumenti e spazi vannogestiti in modo coor<strong>di</strong>nato, necessita<strong>di</strong> una macchina organizzativa efficientee robusta, in grado non solo <strong>di</strong>garantire le attività pianificate ma <strong>di</strong>gestire anche l’imprevisto.Nel Sistema dei Laboratori dello Iuavtale ruolo fondamentale è garantitodalla <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> Marisa Scarso e dallecompetenze organizzative e amministrative<strong>di</strong> Anna Colussi e SabrinaToniolo.Sarà forse un limite della nostra generazione,ma questo lavoro ci ha ancorauna volta <strong>di</strong>mostrato che la ricercaha bisogno <strong>di</strong> risorse non solo intellettuali,per le quali si continuano a formaregiovani brillanti , ma anche materiali(strumenti, spazi, finanziamenti,organizzazione): a queste richieste ilSistema dei Laboratori può dare unapositiva risposta.immaginiCampagna <strong>di</strong> rilievo fotogrammetrico.Per assicurare l’ortogonalità dell’asse otticodelle prese, le immagini sono state acquisiteda piattaforme aeree.Campagna <strong>di</strong> rilievo laser scanning.La strumentazione impiegata per il rilievodelle facciate coniuga le potenzialità dellascansione 3d alla fotogrammetria <strong>di</strong>gitale.Il risultato del rilievo è un modello numerico(detto nuvola <strong>di</strong> punti) che descrive lasuperficie architettonica caratterizzandoneanche i materiali.nella pagina accantoIl <strong>di</strong>segno delle facciate delle chiese è ilrisultato della restituzione fotogrammetricaintegrato con la <strong>di</strong>gitalizzazione della nuvola<strong>di</strong> punti. Il primo prodotto è un <strong>di</strong>segno altratto tri<strong>di</strong>mensionale (minuta) da cui èpossibile ricavare in<strong>di</strong>cazione non solo deglielementi architettonici che compongono lafacciata ma anche la loro variazione inprofon<strong>di</strong>tà (utile per l’estrazione <strong>di</strong> profili).La minuta viene quin<strong>di</strong> proiettata rispettoad un piano me<strong>di</strong>o ed e<strong>di</strong>tata per ottenereuna <strong>di</strong>segno congruente con la scala <strong>di</strong>rappresentazione.Nuvola <strong>di</strong> punti <strong>di</strong> San Francescodella Vigna
Iuav : 59 11Tecniche e meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> rilievoCaterina BallettiNella volontà <strong>di</strong> ottenere una conoscenzail più accurata e fedele possibiledelle opere d’arte si inserisce la possibilità,aperta negli ultimi anni dai progressicompiuti nel campo dell’informaticae dell’optoelettronica, dell’utilizzo<strong>di</strong> tecniche ottiche per lo stu<strong>di</strong>odei beni culturali.In particolare, recentemente abbiamoassistito a un rapido sviluppo <strong>di</strong> tecnologie3D ottiche <strong>di</strong> scansione per laconoscenza della forma <strong>di</strong> oggetti adalta complessità morfologica, sviluppoche ne ha affermato l’efficacia comemetodo per l’analisi e la conservazionedei beni culturali.I moderni meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> acquisizione emodellazione tri<strong>di</strong>mensionale consentono<strong>di</strong> rappresentare un oggetto attraversoun modello <strong>di</strong>gitale che coniugale potenzialità visuali delle immagini(normalmente impiegate per la documentazione)alla precisione del rilievo,<strong>di</strong>ventando contemporaneamente supportosia per la visualizzazione che perla valutazione metrica <strong>di</strong> un qualsiasimanufatto <strong>di</strong> interesse storico-artistico,aprendo nuove potenzialità <strong>di</strong> fruizione,catalogazione e stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> beni culturali.In una prospettiva sempre attenta allequestioni <strong>di</strong> manutenzione e conservazione,l’analisi qualitativa e quantitativadell’esistente è punto <strong>di</strong> passaggioobbligato per il progetto <strong>di</strong> conservazione.In questo senso il rilievo critico,inteso come unione del rilevamento(raccolta dati) e della rappresentazione(traduzione ed interpretazionedei dati), integrate con le nuove tecnologie<strong>di</strong> comunicazione, <strong>di</strong>venta iltramite più efficace, preciso e accuratoverso la conservazione e la fruizionedei beni culturali.I rilievi rigorosi delle quattro facciatedelle chiese palla<strong>di</strong>ane, realizzati dallaboratorio <strong>di</strong> fotogrammetria delSistema Laboratori, hanno previsto l’utilizzo<strong>di</strong> strumenti e tecnologie particolarmenteavanzati, consentendo <strong>di</strong>rappresentare l’architettura palla<strong>di</strong>anaattraverso dei modelli <strong>di</strong>gitali conuna precisione geometrica coerente conla scala architettonica 1:50, ma con uncontenuto semantico per la scala 1:20.I <strong>di</strong>segni delle quattro facciate sono ilrisultato dell’integrazione <strong>di</strong> dati provenientidalla topografia, fotogrammetriae laser scanning.Rilievo topograficoIl rilievo topografico ha un ruolo essenzialenella campagna <strong>di</strong> rilevamento.Attraverso <strong>di</strong> esso si definisce infatti ilsistema <strong>di</strong> riferimento locale nel qualevengono riportati tutti i risultati delloperazioni <strong>di</strong> misura.Il rilievo topografico permette <strong>di</strong> tenereinsieme le varie parti in cui il rilievosi compone, parti che si <strong>di</strong>fferenzianoper tecnica o per organizzazione funzionale(spazio e tempo) del lavoro.Oltre a materializzare il sistema <strong>di</strong> riferimento<strong>di</strong> ogni rilievo, il rilievo topograficodetermina la posizione <strong>di</strong> punti <strong>di</strong>appoggio alla fotogrammetria e <strong>di</strong> punti<strong>di</strong> controllo per la registrazione e allineamentodelle nuvole laser scanning.La tecnologia della più recente strumentazionetopografica elettronica forniscesoluzioni <strong>di</strong> grande interesse chegarantiscono notevoli prestazioni: sipensi all’utilizzo delle stazioni totali con<strong>di</strong>stanziometro ad impulsi per il rilievo<strong>di</strong> punti architettonici inaccessibili perl’appoggio fotogrammetrico.Rilievo fotogrammetricoIl ruolo della fotogrammetria comemoderna e rigorosa tecnica <strong>di</strong> rilievo nelcampo dei beni culturali è in<strong>di</strong>scusso:essendo una tecnica non invasiva, <strong>di</strong>rapida acquisizione e con un’ottimaprecisione nella determinazione metricadella geometria e della forma <strong>di</strong>oggetti <strong>di</strong> ogni tipo, ha conosciuto una<strong>di</strong>ffusione sempre maggiore, oggi decisamenteampliata dalle possibilitàofferte dal <strong>di</strong>gitale.Come tecnica, la fotogrammetria trovafondamento nella volontà <strong>di</strong> ricostruirein modo rigoroso la corrispondenzageometrica tra immagine (attualmenteacquisite con camere metriche <strong>di</strong>gitaliad alta risoluzione) e oggetto almomento dell’acquisizione. Questoavviene definendo delle stelle <strong>di</strong> raggi<strong>di</strong> proiezione nello spazio tra i puntiimmagine, i centri <strong>di</strong> presa e i puntioggetto secondo il modello geometricodella prospettiva centrale.I dati che costituiscono il risultato delrilievo fotogrammetrico in campagnasono le immagini <strong>di</strong>gitali formanti imodelli stereoscopici, i dati <strong>di</strong> orientamento,le coor<strong>di</strong>nate dei punti <strong>di</strong>appoggio (nel sistema <strong>di</strong> riferimentogenerale del rilievo). Questi dati sonoutilizzabili in un tempo successivo perdue scopi fondamentali:– ottenere informazioni metriche, infase <strong>di</strong> restituzione, sulla geometria dell’oggetto;– ottenere informazioni qualitative attraversol’interpretazione delle immagini.Ciò che appare però più significativoè che i dati costituiscono un archiviocontinuo aperto nel tempo: continuosignifica che dalla fotogrammetria èpossibile ottenere infiniti dati sull’oggetto;aperto sia perché incrementabileinfinitamente sia perché consultabilein tempi e per scopi <strong>di</strong>fferenti.La restituzione finale consiste in un<strong>di</strong>segno vettoriale tri<strong>di</strong>mensionale,detto “minuta <strong>di</strong> restituzione”, in cui ilrestitutore <strong>di</strong>segna tutto ciò che vedenel modello stereoscopico. Questoprimo risultato non può essere consideratofinale poiché necessita <strong>di</strong> alcuneoperazioni <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ting per risolvere eventualiproblemi del modello stereoscopico(come le zone in ombra, la presenzain alcuni fotogrammi <strong>di</strong> elementi<strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo) e per assicurare la congruenzagrafica e geometrica, oltre chela proiezione finale delle entità <strong>di</strong>segnatesu un piano parallelo all’andamentome<strong>di</strong>o delle facciate.Rilievo laser scanningLa tecnica del laser scanning rappresentaun nuovo ed efficiente metodoper la <strong>di</strong>gitalizzazione e la modellizzazione<strong>di</strong> oggetti e <strong>di</strong> porzioni <strong>di</strong> territorioaventi qualsiasi forma e <strong>di</strong>mensione.Un sistema laser a scansione forniscecome risultato <strong>di</strong>retto <strong>di</strong> una sessione <strong>di</strong>misure un insieme <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nate tri<strong>di</strong>mensionali,generalmente in un sistema<strong>di</strong> riferimento correlato con lo strumento,riferite ad un numero elevatissimo<strong>di</strong> punti che vengono colpiti dalraggio laser.I laser scanner oggi presenti sul mercatosono molti e ognuno <strong>di</strong> essi presentacaratteristiche <strong>di</strong>fferenti nel principio<strong>di</strong> acquisizione, nella precisioneottenibile, nella portata e nella velocità<strong>di</strong> acquisizione dei dati; sono ancorapochi gli strumenti in grado <strong>di</strong> offrireuna flessibilità tale da poterli utilizzarein ambiti molto <strong>di</strong>fferenti. Quin<strong>di</strong>,in funzione della complessità dellaforma e delle <strong>di</strong>mensioni dell’oggettoe considerando il livello <strong>di</strong> precisioneche si richiede, si sceglierà la strumentazionelaser più adatta alle singoleapplicazioni (accuratezza, portata, campo<strong>di</strong> acquisizione). La prima <strong>di</strong>stinzioneè tra laser <strong>di</strong>stanziometrici e lasertriangolatori: i primi trovano applicazionein rilievi architettonici e ambientaliin cui è richiesta una precisione deidati nell’or<strong>di</strong>ne del centimetro e dovel’oggetto da misurare presenta <strong>di</strong>mensioniapprezzabili; i laser triangolatori,invece, vengono utilizzati quando sivogliono informazioni <strong>di</strong> precisione inferioreal centimetro e per lo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong>oggetti <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni o particolariarchitettonici (come capitelli ebassorilievi).La nuvola <strong>di</strong> punti descrive dunque lasuperficie <strong>di</strong> un oggetto (da oggetti <strong>di</strong>piccole <strong>di</strong>mensioni, all’architettura, alterritorio): nel caso dei rilievi eseguiti, idati acquisiti sono <strong>di</strong> fatto dei modellitri<strong>di</strong>mensionali delle facciate palla<strong>di</strong>anee del contesto in cui si inseriscono.La strumentazione impiegata è unsistema “ibrido laser scanner-fotogrammetrico”che offre la possibilità<strong>di</strong> acquisire non solo le tre osservazioninecessarie alla determinazione dellecoor<strong>di</strong>nate X,Y,Z <strong>di</strong> ogni punto maanche i valori RGB corrispondenti al singolopunto rilevato in modo accuratoe con risoluzione spaziale elevata,assemblando in modo solidale al laserscanneruna fotocamera <strong>di</strong>gitale precalibrata(Nikon D100 con ottica20mm).Questa categoria <strong>di</strong> strumenti permette<strong>di</strong> registrare non solo le coor<strong>di</strong>natespaziali, ma anche le caratteristiche <strong>di</strong>riflessione della luce e la qualità cromaticadei punti. Lo scanner 3d <strong>di</strong>stanziometrico(Time Of Flight) assicura unaprecisione sulla determinazione deipunti <strong>di</strong> ±4 mm in singola acquisizionee <strong>di</strong> ±2 mm in scan-sequence (valoredefinito come me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> misure ripetute),quin<strong>di</strong> adeguate alla scala richiesta.Il sistema, integrando fotogrammetriae laser scanning, rappresenta una dellemigliori soluzioni tecniche oggi <strong>di</strong>sponibiliin grado <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare tutte le esigenze<strong>di</strong> rilievi laser scanner terrestri.Al termine delle fasi <strong>di</strong> acquisizione e <strong>di</strong>un primo processamento delle nuvole(registrazione, allineamento e filtraggio)si ottiene un modello numericoche, pur essendo completo, richiedeulteriori elaborazioni per ottenere prodottifiniti che siano confrontabili conquelli ottenuti da metodologie <strong>di</strong> rilievotra<strong>di</strong>zionali. La ridondanza <strong>di</strong> datioffre la possibilità, me<strong>di</strong>ante software,<strong>di</strong> estrarre un elevato numero <strong>di</strong> profiliorizzontali e verticali nei punti ritenutipiù importanti per la descrizionedell’oggetto rilevato; è possibile inoltre<strong>di</strong>gitalizzare <strong>di</strong>rettamente sullanuvola, consentendo <strong>di</strong> ottenere allafine dei <strong>di</strong>segni al tratto confrontabilicon una restituzione fotogrammetricasia dal punto <strong>di</strong> vista metrico che dellarappresentazione.Nel caso del rilievo svolto, vista la complessitànella fase <strong>di</strong> acquisizione delleprese fotogrammetriche che hannorichiesto l’utilizzo <strong>di</strong> piattaforme aeree,la possibilità <strong>di</strong> restituire i <strong>di</strong>segni dellefacciate anche dai dati laser scanning ha<strong>di</strong>mostrato l’efficacia dell’integrazione.
Iuav : 59 12Università Iuav <strong>di</strong> <strong>Venezia</strong>Sistema dei laboratoricon la partecipazionee il contributo <strong>di</strong>Fondazione <strong>Venezia</strong>in collaborazione conSoprintendenza per i beniarchitettonici e paesaggistici<strong>di</strong> <strong>Venezia</strong> e Lagunacon il patrocinio <strong>di</strong>Regione del VenetoProvincia <strong>di</strong> <strong>Venezia</strong>Comune <strong>di</strong> <strong>Venezia</strong>comitato scientificoCarlo Magnani, rettorePaolo Morachiello, prorettore alla ricercaFabio Achilli, Fondazione <strong>di</strong> <strong>Venezia</strong>Malvina BorgheriniRenata Codello, Soprintendenza BAP<strong>di</strong> <strong>Venezia</strong> e lagunaEmanuele GarbinAndrea GuerraFrancesco GuerraPaola ModestiMario PianaLuca PilotMarisa ScarsoCamillo Trevisanrilievi a cura del laboratorio<strong>di</strong> fotogrammetriaFrancesco Guerra, responsabile scientificoLuca Pilot, responsabile tecnicoAndrea AdamiCaterina BallettiGiovanna FanelloSilvia ManderPaolo Verniermostra a cura <strong>di</strong>Malvina BorgheriniAndrea GuerraFrancesco GuerraPaola Modestiprogetto allestimento mostraMalvina BorgheriniGiovanni Siardrealizzazione allestimentoArtwood arreda srlFincato costruzioni metalliche sncGraphic report sncelaborazioni <strong>di</strong>gitali e videoanimazionidel laboratorio multime<strong>di</strong>aleMalvina Borgherini, responsabileEmanuele GarbinLuciano ComacchioMargherita MarrulliEufemia PiizziSilvia Spinellimodellazione <strong>di</strong>gitaleMarco Gnesuttavideo introduttivoCarlo Ferrosito webMarco GnesuttaLuciano Comacchioautori delle schedeGrazia Fumo(Rilievi nel passato: sezione VI)Paola Modesti(Rilievi nel passato: sezioni I-V)fotografieUmberto FerroMaurizio TarlàorganizzazioneMarisa Scarso, coor<strong>di</strong>namentoAnna ColussiSabrina ToniolocomunicazioneServizio comunicazione e immagine IuavCecilia GualazziniringraziamentiRenato BocchiCristina BrasolinLaura CasagrandeCooperativa CostruendoGloria CorreggiariPiero FalchettaLorenzo LazzariniHope MayoMassimo MazzantiFranca PittalugaMichele RidolfiFrancesca RizziCamillo ToniniMaria Zaghiniistituzioni coinvolte<strong>Venezia</strong>, Soprintendenza per i beniarchitettonici e paesaggistici <strong>di</strong> <strong>Venezia</strong>e laguna<strong>Venezia</strong>, Archivio Storicodel Comune <strong>di</strong> <strong>Venezia</strong><strong>Venezia</strong>, Biblioteca Nazionale Marciana;<strong>Venezia</strong>, Sistema bibliotecariodocumentale, Iuav<strong>Venezia</strong>, Sistema laboratori Iuav/ laboratorio<strong>di</strong> cartografiaVicenza, Museo CivicoFirenze, Alinari <strong>24</strong>oreFrance, Besançon, Bibliothèque Municipale;UK, London, The British LibraryUK, London, The Royal Instituteof British ArchitectsUK, London, The Victoria & Albert MuseumUK, Chatsworth (Derbyshire),The Devonshire CollectionUSA, Cambridge (MA), Harvard University,Houghton LibraryCanada, Montréal, Cana<strong>di</strong>an Centrefor Architecture