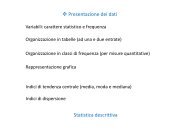01 INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA CLINICA.pdf - WikiMotorio
01 INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA CLINICA.pdf - WikiMotorio
01 INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA CLINICA.pdf - WikiMotorio
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Corso di Psicologia ClinicaNicola GirtlerNeurofisiologia Clinica (DiNOG)Università di Genova
Programma corso di Psicologia Clinica• Le prospettive teoriche- la psicodinamica- la prospettiva umanistica- esistenziale- il comportamentismo- il cognitivismo- l‟approccio cognitivo comportamentale- l‟approccio sistemico familiare- la prospettiva biologica• Cenni di anatomia del Sistema Nervoso
Programma corso di Psicologia ClinicaNeuroscienze e psicanalisi• La biologia al servizio della psicoanalisiClassificazione e assessment psicologico• Il DSM (Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders)- Assi I – V
Programma corso di Psicologia Clinica• I disturbi psicologici- Umore e disturbi dell‟umore- Trattamento dei disturbi dell‟umore- Componenti cognitive- Componenti comportamentali- Componenti psicodinamiche
Programma corso di Psicologia Clinica• I disturbi del comportamento alimentare- Anoressia- Bulimia- Componenti psicodinamiche- Componenti sistemico-familiari- Componenti cognitivo-comportamentali- Componenti biologiche• I disturbi da abuso di sostanze- Sostanze di abuso comune- Effetti delle sostanze psicoattive- Possibili trattamenti
Programma corso di Psicologia Clinica• Psicosi e schizofrenia- Ambiente- Funzione cerebrale- Il modello dell‟Andreasen- Psicodinamica della schizofrenia- Un caso clinico• I disturbi sessuali- Definizione- Classificazione- Disturbi dell‟identità di genere (DIG)
Concetti base• Definire la patologia:Come distinguiamo i comportamenti normalida quelli patologici?• Classificare la patologia:Come vengono caratterizzati ediagnosticati i comportamenti patologici?• Spiegare e trattare la patologia:Come possono venire compresi e modificatii comportamenti patologici?
• Il contesto:Concetti baseSi può caratterizzare un comportamentopatologico solo se si considera il contestosituazionale in cui avviene (eventi di vita,variabili demografiche, ecc.)• Il continuum:I sintomi comportamentali ed emotivi sicollocano lungo un continuum, molte formedi patologia sono versioni esagerate disentimenti e comportamenti normali
• La cultura:Concetti baseLa definizione e la classificazione delcomportamento patologico varianoconsiderevolmente fra culture diverse efra periodo storici diversi.• Vantaggi e limiti della diagnosi:Categorie diagnostiche e classificazionepossono iper-semplificare problemicomplessi, creare stigmatizzazioni
Concetti base• La causalità multipla:Le cause dei disturbi possono esserepredisponenti, precipitanti, psicologiche,biologiche, interne, esterne.• Mente corpo:La comprensione della psicopatologiarichiede la valutazione della connessionemente - corpo
Comportamenti problematici (qualche esempio)• Il contesto:Provare molta paura in situazioni dipericolo (guerra) è normale, mentre si èfuori a fare shopping non lo è affattoIl comportamento può dipendere dallecaratteristiche demografiche:- Disattenzione e iperattività (maschi)- Anoressia (femmine)
Comportamenti problematici (qualche esempio)• Il continuum:Quanto peso bisogna perdere prima diessere considerati affetti da disturboalimentare?Quanto un bimbo deve essere distrattoe/o disattento prima di essere consideratopatologico?• La cultura:Parlare ai defunti è normale o no?
Comportamenti problematici (qualche esempio)• La connessione mente - corpo:Mente e corpo interagiscono in modocomplesso, è sbagliato considerare il soloparadigma psicologico o il solo paradigmabiologicoLa paresi generale (Al Capone)Il nanismo psicosociale
Definire la psicopatologiaQuando possiamo considerare uncomportamento come patologico?Esperienze di vita negative o squilibricerebrali?Criteri RIDDD per definire la psicopatologia• Ricerca di aiuto (pseudopazienti di Rosenhan)• Irrazionalità/pericolosità (contesto)• Devianza (comportamenti estremi)• Distress emozionale (es. tristezza, ansia)• Danno significativo (funzionale)
DSM IV TR definizione di disturbo mentale…si deve ammettere che nessunadefinizione specifica adeguatamente iconfini precisi del disturbo mentale.Questo concetto, come molti altri inmedicina e nella scienza, manca di unadefinizione operativa coerente che copratutte le situazioni. (APA 2000, p 7-8)
Le prospettive teoricheLa psicodinamica e il modello di FreudIl caso di Anna OSeparazione all‟interno della menteParte «accettabile» conscia e razionaleParte «inaccettabile» inconscia, irrazionale, istintualeStudio dei contenuti dell‟inconscio (esperienze traumatiche,desideri, fantasie) come parte inacettabile della menteconscia e rifiutata attraverso la rimozione
Le prospettive teoricheLa psicodinamica e il modello di FreudIl modello strutturaleEs: desideri aggressivi e sessuali infantili, ricerca delpiacereSuper – io: regno giudizio morale estremoIo: parte della mente orientata alla realtà, concilia Es eSuper io
Le prospettive teoricheI meccanismi di difesaRimozione – l‟Io impedisce all‟impulso di giungere alla coscienzaNegazione – un desiderio rimosso giunge alla coscienza ma vienenegatoProiezione – attribuzione all‟esterno di sentimenti e desideririfiutati (odiosono odiato)Spostamento – la minaccia di un impulso interno viene attribuita auna situazione esternaFormazione Reattiva – manifestazione di un comportamentocontrario alla pulsione dal quale ci si difendeSublimazione – trovare uno sbocco costruttivo va un desiderioinaccettabile
Le prospettive teoricheTutti i meccanismi di difesa sono processimentali automatici messi in atto dalla parteinconscia dell‟Io nello sforzo di ridurrel‟ansia causata dai conflitti emozionaliNon sono necessariamente patologiciLa patologia nasce quando i conflitti tra Es, Io, Super Io erealtà non sono mediati con successo dai meccanismi didifesa e da strategie di coping
Le prospettive teoricheScopo della terapia psicodinamica è farraggiungere al soggetto una migliorepadronanza dei conflitti emozionaliSostituzione meccanismi di difesa non adattiviInsight + relazione terapeutica
Le prospettive teoricheProspettiva umanistica ed esistenzialeSi occupano del trattamento piuttosto che dei disturbi- Attualizzazione del sè = essere autentici con se stessi- Considerazione positiva = ricevere amore, empatia,accettazioneLa psicopatologia è considerata una mancanza di autostimae considerazione di sé che deriva dal fallimento dellefigura di riferimento• Le tecniche di intervento si basano sull‟ascolto attivo,l‟empatia e la considerazione positiva incondizionata
Le prospettive teoricheIl comportamentismoAlternativa al modello psicanaliticoGli anni Quaranta e Cinquanta, nella psicologia, furono ilperiodo di maggior successo del comportamentismo ortodossocol quale gli psicologi cercavano di sfuggire alle difficoltà delvecchio mentalismoIl comportamento, compreso quello patologico è appreso
L’APPRENDIMENTO• La psicologia comportamentista è stataprofondamente influenzata dalle ricerchesull’apprendimento animale condotte da unfisiologo russo, I. Pavlov (1849-1936) e dauno psicologo americano, B.F. Skinner (1904-1990).I. PavlovB.F. Skinner
L’APPRENDIMENTO• Pavlov cercò di capire come gli animali potesseroimparare che certi stimoli tendono ad avere luogoassieme (contingenze di stimolo, come un lampodi luce e un rumore) e chiamò questo tipo diapprendimento condizionamento classico• Skinner era interessato al modo in cui gli animaliapprendono che certe risposte tendono ad essereseguite da certi stimoli (contingenze stimolorisposta,come andare in un certo luogo e trovarvi,in genere, del cibo). Skinner chiamò questo tipo diapprendimento condizionamento operante
CONDIZIONAMENTO CLASSICO• Pavlov durante le ricerche sul sistemadigestivo aveva notato come mettendo delcibo in bocca ad un cane si producesse unaumento di salivazione• Questa relazione tra uno stimolo (cibo) e unarisposta (salivazione) è la conseguenza di unriflesso• Il riflesso è una risposta automatica inscrittageneticamente nel sistema nervosodell’animale
• Lavorando sui cani Pavlov notò chequesti producevano più saliva quandoudivano o vedevano eventi che di solitoprecedevano il cibo (i passi dell’inserviente, la vistadel recipiente)• Si tratta, in questo caso, non più di riflessiinnati ma di riflesso condizionato o appreso
• L’esperimento di Pavlov:Un cane viene legato con delle cinghie in una stanzainsonorizzata. Un tubo impiantato chirurgicamente nellacavità orale del cane raccoglieva la saliva in modo chepotesse esserne registrato il flusso. Pavlov stabilì cheponendo del cibo in polvere nella bocca del cane aumenta ilflusso di salivaPavlov chiamò il cibo stimolo incondizionato (SI) e la risposta disalivazione risposta incondizionata (RI)
• Poi provò a far suonare ogni tanto unacampanella (stimolo condizionato – SC)• In seguito fece seguire al suono dellacampanella la presentazione del cibo• dopo un po’ di prove il cane cominciò asalivare in risposta al suono dellacampanella (risposta condizionata – RC)
• Si è verificato il processo dicondizionamento pavloviano classico ocondizionamento classico che comportal’accoppiamento ripetuto di SC (campanella)e SI (cibo)• Tale accoppiamento condiziona lo SC aevocare una RC simile alla RI (RC e RI =salivazione)
• L’esperimento comporta varie fasi:– Fase 1- acquisizione - associazione di tra SC(campanella) e SI (cibo)– Fase 2 - estinzione – continua presentazionedi SC ma non dello SI ottenendo lascomparsa graduale della RI– Riposo del cane per una notte
- Fase 3 – recupero spontaneo – SC viene presentatoda solo e sorprendentemente genera RC piuttostoforti- Fase 4 – riacquisizione – viene presentatonuovamente un rinforzo costituito dalla coppia SC+SIgenerando un riapprendimento molto rapidoIl recupero spontaneo e la riacquisizione mostranoquanto sia difficile eliminare gli effetti delcondizionamento. In effetti vi sono animali che hannomostrato segni del condizionamento ricevuto moltianni prima che era stata acquisita ed estinta unarisposta condizionata.
Generalizzazione e discriminazione• Quando a un particolare SC è stataassociata una risposta condizionata glistimoli simili allo SC tenderanno aelicitare la RC (generalizzazione)Un semplice esempio: lo SC era un grattamento meccanicodella pelle del cane che era stato abbinato con dellacarne in polvere (lo SI). Una volta saldamente instauratala RC (la salivazione), il cane veniva grattato in parti delcorpo differenti da quella originaria: più il punto in cui ilcane veniva grattato era vicino a quello originario, piùl‟animale salivava.
Generalizzazione e discriminazione• Benché il condizionamento tenda ageneralizzarsi a stimoli simili allo SC,è possibile addestrare un animale anon rispondere a tali stimoli purcontinuando a rispondere allo SC.• Si tratta del fenomeno delladiscriminazione
Generalizzazione e discriminazionePavlov condizionò un cane a salivare in risposta ad un tono di1000 Hz. Una volta instaurato il condizionamento, il canesalivava anche con toni di frequenza simile (> era lasomiglianza e > era la salivazione).In seguito Pavlov accoppiò una serie di toni di 1000 Hz col ciboinframmezzati con toni di 900 e 1100 Hz senza cibo; Questoaddestramento portò il cane a rispondere solo a toni di 1000Hz.
Gi stimoli avversivi• Sono definiti dalla caratteristica configurazione dirisposte non condizionate che evocano e cambiano dauna specie all‟altra (configurazioni di risposte speciespecifiche).• Per esempio se sottoponiamo un ratto a una scossaelettrica o ad un forte rumore può emettere gridi,rannicchiarsi, immobilizzarsi.• L‟accoppiamento di uno stimolo avversivo ad es. unascossa (SI) con uno neutro quale una luce (futuro SC)farà si che la luce evochi una risposta RC simile a quellaevocata dallo SI. La luce diventa uno stimolo avversivocondizionato.• Una caratteristica di tale condizionamento è che puòbastare un singolo accoppiamento SC-SI per produrreuna forte risposta condizionata fortemente resistenteall‟estinzione.
Le componenti neurali del condizionamento classico allapaura• Se un ratto viene condizionato ad aver pauramostra una reazione detta freezing(immobilizzazione) ed aumenta l’attività delSNA (battito cardiaco, pressione sanguigna,rilascio ormoni legati allo stress)• Quando si stabilisce un condizionamento allapaura sono presenti queste due componenti(comportamentale e fisiologica)
Le componenti neuralidel condizionamentoclassico alla paura• Il nucleo dell’amigdala gioca un ruolo fondamentale mediante dueconnessioni distinte con altre parti del cervello• Se si interrompono le connessioni amigdala – mesencefalo annulliamo ilfreezing• Se si interrompono le connessioni amigdala – regione lateraleipotalamo annulliamo le risposte autonomiche
Il condizionamento operante: Thorndike eSkinner• Thorndike criticò le “prove” sull’intelligenzaanimale esibite dai naturalisti (compreso C.Darwin)• I suoi studi suggerivano che gli animaliapprendono per prove ed errori• Con un’apposita gabbia (problem-box) accertòche le risposte corrette tendono ad essereripetute e quelle erronee a essere abbandonate• Diminuisce così il tempo di risoluzione delproblema
• Legge dell’effetto:I comportamenti cui fa seguito un“soddisfacente stato delle cose” tendonoad essere ripetuti e quelli che produconouno spiacevole stato delle cose hanno unaminore probabilità di ripetersi
Thorndike problem box
• Skinner riprende il lavoro di Thorndike sostenendo cheil soddisfacimento è un pregiudizio mentalistico e chel’unica cosa necessaria era mostrare che quando unarisposta era seguita da un certo esito, era piùprobabile che si ripetesse di nuovo.• Skinner introduce la distinzione tra:• Comportamenti rispondenti• Comportamenti operantiI primi derivano da riflessi innati (es. salivazione) oappresi (es. associazione SC – SI)I secondi sono emessi spontaneamente dall’organismo [ilgatto che impara a premere la leva per uscire] (associazione S –R)
• I comportamenti operanti aumentano odiminuiscono in funzione del rinforzo• Il rinforzo può essere:• Positivo (cibo, acqua, ecc.)• Negativo (cessazione scossa elettrica o forterumore)• Skinner introduce così il condizionamentooperante dove è il soggetto che operanell’ambiente modificandolo
APPRENDIMENTO OPERANTE
All’inizio un ratto privo di addestramento poteva andare avanti per un belpo’ prima di premere accidentalmente la leva e ricevere del cibo.Nell’esperimento di Skinner il ratto poteva restare nella gabbia un’ora algiorno ottenendo ogni volta il suo cibo più rapidamente fino alla perfettaacquisizione della risposta di abbassamento della barra. Se a questopunto non veniva dato più cibo si verificava una graduale estinzione.Nel condizionamentooperante vi è unintervallo di tempocritico che influenzaprofondamente ilcondizionamento.Per massimizzare ilcondizionamento ilrinforzo deve avereluogo subito dopo cheè stata data larisposta.
• Il modellaggioPuò accadere che si debba aspettare alungo prima che un ratto non addestratoprema la leva per la prima volta.Per ovviare al tempo sprecato Skinnersorvegliava attentamente il ratto e lorinforzava col cibo ogni qualvolta siavvicinava alla leva, via via affinando larispostaSkinner scoprì che approssimazioni successive producevano l’abbassamento dellaleva prima della risposta casuale
Il rinforzo intermittenteSkinner scoprì che la risposta del ratto è ancora più rapida quando l’abbassamentodella leva produce solo a volte del cibo.Con questo schema il ratto continuerà a rispondere molto più a lungo durante ilperiodo di estinzione (quando non si ha rinforzo).I programmi di rinforzointermittenti vengono suddivisi inprogrammi ad intervallo (fisso ovariabile) e a rapporto (fisso ovariabile);I primi sono caratterizzati daltempo ed i secondi dalle risposte.Ad es ogni 10 sec si rinforzal’organismo (intervallo fisso); inmedia ogni 10 sec si dà il rinforzo(intervallo variabile).Ogni 4 risposte si rinforzal’organismo (rapporto fisso); inmedia ogni 4 risposte si dà ilrinforzo (rapporto varabile)
Il fatto interessante dei programmi di rinforzointermittente è che lo stesso programma haesattamente lo stesso effetto, quale che siala risposta, il rinforzo, e la specie animale.La registrazione cumulativa di un piccione chebecca un tasto e riceve del grano secondo undeterminato programma è indistinguibile dallaregistrazione cumulativa prodotta da unapersona che tira la leva di una slot machine ericeve del denaro secondo lo stessoprogramma
• La teoria del condizionamento operante spiegail comportamento patologico affermando chequesto viene appreso quando è seguito da unqualche rinforzo positivo o quando ilcomportamento normale viene punito• Un bambino può sviluppare depressione sericeve attenzioni da un padre (generalmentedisattento) soltanto nei momenti in cui ètriste.• La tristezza è seguita dal rinforzo positivorappresentato dal ricevere attenzioni.• La terapia mira a eliminare rinforzi positiviper i comportamenti patologici
Le componenti neurali delcondizionamento operante• J Olds et al (1956) inserirono deiminuscoli elettrodi in diverse parti delcervello di un ratto che potevacontrollare con una leva la stimolazioneelettrica che riceveva.• Scoprirono le aree del piacere• I ratti premevano ripetutamente la levaper stimolare queste aree
Figure 6.10 Pleasure Centers inthe BrainSchacter, Gilbert and Wegner:Psychology, First EditionCopyright © 2009 by Worth PublishersI neuroni cheformano il fascioproencefalicomediale checolleganomesencefalo –ipotalamo –nucleoaccumbes sonoi più sensibilialla stimolazioneche generapiacereI neuroni di questo “centro dellaricompensa” sono dopaminergici. Ladopamina si associa alle emozionipositive.
Descrizione comportamentale dell‟apprendimento umano• Durante gli anni „40 e ‟50 il “linguaggio”elaborato per descrivere il CondizionamentoClassico e Operante negli organismi inferiorivenne usato anche per descriverel‟apprendimento umano.• Si pensava di “predisporre le appropriatecontingenze di rinforzo” per plasmare il tipodi comportamento desiderato nei propri figli,studenti, dipendenti, pazienti.
Descrizione comportamentale dell‟apprendimento umanoIl condizionamento classico• Il caso più famoso è quello del piccolo Albert chevenne condizionato ad aver paura dei ratti da duepsicologi (Watson e Raynor).Albert amava giocare con i candidi ratti di laboratoriofinchè non gli venne presentato un accoppiamento diun ratto bianco (SC) con un forte rumore improvvisoalle spalle (SI). Come risultato, la vista di un rattobianco cominciò ad evocare risposte (RC) molto vicinaal pianto e alla paura (RI) che sono le risposte tipichedi un bambino di fronte ad un rumore improvviso.Albert generalizzò questa risposta emotiva condizionata mostrandodi aver paura di altri animali e perfino di un pezzo di pelliccia.
Descrizione comportamentale dell‟apprendimento umanoIl condizionamento classico• Gli esseri umani mostrano altri esempi dirisposte emotive generalizzate come larisposta psicogalvanica o elettrodermica (GSR– Galvanic Skin Response; caduta dellaresistenza elettrica della pelle).• Quando una persona riceve una scossaelettrica (SI) una delle reazioni emotive è unamarcata GSR (RI).• Se accoppiamo uno stimolo neutro (ad es. untono) con una scossa elettrica, lo stimoloneutro genererà forti GSR anche dopo soli dueaccoppiamenti.
Descrizione comportamentale dell‟apprendimento umanoIl condizionamento classico• Il linguaggio e la capacità di simbolizzazionedegli esseri umani fa sì che sia possibilecondizionare le persone ad emettere larisposta psicogalvanica in risposta ad una certaparola inserita in una lista e successivamente aparole semanticamente simili:1) Presentazione lista di parole2)Dopo la comparsa della parola “stalla” sisomministra una scossa elettrica (GSR)3)Si consolida il condizionamento4)I soggetti emettono GSR della pelle quandovengono presentate parole come “mucca”,“fieno” ma non con parole non correlate come“tavolo”, “sedia”
Descrizione comportamentale dell‟apprendimento umanoIl condizionamento classico• Un‟altra fondamentale risposta emotiva umanaè l‟aumento della pressione sanguigna (RI) chesegue una scossa elettrica (SI)Bykov accoppiò uno stimolo luminoso (SC) ad unascossa finché non riuscì a provocare unavariazione della pressione sanguigna deisoggetti (RC) semplicemente accendendo laluce.Un condizionamento analogo si può avere quandoun dirigente entra in ufficio o un medico incorsia
Descrizione comportamentale dell‟apprendimento umanoIl condizionamento classico• Già nel 1938 Mowrer e Mowrer elaborarono untrattamento per bambini enuretici ritenendo cheavessero bisogno di aiuto per svegliarsi quando lavescica fosse piena:Prepararono un‟imbottitura speciale con un segnale diallarme da mettere sotto il bambino durante il sonno;il segnale di allarme entrava in azione quandol‟imbottitura si inumidiva.La sensazione di vescica piena (SC) era perciò accoppiataautomaticamente all‟allarme (SI) che svegliava ilbambino (RI).Dopo molti di questi accoppiamenti la vescica piena (SC)svegliava il bambino (RC) in tempo per andare in bagno.
Dipendenza dalle droghe e condizionamento classico della tolleranza• Le persone, quando usano droga (eroina)sviluppano rapidamente una tolleranza (dosi >per effetto =).• L‟effetto della droga sul SN provoca unarisposta immediata di compensazione.• In tal modo gli stimoli che precedonol‟iniezione possono diventare SC non solo deglieffetti della droga ma anche della risposta dicompensazione.
Dipendenza dalle droghe e condizionamento classico della tolleranza• I preparativi e la vista dell‟ago possonoprodurre RC simili alla droga ma ancheinnescare processi condizionati dicompensazione prima che la droga siarealmente iniettata.
Dipendenza dalle droghe e condizionamento classico della tolleranza• Siegel (1982) ha reso dei ratti tollerantiall‟eroina mediante iniezioni eseguite agiorni alterni di quantità crescenti.• Dopo una serie di 15 dosi a tutti glianimali venne somministrata una dosemolto superiore (letale per qualsiasiratto nuovo all‟eroina).
Dipendenza dalle droghe e condizionamento classico della tolleranza• A metà dei ratti venne somministratanella solita stanza all‟altra metà in unastanza nuova.• Molti ratti morirono ma le morti eranodue volte più frequenti per i ratti dellastanza nuova. Probabilmente ilmeccanismo della tolleranza condizionatanon riusciva a funzionare quando gliindici ambientali venivano drasticamentecambiati.
Dipendenza dalle droghe e condizionamento classico della tolleranza• L‟implicazione di questo lavoro è cheparte della tolleranza sviluppata daiconsumatori di droga dovrebbe essereconsiderata una RC di compensazioneevocata dal contesto e dagli attipreparatori.• Questo effetto può essere così forteche i consumatori di droga con un‟elevatatolleranza possono morire per aver usatola loro dose normale di eroina in unasituazione insolita, in cui la RC dicompensazione è più debole.
Le terapie comportamentali• Sono basate principalmente sul«disapprendimento»La terapia del comportamento è«l‟applicazione delle scoperte dellapsicologia sperimentale e delle scienzeconnesse al problema di aiutare le personea modificare gli aspetti del propriocomportamento e della propria esperienzache procurino loro disagio» (British Associationfor Behavioural Psychotherapy)
Le terapie comportamentali• Il comportamentismo assume cheanomalia e patologia della vitacomportamentale e emozionale noncostituiscano fenomeni di ordinequalitativo diverso da quelli normali.
Le terapie comportamentali• I fenomeni della devianza sono diconseguenza “rimediabili” mediantel‟utilizzo dei principi di base dellapsicologia sperimentale.• In particolare, è possibile considerare ilcomportamento nevrotico come uncomportamento appreso.
Le terapie comportamentali• Nella terapia del comportamento ilmodello della devianza psicopatologica sicontrappone dunque al cosiddettomodello medico della devianza e a quellopsicodinamico, secondo il quale ilcomportamento nevrotico è puraespressione epifenomenica di una causa(che è considerata la vera malattia) dicarattere inconscio.
Le terapie comportamentali• Mirano ad annullare l‟associazionecondizionata patologica attraverso varietecniche quali:• l‟estinzione• l‟esposizione• la desensibilizzazione sistematica• terapia avversiva
Le terapie comportamentali• Estinzione: annullamento di un‟associazione tra unostimolo condizionato e una risposta condizionata• Esposizione: si sottopone il soggetto allo stimolocondizionato (ad es ciò che incute paura) ai fini dipromuovere l‟estinzione• Desensibilizzazione: esposizione crescente allo stimolocondizionato accoppiata con tecniche di rilassamento• Terapia avversiva: tecnica che affianca a uncomportamento indesiderato uno stimolo avverso aifini di creare tra i due elementi un‟associazione percondizionamento classico• bimbo con paura dei cani che abbaiano (SC) dopoessere stato assalito (SI) esporlo gradualmente a caniche abbaiano ma non assalgono può ridurre la paura
Il cognitivismo• Si basa sul concetto che gli uomini interpretano ilmondo• Il comportamento, normale e patologico, è radicatonelle credenze e negli schemi cognitivi (modelli mentalidel mondo)• Rifiuta il presupposto psicodinamico che ilcambiamento terapeutico necessita l‟esplorazionedelle cause più profonde• Le terapie cognitive (ristrutturazione cognitiva)mettono a punto tecniche utili al cambiamento dicredenze e pensieri problematici e irrazionali(disadattivi) in atteggiamenti più razionali (adattivi)
Il cognitivismo• Rifiuta il presupposto che i processiinterni (credenze e motivazioni) NONabbiano importanza e NON sianomisurabili• Le attribuzioni causali sono le credenzedi un individuo riguardo alle cause deglieventi giocano un ruolo importante neldeterminare le sue risposte nelleinterazioni sociali
• ciascuno di noi adotta nella realtà di tutti igiorni una rete di microteorie per spiegare lacondotta propria e altrui• mettiamo in atto quotidianamente un insiemedi procedimenti di investigazione con cuiformiamo e alimentiamo tali teorie.
Ad esempio:• un bambino corre in una stanza perlustrando ogniangolo e nascondiglio.Possibile interpretazione basata sul sensocomune:•un comportamento di questo tipo (esplorazione)potrebbe essere immediatamente associato ad unasituazione (perdita di un oggetto).
Osservando il comportamento del bambino,l’interpretazione ingenua potrebbe essere:CONFERMATA se subito dopo avere scoperto il suo giocattolo preferito, ilbambino si ferma e smette di cercareRESPINTA se entra un amico e ci rendiamo conto che stavano facendo unaltro tipo di giocoLe spiegazioni che noi diamo spesso degli eventidella vita possono portare a conclusioni erronee
• La teoria dell'attribuzione causale si occupaesplicitamente del problema del modo in cuila gente tenta di spiegare il comportamentoaltrui e, più in generale, gli eventi del mondosociale.
• Heider parte dall’assunto che le persone:• Siano motivate a considerare il proprio ambientesociale come prevedibile e quindi controllabile• Applichino uno stesso tipo di logica nella predizionedegli eventi sociali e di quelli fisici, cercando lecondizioni necessarie e sufficienti che hannodeterminato il loro accadimento.• Tali condizioni possono essere sia situazionali(esterne alla persona) sia interne (caratteristiche dipersonalità , competenze) alla persona di cuicerchiamo di spiegare il comportamento
• Le attribuzioni alle caratteristiche di una personasaranno meno probabili quando ilcomportamento è percepito come sotto ilcontrollo di vincoli esterni• Tratti personali (atteggiamenti, bisogni,credenze, ecc.) saranno usati per spiegare ilcomportamento che non può essere chiaramenteattribuito a condizioni esterne
Un esempio:• Come le persone spiegano i propri e gli altrui successio fallimenti?• Se una persona raggiunge lo scopo che si eraprefisso, ciò avviene perché il compito era facile,perché è stata fortunata, perché ha capacità superiorio perché si è impegnata di più?• Il livello di prestazione di una persona in un datocompito sarà attribuito a fattori interni o a fattoripropri dell’ambiente esterno
• I fattori ambientali possono essere la fortunae le difficoltà del compito i fattori interni allapersona l’abilità e lo sforzo• L’abilità è considerata un elemento stabilementre lo sforzo è considerato un elementoinstabile
• La differenza tra le due cause interne (abilità esforzo) sembra particolarmente importante nellavalutazione del comportamento proprio e altrui• Weiner e Kukla (1970) hanno scoperto che isoggetti, che dovevano assumere il ruolo diinsegnanti che davano ricompense e punizioni inrelazione ai risultati degli esami degli allievi,ricompensavano di più gli sforzi maggiori che nonle abilità superiori• Quando gli allievi con abilità diverse fornivanoprestazioni simili quelli meno abili venivanomaggiormente ricompensati
Successi o fallimenti personali• ciò che è rilevante è il grado di percezionesoggettiva della responsabilità personalelegata al successo o al fallimento (Weiner et al1971)
• Gli individui con alta motivazione alsuccesso sono attratti da attività chepermettono attribuzioni basate sull’abilità esullo sforzo• Non demordono di fronte ai fallimentiattribuendoli alla mancanza di sforzopiuttosto che alla mancanza di abilità• Scelgono compiti di media difficoltà perchéquelli troppo facili non danno il senso delsuccesso e quelli troppo difficilicondurrebbero all’insuccesso.
• Gli individui con bassa motivazione al successo sonomeno attratti da attività legate al successo• L’eventuale successo è attribuito a cause esterne• Si ritirano di fronte ai primi fallimenti che attribuisconoalla mancanza di abilità piuttosto che di sforzo• Questi soggetti selezionano compiti facili o difficili datoche questi compiti forniscono scarse informazioni per faredelle auto-valutazioni• Tendono, infine, a non fare grossi sforzi dato che ilsuccesso (nei compiti che essi scelgono) vieneconsiderato largamente indipendente dallo sforzo
L‟approccio cognitivo comportamentale• Attenzione all‟apprendimento deicomportamenti (ad es S-R) el‟importanza dei processi cognitivi(attribuzioni)• Ellis: assunzioni irrazionali (bisognaessere perfetti)
Integrazione cognitivo comportamentale«apprendimento dei comportamenti + processi cognitivi»• Beck: distorsioni cognitive- Amplificazione (far di una mosca un elefante)- Ipergeneralizzazione (ricavare uno schema generaleda singolo evento)- Astrazione selettiva (concentrarsi sui soli aspettinegativi)Uno studente che pensasse di essere indegno e senza speranza dopoaver ottenuto un punteggio basso ad un esame, pur avendonesuperato la maggior parte, mostrerebbe tutte e tre questedistorsioni
L‟approccio cognitivo comportamentale• Le distorsioni cognitive produconopensieri automatici negativi cheriguardano se stessi, il proprio futuro e ilproprio mondoSi parla di triade cognitiva
le prospettive sociocultarale e sistemicofamiliare• Tali prospettive pongono l‟accento sucome gli aspetti relativi all‟ambientesociale, culturale e familiarecontribuiscono allo sviluppo dei disturbipsichici• Quale patologia è diffusa tra donnecontemporanee, bianche, benestanti,appartenenti alla società industrializzataoccidentale?
le prospettive sociocultarale e sistemicofamiliare• I sostenitori del modello socio culturalesono piuttosto scettici nei confronti deitrattamenti psicoterapici individuali• La chiave per migliorare il benesserepsicologico della maggior parte dellepersone è:- Riduzione disoccupazione- Riduzione povertà- Riduzione discriminazione
le prospettive sociocultarale e sistemicofamiliare• I sostenitori del modello sistemicofamiliarepongono l‟accento sulledinamiche familiari (famiglia = sistemacomplesso)• L‟attenzione NON è posta sui singolimembri ma sulla famiglia come «unit໕ I sistemi familiari mantengono una certa stabilità oomeostasi
le prospettive sociocultarale e sistemicofamiliare• Riguardo all‟omeostasi un cambiamento inuna parte della famiglia tende a creareun disequilibrio in tutto il sistema e ainnescare una contro reazione perristabilire gli equilibri abituali.
le prospettive sociocultarale e sistemicofamiliare• Ad es genitori che si accaniscono sulledifficoltà di apprendimento di un figlioper evitare di affrontare le difficoltàdel proprio matrimonio.• Se il bambino comincia a migliorare ascuola possono spostare l‟attenzione suun altro problema (ad es di un altrofiglio).
le prospettive sociocultarale e sistemicofamiliare• L‟attenzione NON è posta sui singoli membrima sulla famiglia come «unit໕ I pattern familiari possono essere descritti in termini di «confiniinterpersonali»- La famiglia invischiata ci sono pochi confini tra imembri e si sviluppano relazioni intrusive• La famiglia disimpegnata: ha relazioni distaccate edistanti tra i vari membri di famiglia• E di «ruoli» (potere, responsabilità , alleanze, capro espiatorio)
• Bateson [1972] evidenzia come gli individuinon “si mettono in comunicazione” (approcciocentrato sull’informazione), non “partecipano”alla comunicazione (approccio interazionista)ma “sono” in comunicazione• Attraverso la comunicazione l’individuo giocase stesso e la sua identità
Bateson [1972] studiando la comunicazione fra i delfinie l’uomo e nei sistemi familiari caratterizzati damodelli schizofrenici scoprì che il comunicante simuove sempre secondo due livelli:• Il livello di notizia (cose e contenuti che manifesta)• Il livello di comando (indicazioni all’interlocutore dicome prendere le cose che dice)
La comunicazione si articola su più piani:Il piano della comunicazione (contenuti scambiati)Il piano della metacomunicazione (“cornice” con cui interpretare ilmessaggio)DA CUIOgni scambio comunicativo implica un’interazione concretafra gli individuiUna sequenza di “scambi” costituirà un modello di relazionefra loroLa comunicazione diventa il tessuto che crea, mantiene,modifica e rinnova i legami fra i soggetti
Secondo Bateson la comunicazione produce ladefinizione di sé e dell’altro“Ecco come sono. Ecco come mi vedo. Ecco comemi presento”CONTEMPORANEAMENTE“Ecco come ti vedo. Ecco come sei secondo me.Ecco che relazione ci lega”
La comunicazione secondo questomodello diventa la base costitutivadell’identità personale e della rete direlazioni in cui ciascuno è inserito
le prospettive sociocultarale e sistemicofamiliareIl doppio-legame• Bateson e coll. riteneva che lacomunicazione a doppio-legame da partedei genitori potesse condurre a gravidisturbi come la schizofrenia
le prospettive sociocultarale e sistemicofamiliareIl doppio-legame• Tra due individui uniti da una relazioneemotivamente rilevante, lacomunicazione dell'uno verso l'altropresenta una incongruenza tra il livellodel discorso esplicito (verbale) e unulteriore livello metacomunicativo (nonverbale)
le prospettive sociocultarale e sistemicofamiliareIl doppio-legame• La situazione deve essere tale per cui ilricevente il messaggio non abbia lapossibilità di decidere quale dei duelivelli, che si contraddicono, accettarecome valido, e nemmeno di far notare alivello esplicito l'incongruenza.
le prospettive sociocultarale e sistemicofamiliareIl doppio-legame, un esempio (Bateson)Una madre dopo un lungo periodo rivede ilfiglio ricoverato per disturbi mentali.Il figlio, in un gesto d'affetto, tenta diabbracciare la madre, la quale siirrigidisce; il figlio a questo punto siritrae, al che la madre gli dice: "Non deviaver paura ad esprimere i tuoi sentimenti".
le prospettive sociocultarale e sistemicofamiliare• A livello di comunicazione implicita rifiuta ilgesto d'affetto del figlio• A livello di comunicazione esplicita nega diessere la responsabileAlludendo al fatto che il figlio si sia ritratto nonperché intimorito dall'irrigidimento della madre,ma dai suoi stessi sentimentiIl figlio, colpevolizzato, si trova impossibilitato arispondere.
la prospettive biologicaSi concentrano sulle strutture fisiche e lefunzioni biochimiche che concorrono adeterminare il comportamento patologico• I ricercatori studiano la struttura e ilfunzionamento del cervello• La prospettiva biologica è diventatasempre più influente nell‟ambito dellapsicopatolgia
Cenni di Anatomia del Sistema Nervoso• Assi direzionali:Per evitare confusioni è necessario l‟uso diuna terminologia specifica che consentadi definire la localizzazione di un‟arearispetto alle altre.Gli anatomisti hanno sviluppato un sistemadi termini direzionali simili allecoordinate geografiche (nord – sud)
• Le strutturelocalizzate indirezione dellatesta del cane sonodette rostrali oanteriori; quellelocalizzate indirezione dellacoda sono dettecaudali oposteriori.• Le strutturelocalizzate sulversante ventralesono detteinferiori o ventralimentre quelle dallaparte della schienasuperiori o dorsali
Come quelligeografici i terminianatomici sonodefiniti rispetto ad unpunto di riferimentoLa stazione erettacomportaun’inclinazione a90° del nevrasse
• Esistono terminiche hanno comeriferimento lalinea mediana(linea immaginariache divide il corpoin due metà).• Le strutture chesi trovano sullostesso lato sonodette ipsilaterali,quelle che sitrovano sul latooppostocontrolaterali.Le strutture che si trovano nei pressi della linea medianasono dette mediali, quelle che si trovano ai lati sono dettelaterali.In anatomia le sezioni sono condotte secondo i seguentipiani:CoronaleSaggitaleOrizzontale
Il Sistema Nervoso• Il sistema nervoso viene diviso in due componentiil Sistema nervo Centrale (SNC) e il SistemaNervoso Periferico (SNP).• Il SNC comprende cervello e midollo spinale
Il Sistema Nervoso•Il SNP collega il SNCagli organi ed aimuscoli del corpo e sidivide in SistemaNervoso Somatico ein Sistema NervosoAutonomo•Il Sistema Nervoso Somatico è l’insieme dei nervi chetrasmette informazioni in entrata e in uscita dal SNC•Il Sistema Nervoso Autonomo è l’insieme dei nervi chetrasmette comandi involontari ed automatici checontrollano i vasi sanguigni, gli organi interni e leghiandole
Le componenti del Sistema Nervoso Centrale• Cervello e midollo spinale, dove il midollospinale fa spesso la parte del parentepovero rispetto alla “potenza” delcervello• In realtà il midollo spinale svolge dellefunzioni importantissime: consente larespirazione, la reazione al dolore, ilmovimento muscolare
Il Midollo Spinale• Il midollo spinale (MS) è una struttura di forma allungata e cilindrica,costituita da tessuto nervoso, è sito nel canale vertebrale si estendedal foro occipitale sino al margine inferiore della prima vertebralombare• Al centro del midollo corre per tutta la sua lunghezza il canale centraleche contiene il CSF• I nervi spinali emergono fra le vertebre della colonna• Nel MS si distinguono 31 neuromeri (8 cervicali, 12 toracici, 5 lombari, 5sacrali, 1 coccigeo)
Il Midollo Spinale• Il MS costituisce la principale via di comunicazione per latrasmissione dell‟informazione sensoriale.• I neuroni nelle corna dorsali della H ricevono gli inputsensoriali• I neuroni delle corna ventrali inviano ai muscoli i comandimotori e prendono parte sia ai movimenti volontari che airiflessi spinali
Le principali suddivisionidel cervelloIl cervello viene suddiviso in tre parti: romboencefalo,mesencefalo e prosencefalo.• Romboencefalo + mesencefalo = tronco encefalico• Prosencefalo = lobi cerebrali
Il romboencefalocoordina leinformazionidirette al MS eche provengonoda esso.E‟ formato dalmidollo allungato(o bulbo), dalponte e dalcervelletto.
Il midollo allungato èun‟estensione delMS che occupa laparte più caudaledel cervello.Coordina il battitocardiaco, lacircolazione e larespirazione; undanno in questaparte del cervellorisulta in brevetempo fatale
Il ponte situatorostralmente rispettoal midollo allungato, hail compito diconnettere il midolloallungato ai centrisuperiori del cervello edi creare connessionicon un‟altra strutturaimportante delromboencefalo, ilcervelletto.Fra i nuclei più importanti a questo livellovi sono il nucleo cocleare e quellovestibolare che ricevono fibreprovenienti dall‟orecchio interno
Dietro il midollo allungato si trovail cervelletto un‟ampiastruttura che controlla lecapacità motorie fini, lacoordinazione dei movimentivolontari, il mantenimento deltono muscolare e l‟equilibrioposturale.Lesioni cerebellaricompromettono lacoordinazione ma non causanola paralisiIn sintesi elabora le sequenzedelle contrazioni muscolarinecessarie per eseguire ilmovimento programmato
Il mesencefalo• Al di sopra del romboencefalo poggia il mesencefalo formato da duestrutture principali che sono il tetto ed il tegmento• Il tetto orienta l‟organismo nell‟ambiente. Riceve stimoli dagli occhi,dalle orecchie dalla pelle e muove l‟organismo in modo coordinatoverso lo stimolo• Il tegmento è implicato nel movimento e nell‟attivazione fisiologica(arousal). Parti del tegmento sono coinvolte nella ricerca del piaceree della motivazione. La sostanza nera importante per i movimenti sitrova nel tegmento.Le afferenze dopaminergiche provenientidall'area tegmentale ventrale si pensamodulino l'attività dei neuroni del nucleusaccumbens.
Il prosencefalo• Costituisce il livello più alto del cervello e controllacomplesse funzioni cognitive, emozionali, sensoriali emotorie.• E‟ suddiviso in diencefalo e telencefalo.• Il diencefalo comprende talamo ed ipotalamo, iltelencefalo comprende i due emisferi cerebrali
Il diencefalo• Il talamo riceve e filtra le informazioni provenienti daisistemi sensoriali e trasmette tali informazioni alla cortecciacerebrale.• L‟ipotalamo regola la temperatura corporea, la fame, la setee il comportamento sessuale, non è una struttura omogeneama è costituito da un aggregato di nuclei
Il diencefalo• L‟ipofisi, direttamente collegata all‟ipotalamo, mandasegnali ormonali a molte altre ghiandole checontrollano stress, attività digestive, riproduzione.• Il talamo, l‟ipotalamo e l‟ipofisi sono in posizionestrategica rendono possibile una stretta interazionecon altre strutture cerebrali. Esse ricevonoinformazioni, le elaborano e le ritrasmettono
Il telencefaloNei pressi del diencefalo maformalmente nel telencefalosono localizzati i tre nucleiche costituiscono i ganglidella base:Nucleo caudatoPutamenGlobo pallidoData la stretta connessione conla sostanza nera alcunianatomisti assegnanoquest‟ultima ai gangli dellabase, così come avviene perl‟amigdala.Queste strutture sonocoinvolte nel controllomotorio ed in alcunepatologie psicologiche come ilADHD e l‟ODC
Diverse sono le teorie proposteper individuare qualistrutture prosencefalichecompongono il sitema limbico.Tuttavia tuttecontribuiscono alla nostravita emozionaleIppocampo: è una strutturaarcuata localizzata nellazona mediale del lobotemporale, partecipa aiprocessi dell‟apprendimentoe della memoria
Amigdala: svolge un ruolosignificativo nel controllodelle emozioni come lapaura, la rabbia e lagestione dell‟aggressività(autismo).Ipotalamo: anch‟esso èconsiderato parte delsistema limbico in quantocontrolla fame, sete, sesso,risposta attacco-fuga insituazioni di emergenza;tutti aspetti legati alleemozioni
Giro del cingolo:circonvoluzione situata sullasuperficie interna degliemisferi cerebrali chepartecipa ad una vastagamma di attività emozionaliSetto pellucido: davanti atalamo ed ipotalamo,coinvolto nel comportamentoemozionale; se stimolatoproduce sensazioni piacevoli,se lesionato accessi rabbiaed aggressività
Bulbi olfattivi: localizzati allabase el prosencefalo,ricevono ed elaboranoinformazioni relative agliodoriGiro paraippocampale, corpimammillari e fornice sonoconsiderati, almeno da alcunistudiosi, parte del sistemalimbico. Queste strutturesono altamente connesse fraloro e svolgono una funzionecomune nel comportamentoemozionale e motivazionale
La corteccia cerebrale• E‟ il livello più alto del cervello ed è responsabile degli aspettipiù complessi della cognizione• Lo spessore della corteccia varia da 1,5 mm a 4 mm• Le superfici lisce (circonvoluzioni) della corteccia vengonochiamate giri, gli avvallamenti sono detti solchi; un solcoparticolarmente largo è detto fissura o scissura. Essipermetto alla corteccia di avere una superficie di 2500 cmqGli emisferi cerebrali sono 2 (destro esinistro) separati lungo la lineamediana dalla scissura interemisfericadetta anche scissura longitudinale
La corteccia cerebrale• Ogni emisfero della cortecciacerebrale è suddiviso in 4grandi aree chiamate lobi piùun‟altra grande area nascostadetta lobo dell‟insula
• Il più rostrale è il lobo frontale, il cui confine caudaleè segnato dalla scissura di Rolando (solco centrale).• Sull‟altro lato del solco si colloca il lobo parietale.• Ventralmente il lobo frontale è separato dal lobotemporale tramite la scissura di Silvio (solco laterale).• La parte posteriore della corteccia è occupata dallobo occipitale
• Diversamente dal MS negli emisferi cerebrali lasostanza grigia è localizzata all‟esterno e quella biancaall‟interno.• Sotto gli esili strati corticali di corpi cellulari sonopresenti grossi tratti di fibre che connettono lacorteccia con le altre strutture nervose.• Una formazione importante di sostanza bianca è ilcorpo calloso che costituisce una sorta di ponte dicollegamento tra i due emisferi.• I due emisferi sono inoltre connessi tramite lacommessura anteriore.
• Lobe Occipitale – situato nella parte posteriore dellacorteccia elabora le informazioni visive. I recettorisensoriali negli occhi inviano l‟informazione al talamo che asua volta la invia alle aree primarie occipitali
AGNOSIE VISIVEI disturbi del riconoscimento visivo possonocompromettere selettivamentealcune categorie di stimoli:• Agnosie per gli oggetti animati e non• Agnosie per i colori• Agnosie per le facce• Agnosie del movimento• Agnosia visuo-spaziale (astereoptica)AGNOSIA PER GLI OGGETTIAppercettiva: gli oggetti non vengono descritti nelle loroqualità formali; le funzioni visive primarie non sono osono poco alterateLe agnosie appercettive corrispondono solitamente alesioni bilaterali delle aree visive
Il lobo parietaleIl lobo parietale giace dietro al solco centrale e sopra allascissura laterale. Il giro postcentrale, che è il giro piùanteriore del lobo parietale, accoglie la corteccia interessataalle sensazioni somatiche (corporee).Quest‟area è detta corteccia somatosensoriale.Altre regioni del lobo parietale mediano aspettidell‟attenzione del linguaggio e una varietà di altre funzioni
Il lobo parietalel'area postrolandica dei lobi parietali integra gli stimolisomestesici per il riconoscimento e il ricordo di forme,strutture e pesi. Le aree più posterolaterali consentonoaccurate relazioni visuo-spaziali, l'integrazione dellapropiocezione con le altre sensibilità, la percezione dellaposizione delle varie parti del corpo.
Il lobo parietaleNell'emisfero dominante, l'area parietale inferiore èpreposta alle funzioni matematiche ed è strettamentecorrelata al riconoscimento del linguaggio e alla memoriaper le parole.Il lobo parietale, non dominante, integra il lato sinistro delcorpo con l'ambiente circostante.Ampie lesioni parietali inferiori dell'emisfero dominante(generalmente il sinistro) sono comunemente associate adafasia grave. Lesioni meno estese a questo livello, causanoaprassia, difficoltà di calcolo e talora disorientamento dxsxe agrafia.
Il lobo parietale destroDisturbidella memoriatopograficaAprassiadell‟abbigliamento AnosognosiaIncapacitàdi giudiziosui rapportispaziali
Il lobo parietale sinistroIncomprensione linguaggio parlatolinguaggio scrittoAprassiacostruttiva
• Lobo Temporale situato nella parte laterale inferiore diciascun emisfero è responsabile dell‟udito, del linguaggioe della memoria
• Lobo Frontale si trova dietro la fronte ha aree specializzate per ilmovimento, il pensiero astratto, la progettazione, la memoria, il giudizio.
INSULAElabora in maniera anticipatoria segnali di pericolo o che possano causare ansia esensazioni di disagio. Si attiva in risposta a gruppi di stimoli che induconoemozioni tipicamente umane: senso di colpa, risentimento, vergogna, orgoglio,gelosia...Sebbene non si sa ancora esattamente quale funzione assolva questa areacerebrale, molti autori propongono che la corteccia insulare sia la sede dellatrasduzione cognitiva della corporeità delle emozioni > embodied emotion.
lobi cerebrali
Secondo il neurologo Paul MacLean, il nostro cervello è costituito da tre componentidistinte, ognuna delle quali rappresenta un momento evolutivo ben preciso della specieumana:Cervello rettiliano (o tronco del cervello)Il cervello paleomammifero (o sistema limbico)Cervello neomammifero (o neocorteccia)
Il cervello rettiliano (o tronco del cervello) é filogeneticamente la piùvecchia parte del cervello ed è sede di funzioni vitali come il controllodel ritmo cardiaco e respiratorio e delle regolazioni interne (viscerali eghiandolari). Si occupa di «attività primitive» basate su istinti e riflessi edei centri per risvegliare la vigilanza dell’animale o farlo dormire
Il cervello paleomammifero (o sistema limbico) - corrisponde nella scalaevolutiva al cervello dei mammiferi, specie di quelli più antichi ed ècoinvolto nell'elaborazione delle emozioni;Il sistema limbico è intimamente connesso da sistemi neurali a due-viecon l’ipotalamo e altri centri nel tronco del cervello concernente lesensazioni viscerali e le reazioni emozionali – incluso sesso, fame,paura e aggressione; il sistema limbico produce informazione (cheacquisisce in forma di sentimenti ed emozioni) che diviene la guida perle forze nel comportamento
Cervello neomammifero (o neocorteccia), più recente, è esclusivo deiprimati ed è sede di tutte le funzioni cognitive e razionali. Laneocorteccia è la localizzazione nella quale le informazioni sonoesaminate nelle modalità caratteristiche della mente auto-riflessivaPur se perfettamente coordinate tra loro, queste tre aree sarebbero,secondo MacLean, indipendenti l'una dall'altra e in grado di dominarsireciprocamente. L'idea, in sostanza, che la corteccia cerebraledominasse e coordinasse l'intero funzionamento del cervello, venivacosì a cadere.
Il Sistema Nervoso Periferico - SNPIl Sistema NervosoPeriferico trasportal‟informazione sensorialeverso il centro, cioèverso il midollo spinale eil cervello, e riportaverso la periferia icomandi che innescanole azioni appropriate.Da un punto di vistastrutturale è compostoda: nervi cranici, nervispinali e sistema nervosoautonomo.Da un punto di vistafunzionale si suddividein sistema nervososomatico e sistemanervoso autonomo
Il Sistema Nervoso Autonomo - SNAIl Sistema NervosoAutonomo è il «pilotaautomatico» deinostri organi interni(cuore, polmoni,canale digerente)Controllo volontario:Nuoto; biofeedbackil SNA si divide inSistema NervosoSimpatico (SNS) eSistema NervosoParasimpatico (SNPr)
Il Sistema Nervoso Simpatico - SNSIl SNS è l‟insieme deinervi che prepara ilcorpo per l‟azionenelle situazioniminacciose.Se ci sentiamominacciati aumentala frequenzacardiaca e larespirazione perpompare più ossigenoai muscoli
Il Sistema Nervoso Simpatico - SNSIl SNS, quandonecessario, devia ilflusso sanguignoverso cervello emuscoli, attiva leghiandole sudoripareper raffreddare ilcorpo, inibisce lasalivazione e laperistalsi.
Il Sistema Nervoso Parasimpatico - SNPrIl SNPr aiuta il corpo aritornare a un normalestato di riposo ed aricostruire le riserve dienergiaI neuroni del SNPr sonolocalizzati nel cervello e neisegmenti sacrali del MSAbbandonato il cervello e ilMS, gli assoni pregangliaridel SNPr, dopo un percorsolungo e tortuoso, arrivanonei pressi degli organibersaglio, dove sonolocalizzati i gangli del SNPrIl ruolo principale nel controllocentrale del SNA lo hal‟ipotalamo



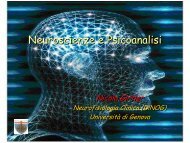
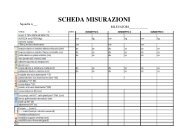
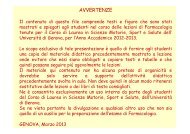
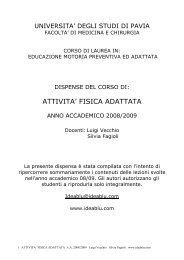
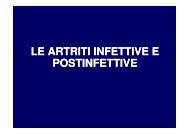
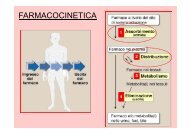



![Arti Marziali JUDO Ge Aprile2012 [modalitàcompatibilità]](https://img.yumpu.com/47286865/1/184x260/arti-marziali-judo-ge-aprile2012-modalitaa-compatibilitaa-.jpg?quality=85)