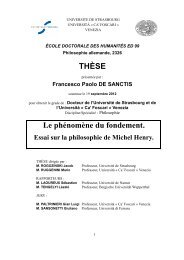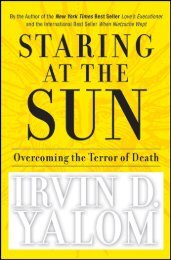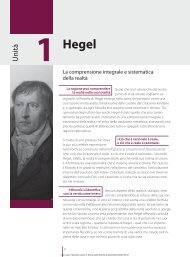Etnocentrismo-e-relativismo-culturale
Etnocentrismo-e-relativismo-culturale
Etnocentrismo-e-relativismo-culturale
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Etnocentrismo</strong> e <strong>relativismo</strong><br />
<strong>culturale</strong><br />
Lezione
ETNOCENTRISMO<br />
• “ETNOCENTRISMO È IL TERMINE TECNICO CHE<br />
DESIGNA UNA CONCEZIONE PER LA QUALE IL<br />
PROPRIO GRUPPO (IN-GROUP) È CONSIDERATO IL<br />
CENTRO DI OGNI COSA, E TUTTI GLI ALTRI (OUT-<br />
GROUPS)SONO CLASSIFICATI E VALUTATI IN<br />
RAPPORTO AD ESSO….<br />
OGNI GRUPPO ALIMENTA IL SUO ORGOGLIO E LA<br />
SUA VANITÀ, PROCLAMA LA PROPRIA<br />
SUPERIORITÀ , ESALTA LE PROPRIE DIVINITÀ E<br />
CONSIDERA CON DISPREZZO GLI STRANIERI.”<br />
• (William Graham Sumner, FOLKWAYS,1906)
ETNOCENTRISMO<br />
ATTITUDINALE (V. Lanternari)<br />
• SENTIMENTO DI ADESIONE<br />
INCONSAPEVOLE ALLA PROPRIA<br />
FORMA DI VITA CONNESSO AL<br />
PROCESSO DI INCULTURAZIONE<br />
• ATTEGGIAMENTI DIFENSIVI DELLA<br />
PROPRIA “FORMA DI VITA” E DI<br />
CULTURA
ETNOCENTRISMO IDEOLOGICO<br />
• SI CONFIGURA COME DISCORSO<br />
POLITICO, PUBBLICO.<br />
• E’ CONNESSO ALLE VARIE FORME DI<br />
NAZIONALISMO ED ETNICISMO.
Esclusivismo <strong>culturale</strong><br />
• Particolare forma di etnocentrismo che<br />
agisce nei rapporti interni alla società<br />
stratificate e complesse. I comportamenti<br />
degli strati subalterni e periferici vengono<br />
disprezzati e respinti fuori della ‘cultura’,<br />
perché non collimano con gli<br />
atteggiamenti e i valori dei ceti colti e<br />
dominanti, e più in genere perché non<br />
collimanti con i modi ufficiali di vedere il<br />
mondo (A.M.Cirese)
RELATIVISMO CULTURALE<br />
• Atteggiamento di rifiuto<br />
dell’etnocentrismo<br />
• Accettazione della pluralità delle<br />
culture
RELATIVISMO CULTURALE<br />
• OGNI CULTURA POSSIEDE UN<br />
PROPRIO SISTEMA DI RAZIONALITA’ E<br />
DI COERENZA.<br />
• TUTTE LE MANIFESTAZIONI HANNO<br />
SIGNIFICATO E VALIDITA’ SOLTANTO<br />
ALL’INTERNO DI TALE CONTESTO.<br />
• (Pasquinelli, Mellino, p. 132)
RELATIVISMO CULTURALE<br />
• IL RELATIVISMO NASCE NELL’AMBITO<br />
DELLA SCUOLA AMERICANA DI<br />
FRANZ BOAS E DEI SUOI ALLIEVI (R.<br />
BENEDICT, M. MEAD, SAPIR, M.<br />
HERSKOVITZ) E DELL’ASSUNTO<br />
SECONDO CUI OGNI CULTURA HA<br />
UNA SUA UNICITA’.
Il <strong>relativismo</strong> etico di M.<br />
Herkovitz<br />
• Nella sua formulazione teorica il <strong>relativismo</strong> si articola in<br />
• <strong>relativismo</strong> etico<br />
• <strong>relativismo</strong> cognitivo o epistemologico<br />
• MELVILLE HERSKOVITZ (1895-1963) cercò nel 1947<br />
di condizionare la Commissione delle Nazioni Unite<br />
incaricata di stendere la Dichiarazione Universale dei<br />
Diritti Umani.<br />
• Vedeva il rischio di una Dichiarazione che fosse<br />
espressione esclusivo del pensiero occidentale<br />
(universalismo etnocentrico).
MELVILLE HERSKOVITZ<br />
(1895-1963)<br />
• “I giudizi sono basati sull’esperienza e l’esperienza è<br />
interpretata da ciascun individuo nei termini della<br />
sua propria inculturazione” (1948).<br />
• Le nozioni di giusto, ingiusto, buono e cattivo, bello<br />
e brutto, il normale e l’anormale sono presenti in<br />
tutte le culture.<br />
• Ciò che varia, ciò che e’ relativo, sono i criteri di<br />
valutazione che sono appresi dagli individui<br />
attraverso il processo di socializzazione,<br />
educazione, inculturazione.
MELVILLE HERSKOVITZ<br />
(1895-1963<br />
• HERSKOVITZ elaborò un documento<br />
• “Statement on Human Rights”:<br />
• una Dichiarazione veramente universale e<br />
non etnocentrica deve tener conto della<br />
legittimità , per gli esseri umani, di pensare e<br />
agire in conformità alle credenze, ai costumi,<br />
ai codici morali della propria cultura.<br />
Lo Statement non fu accolto.
RELATIVISMO CULTURALE<br />
ASPETTI POSITIVI<br />
• VALORIZZAZIONE DELLE CULTURE<br />
PRIMITIVE<br />
• CRITICA DEL RAZZISMO<br />
• TOLLERANZA VERSO LA DIVERSITA’<br />
CULTURALE<br />
• RECIPROCO RISPETTO<br />
• NECESSITA’ DI CONOSCERE<br />
• >
RELATIVISMO CULTURALE<br />
Frutto avvelenato<br />
• Quando il <strong>relativismo</strong> da metodo per la<br />
comprensione della diversità diventa un<br />
assoluto della storia, il riconoscimento<br />
della pluralità delle culture si traduce in<br />
una concezione di esse come entità<br />
chiuse in se stesse e stabili, nettamente<br />
definite, senza relazioni tra esse e<br />
incombenti sugli individui e, (visione<br />
essenzialista).
Le società e le culture non sono cose<br />
• La ricerca antropologica mostra che le società e<br />
le culture non sono così tanto integrate e<br />
organiche al loro interno, sono attraversate da<br />
contraddizioni e conflitti e si sono sempre<br />
reciprocamente influenzate (acculturazione).<br />
• I valori esistono, ma sono piuttosto dei ‘criteri<br />
orientativi’ per gli individui e il processo<br />
inculturativo non elimina la dimensione<br />
individuale, la critica, il conflitto.
Critiche al <strong>relativismo</strong><br />
• Molti antropologi sono stati e sono contrari al<br />
<strong>relativismo</strong>, vedendo in esso il rischio della<br />
perdita di ogni criterio di giudizio morale e anche<br />
conoscitivo, una sorta di strumento per<br />
giustificare tutto in nome del fatto che ogni<br />
gruppo ha la sua cultura e che questa cultura<br />
determina i comportamenti degli individui:<br />
• “scambiare quattro chiacchiere con tutti e non<br />
condannare nessuno” (Gellner cit. in Fabietti,<br />
Antropologia Culturale, p. 21)
Lévi-Strauss, Razza e storia<br />
( 1952)<br />
• Le grandi dichiarazioni dei diritti dell’uomo<br />
dimenticano che gli esseri umani non<br />
realizzano la propria natura in una<br />
umanità astratta, ma in cultura tradizionali.<br />
• Come conciliare il riconoscimento di tale<br />
molteplicità con i principi universali di<br />
uguaglianza del genere umano
Lévi-Strauss, Razza e storia<br />
( 1952)<br />
• La risposta di Lévi-Strauss è la seguente:<br />
• La comune umanità si realizza attraverso<br />
e non malgrado le differenze.<br />
• Il progresso è il frutto delle reciproca<br />
fecondazione di tradizioni diverse.
Relativismo cognitivo<br />
Secondo il <strong>relativismo</strong> cognitivo in ogni<br />
gruppo umano variano non solo i<br />
contenuti dei saperi, legati come essi sono<br />
alle esperienze empiriche e alle<br />
congiunture storiche; ma variano altresì<br />
le strutture stesse del pensiero, le<br />
categorie secondo le quali i saperi<br />
vengono prodotti e organizzati
Relativismo cognitivo<br />
Per quanto riguarda l'antropologia, il<br />
<strong>relativismo</strong> cognitivo ha impegnato gli<br />
studiosi fin dall'inizio del '900 in un<br />
dibattito ancora non concluso, che nella<br />
sua prima fase opponeva il pensiero<br />
magico, prelogico e empatico, ritenuto<br />
proprio dei popoli primitivi, e il pensiero<br />
razionale, astraente, generalizzante,<br />
considerato proprio dei popoli evoluti;
Relativismo cognitivo<br />
Secondo Lévy-Bruhl era possibile parlare<br />
di una "mentalità primitiva" prelogica,<br />
fondata su principi diversi) da quelli della<br />
logica razionale (aristotelica) in quanto a<br />
tale mentalità avrebbero fatto difetto il<br />
principio di identità (A = A), il principio di<br />
non contraddizione (se A = A allora A = B)<br />
e il principio di causalità.
Relativismo cognitivo<br />
• Il problema è il seguente:<br />
• se le forme del pensiero sono relative,<br />
interne a ciascuna cultura, come è<br />
possibile uscire dalla propria cultura,<br />
comunicare transculturalmente, far<br />
circolare i saperi<br />
• Eppure, come l'esperienza dimostra, i<br />
saperi circolano e non da oggi.
Basi storico-filosofiche della<br />
questione<br />
• La filosofia occidentale fin da Platone ha<br />
considerato la molteplicità degli usi e<br />
costumi locali un problema imbarazzante,<br />
rischioso e si è sempre “barcamenata tra il<br />
polo dell’unità e quello della molteplicità”<br />
• (Remotti, Noi primitivi, p. 80)
Basi storico-filosofiche della<br />
questione<br />
• Dopo la scoperta dell’ America tra il XVI e<br />
XVII sec. Si oppongono Montaigne e<br />
Cartesio.<br />
• Il primo accetta la diversità dei costumi del<br />
mondo nuovo<br />
• Il secondo elabora un sistema filosofico<br />
basato sulla ragione che esclude i<br />
costumi, i propri e quelli degli altri:<br />
pensiero che pensa se stesso
Basi storico-filosofiche della<br />
questione<br />
• Montaigne è un esempio del “giro lungo”<br />
dell’antropologia secondo la quale la<br />
diversità dei ‘costumi’ è costitutiva della<br />
ragione e del concetto di agente umano:<br />
tutto è consuetudine, non esistono verità<br />
assolute.
Basi storico-filosofiche della<br />
questione<br />
• Per Cartesio e Kant e altri, la molteplicità<br />
dei costumi non è rilevante, essi sono<br />
“rami secchi” di una Storia e di una<br />
Scienza che ha nella Ragione il suo<br />
fondamento e nella Civiltà occidentale il<br />
suo centro.<br />
• Lettura DEI p. 44
Il Novecento - Anni ‘60<br />
Dibattito tra universalisti e relativisti<br />
• La posizione relativista (Winch):<br />
• Non vi è nessun principio universale di<br />
razionalità in grado di comprendere e<br />
valutare tutte le culture umane.<br />
• Per comprendere i sistemi culturali alieni’<br />
(ad es. la stregoneria presso gli Azande)<br />
non si possono usare le categorie della<br />
scienza occidentale. (vero/falso)
Il Novecento - Anni ‘60<br />
Dibattito tra universalisti e relativisti<br />
• La credenze possono essere compresi<br />
solo sulla base dei sistemi di regole che le<br />
governano e che sono radicati in specifici<br />
contesti sociali (‘forme di vita’).<br />
• Le forme di pensiero sono connesse alle<br />
forme di vita
Il Novecento - Anni ‘60<br />
Dibattito tra universalisti e relativisti<br />
• Posizione universalista:<br />
• Cercare un qualche forma o livello di<br />
razionalità comune a tutte le diverse<br />
culture sulla base dell’unità della mente<br />
umana.
Anti-anti- <strong>relativismo</strong>(1984)<br />
CLIFFORD GEERTZ (1926-2006)<br />
• PERCHÉ ABBIAMO PAURA DEL RELATIVISMO CULTURALE COME<br />
LA CAUSA DI OGNI MALE DEL NOSTRO SECOLO<br />
• IL MONDO GLOBALIZZATO COME COLLAGE IN CUI I BORDI<br />
SOCIALI NON SONO PIÙ NETTI E PRECISI, MA DEVIANO IN<br />
SFUMATURE, DIFFICILI DA LOCALIZZARE E IDENTIFICARE.<br />
•<br />
LA DIVERSITÀ E IL SUO STUDIO SERVONO A CAPIRE CIÒ CHE CI<br />
STA DI FRONTE, A DARCI UNA COLLOCAZIONE IN QUESTO<br />
COLLAGE, SENZA ANNULLARE LE NOSTRE IDENTITÀ, NEL<br />
RISPETTO DELLE IDENTITÀ ALTRUI.<br />
ACQUISIRE “LA CAPACITÀ DI PENETRARE SENSIBILITÀ ESTRANEE,<br />
MODI DI PENSIERO CHE NON POSSEDIAMO E CHE NON SONO<br />
SIMILI AI NOSTRI” È OGGI DI GRANDISSIMA IMPORTANZA PERCHÉ<br />
LE DIFFERENZE SONO IN MEZZO A NOI, TALVOLTA PARTE DI NOI.<br />
• “L’ESTRANEITÀ NON COMINCIA AL DI LÀ DEL FIUME, MA DALLA<br />
PELLE”
Anti-anti- <strong>relativismo</strong>(1984)<br />
CLIFFORD GEERTZ (1926-2006)<br />
• CONSIDERARE GLI ‘ALTRI’ Non<br />
“ALTERNATIVE A NOI”, attraverso un<br />
impiego acritico delle nostre categorie<br />
interpretative ma “ALTERNATIVE PER<br />
NOI” vale a dire:<br />
• IMPARARE A COMPRENDERE CIÒ<br />
CHE NON POSSIAMO ACCETTARE<br />
NELLA DIREZIONE DI UN<br />
ACCRESCIUTO ORIZZONTE<br />
CULTURALE
<strong>Etnocentrismo</strong> critico<br />
E. De Martino<br />
• L’e.c. rappresenta l’impegno da parte<br />
dell’antropologo di fronte ad una cultura ‘altra’ di<br />
presa di coscienza critica dei limiti della propria<br />
storia <strong>culturale</strong>, politica e sociale.<br />
• L’antropologo non può comprendere il diverso<br />
se non partendo dalle categorie conoscitive<br />
della propria cultura.<br />
• Tale sforzo conoscitivo tende a produrre un<br />
esame critico delle categorie usate<br />
dall’Occidente per conoscere l’altro e un loro<br />
ampliamento.