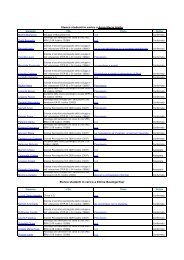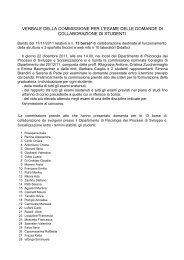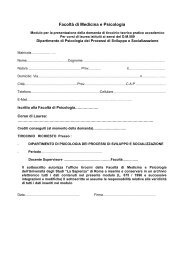1 Abstract La prima parte dell'articolo discute criticamente il concetto ...
1 Abstract La prima parte dell'articolo discute criticamente il concetto ...
1 Abstract La prima parte dell'articolo discute criticamente il concetto ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
E’ sufficiente valutare <strong>il</strong> QI per individuare <strong>il</strong> nucleo essenziale del deficit in un disturbo<br />
neuroevolutivo Esiste un disturbo che possa caratterizzarsi in maniera distintiva<br />
attraverso la congiunzione di due apparentemente semplici condizioni: la valutazione<br />
del QI e quella del deficit nel funzionamento adattivo<br />
Intelligenza e QI<br />
L’idea che <strong>il</strong> nucleo essenziale di un deficit possa cogliersi attraverso <strong>il</strong> QI (tanto da<br />
basare su questo indicatore una delle tre condizioni della diagnosi) ha origine dalla<br />
convinzione che <strong>il</strong> QI possa essere un buon indicatore dell’intelligenza. Questa<br />
convinzione si basa su una tradizione di studi psicometrici che è partita<br />
dall’osservazione statistica di un’alta intercorrelazione tra i punteggi nei diversi<br />
subtest che compongono la valutazione del QI. Nonostante ogni compito di una<br />
batteria che valuta <strong>il</strong> QI presenti la sua specificità, e dunque sia probab<strong>il</strong>e che un<br />
individuo possa far molto bene in un compito e meno bene in un altro, i compiti che<br />
valutano <strong>il</strong> QI tendono ad avere prestazioni correlate tra loro. Chi ha una prestazione<br />
più alta della media in un compito, tende ad avere una prestazione di livello sim<strong>il</strong>e in<br />
altri compiti che concorrono alla valutazione del QI. Applicando l’analisi fattoriale a<br />
questi patterns di correlazioni si è trovato che c’è una porzione di varianza comune tra<br />
i vari subtest, denominata fattore “g”. Ci sono state molte controversie su che cosa sia<br />
effettivamente <strong>il</strong> fattore “g” in termini psicologici o neurofisiologici. Tra le ipotesi<br />
formulate in anni passati dobbiamo includere: una sorta di energia mentale<br />
(Spearman, 1927) corrispondente alle capacità attentive, un’ab<strong>il</strong>ità di ragionamento<br />
astratto (Gustafsson, 1984); una velocità di processamento neurale (Reed & Jensen,<br />
1992) che influenzerebbe anche semplici compiti di tipo percettivo. Nessuna di<br />
quest’ipotesi è stata confermata (per un’ampia rassegna su questi risultati controversi<br />
si veda Neisser et al., 1996), e in effetti persino l’affermazione che un unico fattore<br />
spieghi in maniera ottimale le intercorrelazioni tra i subtest ha ricevuto critiche. Alcuni<br />
studiosi (Thurstone, 1938) hanno infatti individuato gruppi di fattori che spiegano le<br />
intercorrelazioni tra gruppi di test meglio di un fattore unico. Carroll (1993) ha<br />
elaborato un modello psicometrico che prevede 70 diverse specifiche ab<strong>il</strong>ità alla base<br />
dei subtest che valutano <strong>il</strong> QI. Riguardo alle basi psicometriche della fattorialità<br />
sottostante al QI possiamo concludere che non esistono evidenze univoche a conferma<br />
dell’affermazione che <strong>il</strong> QI sia un indicatore della capacità intellettiva. In altre parole,<br />
non può essere scartata l’ipotesi che un QI deficitario sia <strong>il</strong> risultato di deficit in un<br />
vasto insieme di ab<strong>il</strong>ità specifiche piuttosto che l’espressione di un deficitario sv<strong>il</strong>uppo<br />
3