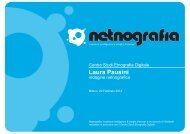www.etnografiadigitale.it 1 - Centro Studi Etnografia Digitale Centro ...
www.etnografiadigitale.it 1 - Centro Studi Etnografia Digitale Centro ...
www.etnografiadigitale.it 1 - Centro Studi Etnografia Digitale Centro ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>www</strong>.<strong>etnografiadig<strong>it</strong>ale</strong>.<strong>it</strong> <br />
1
comun<strong>it</strong>à di sangue e pixel <br />
Don’t worry – I’m a good Indian. I’m from the West, love nature, and have a <br />
special, intimate connection w<strong>it</strong>h the environment…I can speak w<strong>it</strong>h my <br />
animal cousind, and believe <strong>it</strong> or not I’m appropriately spir<strong>it</strong>ual. (Even <br />
smoke the Pipe)…I hope I am authentic enough” <br />
(Durham, 2002:211). <br />
L’imbarazzo immediato derivato dall’inv<strong>it</strong>o di scrivere su Avatar, cioè sul film di James Cameron, deriva da <br />
una condizione personale troppo esposta su tale questione. Nel senso che entrambi i lati “binari” (quello <br />
“etnico” e quello “avatarico”) del film sono stati da me vissuti in prima persona come ricerca sul campo: <br />
Avatar è stata la rivista di antropologia e arti dig<strong>it</strong>ali da me ideata e diretta dalla fine degli anni 90 fino alla <br />
sua secca conclusione; la ricerca etnografica sulle culture indigene brasiliane mi ha fatto vivere e riflettere, <br />
emozionare e crescere nelle mie visioni sulle alter<strong>it</strong>à radicali dall’inizio dei 90. Quindi per me questo intero <br />
decennio si apre con l’incontro Xavante e si chiude con il progetto Avatar. <strong>Etnografia</strong> e dig<strong>it</strong>ale sono <br />
connessi. Infatti, tali esperienze progettuali sono cost<strong>it</strong>utive dell’ipotesi su cui continuo a lavorare della <br />
tensione dialogica e confl<strong>it</strong>tuale tra aldeia e metropoli. Cioè tra i villaggi dove vivono le culture defin<strong>it</strong>e <br />
“native” e la metropoli comunicazionale dove, tra l’altro, si producono cinema e tecnologie dig<strong>it</strong>ali. Questo <br />
è il mio imbarazzo: un eccesso di coinvolgimento sulle mie scelte anche personali che mi hanno fatto <br />
decidere di lasciare Roma e l’univers<strong>it</strong>à <strong>it</strong>aliana. <br />
a-‐ Xavante, Bororo o Na’vi <br />
Il Mato Grosso è uno stato del Brasile, paese che ha una cost<strong>it</strong>uzione federale affine a quella degli Stati <br />
Un<strong>it</strong>i. Negli ultimi anni, la soia – l’oro verde – ha cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o una enorme fonte di espansione economica <br />
dell’intera regione, che ha contribu<strong>it</strong>o al nuovo ruolo internazionale del paese. Tale prodotto, di cui si fanno <br />
persino tre raccolti l’anno, non solo accresce la ricchezza prodotta dalla stato, quanto favorisce la crescente <br />
alleanza strategica globale con la Cina, grande consumatrice e importatrice della soia brasiliana. Ricordo <br />
ancora perfettamente una mia esperienza di diversi anni fa, in una delle prime vis<strong>it</strong>e all’aldeia Bororo, in cui <br />
fui costretto a guidare un fuoristrada in un traffico da incubo per i continui camion stracarichi di questa <br />
soia, su un asfalto che si sbriciolava sotto i pneumatici di questi sgangherati trucks troppo pesanti, <br />
provocando enormi crateri di terra rossa intorno ai quali – ripeto intorno ai quali e no lateralmente – si <br />
dovevano fare continue peripezie acrobatiche per andare avanti. Fu il mio battesimo della soia su <br />
quell’unica strada stratale che passa vicino a una c<strong>it</strong>tà – Rondonia – dedicata all’esploratore che per primo <br />
tentò di difendere e di creare riserve per i diversi gruppi indigeni, Rondon stesso di madre bororo. <br />
Tale mare verde vuole tracimare in quello che resta di queste riserve e ha gli strumenti per avere successo: <br />
in primo luogo offrendo briciole di denaro ad alcuni cacique per ottenere il permesso di entrare nei loro <br />
terr<strong>it</strong>ori extra-‐legem per i fazendeiros. Questi hanno un potere diffuso, controllando tutta la produzione e i <br />
governi locali, senza che la polizia federale possa intervenire con una continu<strong>it</strong>à che offra un minimo di <br />
garanzia pol<strong>it</strong>ica. Essi si chiamano, secondo una tradizione antica, anche coroneis e hanno una forza mil<strong>it</strong>are <br />
privata -‐ criminale/marginale -‐ come per l’assassino di Chico Mendes. Allora si potrebbe affermare che <br />
quell’oggetto prezioso nascosto dal Grande Albero dei Na’vi abbia in Mato Grosso il colore verde della soia
pronta per la zafra e in attesa di penetrare con le buone o con le cattive nelle contigue terre Xavantes e <br />
Bororo. Terre che, come ripete costantemente una stampa compiacente o corrotta, sarebbero estese <br />
eccessivamente per la scarsa popolazione che le ab<strong>it</strong>a; mentre i “contadini” – cioè i fazendeiros – lavorano <br />
duro per arricchire il paese in una terra detta insufficiente. <br />
Xavante e Bororo sono tra loro profondamente diversi. La storia delle loro culture è lunga e non la rifaccio <br />
qui; gli Xavantes furono costretti ad abbandonare i loro terr<strong>it</strong>ori, cioè a essere deportati per una questione <br />
giudiziaria legata alla terra da loro ab<strong>it</strong>ata che ha coinvolto anche la nostra ENI. Costretti a vivere in <br />
prossim<strong>it</strong>à dei loro osp<strong>it</strong>i Bororo (già noti alla letteratura antropologica per i celebri cap<strong>it</strong>oli cui Lévi-‐Strauss <br />
ha dedicato loro sui “tristi tropici”), gli Xavantes si sono da sempre caratterizzati come un popolo guerriero <br />
forte – bravo come si dice in Brasile – che ha dato filo da torcere all’eserc<strong>it</strong>o brasiliano e che non si ferma <br />
dinanzi ai soprusi di qualsiasi tipo ancora oggi. Da un paio di decenni il loro tasso demografico cresce e <br />
quando si uniscono per i loro r<strong>it</strong>uali o per reagire a una ingiustizia possono arrivare in migliaia dalle varie <br />
aldeias, alti e muscolosi, ben nutr<strong>it</strong>i e addestrati agli esercizi fisici e allo sport, armati non solo di archi, <br />
frecce e bonduras, con strategie di attacco e difesa impressionanti. Non è casuale che l’aereo di caccia <br />
brasiliano si chiami appunto Xavante… <br />
Il loro r<strong>it</strong>uale più noto, cui ho potuto partecipare su inv<strong>it</strong>o di un cacique, si chiama foração das orelhas: per i <br />
mesi del r<strong>it</strong>uale si vive in una sospensione delle attiv<strong>it</strong>à normali, in preparazione di forare il lobo auricolare <br />
delle nuove generazioni che stanno per diventare guerrieri e mutare di nome nel loro bel r<strong>it</strong>o di passaggio. <br />
Dopo il foro, praticato da un guerriero anziano appartenente a un clan diverso da quello del giovane, si <br />
infila un pal<strong>it</strong>o, cioè un orecchino di legno di circa tre cm di lunghezza e largo 3-‐4 mm. In tal modo, solo <br />
dopo che è stato forato, il neo guerriero può forare una donna e quindi sposarsi, per cui diventa chiaro <br />
perché il pal<strong>it</strong>o ha il nome dell’organo gen<strong>it</strong>ale maschile. <br />
I Bororo, loro osp<strong>it</strong>i involontari, sono diventati spesso v<strong>it</strong>time degli Xavantes. Da qui una reciproca <br />
diffidenza difficile a superarsi. Per fortuna in questi ultimi anni la s<strong>it</strong>uazione sta mutando anche per loro: il <br />
tasso di natal<strong>it</strong>à cresce, meno significativamente degli Xavantes ma cresce, l’assistenza san<strong>it</strong>aria è ancora <br />
precaria ma non assente, il sistema nutr<strong>it</strong>ivo migliora e anche l’educazione. Non sono pochi quelli che <br />
studiano antropologia o come Kleber – ora mio caro amico – che è laureato in biologia. E da questo humus <br />
culturale sta nascendo la volontà di ristabilire la loro aldeia tradizionale utilizzando il dig<strong>it</strong>ale come mezzo di <br />
ricerca e documentazione. Il loro r<strong>it</strong>uale per eccellenza è il funerale e ho potuto assistere anche a questo <br />
complesso r<strong>it</strong>o sempre su inv<strong>it</strong>o di Kleber e di alcuni altri bororo. Posso dire che entrambi i r<strong>it</strong>uali -‐ foração <br />
das orelhas xavante e funeral bororo – sono state le esperienze culturali più straordinare cui ho potuto <br />
partecipare nelle mie ricerche etnografiche. Un trasbordare di emozioni e visioni, canti e danze, calore <br />
diurno e freddo notturno, pao de cachorro che ti penetra nei piedi e borrachudas che ti mordono in ogni <br />
frammento di pelle visibile, digiuni e sete -‐ esperienza, quest’ultima, la più estrema. <br />
Entrambi i r<strong>it</strong>uali sono sopravvissuti all’ingerenza salesiana che, in nome di una difesa contro i fazendeiros e <br />
pol<strong>it</strong>ici senza scrupoli, hanno iniziato e stanno continuando la più colonialista delle missioni: evangelizzare <br />
l’altro, sottraendo la forza delicata delle loro culture attraverso strumenti sottili che vanno dalla nozione di <br />
peccato e colpa, alle offerte di medicinali e assistenza alimentare o giuridica. Abbiamo quindi una prima <br />
variazione alla proposta Avatar, cioè l’espansione crescente di missionari cattolici e ancor più protestanti <br />
(che sono recenti, più aggressivi e fondamentalisti) riesce a creare una rete persuasiva di complic<strong>it</strong>à, ricatti, <br />
benefici materiali attraverso cui guidare e correggere le loro anime. Classico esempio di una religios<strong>it</strong>à <br />
tutta materialista applicata a persone da convertire rispetto a una filosofia di v<strong>it</strong>a altra che, per motivi <br />
<strong>www</strong>.<strong>etnografiadig<strong>it</strong>ale</strong>.<strong>it</strong> <br />
3
inspiegabili, diventa inaccettabile per i cristiani e fonte di una missione v<strong>it</strong>ale: convertire -‐ termine pessimo <br />
quanto esemplare di una procedura di dominio continuo. I missionari si convincono di stare nel giusto, con <br />
il loro dio, e questo li leg<strong>it</strong>tima a procedere verso una deculturazione sistematica e quotidiana. <br />
James Cameron vive in California dove ci sono tra i migliori antropologi attuali e celebri biblioteche: parlare <br />
con Renato Rosaldo o George Marcus non dovrebbe essere un suo problema. E nemmeno dare un’occhiata <br />
ai tanti testi da Marvin Harris, Dennis Tedlock a Clifford Geertz che sono c<strong>it</strong>ati da ogni studente di primo <br />
anno. Niente. Il suo scopo non è quello di dare un minimo di informazioni e conoscenze sulle culture <br />
“native”. Tanto meno di far crescere la consapevolezza tra i vari pubblici filmici che le cose sono un po’ più <br />
complesse da come si continua a far credere nella tradizione cinematografica di Hollywood. Per essere <br />
brutale: l’unica antropologia che Cameron conosce e “rielabora” è quella di Tarzan, rivest<strong>it</strong>a dal peggio <br />
romanticismo pseudo-‐russoviano stile National Geographic o Geo&Geo (1). Il modello è semplice e <br />
funzionale: il film applica un modulo sado-‐masochista allo spettatore globalizzato (sì, caro A.A., ancora <br />
quello affrontato da Adorno nell’industria culturale “illuminista”). Lo si colpevolizza masochisticamente di <br />
aver distrutto la “natura” e gli “indiani”; e lo si fa identificare sadicamente con l’eroe vendicatore e <br />
assassino leg<strong>it</strong>timo. Cameron, involontario fan della “Dialettica dell’Illuminismo” , continua nell’immutabile <br />
cuore di tenebra secondo cui l’Occidente è il Male (nel caso specifico un eserc<strong>it</strong>o troppo simile a un <br />
videogame per essere davvero identificato con quello degli Usa) e il Bene risiede nelle radici naturalistiche e <br />
naif dei selvaggi che avrebbero mantenuto un sacrale rapporto con la natura e la v<strong>it</strong>a, una natura-‐donna <br />
selvaggia, certo, piena di animalacci e precipizi quanto divertente ed ecc<strong>it</strong>ante. <br />
Viceversa nelle scuole Xavantes,la cui forma già da sola vale una ricerca, essendo una rielaborazione <br />
sincretica tra lo stile conico tradizionale con in cima rami e foglie per far passare l’aria su una base circolare <br />
di cemento più solida e igienica. E dentro ci sono tanti banchi quanti sono gli studenti e su ognuno c’è il <br />
computer acceso, su cui specie le ragazze elaborano i loro comp<strong>it</strong>i e ricerche. Sottolineo specie le ragazze, <br />
in quanto tra gli Xavantes il preconcetto diciamo “machista” è molto forte, cui accenno solo in quanto <br />
mer<strong>it</strong>erebbe una articolata riflessione. Comunque il risultato è che le ragazze sono più brave dei maschietti <br />
al pc e questo intacca l’orgoglio del cyber-‐guerriero. E i professori, dall’aria ironica e arguta che mi <br />
ricordano l’amico e filosofo Decio, danno lezioni di lingua e letteratura portoghese-‐brasiliana e xavante. <br />
Sulla lavagna, una frase di Gramsci… <br />
Divino Tserewaru è il giovane xavante che, quando arrivai nel ’98 nella sua aldeia con videocamera <br />
analogica, macchina fotografica, tacquino, mi si presentò davanti con la sua telecamera dig<strong>it</strong>ale filmandomi. <br />
Il senso di un mondo che mutava radicalmente mi apparve chiarissimo in quel momento e mai lo scorderò: <br />
il mio potere, cioè il potere dell’antropologo o del giornalista, del turista o del missionario, era messo in <br />
discussione dalla semplice presenza del video nelle sue mani “divine” che intaccavano il mio ruolo. E il <br />
mio sapere … Non ero più “io” a poter rappresentare l’altro, selvaggio, nativo o Na’vi. L’altro aveva <br />
imparato a rappresentarsi da solo e anzi mi rappresentava. Ora nella casa di Divino vi è una modernissima <br />
centralina di montaggio e di ed<strong>it</strong>ing: cioè lui non solo filma, ma costruisce narrativamente i suoi video con <br />
una sapienza soggettiva per i vari climax. E alcuni di questi video sono stati girati in aldeias diverse da <br />
quelle xavantes, uno dei quali a Mariposa do Sol tra i Macuxi, laddove Divino ha realizzato uno dei più bei <br />
documentari antropologici e mil<strong>it</strong>anti che abbia mai visto. Purtroppo James Cameron non lo conosce come <br />
la maggioranza schiacciante-‐schiacciata del pubblico tv-‐filmico. Il maestro di Divino si chiama Vincent <br />
Carelli, fondatore di Videos nas Aldeias, i cui film dovrebbero essere amati, studiati e c<strong>it</strong>ati da chiunque <br />
vorrebbe fare i film su tale argomento. Tra cui Bechis e i suoi “uomini rossi”…
Documentare la propria cultura attraverso il dig<strong>it</strong>ale è la sfida di oggi che coinvolge e avvolge sia le culture <br />
“indigene” e sia le varie culture metropol<strong>it</strong>ane nella divers<strong>it</strong>à dei propri spazi-‐tempi e modi-‐stili. Le <br />
tecnologie analogiche, infatti, erano costose, pesanti, care, difficili da usare e impossibili da aggiustare; con <br />
il dig<strong>it</strong>ale uno xavante può avvisare in tempo reale di un sopruso e favorire una immediata mobil<strong>it</strong>azione; <br />
può registrare un evento e inviarlo nelle altre aldeias o in ogni parte del mondo; può facilmente ed<strong>it</strong>arlo e <br />
persino venderlo. Filmare un evento indigeno è possibile solo se si accetta e favorisce che anche gli stessi <br />
soggetti – da oggetti passivi naturalistici, senza nome o età, indifeso panorama etnico – siano riconosciuti <br />
come tali nella tensione pol<strong>it</strong>ica, dialogica e sincretica che trans<strong>it</strong>a dalla conoscenza iniziale alla <br />
composizione finale del testo. È questa una prospettiva che può favorire la diffusione decentrata delle <br />
transculture e non le v<strong>it</strong>torie monologiche nel botteghino. <br />
b-‐ Avatar, Bateson e l’arte <br />
Tutto questo per introdurre il secondo punto della mia riflessione esperienziale, quella per certi versi <br />
ancora più soggettiva e direi amara, che inizialmente mi ha causato un ambiguo senso tra la rivinc<strong>it</strong>a e il <br />
disastro appena il film fu annunciato: come se avessi una sorta di copyright sull’avatar, cosa semplicemente <br />
priva di senso, o se mer<strong>it</strong>assi un riconoscimento dopo tanti anni in cui quando pronunciavo il nome della <br />
rivista – Avatar, appunto – colleghi o amici o semplici conoscenti non la intendevano e la deformavano nel <br />
modi e toni più strambi. Ricordo il “mio” preside al consiglio di facoltà che annunciò l’usc<strong>it</strong>a della rivista <br />
Aratara, Avaratata o qualcosa del genere. E adesso, dopo un solo giorno di proiezione e i molti spot, <br />
neanche il bambino del villaggio più sperduto lo pronuncia male e tutti sanno cosa sia un avatar. Però… <br />
però il problema, caro James Cameron, è che l’idea di avatar secondo la filosofia hindu e poi nella sua <br />
diversione dig<strong>it</strong>ale, l’idea profonda -‐ mistica o comunicazionale -‐ sta nel fatto della molteplic<strong>it</strong>à di <br />
manifestazione del dio nelle varie ent<strong>it</strong>à empiriche ovvero nella plural<strong>it</strong>à ident<strong>it</strong>aria del soggetto che <br />
pratica gli e-‐space del web. La molteplic<strong>it</strong>à soggettiva del’avatar cerca di oltrepassare potenzialmente il <br />
dualismo, anzi quella logica binaria da cui persino i software si stanno disvincolando, in quanto è proprio la <br />
prospettiva avatarica che esprime una sorta di utopia concreta, materialimmateriale, che potrebbe favorire <br />
la ricerca dell’oltre piuttosto che del contro. E invece Avatar-‐film è la massima estensione del dualismo <br />
bene-‐male, una applicazione senza scrupoli e ormai fin troppo facile nel rappresentare il peggio come <br />
ridicolo-‐mostruoso; e di converso il meglio come puro, bello, onesto e soprattutto che ha un rapporto sacro <br />
con la natura. E qui viene da r<strong>it</strong>ornare alla ironicamara c<strong>it</strong>azione iniziale di Jimmie Durham, grande artista <br />
cherokee che, nel prendere in giro i “bianchi” alla ricerca dell’”indiano” ecologico o originario, sembra <br />
rivolgersi a persone proprio come Cameron, persone che con un mix difficile da dipanare tra ingenu<strong>it</strong>à e <br />
cinismo continuano a propinare questo dicotomico razzismo alla rovescia. È dai tempi di Soldato Blu che <br />
questo rovesciamento dei buoni in cattivi e viceversa non dovrebbe funzionare più, proprio in quanto <br />
riproduce industrialmente l’imperterr<strong>it</strong>a opposizione dicotomica. <br />
E allora come in una elegia dove si mescola Tarzan e Heidegger, Rousseau e Gunga Din la commozione <br />
dilaga nel brivido del buon selvaggio… anzi no… mi correggo maliziosamente: della selvaggia dal sex-‐appeal <br />
transorganico e postuman che insegna a vivere e ad amare a un “eroe” che esclude a priori, cioè dopo il <br />
primo fotogramma, ogni possibile identificazione. Ma evidentemente non deve essere così in platea. Si <br />
rifletta sulla “dialettica” dell’identificazione: all’estrema banal<strong>it</strong>à fisiognomica dell’eroe realista, <br />
corrisponde una simmetrica eccezional<strong>it</strong>à dell’eroe avatarico. Mi domando se lo spettatore riesce a <br />
scivolare schizoidamente tra le due ident<strong>it</strong>à: domanda inutile perché il botteghino ha già risposto. Di <br />
<strong>www</strong>.<strong>etnografiadig<strong>it</strong>ale</strong>.<strong>it</strong> <br />
5
conseguenza, lo spettatore si sente paral<strong>it</strong>ico come l’eroe soldato, seduto nelle varie platee in sedie senza <br />
rotelle, si assimila all’infelice che non sa più correre, troppo ab<strong>it</strong>uato ai r<strong>it</strong>mi urbani dove al massimo si <br />
corre fermi nei tapis-‐roulant recap<strong>it</strong>ati direttamente a casa mentre si osserva una parete grigia o la tv <br />
illuminata. E improvvisamente riscopre l’ebbrezza della corsa libera e senza direzione che il suo avatar <br />
accende. <br />
Una volta chiar<strong>it</strong>o nella parte etnografica la sfida confl<strong>it</strong>tuale di Xavantes e Bororo con il dig<strong>it</strong>ale, il mio <br />
malessere gira sul perchè il cinema di James Cameron – cioè l’unico che regna globalmente, quello <br />
hollywoodiano – sembra non riuscire mai a incontrare Jimmie Durham, ovvero un cherokee mil<strong>it</strong>ante di <br />
Wounded Knee che, in segu<strong>it</strong>o allo sconforto derivato dalla difficoltà di liberazione della propria gente, <br />
decide di dedicarsi all’arte contemporanea. Supremo scandalo per una persona che cr<strong>it</strong>ica ogni stereotipo <br />
incrostato sull’ “indiano”, a partire dalla tassonomia utilizzata per individuarlo e classificarlo. “”Noi <br />
indiani””, dice, e mette le doppie virgolette ironizzando sulla persistenza di questo termine che riproduce <br />
un fraintendimento coloniale continuo nei secoli: e che sembra impedire l’uso di Cherokee che, come è <br />
noto, ormai sembra individuare solo un ottimo fuoristrada. Un brand ecologico e selvaggio. L’arte <br />
contemporanea espressa da soggettiv<strong>it</strong>à irregolari come quella di Durham non rimane immobile, fuori dal <br />
tempo e dallo spazio, nel ruolo esotizzato predisposto all’interno di riserve stile theme-‐park; e qui essere <br />
fotografati a prezzi correnti dai turisti che trans<strong>it</strong>ano indifferentemente tra Hare Krishna e Ghost Dance, <br />
alla ricerca del popolo-‐di-‐natura, volkish, ingenuo e istintivo. Purtroppo le opere visuali o scr<strong>it</strong>te di Durham <br />
non riescono ad essere percep<strong>it</strong>e o neanche immaginate da Cameron e dalla sua Grande Narrazione che <br />
almeno con Avatar dovrebbe essere chiaro che non solo non è morta, ma che è vivissima e che ha solo <br />
trans<strong>it</strong>ato di genere. Filosofia e antropologia sono unificate da Cameron. Avatar è una parodia de L’ecologia <br />
della mente di Bateson: una trama che connette alberi di sequoia, anemoni di mare, videogame, pandore <br />
preistoriche alla sacral<strong>it</strong>à della natura e agli spettatori occhiuti. Suggestioni batesoniane senza Gregory. Il <br />
divario non è certo tra le “due culture” – quelle tecno-‐scientifiche e quelle umanistiche: questo cinema ha <br />
chiaramente unificato tecnologia e cultura, scienza e storia. Forse il confl<strong>it</strong>to (per me semplificativo) è tra i <br />
flussi di arti dig<strong>it</strong>ali, la web-‐comunicazione soggettivizzata, i nuovi media di cui il cinema 3D è l’attuale <br />
campione. È bizzarra questa s<strong>it</strong>uazione in cui tanta arte ha accettato da tempo, ben prima di Fluxus, la sfida <br />
di relazionare corpo e tecnologia, per cui alcuni degli artisti contemporanei più sensibili hanno espresso e <br />
continuano a esprimere alcune delle emozioni più innovative incorporando arte e dig<strong>it</strong>ale (cfr “Documenta” <br />
con Posthuman che ormai è storia dell’arte); mentre “il” cinema -‐ che entra nelle forme più emotive e <br />
inus<strong>it</strong>ate offerte da queste stesse tecnologie – continua a rinserrare le culture “etniche” nel recinto della <br />
stessa oppressiva banal<strong>it</strong>à. <br />
Ho adorato le immagini di Avatar che inventano fantasmagorie del XXI secolo e penetrano indubbiamente <br />
nel sublime della meraviglia. Sono invenzioni continue che dilatano la pupilla oltre le regole normali della <br />
percezione orb<strong>it</strong>ale. Ogni movimento di camera sui primi piani degli occhi di lei-‐avatar fanno scorrere <br />
mondi sognanti alla Grandville, si aprono nei multiversi di piante-‐meduse galleggianti: un suo primo piano <br />
include ogni altro sguardo, i miei sensi sprofondano e si innalzano per ogni sorpresa applicata da questo <br />
sound-‐design alterato dal quale non si potrà tornare indietro. E invece si assiste ancora e sempre ai mostri <br />
preistorici e ai goldrake-‐usa… <br />
Questo allora il problema. Se oggi la forbice non è più tra le “due culture”, significa che le due lame si <br />
divaricano all’interno della stessa cultura umanistica: due lame che da tempo usano il tecno-‐dig<strong>it</strong>ale <br />
(nell’arte o nel cinema) e che, invece di essere interconnesse, sembrano allontanarsi tra loro sideralmente. <br />
Questa forbice si lacera sempre più e diventa quasi comica quando Cameron inquadra i Na’vi un<strong>it</strong>i per le <br />
mani adorando l’albero-‐totem primigenio e danzando uga uga! Neanche nelle pubblic<strong>it</strong>à razzializzate dei
’50 si era vista una cosa simile. La scena è la stessa da sempre: e si deve dire che è i-‐n-‐s-‐o-‐p-‐p-‐o-‐r-‐t-‐a-‐b-‐i-‐l-‐e. <br />
Qui Alberto Abruzzese ha ragione ripetendo che il paradigma è ancora e sempre King Kong. Immortale e <br />
indistruttibile, il selvaggio rimane tale anche quando – anzi soprattutto quando -‐ commuove per la sua <br />
religios<strong>it</strong>à naif verso una natura-‐videogioco e per il senso di comun<strong>it</strong>à che sa esprimere. Volksgemeinschaft <br />
forever… Il cavaliere della valle sol<strong>it</strong>aria è tornato, anzi, Shane non è mai part<strong>it</strong>o perché non ci <br />
abbandonerà mai. <br />
Non certo Gregory Bateson è ispiratore del film, come qualcuno ingenuamente ha affermato, ma la <br />
peggiore tradizione sociologica-‐filosofica da Toennies a Heidegger che continua a invocare la comun<strong>it</strong>à di <br />
sangue e di pixel per uscire dalle anomie attuali. Dovrebbe essere chiaro che è proprio tale ossessiva <br />
affermazione delle radici il nodo nodoso, ideologia ossuta tra le ideologie, razzismo rovesciato e dr<strong>it</strong>to nello <br />
stesso tempo che blocca l’affermazione compos<strong>it</strong>iva di narrazioni – né grandi né piccole – semplicemente <br />
altre e forse alla ricerca dell’oltre. <br />
Non è vero che la tecnologia è diventata l’unico contenuto che muta lasciando e rinserrando la storia nel <br />
sempre uguale. Se fosse vera questa ipotesi, riguarderebbe ogni forma espressiva della cultura mentre si è <br />
visto che per le arti visuali non è così. E anche per lo stesso cinema: si pensi alle oscur<strong>it</strong>à segrete che <br />
Haneke riesce a rivelare o alle dissoluzioni del pattern-‐hollywood che un Lynch continua a risvegliare. Ma <br />
questi sono esempi, come accennavo all’inizio, che coinvolgono un altro cinema, un cinema diverso da <br />
questo mainstream. La sfida di Avatar è questa radicale ambigu<strong>it</strong>à, più estrema di tante altre operazioni, <br />
per cui può essere giusto parlare di un prima e dopo Cameron-‐Avatar: ma solo da un punto di vista delle <br />
visioni di una realtà aumentata, direi di una realtà illim<strong>it</strong>ata quale il suo cinema riesce a masticare. Per il <br />
resto, pare un film-‐saggio finalizzato a confermare le stanche tesi di laurea che continuano ad applicare la <br />
morfologia di Propp sull’eroe dalla fiaba al cinema; o l’ecc<strong>it</strong>ante attrazione che ancora continua a eserc<strong>it</strong>are <br />
Schmidt sul pol<strong>it</strong>ico basato sulla dicotomia amico-‐nemico applicato alle masse dig<strong>it</strong>ali. <br />
c – Pixel dust <br />
Non posso immaginare cosa penseranno Bororo o Xavante nel Mato Grosso vedendo il film. Forse come <br />
altri spettatori disperati (quei palestinesi che si sono dipinti di blu) si identificheranno con i Na’vi o li <br />
useranno per i loro dir<strong>it</strong>ti. Forse i Bororo vedranno nel Grande Albero il loro villaggio tradizionale di forma <br />
circolare, con al centro il ba<strong>it</strong>o, la casa degli uomini, al cui centro del centro vi è un grande palo che è <br />
simbolicamente connesso con l’intero cosmo; questo modello circolare, come accennavo, è stato in molti <br />
casi distrutto dalla car<strong>it</strong>à cristiana dei salesiani e trasformato in case di cemento a forma di 7 che <br />
accumulano un calore intensivo che le capanne filtravano e disperdevano. Mai dimenticherò la prima volta <br />
che arrivai in una aldeia xavante di notte, dopo una corsa folle sulle strade sterrate con il loro pick-‐up, <br />
aggrappato da qualche parte per ev<strong>it</strong>are i rami che si richiudevano per abbattersi su noi in piedi: la notte <br />
era quasi di luna nuova e,una volta arrivato, solo dopo un po’ di tempo la mia vista percepì che stavo al <br />
centro del villaggio e che intorno vi erano gli anziani con le loro mogli e soprattutto Domingos Mahoro’e’o, <br />
il cacique mio amico con cui mi ero incontrato già diverse volte in contesti molto diversi. Lui mi abbracciò e <br />
poi iniziò un lungo discorso in xavante di cui non capivo nulla se non il senso che potevo immaginare. E poi <br />
su sua richiesta ho dovuto rivolgere a mia volta un discorso agli uomini e alle donne a me intorno con un <br />
mio portoghese che si emozionava più di quanto avrei immaginato. E poi ci stringemmo tutti le mani <br />
formando un circolo con le braccia oblique verso il suolo, le gambe divaricate, il canto r<strong>it</strong>mico e forte che <br />
<strong>www</strong>.<strong>etnografiadig<strong>it</strong>ale</strong>.<strong>it</strong> <br />
7
cercai sub<strong>it</strong>o di seguire, mentre le gambe si rinserravano e riaprivano r<strong>it</strong>micamente sollevando polvere e i <br />
piedi, nello strusciare al suolo, producevano un r<strong>it</strong>mo di accompagnamento. <br />
Né mai dimenticherò l’incontro con José Carlos, mestre dei canti bororo, che mi accolse nella sua capanna <br />
durante il funerale della moglie morta e tracciò con un bastone una linea di polvere tra lui e me dicendo <br />
con forza che lui stava e sarebbe rimasto da questa parte in quanto bororo e che io stavo e sarei rimasto da <br />
quell’altra in quanto romano. Come dire che lo scambio culturale e persino emotivo tra noi era quasi <br />
impossibile per l’eccesso di differenza e forse di potere. L’essere riusc<strong>it</strong>o a vincere almeno parzialmente <br />
questa sua dura diffidenza rimane uno degli eventi di cui posso sentirmi pieno: per cui alla fine dei nostri <br />
incontri la polvere sollevata da quel bastone ricadde sia dalla sua che dalla mia parte. E che questo <br />
rappresentò per me un vero r<strong>it</strong>o di iniziazione alla fine del quale qualcosa di mescolò e impolverò da <br />
entrambi i lati dei nostri corpi. <br />
L’ultimo ricordo che voglio tracciare, prima delle conclusioni finali o parziali, è adatto al nostro tema <br />
cinema/etnic<strong>it</strong>à: era l’11 ottobre 1992 e mi trovavo in una piccola scuola Guaranì nel versante argentino <br />
insieme a Domingos Mahoro’e’o. Una scuola gest<strong>it</strong>a da una maestra argentina che per me era ed è una <br />
eroina, insegnando spagnolo e guarani a dei bambini dalla condizione san<strong>it</strong>aria e alimentare disastrosa, <br />
bambini di 2-‐3 anni con ulcere nel viso o nel corpo ripiene di mosche, chiazze di mosche che si ag<strong>it</strong>avano <br />
per succhiare il loro sangue, un sangue già esangue per il poco che potevano mangiare. E che mangiare: <br />
quando arrivava la camionetta da una caserma non lontana, volenterosi soldati scaricavano un pentolone <br />
con i resti della loro mensa tutti mescolati e maleodoranti, residui di grasso o pezzi di osso attaccati a una <br />
mappazza di riso su cui di nuovo le mosche si avventavano. Fu lì che vedemmo di sera, in un piccolo <br />
televisore, un film a mio avviso molto discutibile -‐ Mission di Ronald Jaffe -‐ che per una sorpresa della <br />
storia fu filmato proprio a pochi chilometri da dove stavamo, a Iguaçu, una delle cascate più impressionanti <br />
al mondo. Alla fine Domingos Mahoro’e’o si alzò e disse: “Questa è storia”. Poco dopo la maestra ricordò <br />
che il giorno dopo si sarebbe festeggiato il cinquecentenario della cosiddetta “scoperta” dell’America, per <br />
cui in quella sera noi stavamo ricordando l’ultimo giorno libero di quelle genti che si sarebbero chiamati <br />
indios in omaggio agli errori di Colombo (2). <br />
Questi tre esempi – la forza simbolica dell’aldeia circolare, la linea di polvere che separa e forse mescola, la <br />
conquista coloniale che sembra non finire mai – insieme agli altri già presentati sull’uso potenzialmente <br />
liberatorio del dig<strong>it</strong>ale per le culture “indigene”, mi causano un ambiguo girare intorno Avatar. Un senso <br />
per me inusuale di rimprovero, delusione e quasi rancore per quello che potrebbe essere il cinema che <br />
amo si mescola con una fascinazione per gli ined<strong>it</strong>i panorami visionari e per un sublime tipo di bellezza <br />
possibile. Insomma Avatar solleva una polvere di pixel che si innalza con una forza visuale accecante, la cui <br />
ricaduta è lenta, lentissima, sembra rimanere sospesa nell’aria incerta su quale versante del suolo <br />
immateriale posarsi o continuare a fluttuare come un pulviscolo numinoso che il giorno dopo si dissolverà <br />
nell’oblio. <br />
Note <br />
1.Un bell’articolo di Raffaele Oriani sul Corriere della Sera del 5/3/2010 informa sul rapporto tra antropologi Usa e una <br />
antropologa, Montgomery McFate, che chiarisce tutte le mie cr<strong>it</strong>iche al film: secondo una tradizione iniziata negli anni <br />
60, l’eserc<strong>it</strong>o degli Usa arruolava antropologi/e per conoscere le culture locali dove si affermavano movimenti di <br />
liberazione. E all’epoca gli antropologi si rifiutarono di dare informazioni all’eserc<strong>it</strong>o per capire meglio e quindi poter <br />
controllare mil<strong>it</strong>armente quelle popolazioni che cercavano di affermare il loro dir<strong>it</strong>to alla libertà (. “Se li vuoi vincere, <br />
li devi conoscere”…). Ora questa antropologa embedded ha ripreso questo ruolo in Iraq e Afganistan e, guarda caso, è
l’unica che Cameron abbia consultato per immaginare il suo film. “Montgomery McFate è convinta che il suo drappello<br />
di antropologi embedded abbia il mer<strong>it</strong>o storico di aver fatto diminuire il numero dei civili uccisi per errore”. Già: solo <br />
che lei non si chiede il perché dell’invasione dell’Iraq da parte dei Bush. Invasione accettata come un fatto pos<strong>it</strong>ivo e <br />
pos<strong>it</strong>ivista. Il suo progetto Cultural Preparation of the Environment ha un nome ancora valido, per me: neocolonialismo.<br />
Per fortuna gli antropologi statun<strong>it</strong>ensi hanno respinto queste procedure usando lo stesso mio concetto. <br />
2.Sulla questione della crisi delle tassonomie in relazione alle culture etniche, rinvio a questa purtroppo lunga <br />
c<strong>it</strong>azione tratta dalla mia introduzione al n. 3 di Avatar su “arte ed etnic<strong>it</strong>à”: <br />
“L’altro di è de-‐nativizzato. Ha sottratto la classificazione di ”nativo” come esclusiva della sua ident<strong>it</strong>à. Quello che è <br />
stato il paradigma dell’antropologia – cogliere il punto di vista nativo – ora sta ridefinendosi in modo ben diverso: <br />
cogliere il punto di vista dell’auto-‐rappresentazione. E in questo prefisso – “auto” -‐ vi è un soggetto che non è più <br />
inscrivibile dentro una cultura di appartenenza compatta e immobile. Con auto-‐rappresentazione non si deve <br />
intendere che la cultura Cherokee o Bororo è rappresentabile solo da un soggetto locale: anche questo è un sistema <br />
logico unificato che è inscr<strong>it</strong>to in un potere occidentale obsoleto, per quanto ancora vivo di dominio. <br />
Qui si moltiplicano soggettiv<strong>it</strong>à “native” che dissolvono il concetto stesso di nativo. Se prima le etichette per l’altro <br />
erano selvaggio, prim<strong>it</strong>ivo, senza-‐scr<strong>it</strong>tura, ora l’uso del termine ben educato di nativo rimane ambiguo. Nella parola si <br />
afferma una vicinanza con l’essere nato, nato-‐lì, cioè precedente, originario e quindi più autentico perché più-‐nato. <br />
Eppure tutti noi siamo nati in qualche “lì” e questo non dovrebbe dare nessun dir<strong>it</strong>to di precedenza o purezza… Solo l’ <br />
“indiano” è nativo (na’vi), campione di natura-‐amore-‐animali, un po’ shamano, iper-‐sex e pre-‐tech, alquanto alterato <br />
da fumi r<strong>it</strong>ualizzati. A tale immagine di nativo, qualche presunto “nativo” non ci sta più. <br />
Avatar dichiara decaduto l’uso antropologico del termine “nativo” per indicare popolazioni prima defin<strong>it</strong>e selvagge o <br />
prim<strong>it</strong>ive. Avatar sollec<strong>it</strong>a l’uso dei termini che loro stessi adottano: Cherokee, Xavante, Bororo, Textal. Avatar si <br />
impegna a non favorire la riproduzione di tassonomie che riproducono non solo linguisticamente il dominio coloniale. <br />
Avatar si schiera sulla svolta basata nell’auto-‐rappresentazione” (Canevacci, 2002, p 3) <br />
Bibliografia <br />
Canevacci, M., Forward in Avatar n. 3, Roma, Meltemi, 2002 <br />
Durham, J, Cowboys and …, in Avatar n. 3, Roma, Meltemi, 2002 <br />
<strong>www</strong>.<strong>etnografiadig<strong>it</strong>ale</strong>.<strong>it</strong> <br />
9