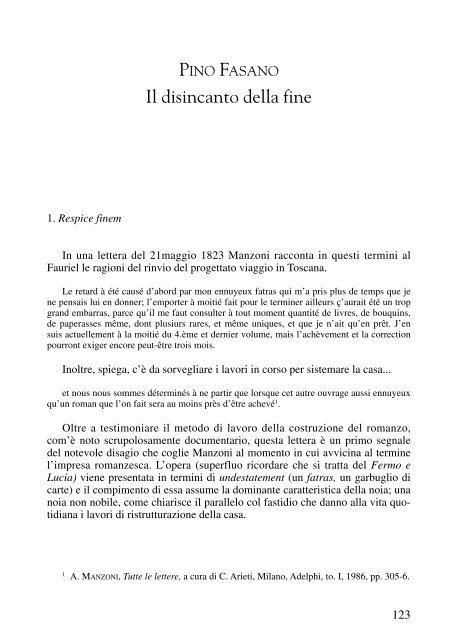Il disincanto della fine - Sapienza
Il disincanto della fine - Sapienza Il disincanto della fine - Sapienza
1. Respice finem PINO FASANO Il disincanto della fine In una lettera del 21maggio 1823 Manzoni racconta in questi termini al Fauriel le ragioni del rinvio del progettato viaggio in Toscana. Le retard à été causé d’abord par mon ennuyeux fatras qui m’a pris plus de temps que je ne pensais lui en donner; l’emporter à moitié fait pour le terminer ailleurs ç’aurait été un trop grand embarras, parce qu’il me faut consulter à tout moment quantité de livres, de bouquins, de paperasses même, dont plusiurs rares, et même uniques, et que je n’ait qu’en prêt. J’en suis actuellement à la moitié du 4.ème et dernier volume, mais l’achèvement et la correction pourront exiger encore peut-être trois mois. Inoltre, spiega, c’è da sorvegliare i lavori in corso per sistemare la casa... et nous nous sommes déterminés à ne partir que lorsque cet autre ouvrage aussi ennuyeux qu’un roman que l’on fait sera au moins près d’être achevé 1 . Oltre a testimoniare il metodo di lavoro della costruzione del romanzo, com’è noto scrupolosamente documentario, questa lettera è un primo segnale del notevole disagio che coglie Manzoni al momento in cui avvicina al termine l’impresa romanzesca. L’opera (superfluo ricordare che si tratta del Fermo e Lucia) viene presentata in termini di undestatement (un fatras, un garbuglio di carte) e il compimento di essa assume la dominante caratteristica della noia; una noia non nobile, come chiarisce il parallelo col fastidio che danno alla vita quotidiana i lavori di ristrutturazione della casa. 1 A. MANZONI, Tutte le lettere, a cura di C. Arieti, Milano, Adelphi, to. I, 1986, pp. 305-6. 123
- Page 2 and 3: Pino Fasano La previsione del perio
- Page 4 and 5: Pino Fasano Presqu’au bout, ma no
- Page 6 and 7: Pino Fasano parola usata a caso: il
- Page 8 and 9: Pino Fasano viene restaurata, capov
- Page 10 and 11: Pino Fasano punto che scatta un’a
- Page 12 and 13: Pino Fasano esposizione della metod
- Page 14 and 15: Pino Fasano interviene addirittura
- Page 16 and 17: Pino Fasano La storia dei promessi
- Page 18 and 19: Pino Fasano da, raccattava, per dir
- Page 20 and 21: Pino Fasano resistere alla riduzion
- Page 22 and 23: Pino Fasano che, con altri oziosi i
- Page 24 and 25: Pino Fasano chese erede buono di Do
- Page 26: Pino Fasano rebbe a morte». Tocche
1. Respice <strong>fine</strong>m<br />
PINO FASANO<br />
<strong>Il</strong> <strong>disincanto</strong> <strong>della</strong> <strong>fine</strong><br />
In una lettera del 21maggio 1823 Manzoni racconta in questi termini al<br />
Fauriel le ragioni del rinvio del progettato viaggio in Toscana.<br />
Le retard à été causé d’abord par mon ennuyeux fatras qui m’a pris plus de temps que je<br />
ne pensais lui en donner; l’emporter à moitié fait pour le terminer ailleurs ç’aurait été un trop<br />
grand embarras, parce qu’il me faut consulter à tout moment quantité de livres, de bouquins,<br />
de paperasses même, dont plusiurs rares, et même uniques, et que je n’ait qu’en prêt. J’en<br />
suis actuellement à la moitié du 4.ème et dernier volume, mais l’achèvement et la correction<br />
pourront exiger encore peut-être trois mois.<br />
Inoltre, spiega, c’è da sorvegliare i lavori in corso per sistemare la casa...<br />
et nous nous sommes déterminés à ne partir que lorsque cet autre ouvrage aussi ennuyeux<br />
qu’un roman que l’on fait sera au moins près d’être achevé 1 .<br />
Oltre a testimoniare il metodo di lavoro <strong>della</strong> costruzione del romanzo,<br />
com’è noto scrupolosamente documentario, questa lettera è un primo segnale<br />
del notevole disagio che coglie Manzoni al momento in cui avvicina al termine<br />
l’impresa romanzesca. L’opera (superfluo ricordare che si tratta del Fermo e<br />
Lucia) viene presentata in termini di undestatement (un fatras, un garbuglio di<br />
carte) e il compimento di essa assume la dominante caratteristica <strong>della</strong> noia; una<br />
noia non nobile, come chiarisce il parallelo col fastidio che danno alla vita quotidiana<br />
i lavori di ristrutturazione <strong>della</strong> casa.<br />
1 A. MANZONI, Tutte le lettere, a cura di C. Arieti, Milano, Adelphi, to. I, 1986, pp. 305-6.<br />
123
Pino Fasano<br />
La previsione del periodo necessario per “achever” e “corriger” si rivela<br />
persino ottimistica, perché di mesi ce ne vorranno quasi quattro: la data autografa<br />
sull’ultima pagina del Fermo e Lucia è quella del 17 settembre 1823.<br />
Ma, com’è ben noto, la <strong>fine</strong> del manoscritto è già quasi un nuovo principio:<br />
il lavoro per la stampa riprenderà dall’incipit nella primavera del 1824, e in una<br />
prima fase sembra marciare spedito. Con la fattiva collaborazione degli amici,<br />
da Visconti al Fauriel, da Rossari a Gaetano Cattaneo, da Grossi a Torti, nel giugno<br />
di quello stesso anno, in un paio di mesi, il primo volume dei Promessi<br />
sposi (comprendente i primi 11 capitoli, sino all’ingresso di Renzo a Milano), è<br />
finito e viene dato alle stampe col nuovo titolo: l’imprimatur è del luglio, a ottobre<br />
il tomo è pronto. Ma già per la stampa del secondo volume bisognerà arrivare<br />
all’ottobre 1825. <strong>Il</strong> rallentamento del lavoro (quasi un anno per tredici capitoli,<br />
dal XII al XXIV, termine <strong>della</strong> “giornata dell’Innominato”) si spiega certo<br />
con le profonde revisioni introdotte rispetto al Fermo e Lucia: la ristrutturazione<br />
<strong>della</strong> parte sulla Monaca di Monza, l’anticipazione delle vicende di Renzo. Ma<br />
non si tratta di una felice operosità: anzi, momenti di “découragement” sono<br />
attestati dalla moglie Enrichetta e dalla madre Giulia Beccaria («l’ouvrage de<br />
mon fils est bien arrierée») e il Fauriel loro corrispondente ne prende atto con<br />
rammarico («Alexandre… n’est pas très bien disposé») 2 . Apparentemente, l’insoddisfazione<br />
tocca soprattutto il piano linguistico, come risulta dalle discussioni<br />
con gli amici-correttori su «quella lingua toscano-milanese che vagheggiamo»<br />
3 . Tuttavia c’è un’incontentabilità più profonda, che sembra legata più all’opera<br />
in sé e all’avvicinarsi del suo compimento che alle modalità <strong>della</strong> sua configurazione:<br />
tant’è vero che il rallentamento del lavoro è direttamente proporzionale<br />
all’avvicinamento <strong>della</strong> <strong>fine</strong>. Per il terzo e ultimo volume (quattordici<br />
capitoli dal XXV al XXXVIII) di anni ce ne vorranno due. Gli otto capitoli dal<br />
XXV al XXXII, raccordo fra il felice esito del rapimento di Lucia e la descrizione<br />
<strong>della</strong> peste, che costituisce l’avvio alla parte finale <strong>della</strong> fabula, sono consegnati<br />
per il visto di censura nel luglio 1826 (più di un anno di lavoro). I segnali<br />
di insoddisfazione si moltiplicano, sino ad esplicitarsi nei primi propositi di<br />
“ripudio”. «Non desidero la diffusione dell’opera» scrive a Tommaso Grossi nel<br />
novembre 1826 4 : siamo ormai a una vera e propria nevrosi <strong>della</strong> <strong>fine</strong>, al terrore<br />
del distacco che sarà segnato dalla pubblicazione. Dopo altri tre mesi Manzoni<br />
ha preparato solo altri due capitoli: il XXXIII, col rientro in scena dei due protagonisti<br />
maschili, esemplarmente coinvolti dalla capacità “riparatrice” <strong>della</strong><br />
peste: uccisione del malvagio, salvezza del perseguitato; e il XXXIV, seconda<br />
entrata di Renzo a Milano, ripetizione con le opportune varianti, anch’esse<br />
124<br />
2 Cfr. Tutte le lettere, cit., I, p. 883.<br />
3 Lettera a Luigi Rossari del giugno 1825, in Tutte le lettere, cit., I, p. 380.<br />
4 Tutte le lettere, cit., p. 407.
<strong>Il</strong> <strong>disincanto</strong> <strong>della</strong> <strong>fine</strong><br />
significativamente “esemplari” come vedremo, del primo arrivo descritto nell’XI.<br />
Sta correggendo il XXXV (il lazzaretto e l’incontro di Renzo con Fra Cristoforo)<br />
quando scrive al Fauriel, il 20 novembre 1826:<br />
Pour moi, je suis depuis quelque temps, c’est à dire depuis deux mois à peu près, plus tormenté<br />
qu’à l’ordinaire de mes maux imaginaires ou réels, mais bien réels pour moi dans un cas,<br />
comme dans l’autre; je vous dirai même que les symptômes plus sensibles que j’en ai (et surtout<br />
des douleurs presque continuelles d’estomac) me font presque plaisir en ce qu’ils me donnent la<br />
raison d’une tristesse et d’un abattement qui me serait encore plus pénible si je ne pouvais en<br />
assigner une cause physique. Mon travail avance on ne peut plus lentement, et avec de fort longues<br />
interruptions: j’en suis désenchanté à merveille, la seule chose qui m’anime un peu c’est<br />
l’envie d’en être débarassé une bonne fois: vous sentez quelle verve cela doit donner 5 .<br />
Non si potrebbe essere più espliciti. “Straordinario <strong>disincanto</strong>” verso il lavoro,<br />
la <strong>fine</strong> come desiderio di “sbarazzarsene”. Se leghiamo questa proclamazione<br />
al discorso precedente sui “mali” immaginari o reali che affliggono il suo<br />
fisico, ma reali comunque psichicamente, l’immagine diventa ancora più cruda:<br />
lo sforzo creativo diventa nausea, viene somatizzato come emetico; la <strong>fine</strong> del<br />
romanzo sarà un vomito liberatorio. I tre capitoli in questione sono consegnati a<br />
Natale del ’26, stampati nel febbraio del ’27. Per gli ultimi tre capitoli, dal<br />
XXXVI al XXXVIII, serviranno altri quattro mesi, sempre più tormentati e sussultori.<br />
Manzoni è continuamente costretto a smentire amici e conoscenti che<br />
danno il libro per finito, non immaginando questa impasse finale:<br />
La filastrocca <strong>della</strong> quale Ella ha la bontà di richiederne, è bensì stampata in gran parte,<br />
ma nulla ne è ancor pubblicato, né sarà che ad opera compiuta. Del quando, non posso fare<br />
alcuna congettura un po’ precisa; perché di quel che manca alla stampa, una parte manca<br />
ancora allo scritto; e il compimento di questo dipende da una salute incerta e bisbetica, la<br />
quale spesso mi fa andare assai lento, e talvolta cessare affatto per buon numero di giorni 6 .<br />
Un mese dopo questa lettera alla Saluzzo Roero, la figlia Giulietta fissa in un<br />
sintagma divenuto celebre la lentezza esasperante di questa <strong>fine</strong> del lavoro al<br />
romanzo, scrivendo l’11 aprile al Fauriel:<br />
Papa… il travaille, et me charge de vous dire qu’il se croit enfin presqu’arrivé au bout de<br />
son éternel ouvrage. Vous savez pourtant que souvent un chapitre lui emporte des semaines,<br />
c’est sa santé toujours mauvaise qui en est la cause; ainsi donc c’est presque fini, mais quand<br />
sera-ce tout-à-fait fini 7 ?<br />
5 Tutte le lettere, cit., I, p. 409 (corsivi miei).<br />
6 Lettera a Diodata Saluzzo Roero del 12 marzo 1827 (corsivo mio). Tutte le lettere, cit.,<br />
I, p. 413.<br />
7 A. MANZONI, Carteggio, a cura di G. Sforza e G. Gallavresi, Milano 1921, vol. II, p.<br />
274 (corsivo mio).<br />
125
Pino Fasano<br />
Presqu’au bout, ma non ancora tout-à-fait. La <strong>fine</strong> è sempre più imminente,<br />
ma non arriva ancora. Padre e figlia danno la colpa alla malattia, ma è difficile<br />
separare causa ed effetti di questa nevrosi manzoniana, che si esprime nella<br />
ambivalente pulsione a rallentare e ritardare, e insieme desiderare, la <strong>fine</strong>. Per<br />
quanto risulta, lo “scritto” sarà compiuto alla <strong>fine</strong> di aprile; ma ci vorranno<br />
ancora due mesi di revisioni, correzioni bozze, ecc., per arrivare all’annuncio,<br />
tutt’altro che trionfale, all’amico Fauriel (11 giugno):<br />
Respice <strong>fine</strong>m, cher ami; et c’est pour moi une véritable consolation de penser que désormais<br />
je vous entretiendrai d’autre chose que de cette fastidieuse histoire, dont je suis ennuyé<br />
moi-même autant que dix lecteurs; moi, dis-je; pour vous je vous le laisse à penser. Voici<br />
donc, pour finir d’en parler, les derniers feuilles du dernier volume….[seguono istruzioni per<br />
il traduttore francese, autorizzato a tagliare quel che vuole <strong>della</strong> descrizione <strong>della</strong> peste; e<br />
preghiere all’amico di distribuire le copie quando arriveranno] Mais aussi, ce sera la fin de<br />
la fin 8 .<br />
L’ossessione <strong>della</strong> <strong>fine</strong> risuona nell’iterazione del termine. <strong>Il</strong> motto latino,<br />
estratto dal contesto gnomico (quidquid agis, agas prudenter et respice <strong>fine</strong>m)<br />
diventa consolantemente asseverativo: contempliamo la <strong>fine</strong>. Ma bisogna finire<br />
anche questa contemplazione, liberarsi per sempre da questa “fastidiosa storia”<br />
(quella di Renzo e Lucia, ma anche quella di chi la racconta), cessare anche di<br />
parlarne: arrivare alla <strong>fine</strong> <strong>della</strong> <strong>fine</strong>.<br />
2. L’inizio <strong>della</strong> <strong>fine</strong><br />
La lettera del “<strong>disincanto</strong>” al Fauriel (novembre 1826) data in modo preciso<br />
il momento di acutizzazione del malessere al settembre di quell’anno: «depuis<br />
deux mois à peu près». È esattamente il momento in cui inizia la correzione del<br />
capitolo del Fermo e Lucia che diverrà il XXXIII dei Promessi sposi. Dopo la<br />
lunga digressione sulla peste, conclusa con l’annuncio di un “nuovo lavoro” che<br />
sarà la Storia <strong>della</strong> colonna infame, il XXXII terminava con l’annuncio esplicito<br />
che sta per iniziare la conclusione <strong>della</strong> storia di Renzo e Lucia.:<br />
Ma l’affare delle così dette unzioni di Milano, come fu il più celebre, così è fors’anche il<br />
più osservabile; o, almeno, c’è più campo di farci sopra osservazione, per esserne rimasti<br />
documenti più circostanziati e più autentici. E quantunque uno scrittore lodato poco sopra se<br />
ne sia occupato, pure, essendosi lui proposto, non tanto di farne propriamente la storia, quanto<br />
di cavarne sussidio di ragioni, per un assunto di maggiore, o certo di più immediata importanza<br />
[si tratta, com’è noto, delle Osservazioni sulla tortura di Pietro Verri], c’è parso che la<br />
126<br />
8 Tutte le lettere, cit., I, p. 415.
<strong>Il</strong> <strong>disincanto</strong> <strong>della</strong> <strong>fine</strong><br />
storia potesse esser materia d’un nuovo lavoro. Ma non è cosa da uscirne con poche parole; e<br />
non è qui il luogo di trattarla con l’estensione che merita. E oltre di ciò, dopo essersi fermato<br />
su que’ casi, il lettore non si curerebbe più certamente di conoscere ciò che rimane del nostro<br />
racconto. Serbando però a un altro scritto la storia e l’esame di quelli, torneremo finalmente<br />
a’ nostri personaggi, per non lasciarli più, fino alla <strong>fine</strong> 9 .<br />
Notiamo subito che l’inizio <strong>della</strong> <strong>fine</strong> si colloca esattamente all’incrocio fra<br />
storia e invenzione. La materia del Discorso sul romanzo storico, che Manzoni<br />
inizierà a scrivere appena pubblicata la ventisettana, e cioè la dimostrazione dell’impossibilità<br />
di coniugare i due termini nello stesso testo, prende corpo nel<br />
momento in cui quel testo si de-finisce, <strong>fine</strong>ndo, e quindi nascendo. Manzoni si<br />
accorge che la Storia con la maiuscola rischia di sopraffare l’invenzione, e decide<br />
di dislocarla altrove, concentrandosi ora sulla conclusione <strong>della</strong> storia con la<br />
minuscola, la storia di Renzo e Lucia.<br />
Ma l’altro dato importante da sottolineare è che questa decisione è annunciata<br />
entro il romanzo, e ad essa saranno continuamente richiamati i lettori nei<br />
capitoli finali. Philippe Hamon 10 , e sulle sue tracce più distesamente Guy<br />
Larroux 11 , distinguono i finali nelle due fondamentali categorie di finali “accentuati”<br />
(o marcati) e finali non accentuati, o non marcati. Non c’è dubbio che i<br />
Promessi sposi appartengono alla prima categoria 12 ; e vi si iscrivono intanto<br />
attraverso una delle marche tipiche di essa: l’intensificazione dei segnali metatestuali,<br />
l’enfatizzazione esplicita del processo di enunciazione. Come osserva<br />
Hamon, questa scelta di messa in scena, al momento <strong>della</strong> conclusione, <strong>della</strong><br />
comunicazione letteraria e dei suoi protagonisti, autore e lettori, risponde al<br />
principio <strong>della</strong> retorica classica che impone di accentuare, per la perorazione<br />
finale, la relazione patetica con l’uditorio 13 .<br />
Ma come vedremo, le marche di enfatizzazione del finale sono nei Promessi<br />
sposi anche altre, e più complessamente intrecciate. La conclusione comincia<br />
dunque con la decisione esplicita di “ritornare” ai personaggi. Ritorno non è<br />
9 A. MANZONI, I Promessi sposi (1840), a c. di S. S. Nigro, edizione anastatica, Milano<br />
2002, p. 624. Anche se il ragionamento si riferisce a rigore alla ventisettana, cito per comodità<br />
del lettore dalla “quarantana”, del resto com’è noto diversa solo per ritocchi formali e<br />
linguistici, ininfluenti rispetto all’argomento qui svolto.<br />
10 P. HAMON, Clausules, in «Poétique», 24, 1975, p. 509.<br />
11 G. LARROUX, Le mot de la fin, Paris 1995, pp. 83-106.<br />
12 Scelta tutt’altro che scontata, per un autore che aveva appena teorizzato la linea<br />
romantica dell’abbattimento delle regole e dei modelli: se è vero ciò che scrive Hamon (loc.<br />
cit., p. 517), che l’accentuazione <strong>della</strong> conclusione è tipica delle scuole letterarie classicistiche,<br />
mentre quelle che privilegiano l’espressione piuttosto che le forme, il “voler-dire” piuttosto<br />
che il “saper- dire” (e fra queste “romanticismi, lirismi ed espressionismi vari”) tenderebbero<br />
piuttosto a testi “aperti”, a conclusioni meno accentuate e meno prevedibili.<br />
13 Op. cit., p. 513.<br />
127
Pino Fasano<br />
parola usata a caso: il percorso narrativo del finale, ricalcando e allo stesso<br />
tempo mutando di segno lo schema delle vicende che occupano il centro del<br />
romanzo, sembra richiamare esplicitamente la mutazione provvidenziale<br />
sopravvenuta. Ezio Raimondi 14 ha descritto con magistrale raffinatezza la corrispondenza<br />
impressionante fra il capitolo XXXIII, inizio del finale come s’è<br />
detto, e l’XI. I due capitoli sono entrambi dedicati alla coppia Renzo/Don<br />
Rodrigo, gli antagonisti maschili <strong>della</strong> storia: due personaggi che non si incontrano<br />
mai, se non all’estremo, quando Don Rodrigo è ormai inebetito dalla<br />
peste. L’interazione fra i due e è dunque solo di intreccio, e ciò è appunto evidenziato<br />
dalla struttura parallela dei due capitoli: nella prima parte di ciascuno<br />
di essi si narra di Don Rodrigo (XI: ritorno dei bravi scornati senza Lucia, e colloqui<br />
col Griso che preparano il rapimento, stavolta destinato a riuscire, di<br />
Lucia dal convento di Monza; XXXIII: Don Rodrigo a Milano si scopre la<br />
peste, ancora colloqui col Griso sino al tradimento di quest’ultimo e al trasporto<br />
di Don Rodrigo al lazzaretto); nelle seconde parti si riprendono le vicende di<br />
Renzo: prima entrata a Milano nell’XI, ritorno al paese (con il celebre “pezzo”<br />
<strong>della</strong> vigna distrutta) e ripartenza per Milano alla ricerca di Lucia nel XXXIII.<br />
Le storie dei potenti e degli umili restano separate nella fabula: il loro collegamento<br />
è tutto affidato alla narrazione, ed è il responsabile di questa infatti a<br />
intervenire esplicitamente in prima persona, nei due capitoli, per creare la congiunzione.<br />
Nell’XI a questo <strong>fine</strong> viene utilizzato il celebre paragone (che rinforza<br />
con l’allusione familiare l’entrata in scena dell’autore) fra narratore e pastorello,<br />
personaggi e porcellini d’India:<br />
Ma (come vanno alle volte le cose di questo mondo!) intanto che colui [Don Rodrigo]<br />
pensava al dottore [Azzeccagarbugli], come all’uomo più abile a servirlo in questo, un<br />
altr’uomo, l’uomo che nessuno s’immaginerebbe, Renzo medesimo, per dirla, lavorava di<br />
cuore a servirlo, in un modo più certo e più spedito di tutti quelli che il dottore avrebbe mai<br />
saputi trovare.<br />
Ho visto più volte un caro fanciullo, vispo, per dire il vero, più del bisogno, ma che, a<br />
tutti i segnali, mostra di voler riuscire un galantuomo; l’ho visto, dico, più volte affaccendato<br />
sulla sera a mandare al coperto un suo gregge di porcellini d’India, che aveva lasciati scorrer<br />
liberi il giorno, in un giardinetto. Avrebbe voluto fargli andar tutti insieme al covile; ma era<br />
fatica buttata: uno si sbandava a destra, e mentre il piccolo pastore correva per cacciarlo nel<br />
branco, un altro, due, tre ne uscivano a sinistra, da ogni parte. Dimodoché, dopo essersi un<br />
po’ impazientito, s’adattava al loro genio, spingeva prima dentro quelli ch’eran più vicini<br />
all’uscio, poi andava a prender gli altri, a uno, a due, a tre, come gli riusciva. Un gioco simile<br />
ci convien fare co’ nostri personaggi: ricoverata Lucia, siam corsi a don Rodrigo; e ora lo<br />
dobbiamo abbandonare, per andar dietro a Renzo, che avevam perduto di vista 15 .<br />
14 E. RAIMONDI, L’antitesi romanzesca, in <strong>Il</strong> romanzo senza idillio, Torino, Einaudi, 1974,<br />
pp. 249-307.<br />
15 Promessi sposi, ed. cit., pp. 228-29.<br />
128
Nel XXXIII è una più sbrigativa ma non meno importante inserzione d’autore<br />
(ci torneremo, ma si noti subito la sapienza modernissima delle allusioni<br />
metanarrative, con quel richiamo all’“intralcio” delle storie come costituzione<br />
<strong>della</strong> narrabilità) a stabilire, in perfetto parallelismo col meccanismo dell’XI<br />
capitolo, la transizione dalla “storia di Don Rodrigo” a quella di Renzo:<br />
Lasciando ora questo [Don Rodrigo] nel soggiorno de’ guai, dobbiamo andare in cerca<br />
d’un altro, la cui storia non sarebbe mai stata intralciata con la sua, se lui non l’avesse voluto<br />
per forza; anzi si può dir di certo che non avrebbero avuto storia né l’uno né l’altro: Renzo,<br />
voglio dire, che abbiam lasciato al nuovo filatoio, sotto il nome d’Antonio Rivolta 16 .<br />
Che la corrispondenza dei due capitoli non sia casuale, non ce lo dice solo la<br />
perfetta analogia strutturale; è Manzoni stesso a confermarcene l’intenzionalità,<br />
con un’altra entrata in prima persona nel racconto dell’XI, che costituisce anche<br />
un celebre esempio di prolessi narrativa. Quando Don Rodrigo loda il Griso per<br />
la sua azione di indagine sui misteri <strong>della</strong> notte degli imbrogli, con la evidente<br />
intenzione «di risarcirlo degl’improperi precipitati coi quali lo aveva accolto»,<br />
l’autore si rivolge al personaggio («Va a dormire, povero Griso, che tu ne devi<br />
aver bisogno…») per congratularsi ironicamente con lui <strong>della</strong> ristabilita giustizia<br />
nel giudizio sul suo operato, scellerato ma tecnicamente ineccepibile; annunciandogli<br />
altresì ellitticamente che con ugual scellerataggine sarà lui Griso (tradendo<br />
Don Rodrigo e consegnandolo ai monatti, e siamo al nostro XXXIII) a<br />
confermare «che qualche volta la giustizia, se non arriva alla prima, arriva, o<br />
presto o tardi anche in questo mondo.»<br />
Va a dormire per ora: che un giorno avrai forse a somministrarcene un’altra prova, e più<br />
notabile di questa 17 .<br />
Vediamo dunque subito il meccanismo del finale impostato su un rigoroso<br />
parallelismo con l’“in mezzo” aristotelico dell’azione: un parallelismo che deve<br />
didatticamente assicurare la piena visibilità <strong>della</strong> restaurazione <strong>della</strong> giustizia,<br />
anche in questo mondo. Non solo la bipartizione dei due capitoli indica nel confronto<br />
il ribilanciamento dei rapporti di forza fra potenti e umili assicurato dalla<br />
peste: che fa di Renzo, umiliato ed esiliato dalla prepotenza nobiliare nell’XI, il<br />
rappresentante nel XXXIII di quella “classe privilegiata” che sono i guariti, ed<br />
uguaglia spietatamente la sorte del nobiluomo Don Rodrigo a quella di tutti gli<br />
altri appestati gettati sul carro dei monatti. Ma entro ciascuna delle due parti dei<br />
capitoli in questione sono gettati altri minori e meno patenti ma non meno suggestivi<br />
parallelismi: anche all’interno del mondo dei malvagi la “giustizia”<br />
16 Promessi sposi, ed. cit., p. 632.<br />
17 Promessi sposi, ed. cit., p. 218.<br />
<strong>Il</strong> <strong>disincanto</strong> <strong>della</strong> <strong>fine</strong><br />
129
Pino Fasano<br />
viene restaurata, capovolgendosi come abbiamo accennato il segno <strong>della</strong> prevaricazione<br />
– di Don Rodrigo sul Griso, ingiustamente tartassato per l’esito incolpevolmente<br />
sfortunato dell’impresa affidatagli, nell’XI; e del bravo sul padrone<br />
appestato nel XXXIII. E non solo l’esplicita prolessi già citata segnala la<br />
volontà del parallelismo a parti invertite, ma anche la costruzione degli episodi:<br />
si osservi come il dialogo fra i due passa nell’XI dai rimbrotti alle lodi, nel<br />
XXXIII dalle adulazioni («tu sei sempre stato il mio fido», «di te mi posso fidare»)<br />
alle urla impotenti e furiose quando Don Rodrigo scopre il tradimento («Ah<br />
traditore infame… canaglia»).<br />
Del resto anche al di fuori dei due capitoli paralleli troviamo sparsi nel racconto<br />
di questo inizio di conclusione lampi narrativi che rinviano ad episodi del<br />
“mezzo” del romanzo per costituirsi come segni <strong>della</strong> giustizia finale; il più suggestivo<br />
è dato dalla ripetizione nel sogno di Don Rodrigo del gesto di Fra<br />
Cristoforo sdegnato dall’offerta di “protezione” beffardamente offerta a Lucia:<br />
la sinistra levata con l’indice teso, ad annunciare la punizione del malvagio.<br />
«Verrà un giorno…» (siamo nel VI capitolo). La predizione si avvera perfettamente<br />
a partire dalla coscienza, o dall’inconscio, di Don Rodrigo, che ricostruisce<br />
nel sogno la scena (per la quale è stato evocata la suggestione <strong>della</strong> apparizione<br />
a Don Giovanni <strong>della</strong> statua del commendatore 18 ) ed esattamente nel tentativo<br />
di ripetizione del precedente reale («afferrò rapidamente per aria quella<br />
mano minacciosa», nella scena del castello 19 ; «come per islanciarsi ad acchiappar<br />
quel braccio teso per aria», nell’incubo milanese) scopre, destandosi, sotto il<br />
suo stesso braccio che aveva minacciato il «poltrone incappucciato» il segno<br />
<strong>della</strong> punizione divina, il «sozzo bubbone d’un livido paonazzo».<br />
<strong>Il</strong> meccanismo <strong>della</strong> “ripetizione” di tratti narrativi allo scopo di palesare il<br />
restauro di una giustizia nella distribuzione del bene e del male sembra dunque<br />
assegnare al finale del romanzo una funzione didattica ed edificante: quella funzione<br />
che già Friedrich Schlegel aveva identificato come punto debole del genere-romanzo,<br />
del novel, ironizzando sui finali di Richardson e Fielding, quei<br />
finali in cui «i commercianti falliti riacquistano denaro e credito, tutti i poveri<br />
diavoli trovano da mangiare, i simpatici mascalzoni tornano persone ammodo, e<br />
le ragazze perdute ritrovano la virtù» 20 . <strong>Il</strong> “mal di stomaco” manzoniano (o se si<br />
preferisce il <strong>disincanto</strong>) nasce esattamente intorno a questa funzione, e al conflitto<br />
che essa determina rispetto alla scelta romanzesca: mossa dalla scoperta<br />
<strong>della</strong> possibilità, indicata da Scott, di raccontare il vero «attraverso una favola di<br />
18 Cfr. P. STOPPELLI, Manzoni e il tema di don Giovanni, «Belfagor», XXXIX, 1984, pp.<br />
501-516.<br />
19 Promessi sposi, VI capitolo, ed. cit., p. 105.<br />
20 Cfr. F. SCHLEGEL, Lettera sul romanzo, in Dialogo sulla poesia (1800), a c. di A.<br />
Lavagetto, Torino, Einaudi, 1991, pp. 62-63.<br />
130
propria invenzione», e approdata alla constatazione <strong>della</strong> incompatibilità tra i<br />
livelli <strong>della</strong> storia e dell’invenzione, non per caso nel momento in cui la “cantafavola”,<br />
come la chiama deluso in una di queste lettere del 26-27, esige una<br />
conclusione – giacché è la conclusione che sanziona irrevocabilmente quella<br />
“unità artificiale” del testo romanzesco da cui Manzoni pretendeva di rifuggire,<br />
perché non esistente nella vita reale 21 .<br />
Sarà questa in sostanza la motivazione <strong>della</strong> repentina interruzione <strong>della</strong> carriera<br />
di romanziere di Manzoni, e del ripudio esplicito del genere: ed è ozioso<br />
rammaricarsene. Ma quel che non si può fare a meno di ammirare è che, di fronte<br />
a questo conflitto, Manzoni esercita nel romanzo un meccanismo vittorioso di<br />
autoanalisi che gli consente di “superarlo”, nell’unico modo in cui si possono<br />
superare i conflitti: rappresentandoli. La conclusione dei Promessi sposi consiste<br />
esattamente nella messa in scena esplicita e sempre più consapevole e autoironica<br />
dei meccanismi conclusivi di una finzione romanzesca.<br />
3. Rime<br />
<strong>Il</strong> <strong>disincanto</strong> <strong>della</strong> <strong>fine</strong><br />
<strong>Il</strong> virtuosismo consiste nella capacità di condurre quest’analisi, corrosiva dei<br />
meccanismi canonici <strong>della</strong> produzione romanzesca, come sovrastrato dell’esercizio<br />
sapiente di quegli stessi meccanismi. Non per caso tutto il finale, a partire<br />
dalla transizione d’autore che bipartisce il capitolo XXXIII, è fondato sulla<br />
dominante presenza e centralità prospettica di Renzo. Renzo infatti, come personaggio<br />
“ingenuo”, ammaestrato dalle proprie avventure, è il garante <strong>della</strong> funzione<br />
didattica del romanzo; ma allo stesso tempo, come sarà sempre più evidente<br />
sino alla dichiarazione esplicita nel penultimo capitolo, è nella finzione<br />
strutturale del romanzo la fonte primaria <strong>della</strong> narrazione. È lui infatti («tutto<br />
conduce a crederlo» 22 ) che ha raccontato più volte la storia all’Anonimo autore<br />
<strong>della</strong> “scartafaccio” ritrovato. E i capitoli finali affidano a questa sua duplice<br />
funzione la possibilità di orientare il “senso” etico <strong>della</strong> storia raccontata (il<br />
“sugo”, la “conclusione”, condivisibile “benché trovata da povera gente”) allo<br />
stesso momento in cui il meccanismo narrativo che costituisce la “finzione”<br />
viene spietatamente denudato e demistificato attraverso il doppio gioco di selezione,<br />
commento, intrusione, garantito dai due livelli successivi di “rifacimento”<br />
<strong>della</strong> storia raccontata da Renzo: da parte dell’Anonimo e da parte di<br />
Manzoni.<br />
Che sia Renzo il personaggio deputato a condurre la conclusione, lo intuiamo<br />
subito, al suo rientro in scena a metà del XXXIII capitolo, perché è in quel<br />
21 Lettera a Claude Fauriel del 29 maggio 1822, in Tutte le lettere, cit., I, p. 272 .<br />
22 Promessi sposi, ed. cit., p. 714.<br />
131
Pino Fasano<br />
punto che scatta un’altra marca caratteristica dei finali: l’accelerazione del racconto,<br />
che qui è addirittura vertiginosa. La durata delle unità narrative è enormemente<br />
scorciata rispetto al tempo delle vicende narrate, anche al paragone<br />
<strong>della</strong> prima parte dello stesso capitolo: basta confrontare il pathos insistito <strong>della</strong><br />
scena in cui Don Rodrigo si scopre la peste, con i tocchi psicologici e clinici cui<br />
abbiamo accennato, e la nuda enunciazione dell’analogo evento capitato a<br />
Renzo: in tre righe sappiamo che prese la peste, non si curò, guarì 23 . Questo<br />
cambio di velocità <strong>della</strong> narrazione è autoironicamente dichiarato dall’autore<br />
nel suo sternesco dialogo coi lettori: «non vi sgomentate», ci apostrofa direttamente<br />
il narratore dopo aver accennato alla diffusione <strong>della</strong> peste nel Bergamasco,<br />
«ch’io non voglio raccontar la storia anche di questa».<br />
Ma poi, come dicevo, è appunto a Renzo che è delegata la responsabilità di<br />
finire. Segnali di questa funzione “conclusiva” del personaggio, fra assunzione<br />
di una sempre più dominante focalizzazione interna del racconto e implicite, ma<br />
talvolta esplicite, correzioni d’autore alla sua prospettiva “positiva” («Giova<br />
sperare, caro il mio Renzo», è il commento ironico del narratore al soliloquio<br />
ottimistico del protagonista 24 ) sono sparsi già in questo sommario rapidissimo<br />
delle sue vicende. Da una parte, la narrazione si mette a fuoco progressivamente<br />
e sempre più esplicitamente dal punto di vista di Renzo: dall’iniziale sfrontata<br />
esibizione dell’onniscienza del narratore (ad esempio nello svelamento <strong>della</strong><br />
vena di egoistica convenienza che muove la premura di Bortolo verso il cugino<br />
25 ) si passa alla assunzione occulta del linguaggio del protagonista entro il<br />
discorso del narratore («quelle benedette lettere di Agnese» «gli era saltato il<br />
grillo di farsi soldato»), poi alla rappresentazione indiretta dei suoi pensieri, del<br />
suo flusso di coscienza («risorsero più che mai rigogliose nell’animo suo le<br />
memorie, i desidèri, le speranze, i disegni <strong>della</strong> vita») sino alle enunciazione<br />
diretta di quei pensieri, fra virgolette: «Anderò io… disse tra sé. Trovarla, lo troverò<br />
io…». Ma dall’altra parte in questa stessa presa di parola diretta cominciano<br />
ad affiorare i segni che legano il discorso di Renzo-personaggio alla sua funzione<br />
di protonarratore, di rivelatore quindi dello scheletro <strong>della</strong> narrazione e<br />
<strong>della</strong> sua deludente conclusione.<br />
23 «Quel ch’io volevo dire è che Renzo prese anche lui la peste, si curò da sé, cioè non<br />
fece nulla; ne fu in fin di morte, ma la sua buona complessione vinse la forza del male: in<br />
pochi giorni, si trovò fuor di pericolo». Promessi sposi, ed. cit., p. 634.<br />
24 Promessi sposi, ed. cit., p. 635.<br />
25 «… perché Renzo, come giovine di talento, e abile nel mestiere, era, in una fabbrica, di<br />
grande aiuto al factotum, senza poter mai aspirare a divenirlo lui, per quella benedetta disgrazia<br />
di non saper tener la penna in mano. Siccome anche questa ragione c’era entrata per qualche<br />
cosa, così abbiam dovuto accennarla. Forse voi vorreste un Bortolo più ideale: non so che<br />
dire: fabbricatevelo. Quello era così.» Cap. XXXIII, Promessi sposi, ed. cit., pp. 632-33.<br />
132
<strong>Il</strong> <strong>disincanto</strong> <strong>della</strong> <strong>fine</strong><br />
<strong>Il</strong> ritorno di Renzo al suo paese, devastato dalla peste e dalla guerra, infatti,<br />
prepara lo scioglimento a partire da una sorta di sintesi soggettiva degli eventi<br />
<strong>della</strong> prima parte del romanzo: non solo, a livello del narrato, attraverso le<br />
“dolorose rimembranze” suscitate dai luoghi nel protagonista; ma anche e<br />
soprattutto, a livello <strong>della</strong> narrazione, attraverso un meccanismo di ripetizione<br />
occulta di quegli eventi, che funziona come una sorta di rima: risuscitando in<br />
risonanza la prima occorrenza e incrementandone i significati alla luce <strong>della</strong> sua<br />
ricorrenza finale. L’esempio più eclatante di questo meccanismo, in questo scorcio<br />
di capitolo, è l’incontro di Renzo con Don Abbondio: che ci rimanda, in<br />
prima istanza, al dialogo del II capitolo, quando il giovane si trova di fronte al<br />
rifiuto del curato di celebrare il matrimonio; anche qui Renzo incalza per sapere,<br />
per ottenere, e il curato, preda ancora, nonostante tutti gli avvenimenti, <strong>della</strong><br />
stessa ostinata paura, sfugge, svicola, cerca di liberarsi dell’interlocutore. Anzi<br />
in questo senso Renzo – lui sì cambiato dall’esperienza e dalla peste, reso forte<br />
e “ferrato” dalla guarigione come un guerriero medievale – rappresenta, nella<br />
prospettiva pavida di Don Abbondio, un nuovo “bravo” minaccioso; e qui la<br />
rima è addirittura col celeberrimo incipit del romanzo: dal punto di vista del<br />
curato, la sequenza dell’episodio è identica – la camminata nel viottolo, l’incontro<br />
inquietante – «vide una cosa che non s’aspettava e che non avrebbe voluto<br />
vedere» (I capitolo) e che gli detta ora una «meraviglia scontenta» (XXXIII), il<br />
riconoscimento, il gesto di sconforto e di imbarazzo (le due dita nel colletto e la<br />
faccia volta all’indietro nell’incontro con i bravi, le mani al cielo e il bastone in<br />
aria di fronte a questo Renzo-bravo di ritorno) e in<strong>fine</strong> il colloquio inevitabile e<br />
penoso.<br />
Ma vorrei rapidamente venire al passaggio fra XXXIII e XXXIV capitolo, al<br />
momento cioè in cui Renzo, esplicitando il modulo <strong>della</strong> ripetizione, riparte dal<br />
paese per rifare velocemente – in conclusione – il circuito che aveva costituito il<br />
“mezzo” delle sue avventure: dal paese a Monza a Milano a Bergamo e ritorno a<br />
casa.<br />
Ho detto esplicitando il modulo <strong>della</strong> ripetizione: in realtà nella ventisettana<br />
i richiami espliciti alla prima partenza per Milano sono sapientemente sfumati,<br />
sono veloci ammiccamenti al lettore – Renzo è guidato da «un po’ di memoria<br />
de’ luoghi, che gli era rimasta dell’altro viaggio» (il sintagma mantiene l’eco<br />
inconsapevole di quello dantesco); e si veda anche il dettaglio, in <strong>fine</strong> capitolo,<br />
del duomo che funge da “stella polare”, variante dell’immagine che era comparsa<br />
nell’XI, «quella gran macchina del Duomo». Ma la scelta di quel meccanismo<br />
era stata distesamente svelata, e ironicamente difesa come modulo narrativo<br />
“realistico”, nel Fermo e Lucia. Anche lì alla <strong>fine</strong> del capitolo precedente, il<br />
V del IV libro, c’era una semplice sottolineatura (ma più esplicita) <strong>della</strong> ripetizione:<br />
«Fermo……..fece la sua seconda entrata a Milano, che gli comparve in<br />
un aspetto più tristo e più strano d’assai che non era stato la prima volta». Ma<br />
l’apertura del capitolo successivo, il VI, consiste in un’esplicita, argomentata<br />
133
Pino Fasano<br />
esposizione <strong>della</strong> metodologia, del “principio di somiglianza” che lega gli eventi<br />
narrati.<br />
S’io avessi ad inventare una storia, e per descrivere l’aspetto d’una città in una occasione<br />
importante, mi fosse venuto a taglio una volta il partito di farvi arrivare, e girar per entro un<br />
personaggio, mi guarderei bene dal ripetere inettamente lo stesso partito per descrivere la<br />
stessa città in un’altra occasione: che sarebbe un meritarsi l’accusa di sterilità d’invenzione,<br />
una delle più terribili che abbian luogo nella repubblica delle lettere, la quale, come ognun sa,<br />
si distingue fra tutte per la saviezza delle sue leggi. Ma, come il lettore è avvertito, io trascrivo<br />
una storia quale è accaduta: e gli avvenimenti reali non si astringono alle norme artificiali<br />
prescritte all’invenzione, procedono con tutt’altre loro regole, senza darsi pensiero di soddisfare<br />
alle persone di buon gusto. Se fosse possibile assoggettarli all’andamento voluto dalle<br />
poetiche, il mondo ne diverrebbe forse ancor più ameno che non sia; ma non è cosa da potersi<br />
sperare. Per questo incolto e materiale procedere dei fatti, è avvenuto che Fermo Spolino sia<br />
giunto due volte in Milano appunto in due epoche, diversamente singolari, e che l’una e l’altra<br />
volta abbia ricevuta dall’aspetto di quella città una impressione, che noi dobbiamo pur<br />
riferire, trattandosi d’uno dei nostri protagonisti. Nè in questo solo ma anche fra i due soggiorni<br />
di Fermo in Milano, anche fra le due partenze v’è un principio singolare di somiglianza:<br />
cui ella spiacesse, se la pigli con le cose, che hanno voluto essere a quel modo 26 .<br />
Polemizzando con le poetiche “romanzesche” (s’io dovessi inventare una<br />
storia) Manzoni dichiara la propria poetica. La ripetizione è teorizzata sotto la<br />
giustificazione che si tratta di realtà accaduta, di non-invenzione: sono le cose,<br />
che hanno voluto essere a quel modo. <strong>Il</strong> paradosso è evidente: il richiamo alla<br />
finzione dell’Anonimo (io trascrivo una storia qual è accaduta) ci ricorda che<br />
proprio la ripetizione è invenzione, ma invenzione motivata e sistematica; essa<br />
riguarda non solo il nuovo arrivo a Milano, ma anche il nuovo soggiorno, ed<br />
anche le due partenze. Ed è strumentale alla confrontabilità di due esperienze<br />
“diversamente singolari” attraverso la “singolare somiglianza” di esse: con un<br />
elemento invariante, il protagonista, che ci consente di “misurare” il cambiamento.<br />
Se torniamo alla ventisettana, l’applicazione sapientissima del modulo ci<br />
apparirà in modo assolutamente suggestivo. La prospettiva, come quasi sempre<br />
nel finale, è quella di Renzo – sembra di ascoltare direttamente il suo racconto<br />
all’Anonimo. Lo è non solo nella esposizione dei suoi pensieri, ma nel modo in<br />
cui si scoprono gli avvenimenti, rivelando alla sua ingenuità e sprovvedutezza<br />
la loro singolarità ed eccezionalità. <strong>Il</strong> gioco di somiglianze/diversità <strong>della</strong> ripetizione<br />
è perfettamente esemplificato dal segnale che nelle due circostanze Renzo<br />
riceve: un inaspettato segnale di senso, non di intelletto, da decodificare nella<br />
sua eccezionalità: nell’XI, era il bianco in terra di «strisce bianche e soffici<br />
come di neve»; qui, il nero in aria «d’un fumo oscuro e denso». Dal colore, pri-<br />
134<br />
26 Fermo e Lucia, in Tutte le opere di Alessandro Manzoni, cit., vol. II to. III, p. 605.
<strong>Il</strong> <strong>disincanto</strong> <strong>della</strong> <strong>fine</strong><br />
mo ictus sui sensi dello spettatore, alla scoperta del suo significato: farina<br />
lasciata cadere dai saccheggiatori dei forni nel primo caso; suppellettili degli<br />
appestati bruciate nel secondo. In entrambi i casi, distruzione e dissipazione di<br />
beni, di ricchezza, segnale drammatico di straordinarietà, di avvenimenti “fuor<br />
dell’ordinario”, presunzione di dramma ribadita da «quella solitudine, quel<br />
silenzio, così vicino a una gran città» (capitolo XXXIV; e nell’XI: «la strada era<br />
deserta… se non avesse sentito un ronzio lontano… gli sarebbe parso di entrare<br />
in una città disabitata»).<br />
Anche la toponomastica funziona da richiamo alla ripetizione. Manzoni non<br />
esagera sino al punto di far arrivare Renzo esattamente dalla stessa strada, ma è<br />
più astuto: scopriamo infatti ora, in piena epidemia, che non era casuale che<br />
nell’XI Renzo fosse arrivato dalla parte del lazzaretto (ivi descritto nelle istruzioni<br />
del passante: «una fabbrica lunga e bassa: è il lazzeretto»); il meccanismo<br />
funziona, esattamente come una rima, scoprendosi al momento in cui il segmento<br />
viene ripetuto, ma in quel momento riattivando e potenziando significati <strong>della</strong><br />
prima occorrenza – il finale dà senso alla storia, come scriverà Sartre «la <strong>fine</strong> è<br />
lì presente a trasformare tutto» 27 . Altro elemento in comune, il comportamento<br />
dei gabellieri: in entrambi gli episodi il controllo del bene pubblico che essi<br />
dovrebbero garantire (e che Renzo si aspetta) è allentato, clamorosamente lassista<br />
quando non corrotto («nessuno dei gabellini gli bada», XI; mentre nel<br />
XXXIV è un «mezzo ducatone» a funzionare da lasciapassare per Renzo):<br />
nuovo segnale di disordine sociale, di caduta delle regole.<br />
<strong>Il</strong> parallelismo dei due episodi prosegue con il primo incontro di un cittadino<br />
milanese: in XI, il viandante frettoloso, in fuga dai disordini urbani; qui un cittadino<br />
(«Un cristiano finalmente!») altrettanto poco incline a dar retta a Renzo.<br />
Lo schema dei due episodi è assolutamente identico: la costante è l’atteggiamento<br />
interrogativo di Renzo (<strong>della</strong> strada in prima istanza; ma più in profondo<br />
del cammino esistenziale, del reale, del vero: è il Renzo “cercatore” di cui ci<br />
parla Raimondi); la risposta e l’atteggiamento dell’altro sono “diversamente singolari”.<br />
Nel primo arrivo il passante è esageratamente gentile, e lascia per questo<br />
Renzo stupefatto ed edificato; qui al contrario è immotivatamente villano e<br />
minaccioso, sino ad agitare contro Renzo un «noderoso bastone». In entrambi i<br />
casi si tratta di un comportamento “stravagante”. E per dare al lettore il significato<br />
<strong>della</strong> stravaganza, in entrambi i casi Manzoni interviene rompendo il flusso<br />
<strong>della</strong> prospettiva ignara di Renzo ed entrando con la consapevolezza del narratore<br />
onnisciente nella psicologia dell’interlocutore: il passante del primo episodio,<br />
ci informa l’autore, «non vedeva l’ora di trovarsi a casa, e avrebbe fatto<br />
volentieri di meno di quella fermata»; mentre nel capitolo del finale Manzoni<br />
27 J.-P. SARTRE, La nausea (1938), traduzione di B. Fonzi, Torino, Einaudi, 1999 11 , p. 60.<br />
135
Pino Fasano<br />
interviene addirittura con una non breve digressione sul comportamento successivo<br />
del cittadino (tornato a casa, racconta di aver incontrato un untore e di<br />
averlo messo in fuga) totalmente fuori cornice, e in clamorosa violazione <strong>della</strong><br />
finzione strutturale (chi poteva aver dato quelle notizie al narratore?): digressione<br />
che costituisce un segnale forte, straniante, di regia dello scrittore, <strong>della</strong><br />
volontà didascalica di mostrare la “irrazionalità” dominante (il “delirio dell’unzioni”).<br />
Subito dopo Manzoni rientra nello schema, restituendo a Renzo il giudizio<br />
sulla “irragionevolezza” <strong>della</strong> situazione, ma anche la rozza consapevolezza<br />
<strong>della</strong> ripetizione:<br />
– La principia male, – pensava però: – par che ci sia un pianeta per me, in questo Milano.<br />
Per entrare, tutto mi va a seconda; e poi, quando ci son dentro, trovo i dispiaceri lì apparecchiati<br />
28 .<br />
<strong>Il</strong> pianeta, un destino disgraziato che si ripete – ma il pianeta appunto ripassa<br />
periodicamente dallo stesso punto. Con l’episodio successivo si comincia a<br />
cogliere esplicitamente il senso che Manzoni vuol dare al meccanismo. La<br />
“rima” qui è data da due oggetti colmi di significati simbolici, i due pani: cibo,<br />
vita, produzione, economia, ma anche cristianamente eucaristia. Come si ricorderà,<br />
Renzo nell’XI capitolo aveva raccolto i pani caduti ai saccheggiatori, e se<br />
ne era ficcato due in tasca – ora si cava di tasca i due pani comprati per sé a<br />
Monza e li dona a una madre contornata da bambini affamati, consapevole che<br />
si tratta di “una restituzione” di quelli in certo modo – per delega – rubati nel<br />
primo episodio. La ripetizione, invertita di segno, trasforma Renzo da collaboratore<br />
(sia pure involontario e inconsapevole) alla violenza e all’ingiustizia in<br />
riparatore del male. Ciò che, alla <strong>fine</strong>, gioverà anche a lui: secondo l’aforisma<br />
messo in bocca all’Anonimo nell’ultimo capitolo, se si pensa più a far bene che<br />
a star bene, si finisce anche a star meglio.<br />
4. <strong>Il</strong> finale <strong>della</strong> storia<br />
Questo schema didattico del meccanismo, in realtà, non convince del tutto<br />
Manzoni – ma anziché rinunciarvi, egli sembra metterlo in scena sino in fondo<br />
per poi contestarlo, eroderlo dall’interno. Ci troviamo di fronte infatti a due<br />
finali successivi: i tre capitoli dal XXXIV al XXXVI concludono secondo i<br />
canoni del lieto <strong>fine</strong> la fabula, in coscienziosa applicazione del “principio di<br />
simiglianza” che lega i due percorsi milanesi di Renzo e che rende visibile, sia<br />
136<br />
28 Promessi sposi, ed. cit., p. 653.
pure attraverso la tragedia <strong>della</strong> peste, il cambiamento in bene di tutto ciò che<br />
nel “mezzo” del racconto era male. Mentre nel XXXVII e nel XXXVIII questa<br />
conclusione viene sottoposta ad un’analisi corrosiva che porta l’attenzione piuttosto<br />
sul raccontare che sul raccontato, e utilizza a tal <strong>fine</strong> lo stesso meccanismo<br />
<strong>della</strong> ripetizione assai più come svelamento (e svalutazione) dell’artificio narrativo<br />
che come sostegno alla felice evoluzione <strong>della</strong> vicenda narrata.<br />
L’episodio dei pani restituiti apre la seconda esperienza milanese di Renzo. La<br />
ripetizione dello schema <strong>della</strong> precedente entrata in città ha il preciso <strong>fine</strong> di far<br />
funzionare la “funesta mutazione” cui il giovane assiste («Quale città! E cos’era<br />
mai, al paragone, quello ch’era stata l’anno avanti, per cagion <strong>della</strong> fame!» 29 )<br />
come prova da superare in una quête formativa ed espiatoria, che garantirà alla<br />
<strong>fine</strong> il miracolo cristiano del perdono e il premio del ricongiungimento felice a<br />
Lucia. Come nei capitoli sulla carestia, la narrazione nel XXXIV capitolo segue il<br />
cammino e l’osservazione ingenua di Renzo, il suo cogliere i segni misteriosi di<br />
una situazione “fuor de l’ordinario” – rumori, voci, la sinistra apparizione <strong>della</strong><br />
macchina <strong>della</strong> tortura – per dar modo al narratore di illustrare il retroscena di<br />
quella situazione, alternando l’interpretazione al racconto, il distanziamento giudicante<br />
(l’arbitrio e la tortura come rimedio “eccessivo e inefficace”) al coinvolgimento<br />
patetico (la madre di Cecilia). E come nel primo soggiorno milanese,<br />
Renzo è coinvolto suo malgrado nella irrazionalità violenta, è scambiato per quel<br />
che non è (un rivoltoso nel primo caso, un untore adesso), e si salva saltando sul<br />
carro dei monatti: ripetizione invertita dello scampo trovato la prima volta, allora<br />
la folla l’aveva salvato dagli sbirri («scappa, scappa, galantuomo»), ora questi<br />
particolari sbirri lo salvano dalla folla («vedi se noi sappiamo proteggere i galantuomini?»).<br />
Non per caso infatti Renzo ritrova a questo punto la scena topografica<br />
<strong>della</strong> prima volta, “riconosce” il luogo, la via che portava dritta al lazzaretto:<br />
«tratto speciale <strong>della</strong> Provvidenza» per consentirgli il ritrovamento di Lucia.<br />
I due capitoli che seguono, il XXXV e il XXXVI, nella scena purgatoriale<br />
del lazzaretto, tracciano per Renzo un cammino di dolorosa contemplazione, di<br />
simbolica purificazione e di riscatto, che prepara, dopo il ritrovamento di Fra<br />
Cristoforo e la visione di Don Rodrigo morente, l’incontro con Lucia. <strong>Il</strong> miracolo<br />
cristiano s’è avverato (come vuole la proppiana morfologia <strong>della</strong> fiaba, il<br />
ritrovamento dei promessi sposi è favorito da un oggetto magico, il campanellino<br />
da monatto che Renzo incautamente si era legato al piede), ma c’è ancora un<br />
ostacolo da rimuovere perché l’eroe Renzo, “intralciato” dal malvagio Don<br />
Rodrigo, raggiunga il suo <strong>fine</strong>: il voto di verginità di Lucia. Viene all’uopo ripescato<br />
l’ausiliario per eccellenza dei Promessi sposi, Fra Cristoforo, che pronuncia,<br />
come in tutte le fiabe, la formula magica, liberando Lucia «dal voto… e da<br />
ogni obbligazione che poteste averne contratta».<br />
29 Promessi sposi, ed. cit., p. 658.<br />
<strong>Il</strong> <strong>disincanto</strong> <strong>della</strong> <strong>fine</strong><br />
137
Pino Fasano<br />
La storia dei promessi sposi è finita. Rimossi tutti gli ostacoli al matrimonio:<br />
Don Rodrigo morente, il voto sciolto, Lucia e Renzo guariti dalla peste. Per di<br />
più, tutti a posto i significati didattici del romanzo: la virtù di Lucia ha convertito<br />
il malvagio, Renzo vede premiato dal ritrovamento (e dalla “riconquista”) di<br />
Lucia il suo atteggiamento non più vendicativo. Eppure Manzoni scrive altri due<br />
capitoli, preparati da una sapiente strategia narrativa che annuncia fra le righe del<br />
finale canonico un secondo “risolvimento”, segnato dalla scena simbolica <strong>della</strong><br />
burrasca liberatrice. All’inizio del XXXV capitolo, subito dopo l’ingresso di<br />
Renzo nel lazzaretto, troviamo una prima digressione meteorologica, una topica<br />
scena di temporale imminente (borbottar di tuoni, rondini che rasentano il terreno,<br />
aria immobile e pesante) che in apparenza serve solo a incrementare lo sgomento<br />
dell’osservazione di Renzo, «l’orrore di quelle viste» 30 . La stessa descrizione<br />
era anche nel Fermo e Lucia, ma collocata dopo il ritrovamento di Lucia,<br />
come accompagnamento del cammino di Renzo e Fra Cristoforo verso il recinto<br />
che ospita la fanciulla, dove sta per avvenire il proscioglimento del voto; e lì<br />
Manzoni, esplicitamente, capovolgeva il significato desolato e oppressivo di<br />
quell’“ora amara”, segnalandone la funzione di preparazione del finale lieto:<br />
Eppure quegli che sopravvissero rammentarono quell’ora con gioja per tutta la vita; era la<br />
preparazione d’una burasca, che scoppiò la notte, e menò poi per due giorni una pioggia continua,<br />
dopo la quale il contagio cessò quasi ad un tratto 31 .<br />
Nella ventisettana questa prolessi esplicita non c’è, e l’avvicinarsi <strong>della</strong><br />
pioggia è più sapientemente segnalato da successivi inserti descrittivi, alternati<br />
agli eventi, senza che mai ne venga enunciata la portata miracolosa, la <strong>fine</strong> del<br />
contagio.<br />
<strong>Il</strong> tempo s’era andato sempre più rabbuiando, e annunziava ormai certa e poco lontana la<br />
burrasca. De’ lampi fitti rompevano l’oscurità cresciuta, e lumeggiavano d’un chiarore istantaneo<br />
i lunghissimi tetti e gli archi de’ portici, la cupola <strong>della</strong> cappella, i bassi comignoli delle<br />
capanne; e i tuoni scoppiati con istrepito repentino, scorrevano rumoreggiando dall’una<br />
all’altra regione del cielo 32 .<br />
Nulla annuncia il significato positivo (e quindi conclusivo) <strong>della</strong> tempesta in<br />
arrivo. E quando, subito dopo l’estremo saluto di Renzo a Fra Cristoforo, un<br />
ultimo breve enunciato ecfrastico segnala l’imminenza <strong>della</strong> burrasca, la sua<br />
collocazione al termine del capitolo, anziché suonare come annuncio di <strong>fine</strong>, di<br />
lieta <strong>fine</strong>, ma di <strong>fine</strong>, sembra prepararci a un nuovo inizio.<br />
138<br />
30 Promessi sposi, ed. cit., p. 675.<br />
31 Fermo e Lucia, ed. cit., IV, 8°, p. 652.<br />
32 Promessi sposi, ed. cit., pp. 704-05.
C’era un movimento straordinario, un correr di monatti, un trasportar di roba, un accomodar<br />
le tende delle baracche, uno strascicarsi di convalescenti a queste e ai portici, per ripararsi<br />
dalla burrasca imminente 33 .<br />
5. I racconti di Renzo<br />
Comincia infatti qui, con il penultimo capitolo e lo scrosciare finalmente<br />
<strong>della</strong> pioggia, quello che possiamo chiamare il secondo finale del romanzo. <strong>Il</strong><br />
lettore si domanda, una volta che l’autore gli ha svelato il valore liberatorio del<br />
diluvio, e quindi ha aggiunto un lieto <strong>fine</strong> generale a quello particolare dei due<br />
protagonisti, che cosa ancora possa accadere nei due capitoli che lo separano<br />
dalla <strong>fine</strong> tipografica del libro. Persino la scena <strong>della</strong> celebrazione del matrimonio<br />
era stata in certo modo già prefigurata in anticipo nel capitolo precedente,<br />
attraverso la formula liberatoria dal voto pronunciata da Fra Cristoforo, cui era<br />
seguita una breve omelia augurale e ammonitrice agli sposi. In effetti, l’aspetto<br />
singolare di questa sorta di post-finale è che non “accade” praticamente nulla.<br />
Renzo – è ancora suo il ruolo conduttore del racconto – torna al paese, ritrova<br />
Agnese viva, aspetta con lei che Lucia finisca la quarantena, si sposa, va a vivere<br />
con la moglie nel Bergamasco e diventa, se non proprio ricco, un piccolo<br />
imprenditore agiato. Punto. Bastavano due capoversi, anziché due capitoli. E<br />
infatti in Fermo e Lucia i due capitoli non c’erano: la materia del XXXVII è<br />
ristretta in sette-otto paginette del manoscritto, la materia del XXXVIII in una;<br />
il tutto già anticipato come sbrigativa appendice al racconto <strong>della</strong> romanzesca<br />
morte di Don Rodrigo.<br />
Se nei Promessi sposi questo finale si prolunga, è perché viene dato spazio,<br />
assai più che agli enunciati narrativi, alle modalità dell’enunciazione. A<br />
Manzoni, in conclusione dell’“eterno lavoro”, interessa verificare non se sia<br />
giusta la morale del racconto, ma se quella morale si collochi correttamente in<br />
una finzione narrativa; in ultima analisi, se abbia senso l’impresa romanzesca.<br />
Non a caso protagonista assoluto di questi due ultimi capitoli è ancora Renzo,<br />
ma un Renzo di cui si coglie soprattutto la funzione di alter-ego del narratore,<br />
colta attraverso la verifica che il suo percorso mentale fa dell’andamento delle<br />
proprie avventure a partire dal loro felice termine: «il gran lavoro <strong>della</strong> sua<br />
mente era di riandare la storia di que’ tristi anni passati».<br />
Andava dunque il nostro viaggiatore allegramente, senza aver disegnato né dove, né<br />
come, né quando, né se avesse da fermarsi la notte, premuroso soltanto di portarsi avanti,<br />
d’arrivar presto al suo paese, di trovar con chi parlare, a chi raccontare, soprattutto di poter<br />
presto rimettersi in cammino per Pasturo, in cerca d’Agnese. [……..] Guardando per la stra-<br />
33 Promessi sposi, ed. cit., p. 710.<br />
<strong>Il</strong> <strong>disincanto</strong> <strong>della</strong> <strong>fine</strong><br />
139
Pino Fasano<br />
da, raccattava, per dir così, i pensieri, che ci aveva lasciati la mattina e il giorno avanti, nel<br />
venire; e con più piacere quelli appunto che allora aveva più cercato di scacciare, i dubbi, le<br />
difficoltà, trovarla, trovarla viva, tra tanti morti e moribondi! – E l’ho trovata viva! – concludeva.<br />
Si rimetteva col pensiero nelle circostanze più terribili di quella giornata; si figurava<br />
con quel martello in mano: ci sarà o non ci sarà? e una risposta così poco allegra; e non aver<br />
nemmeno il tempo di masticarla, che addosso quella furia di matti birboni; e quel lazzeretto,<br />
quel mare! lì ti volevo a trovarla! E averla trovata! Ritornava su quel momento quando fu<br />
finita di passare la processione de’ convalescenti: che momento! che crepacore non trovarcela!<br />
e ora non gliene importava più nulla. E quel quartiere delle donne! E là dietro a quella<br />
capanna, quando meno se l’aspettava, quella voce, quella voce proprio! E vederla, vederla<br />
levata! Ma che? c’era ancora quel nodo del voto, e più stretto che mai. Sciolto anche questo.<br />
E quell’odio contro don Rodrigo, quel rodìo continuo che esacerbava tutti i guai, e avvelenava<br />
tutte le consolazioni, scomparso anche quello. Talmenteché non saprei immaginare una<br />
contentezza più viva, se non fosse stata l’incertezza intorno ad Agnese, il tristo presentimento<br />
intorno al padre Cristoforo, e quel trovarsi ancora in mezzo a una peste 34 .<br />
<strong>Il</strong> viaggio di ritorno al paese è non solo proiettato verso il racconto («trovar<br />
con chi parlare, a chi raccontare…»); di più, è metaforicamente un racconto<br />
esso stesso, un percorso all’indietro negli avvenimenti («…si rimetteva col pensiero<br />
… ritornava su quel momento…»). Renzo è ormai ossessivamente dedito<br />
al ricordo e alla narrazione, per tutto il capitolo non farà altro. «Cose grandi,<br />
cose di fuoco….ti racconterò poi tutto», all’amico che lo accoglie fradicio di<br />
pioggia. E ancora, mentre si cambia e aspetta la cena: «Ne ho da raccontartene<br />
per tutta la giornata». E, conferma il narratore, «mantenne ciò, che aveva detto<br />
all’amico, di voler raccontargliene per tutta la giornata». Questa vocazione narrativa<br />
di Renzo è infatti avvalorata a questo punto dall’esplicita immissione del<br />
personaggio nel meccanismo strutturale di costruzione del romanzo:<br />
Come la facesse quando trovava due strade; se quella poca pratica, con quel poco barlume,<br />
fossero quelli che l’aiutassero a trovar sempre la buona, o se l’indovinasse sempre alla<br />
ventura, non ve lo saprei dire; ché lui medesimo, il quale soleva raccontar la sua storia molto<br />
per minuto, lunghettamente anzi che no (e tutto conduce a credere che il nostro anonimo l’avesse<br />
sentita da lui più d’una volta), lui medesimo, a questo punto, diceva che, di quella<br />
notte, non se ne rammentava che come se l’avesse passata in letto a sognare 35 .<br />
Lo svelamento <strong>della</strong> funzione di Renzo come “protonarratore” serve a<br />
Manzoni per sdoppiarsi e mettersi in condizione di giudicare, a partire dalla<br />
<strong>fine</strong>, il valore del proprio lavoro, e <strong>della</strong> sua capacità didascalica. L’ingenuità di<br />
Renzo nel “rifare” a ritroso la propria storia rappresenta l’onestà intellettuale di<br />
Manzoni, e consente di immettere nella pagina del romanzo i dubbi che nutrivano<br />
le sue nevrosi creative, trasportando anche l’attenzione del lettore dai fatti<br />
140<br />
34 Promessi sposi, ed. cit., pp. 712-13.<br />
35 Promessi sposi, ed. cit., p. 714.
accontati, ormai alla <strong>fine</strong> <strong>della</strong> storia tutti noti, alla scrittura romanzesca in sé e<br />
al suo valore o disvalore. Emblematica in questo senso la scena del colloquio di<br />
ritrovamento con Agnese, in cui i due personaggi, seduti l’uno di fronte all’altro<br />
a prudente distanza per timore del contagio, si raccontano l’un l’altra gli avvenimenti<br />
passati, e il lettore è chiamato a partecipare alla scena come ipotetico<br />
“terzo”.<br />
….son certo che, se il lettore, informato come è delle cose antecedenti, avesse potuto trovarsi<br />
lì in terzo, a veder con gli occhi quella conversazione così animata, a sentir con gli orecchi<br />
que’ racconti, quelle domande, quelle spiegazioni, quell’esclamare, quel condolersi, quel<br />
rallegrarsi, e don Rodrigo, e il padre Cristoforo, e tutto il resto, e quelle descrizioni dell’avvenire,<br />
chiare e positive come quelle del passato, son certo, dico, che ci avrebbe preso gusto, e<br />
sarebbe stato l’ultimo a venir via. Ma d’averla sulla carta tutta quella conversazione, con<br />
parole mute, fatte d’inchiostro, e senza trovarci un solo fatto nuovo, son di parere che non se<br />
ne curi molto, e che gli piaccia più d’indovinarla da sé 36 .<br />
Sempre di più, in questi capitoli conclusivi, la mancanza di “fatti nuovi” nell’enunciato<br />
narrativo sposta l’attenzione sulla situazione enunciazionale: Renzo<br />
continua a raccontare la sua storia, Manzoni continua a tirarsene fuori, a dialogare<br />
con i suoi lettori («direte forse… chi volesse anche sapere…»), commentando<br />
la previsione del lieto <strong>fine</strong> come una formalità un po’ noiosa da espletare.<br />
Alle curiosità del lettore (come se la cava Renzo con il bando, la “cattura” che<br />
pendeva sulla sua testa? e come finisce con Don Abbondio?) il narratore risponde<br />
eliminando ogni colore romanzesco (il bando si annulla nei fatti, perché non<br />
c’è più nessuno interessato a farlo applicare) e dilazionando nelle chiacchiere<br />
inani con Agnese, “per far passare il tempo” la decisione di Don Abbondio. <strong>Il</strong><br />
tempo del narrato si svuota, è pura attesa del termine <strong>della</strong> quarantena di Lucia,<br />
e ad esso si sostituisce il tempo <strong>della</strong> narrazione: «Al lettore noi lo faremo passare<br />
in un momento tutto quel tempo…».<br />
Tuttavia fra le incombenze del narratore, c’è quella fondamentale di portare<br />
a compimento le situazioni lasciate in sospeso. Le fini doverosamente da raccontare,<br />
ci annuncia Manzoni 37 , sono tre: quella di Gertrude, quella di Fra<br />
Cristoforo, quelle di Don Ferrante e Donna Prassede. Ma curiosamente non<br />
sono trattate in proporzione all’importanza di ciascun personaggio: sul pentimento<br />
di Gertrude, appena enunciato, viene subito calato il sipario del romanzesco<br />
per rimandare il lettore alla Storia, con tanto di rinvio erudito in nota al<br />
“citato altrove” Ripamonti; <strong>della</strong> morte di Fra Cristoforo, eroe dei primi capitoli<br />
e degli ultimi, la pura e semplice notizia. La <strong>fine</strong> del romanzo sembra programmaticamente<br />
evitare ogni enfasi agiografica o esemplare, nel male e nel bene,<br />
36 Promessi sposi, ed. cit., p. 718.<br />
37 Promessi sposi, ed. cit., pp. 723-26.<br />
<strong>Il</strong> <strong>disincanto</strong> <strong>della</strong> <strong>fine</strong><br />
141
Pino Fasano<br />
resistere alla riduzione a favola <strong>della</strong> storia. Tant’è vero che solo sulla terza<br />
informazione, quella di cui tutto sommato il lettore avrebbe anche potuto fare a<br />
meno 38 , Manzoni si ferma invece per un paio di pagine, recuperando – in un<br />
impianto molto più asciutto e concentrato – un tratto del Fermo e Lucia interno<br />
ai capitoli sulla peste. Si tratta <strong>della</strong> <strong>fine</strong> di Don Ferrante – e la ragione per cui<br />
su questa morte (e solo su questa: «di donna Prassede, quando si dice ch’era<br />
morta, è detto tutto») «l’anonimo ha creduto d’estendersi un po’ di più», è spiegata<br />
ironicamente dal “trascrittore”: «trattandosi ch’era stato dotto». Ora Don<br />
Ferrante, ci ha mostrato Raimondi, è un doppio dell’Anonimo: la sua biblioteca<br />
è la stessa dell’Anonimo, e il pastiche dell’Introduzione ha parecchi tratti in<br />
comune, scambi di materiale, con il celebre ragionamento paradossale sulla<br />
peste che conduce Don Ferrante alla morte 39 . Ma il “dotto” che raccoglie<br />
l’Anonimo e Don Ferrante, è a sua volta paradigma polemico del letterato, esce<br />
dalla cornice secentesca 40 per rappresentare più generalmente una funzione, e i<br />
dubbi su di essa. La finzione del manoscritto ritrovato trascina anche i Promessi<br />
sposi nella simbolica dispersione <strong>della</strong> “libreria” del dotto «su per i muriccioli».<br />
6. I fastidi <strong>della</strong> <strong>fine</strong><br />
E siamo giunti all’ultimo capitolo. A piena conferma <strong>della</strong> programmatica<br />
inessenzialità narrativa di questo finale, si tratta di un capitolo del tutto privo di<br />
linea di racconto, costruito non come uno sviluppo trascinante di avvenimenti<br />
(non accade nulla che non sia prevedibile o risaputo o scontato), ma come una<br />
sequenza di frammenti – espositivi o riflessivi – ciascuno dei quali è meramente<br />
giustapposto al seguente mediante un sistematico abbattimento dell’illusione narrativa,<br />
perseguito con continui rinvii alla situazione enunciazionale: «Chi domandasse…»;<br />
«se lo immagini il lettore…»; «Cosa direte ora, sentendo…»;<br />
«Non crediate però…»; «…lo lascio considerare a voi….»; «…vi lascio pensare…»;<br />
«Capisco anch’io che qui ci vuole una spiegazione…»; «E vedete un<br />
poco…»; «Ora sapete com’è...». Volendo analizzarlo compiutamente, potremmo<br />
38 Lo dichiara implicitamente lo stesso narratore, indicando in “due almeno” fra le tre<br />
cose da raccontare quelle che il lettore si aspetta non passino sotto silenzio – è chiaro che si<br />
tratta di Gertrude e di Fra Cristoforo. Cfr. Promessi sposi, ed. cit., p. 723.<br />
39 Cfr. E. RAIMONDI, La radice quadrata del romanzo in <strong>Il</strong> romanzo senza idillio, cit.,<br />
pp. 125-172.<br />
40 Nel Fermo e Lucia una lunga e polemica digressione sulle “idee dominanti”, sulle<br />
“opinioni false e credute”, avvisa che il fenomeno è proprio di tutte le epoche, e che molte<br />
delle più affermate dottrine contemporanee potrebbero avere le stesse caratteristiche di<br />
implausibilità o quanto meno discutibilità dell’aristotelismo e dell’astrologia di Don Ferrante<br />
(cfr. ed. cit., pp. 560-64).<br />
142
<strong>Il</strong> <strong>disincanto</strong> <strong>della</strong> <strong>fine</strong><br />
distinguere tre parti, in ciascuna delle quali la pertinenza al “finale” è sottolineata<br />
attraverso il consueto meccanismo <strong>della</strong> “ripetizione” variata di tratti precedenti.<br />
Nella prima parte la situazione, col ritorno di Lucia, viene riportata al punto<br />
di partenza; e ci si presenta una sorta di replica sdrammatizzata dell’inizio del<br />
romanzo: Don Abbondio è ancora renitente a celebrare il matrimonio, vengono<br />
compiuti vari tentativi per superare le sue resistenze.<br />
C’è poi una parte centrale, con la rimozione degli ultimi ostacoli e il matrimonio.<br />
Anche in questo caso la strategia conclusiva è quella <strong>della</strong> ripetizione di<br />
episodi già accaduti nel “mezzo”, ma a segno (apparentemente) invertito: tutto<br />
ciò che era male sembra diventare bene.<br />
La terza ed ultima parte è l’unica proiettata al futuro, quanto alla storia degli<br />
sposi: la vita matrimoniale, i figli, la sistemazione economica <strong>della</strong> famiglia. Ma<br />
anche qui lo sguardo del narratore è volto all’indietro sull’opera finalmente conclusa:<br />
le sentenze finali sapientemente includono nella morale <strong>della</strong> storia raccontata<br />
una autoironica riflessione sul raccontare.<br />
Aleggia del resto su tutto il capitolo – come mostra la sua stessa costruzione,<br />
fondata sulla dilazione apparentemente oziosa e sul continuo rinvio <strong>della</strong> <strong>fine</strong>,<br />
sulla continua rimessa in causa del carattere lieto di tale <strong>fine</strong> – un dichiarato<br />
“fastidio” del narratore, che lo rovescia sui poveri sposi infliggendo loro inattesi<br />
inconvenienti a turbare la prevista, rituale felicità.<br />
Per azzerare gli sviluppi romanzeschi e consentirsi il gioco <strong>della</strong> ripetizione,<br />
Manzoni spoglia il ritorno di Lucia e il ritrovamento <strong>della</strong> madre e del fidanzato di<br />
ogni pathos affettivo, rimettendo «l’accoglienze vicendevoli…. all’immaginazione<br />
del lettore». Come se nulla fosse accaduto, Lucia è asciuttamente pudibonda nei<br />
confronti di Renzo, e Renzo ne accetta serenamente, anzi allegramente, la reticenza.<br />
La vedova che era stata assistita da Lucia nel lazzaretto «non guasta la compagnia»:<br />
anche lei serve ad annullare le esperienze drammatiche di Lucia, costituendosi nel<br />
suo atteggiamento teneramente protettivo come un doppio di Gertrude, ma affidabile<br />
e “scherzevole”, diversamente dalla drammatica monaca, nel suo maternage.<br />
Così restaurata la scena di inizio romanzo, Manzoni ripete esattamente, in<br />
sintesi, la sequenza degli eventi narrati nei primi capitoli. Di nuovo Renzo va da<br />
Don Abbondio «a prendere i concerti per lo sposalizio», e di nuovo si trova di<br />
fronte alle resistenze reticenti del curato. La ripetizione <strong>della</strong> scena è sottolineata<br />
esplicitamente nel testo: Renzo accenna «tra burlevole e rispettoso» al «mal<br />
di capo» dell’altra volta. Tutto è ovviamente sdrammatizzato: Renzo infatti stavolta<br />
non se la prende troppo, sa che tutto si potrà risolvere; e lo stesso Don<br />
Abbondio non sente il pericolo così imminente. Ma è come se Manzoni non<br />
volesse affrettare l’evento finale, la soluzione miracolosa e lieta: è lui a creare<br />
impicci e difficoltà per ritardare le nozze.<br />
E di nuovo Renzo torna dalle sue donne a riferire l’esito negativo del suo<br />
incontro con Don Abbondio («pareva proprio quello dell’altra volta»). Dopo di<br />
143
Pino Fasano<br />
che, con altri oziosi intermezzi che servono solo ad allungare il racconto (passeggiate<br />
lungo il lago, visita all’ospite di Renzo), partono come nella prima<br />
parte del romanzo le contromosse degli aspiranti sposi. Stavolta Renzo non va a<br />
cercare giustizia da un azzeccagarbugli, ma «se n’andò senza dir dove» – scopriremo<br />
poco dopo che anche in questo caso il giovane cerca una soluzione<br />
“legale”, e sarà l’accertamento <strong>della</strong> morte di Don Rodrigo con la nomina di un<br />
suo «erede per fidecommisso». Nell’attesa le tre donne vanno “all’assalto” di<br />
Don Abbondio, ripetendo in chiave diplomatica e meno aggressiva l’assalto del<br />
matrimonio di sorpresa. Ma anche questo ultimo fallirebbe, di fronte alla ipocrita<br />
strategia difensiva del curato (come si fa, «con quella cattura viva…»): se<br />
non arrivasse attraverso il sacrestano Ambrogio (quello che nella notte degli<br />
imbrogli aveva scatenato lo scampanio di allarme) la conferma <strong>della</strong> morte di<br />
Don Rodrigo, che finalmente tranquillizza il pavido Don Abbondio.<br />
Inizia qui la parte centrale del capitolo, e dovremmo esser finalmente allo<br />
scioglimento. Ma il “furono sposi”, centro di questo centro, è preceduto, accompagnato<br />
e seguito da una serie di eventi insignificanti, chiacchiere oziose, divaganti<br />
riflessioni, che nell’insieme sminuiscono e quasi occultano il lieto <strong>fine</strong><br />
nuziale. C’è innanzi tutto la descrizione dello sblocco di Don Abbondio: una<br />
poco cristiana esplosione di sollievo per la <strong>fine</strong> di Don Rodrigo («Ah! è morto<br />
dunque! È proprio andato!») che dà luogo alla teoria <strong>della</strong> peste-scopa, versione<br />
volgare del provvidenzialismo così spesso imputato dalla critica all’inventore<br />
del personaggio. Mentre se mai abbiamo già qui il segno di una pessimistica<br />
negazione, da parte di Manzoni, <strong>della</strong> possibilità che gli eventi correggano le<br />
viltà e le debolezze dell’uomo. Comunque, bene o male ora Don Abbondio è<br />
pronto a celebrare le nozze; ma di colpo viene introdotta una assurda digressione<br />
che occupa un paio di pagine: il curato, Agnese, la vedova, si imbarcano in<br />
una insensata e slabbrata discussione sul titolo da dare al cardinale arcivescovo<br />
(eminenza, o vossignoria, o monsignore). Difficile capire la motivazione narrativa<br />
di questo inserto, incongruo e sproporzionato anche se volesse segnalare lo<br />
sblocco psicologico dei personaggi, il ritorno al quotidiano, alla chiacchiera<br />
vuota e innocente; se non ci soccorresse il ricordo di un’analoga discussione<br />
con cui questa sembra come al solito ‘far rima’, quella sul “punto di cavalleria”<br />
che nel V capitolo impegna il podestà e il conte Attilio, e su cui Don Rodrigo<br />
chiama a giudice Fra Cristoforo. Anche gli umili dunque – altro segno del pessimismo<br />
manzoniano nascosto nella coda, e non sempre colto dalla tradizione critica<br />
più consolidata – partecipano <strong>della</strong> vuota esteriorità, <strong>della</strong> irrazionalità<br />
disordinata e ridicola del secolo, tutti impegnati come sono – esattamente come<br />
i potenti – a discutere le gerarchie feudali e le regole di precedenza.<br />
In realtà la strategia del finale è fondamentalmente quella del suo allungamento<br />
artificioso: la conversazione con il curato si prolunga in bubbole futili<br />
per un altro paio di pagine; e anche se l’improvvisa “parlantina” di Don Abbondio<br />
ha un’ovvia motivazione nella psicologia del personaggio, ringalluzzito dal-<br />
144
la notizia <strong>della</strong> morte di Don Rodrigo, Manzoni non manca di segnalarcene la<br />
funzione dilatoria rispetto alla <strong>fine</strong> del romanzo: «… saremmo ancor ben lontani<br />
dalla <strong>fine</strong>, se volessimo riferire tutto il rimanente di que’ discorsi…» 41 . Ma bisogna<br />
pur giungere al matrimonio, e al suo significato di vittoria finale del bene<br />
sul male. Manzoni sembra sottomettersi allo schema, persino esagerandolo. <strong>Il</strong><br />
malvagio Don Rodrigo è sostituito da un erede che è il suo perfetto rovescio, e<br />
si presenta a Don Abbondio chiedendo come «si possa far… del bene» ai promessi<br />
sposi; Don Abbondio, che era stato tramite negativo delle perversa<br />
volontà di Don Rodrigo, ora si fa zelante tramite positivo <strong>della</strong> buona volontà<br />
del successore: suggerendo l’acquisto a buon prezzo dei beni immobili degli<br />
sposi, e l’intercessione autorevole per far togliere la “cattura” a Renzo. Qualche<br />
dubbio sulla plausibilità di questa improvvisa disponibilità al bene di tutti i personaggi<br />
per la verità il narratore lo insinua, mettendo in bocca a Don Abbondio<br />
la grottesca invocazione di una peste per ogni generazione. Ma la svalutazione<br />
del lieto <strong>fine</strong> la cogliamo soprattutto nell’enunciazione dell’atto finale, quello<br />
che doveva premiare l’attesa creata da tutte le peripezie <strong>della</strong> narrazione, il<br />
matrimonio: un’enunciazione tanto sbrigativamente elencativa ed asciutta quanto<br />
diffusa, divagante, dilatoria era stata quella delle pagine che la precedono.<br />
Venne la dispensa, venne l’assolutoria, venne quel benedetto giorno: i due promessi andarono,<br />
con sicurezza trionfale, proprio a quella chiesa, dove, proprio per bocca di don<br />
Abbondio, furono sposi 42 .<br />
Certo, un trionfo, il trionfo del bene sul male, con quei due “proprio” a denotare<br />
esplicitamente il rovesciamento positivo delle cose. È la conclusione del<br />
melodramma, con i personaggi che intonano il coro finale. Ma già l’incongruità<br />
di quell’atteggiamento epico per i due contadini scopre una vena ironica e paternalistica;<br />
e il distacco ironico è ancora più evidente nel contrasto fra solennità<br />
conclusiva dell’evento e sua formulazione narrativa: il trionfo è ridotto a due<br />
parole, “furono sposi”. Per confermare e corroborare questo atteggiamento<br />
d’autore, Manzoni narra nel segmento successivo «un altro trionfo, e ben più<br />
singolare»: il banchetto in onore degli sposi offerto dall’erede di Don Rodrigo,<br />
nel suo “palazzotto”. Si tratta, ancora una volta, di una ripetizione (e del resto la<br />
scena del banchetto al castello è un topos ricorrente del romanzo storico), la<br />
ripetizione del “convito” del V capitolo cui, a perorare vanamente la causa degli<br />
sposi promessi, s’era presentato Fra Cristoforo (il quale infatti viene rievocato e<br />
rimpianto, unico mancante «per compir la festa»). Apparentemente, secondo lo<br />
schema del finale “trionfale”, l’episodio rovescia il precedente: non solo il mar-<br />
41 Promessi sposi, ed. cit., p. 736.<br />
42 Promessi sposi, ed. cit., p. 739.<br />
<strong>Il</strong> <strong>disincanto</strong> <strong>della</strong> <strong>fine</strong><br />
145
Pino Fasano<br />
chese erede buono di Don Rodrigo ha favorito, anziché impedire, il matrimonio,<br />
ma la porta del suo palazzo, “quella porta”, quella lugubre porta con due avvoltoi<br />
inchiodati sui battenti che aveva varcato Fra Cristoforo, lì rappresentante<br />
degli “umili”, si spalanca ora in onore degli stessi; e in luogo <strong>della</strong> sprezzante<br />
violenza di Don Rodrigo verso il frate («Escimi di tra’ piedi, villano temerario,<br />
poltrone incappucciato») c’è l’ospitalità generosissima del marchese suo erede:<br />
il quale non solo mette a tavola gli sposi, ma «prima di ritirarsi a pranzare altrove<br />
con don Abbondio, volle star lì un poco a far compagnia agl’invitati, e aiutò<br />
anzi a servirli». Ed è proprio su questa melenso trionfalismo del bene che scocca<br />
la freccia dell’ironia manzoniana:<br />
A nessuno verrà, spero, in testa di dire che sarebbe stata cosa più semplice fare addirittura<br />
una tavola sola. Ve l’ho dato per un brav’uomo, ma non per un originale, come si direbbe ora;<br />
v’ho detto ch’era umile, non già che fosse un portento d’umiltà. N’aveva quanta ne bisognava<br />
per mettersi al di sotto di quella buona gente, ma non per istar loro in pari 43 .<br />
Nobiltà e clero restano separati dal popolo. <strong>Il</strong> miracolo non è avvenuto, i rapporti<br />
economico-sociali sono ancora gli stessi. Con un’attualizzazione assai<br />
significativa in tempi postrivoluzionari Manzoni denuncia in prima persona,<br />
assai prima di molti suoi critici, che l’umiltà cristiana, la sottomissione, è alternativa<br />
alla vera “originalità” (“come si direbbe ora”), quella dell’uguaglianza.<br />
Le nozze, comunque, compiono il percorso memoriale di Renzo: e il «lavoro<br />
<strong>della</strong> [sua] mente» passa in<strong>fine</strong> – siamo alla terza ed ultima parte del capitolo –<br />
dai ricordi ai progetti, ma anche dalla soddisfazione per le difficoltà superate<br />
all’inquietudine per quelle che sopraggiungono. A partire dall’“incomodo” dei<br />
quattrini che si trova in tasca, provento miracoloso di due pentimenti: cinquanta<br />
scudi dell’Innominato destinatigli da Lucia, più il ricavato <strong>della</strong> vendita <strong>della</strong><br />
vigna e <strong>della</strong> casa, generosamente sovrastimate dall’erede di Don Rodrigo. La<br />
ricchezza, finale tipico delle favole, viene immediatamente derubricata a concreto<br />
“impiccio”: già proiettato verso ansie capitalistiche, Renzo si trova di<br />
fronte a difficili decisioni di investimento. E la nuova partenza dell’intera famiglia<br />
verso il Bergamasco, ripetendo il celeberrimo addio ai monti del IX capitolo,<br />
lo spoglia totalmente di patetismo lirico, e fa dell’abbandono dei luoghi natali<br />
un momento di crescita, benché doloroso: il paragone (assegnato prudentemente<br />
all’Anonimo) con lo svezzamento del bambino sembra trasformare per<br />
un attimo i Promessi sposi in un romanzo di formazione.<br />
Per un attimo solo, però. Perché immediatamente Manzoni riprende il dialogo<br />
col lettore per scartare di registro e tornare alla “miserie” che insidiano lo<br />
“stato felice” dei suoi protagonisti, informandoci dei «disgusti bell’e preparati»<br />
che Renzo trova nel paese di destinazione.<br />
146<br />
43 Promessi sposi, ed. cit., p. 740.
<strong>Il</strong> <strong>disincanto</strong> <strong>della</strong> <strong>fine</strong><br />
<strong>Il</strong> parlare che, in quel paese, s’era fatto di Lucia, molto tempo prima che la ci arrivasse; il<br />
saper che Renzo aveva avuto a patir tanto per lei, e sempre fermo, sempre fedele; forse qualche<br />
parola di qualche amico parziale per lui e per tutte le cose sue, avevan fatto nascere una<br />
certa curiosità di veder la giovine, e una certa aspettativa <strong>della</strong> sua bellezza. Ora sapete come<br />
è l’aspettativa: immaginosa, credula, sicura; alla prova poi, difficile, schizzinosa: non trova<br />
mai tanto che le basti, perché, in sostanza, non sapeva quello che si volesse; e fa scontare<br />
senza pietà il dolce che aveva dato senza ragione. Quando comparve questa Lucia, molti i<br />
quali credevan forse che dovesse avere i capelli proprio d’oro, e le gote proprio di rosa, e due<br />
occhi l’uno più bello dell’altro, e che so io? cominciarono a alzar le spalle, ad arricciare il<br />
naso, e a dire: «eh! l’è questa? Dopo tanto tempo, dopo tanti discorsi, s’aspettava qualcosa di<br />
meglio. Cos’è poi? Una contadina come tant’altre. Eh! di queste e delle meglio, ce n’è per<br />
tutto.» Venendo poi a esaminarla in particolare, notavan chi un difetto, chi un altro: e ci furon<br />
fin di quelli che la trovavan brutta affatto 44 .<br />
Questi paesani schierati in attesa di un’eroina tanto fedelmente amata attraverso<br />
disavventure e patimenti rappresentano in certo modo l’aspettativa di<br />
“bellezza” del lettore: ci farebbero pensare a un altro celebre finale, ai cortigiani<br />
schierati sulla banchina del porto a ricevere plaudenti l’arrivo <strong>della</strong> nave ariostesca<br />
del Furioso, se non fossero, diversamente da quelli, delusi. Ancora una volta<br />
Manzoni tematizza obliquamente nel romanzo la sua problematica d’autore.<br />
Rifiutando, certo, la conversione fiabesca <strong>della</strong> sua storia, se si scopre che Lucia<br />
non solo non è una principessa dai capelli d’oro e dalle gote di rosa, ma è una<br />
contadinotta decisamente bruttina. Ma anche rappresentando attraverso il<br />
“disgusto” di Renzo – di malumore, sgarbato, scontento di tutto – il disagio<br />
dello scrittore che vede finalmente realizzata la sua impresa e si scopre al bivio<br />
fra la pressione di orizzonti d’attesa banalmente romanzeschi («V’ho detto mai<br />
che v’avrei menato qui una principessa?» dice Renzo ai «critici di Lucia») e un<br />
isolamento scontroso in cui anch’egli trova «in tutto … da criticare».<br />
A livello dei contenuti espliciti <strong>della</strong> storia, la sliricizzazione, la caduta dell’idillio,<br />
agisce con il brusco trasferimento <strong>della</strong> metamorfosi dei protagonisti<br />
dal livello sentimentale a quello economico. Sciogliendo i suoi dubbi, Renzo di<br />
fronte alla possibilità di investire il suo capitale nell’acquisto a buon prezzo di<br />
un filatoio, si risolve “per l’industria”: e, mutandosi da contadino e operaio in<br />
piccolo imprenditore”, realizza e rispecchia un vero e proprio passaggio<br />
d’epoca 45 , che consente a Manzoni di avviare il suo finale dal romanzo verso la<br />
storia, abbandonando i suoi protagonisti a «una vita delle più tranquille, delle<br />
più felici, delle più invidiabili», e proprio perciò, da non raccontare: «vi secche-<br />
44 Promessi sposi, ed. cit., pp. 742-43.<br />
45 Per questo aspetto del ruolo di Renzo, mi permetto di rinviare a un breve saggio di chi<br />
scrive: P. FASANO, Renzo: il capitale e l’industria, in Letteratura e industria. Atti del XV<br />
Congresso A.I.S.L.L.I., a c. di G. Bàrberi Squarotti e C. Ossola, Firenze, Olschki, 1997,<br />
pp. 275-82.<br />
147
Pino Fasano<br />
rebbe a morte». Toccherà ancora a Renzo, nelle pagine finali del romanzo, ripetere<br />
per l’ultima volta la propria storia («<strong>Il</strong> bello era a sentirlo raccontare le sue<br />
avventure») e tentare di cavarne una “dottrina” che ne garantisca l’utilità didascalica:<br />
una dottrina astensionista e immobilista (non bisogna andare in cerca di<br />
guai) che Lucia contesta soavemente, e che conduce entrambi a trovare, al di là<br />
delle responsabilità individuali, nell’utilità delle sofferenze se addolcite dalla<br />
fiducia in Dio, “il sugo di tutta la storia”.<br />
Ma “questa conclusione” <strong>della</strong> storia raccontata, necessariamente condivisa<br />
dal cristiano Manzoni, lascia aperti i dubbi sul racconto, sulla storia in sé.<br />
La quale, se non v’è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l’ha scritta, e anche un<br />
pochino a chi l’ha raccomodata. Ma se in vece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non<br />
s’è fatto apposta 46 .<br />
Se non è veramente “trionfale” nemmeno il finale dell’enunciato, punteggiato<br />
da “fastidiucci” e impicci sino all’ultimo, tanto meno lo è il finale dell’enunciazione.<br />
L’inchino finale al pubblico affida al benevolo lettore il successo dell’impresa:<br />
il dubbio d’avere annoiato è recitato secondo i canoni <strong>della</strong> captatio<br />
benevolentiae teatrale; e tuttavia non può essere senza significato che il libro si<br />
chiuda nel segno <strong>della</strong> noia, con un autoironico scarico di responsabilità («Non<br />
s’è fatto apposta») che segna la resa dell’autore, e la <strong>fine</strong>, assai più che del suo<br />
romanzo, <strong>della</strong> sua carriera di romanziere.<br />
148<br />
46 Promessi sposi, ed. cit., p. 746.