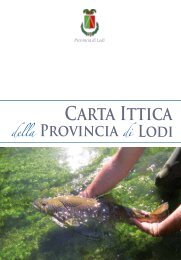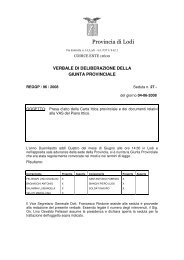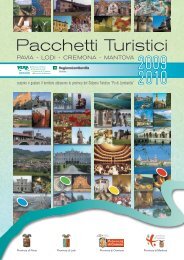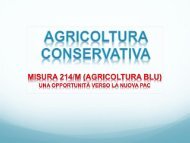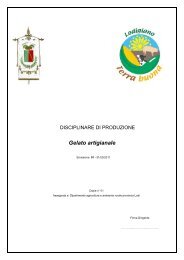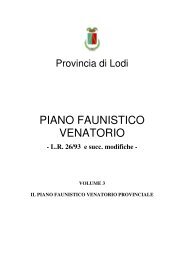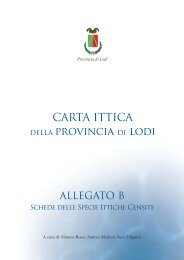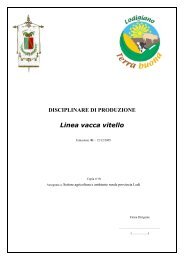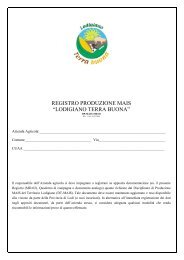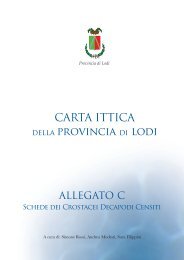B_specie alloctone - Provincia di Lodi
B_specie alloctone - Provincia di Lodi
B_specie alloctone - Provincia di Lodi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
30. Storione esotico<br />
Acipenser sp.<br />
108 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite<br />
(foto Clau<strong>di</strong>o Flamini)
La frequente introduzione <strong>di</strong> soggetti <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse <strong>specie</strong> <strong>di</strong> storione (genere Acipenser) all’interno<br />
dei Centri Privati <strong>di</strong> Pesca determina accidentalmente l’arrivo <strong>di</strong> qualche esemplare nel<br />
sistema idrico esterno ai Centri: la maggior parte delle <strong>specie</strong> introdotte è origine alloctona<br />
e può pertanto determinare squilibri nel popolamento ittico. In tal senso è da ritenersi negativo<br />
il rinvenimento nel tratto terminale del fiume Adda <strong>di</strong> un soggetto esotico <strong>di</strong> storione, la<br />
cui determinazione specifica non è stata possibile dall’esame del solo materiale fotografico;<br />
tale cattura è avvenuta nel 2006.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 109
31. Salmerino <strong>di</strong> Fonte<br />
Salvelinus fontinalis<br />
110 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Il salmerino <strong>di</strong> fonte è una <strong>specie</strong> esotica <strong>di</strong> origine americana introdotta in Italia a cavallo<br />
tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Nel territorio lo<strong>di</strong>giano la sua presenza, accertata<br />
nel colo Mortone, è legata esclusivamente a passate immissioni pronta pesca. La fuga<br />
<strong>di</strong> qualche soggetto da tale ambiente può occasionalmente determinarne il rinvenimento<br />
nelle a<strong>di</strong>acenti porzioni del fiume Adda (comune <strong>di</strong> Boffalora d’Adda). La <strong>specie</strong> non è in<br />
grado <strong>di</strong> riprodursi nelle acque lo<strong>di</strong>giane, per cui la sua presenza è legata esclusivamente alle<br />
introduzioni operate dall’uomo.<br />
Le maggiori problematiche connesse alla presenza della <strong>specie</strong> sono legate al rischio <strong>di</strong> trasmissione<br />
<strong>di</strong> patologie ai salmoni<strong>di</strong> in<strong>di</strong>geni (trota marmorata e temolo) e all’aumentata<br />
probabilità <strong>di</strong> predazione a carico dei pesci autoctoni <strong>di</strong> piccola taglia.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 111
32. Trota Fario<br />
Salmo (trutta) trutta<br />
112 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
La trota fario è una <strong>specie</strong> che, pur essendo autoctona in alcune regioni italiane, è tuttavia<br />
considerata da molti Autori esotica all’interno del <strong>di</strong>stretto padano; tale ipotesi è a maggior<br />
ragione valida nelle acque lo<strong>di</strong>giane, se si tiene conto che i soggetti <strong>di</strong> trota fario rinvenibili<br />
appartengono a ceppi d’oltralpe.<br />
La <strong>specie</strong>, sempre occasionale, è stata segnalata anche recentemente (fine 2007) nel tratto<br />
superiore dell’Adda e nelle porzioni terminali <strong>di</strong> alcuni fontanili ad esso collegati. Tale presenza<br />
è presumibilmente dovuta alla deriva verso valle <strong>di</strong> soggetti provenienti dalle zone site<br />
più a monte o dal Brembo; non è da escludere inoltre la possibile provenienza dal Centro<br />
Privato <strong>di</strong> Pesca “Il Mortone” (comune <strong>di</strong> Zelo Buon Persico), che in passato ha effettuato<br />
immissioni <strong>di</strong> trote fario. Di altra origine è il rinvenimento <strong>di</strong> un soggetto nel fiume Po a valle<br />
dell’immissione del Lambro: tale in<strong>di</strong>viduo è probabilmente oggetto <strong>di</strong> deriva naturale dai<br />
corsi appenninici fiume Trebbia e torrente Nure.<br />
La principale problematica legata alla presenza della trota fario nelle acque lo<strong>di</strong>giane è<br />
dovuta alla possibilità <strong>di</strong> ibridazione, con conseguente inquinamento genetico, con soggetti<br />
appartenenti alle popolazioni locali <strong>di</strong> trota marmorata.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 113
33. Trota Iridea<br />
Oncorhynchus mykiss<br />
114 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
La trota iridea è una <strong>specie</strong> esotica <strong>di</strong> origine americana introdotta in Italia a cavallo tra la<br />
fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Nel territorio lo<strong>di</strong>giano la sua presenza è legata esclusivamente<br />
ad immissioni “pronta pesca”, in quanto la <strong>specie</strong> non è in grado <strong>di</strong> riprodursi<br />
nelle acque lo<strong>di</strong>giane.<br />
Risulta presente nelle porzioni lentiche del colo Mortone e dell’Adda Vecchia oltre che, nei<br />
mesi successivi all’apertura della pesca alla trota, nel tratto lo<strong>di</strong>giano dell’Adda. Qualche<br />
soggetto, frutto <strong>di</strong> passate pratiche <strong>di</strong> semina, è occasionalmente censito nel sistema dei<br />
fontanili dell’Oltreadda.<br />
Le maggiori problematiche connesse alla presenza della <strong>specie</strong> sono da ricercarsi nel rischio<br />
<strong>di</strong> trasmissione <strong>di</strong> patologie ai salmoni<strong>di</strong> in<strong>di</strong>geni (trota marmorata e temolo) e nell’aumentata<br />
probabilità <strong>di</strong> predazione a carico dei pesci autoctoni <strong>di</strong> piccola taglia.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 115
34. Abramide<br />
Abramis brama<br />
116 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
L’abramide è una <strong>specie</strong> esotica <strong>di</strong> provenienza transalpina, recentemente introdotta in<br />
Italia. È presente in 9 dei 159 punti <strong>di</strong> monitoraggio (5,7% del totale), risultando pari allo<br />
0,6% dei pesci complessivamente conteggiati.<br />
Colonizza con successo molti ambienti lentici, e spiccano a proposito le elevate densità<br />
raggiunte all’interno della lanca <strong>di</strong> Soltarico; è <strong>di</strong>ffuso inoltre nel Po, nel tratto terminale <strong>di</strong><br />
Adda e Lambro e si rinviene saltuariamente anche in emissari <strong>di</strong> acque lentiche e nelle porzioni<br />
terminali della rete <strong>di</strong> bonifica. Pur non catturata durante i monitoraggi, l’abramide è<br />
sicuramente segnalata nell’Adda già a partire da Comazzo e nella Muzza a valle della centrale<br />
termoelettrica <strong>di</strong> Tavazzano-Montanaso. La <strong>specie</strong>, tipicamente potamale, colonizza<br />
<strong>di</strong>fferenti tipologie <strong>di</strong> substrato con pre<strong>di</strong>lezione per le porzioni più fini, pur necessitando ai<br />
fini riproduttivi <strong>di</strong> zone con ghiaia; è molto selettiva nei confronti della velocità <strong>di</strong> corrente,<br />
che in genere risulta nulla o molto bassa; è poco sensibile nei confronti dell’aumento dei<br />
valori <strong>di</strong> torbi<strong>di</strong>tà, che anzi potrebbero fornire un vantaggio selettivo nei confronti <strong>di</strong> altre<br />
<strong>specie</strong>.<br />
In assenza <strong>di</strong> fattori limitanti, l’abramide è in grado <strong>di</strong> costituire popolazioni aventi densità<br />
talora elevatissime, con danno anche consistente alle <strong>specie</strong> autoctone simpatriche.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 117
Abbondanza relativa nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento con le <strong>di</strong>fferenti tipologie <strong>di</strong> substrato.<br />
118 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> corrente.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> trasparenza dell’acqua.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 119
35. Aspio<br />
Aspius aspius<br />
120 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
L’aspio è una <strong>specie</strong> esotica <strong>di</strong> provenienza est europea recentemente introdotta in Italia. È<br />
presente in 5 dei 159 punti <strong>di</strong> monitoraggio (3,1% del totale), risultando pari allo 0,2% dei<br />
pesci complessivamente conteggiati. È attualmente <strong>di</strong>ffuso lungo il corso principale del Po,<br />
nel tratto terminale dell’Adda (fino alla briglia <strong>di</strong> Maleo) e lungo il corso del Lambro, fino<br />
a Sant’Angelo Lo<strong>di</strong>giano; le maggiori densità si rinvengono nelle porzioni meri<strong>di</strong>onali della<br />
provincia. La <strong>specie</strong>, tipicamente potamale, potrebbe rapidamente espandersi verso monte<br />
a danno <strong>di</strong> molte <strong>specie</strong> autoctone: occorre tener presente che l’aspio è un vorace predatore,<br />
che quin<strong>di</strong> può incidere in modo rilevante sulla struttura trofica degli ecosistemi acquatici.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Abbondanza relativa nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 121
36. Barbo d’Oltralpe<br />
Barbus barbus<br />
122 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Il barbo d’oltralpe è una <strong>specie</strong> esotica proveniente dall’Europa continentale e recentemente<br />
introdotta in Italia, che in breve tempo ha colonizzato le porzioni inferiori del territorio provinciale.<br />
È presente in 21 dei 159 punti <strong>di</strong> monitoraggio (13,2% del totale), risultando pari<br />
all’1,4% dei pesci complessivamente conteggiati.<br />
È in grado <strong>di</strong> raggiungere densità molto elevate lungo il Po e nel tratto terminale degli affluenti,<br />
risultando in espansione verso monte anche lungo il Lambro e nella rete <strong>di</strong> bonifica.<br />
È per il momento occasionale in corpi idrici minori del sistema inferiore della Muzza e nel<br />
tratto terminale <strong>di</strong> qualche fontanile. Pur non segnalato <strong>di</strong>rettamente lungo l’asta principale,<br />
è probabile che il barbo d’oltralpe sia già presente anche nella porzione <strong>di</strong> Adda a valle <strong>di</strong><br />
Lo<strong>di</strong>. La <strong>specie</strong>, tipicamente potamale e ad elevata euriecìa, sembrerebbe in grado <strong>di</strong> colonizzare<br />
con successo <strong>di</strong>fferenti tipologie <strong>di</strong> substrato, tratti con variabili velocità <strong>di</strong> corrente<br />
(ad esclusione delle acque lentiche) e corpi idrici con torbi<strong>di</strong>tà anche molto elevata. Non<br />
parrebbe inoltre particolarmente sensibile nei confronti delle alterazioni idroqualitative.<br />
La progressiva espansione del barbo d’oltralpe desta forti preoccupazioni, in quanto la <strong>specie</strong><br />
ha probabilmente già determinato l’estinzione locale del barbo comune nel fiume Po e<br />
nel tratto terminale dei suoi principali affluenti (Adda e Lambro) ed è presumibilmente tra<br />
i principali responsabili della rarefazione delle <strong>specie</strong> reofile lungo le porzioni potamali del<br />
territorio provinciale, a seguito <strong>di</strong> meccanismi <strong>di</strong> predazione (su uova e sta<strong>di</strong> giovanili) e/o<br />
competizione. Il posizionamento <strong>di</strong> grossi branchi <strong>di</strong> barbi d’oltralpe nelle aree <strong>di</strong> deposizione<br />
determinerebbe infatti uno scarso successo riproduttivo per molte <strong>specie</strong> autoctone.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 123
Abbondanza relativa nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento con le <strong>di</strong>fferenti tipologie <strong>di</strong> substrato.<br />
124 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> corrente.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> trasparenza dell’acqua.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 125
37. Carassio<br />
Carassius sp.<br />
126 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Il carassio è stato introdotto in Italia nel corso del XVII secolo. Delle due <strong>specie</strong> <strong>di</strong> carassio,<br />
entrambe <strong>di</strong> provenienza presumibilmente asiatica e/o est europea, era in passato considerato<br />
prevalente il Carassius carassius; ad oggi tuttavia sembrano ampiamente <strong>di</strong>ffuse anche<br />
le popolazioni <strong>di</strong> Carassius auratus. Poiché la determinazione specifica si effettua me<strong>di</strong>ante<br />
conteggio del numero <strong>di</strong> branchiospine del primo arco branchiale e non è pertanto eseguibile<br />
me<strong>di</strong>ante semplice analisi dei caratteri esterni, si considerano i carassi catturati come<br />
Carassius sp., rimandando gli ulteriori approfon<strong>di</strong>menti a futuri stu<strong>di</strong>. Presente in 95 dei 159<br />
punti <strong>di</strong> monitoraggio (59,7% del totale), risulta pari al 3,5% dei pesci complessivamente<br />
conteggiati.<br />
Ampiamente <strong>di</strong>ffuso ed in grado <strong>di</strong> raggiungere elevate densità nel me<strong>di</strong>o corso del Lambro,<br />
è <strong>specie</strong> tipica delle lanche, delle morte e dei loro emissari ed immissari; è facilmente rinvenibile<br />
anche nei corsi minori della rete <strong>di</strong> bonifica e nel tratto inferiore della Muzza. Pur<br />
presente in tutte le tipologie funzionali, è spora<strong>di</strong>co nell’Adda, nel sistema superiore della<br />
Muzza e nella rete dei fontanili, mentre mostra una decisa contrazione delle densità lungo<br />
il Po e nel tratto terminale dei suoi principali affluenti, presumibilmente a causa della predazione<br />
e della competizione esercitata da <strong>specie</strong> <strong>alloctone</strong> <strong>di</strong> più recente introduzione. Dal<br />
punto <strong>di</strong> vista delle preferenze ambientali il carassio, pur in grado <strong>di</strong> colonizzare <strong>di</strong>fferenti<br />
tipi <strong>di</strong> habitat, sembra pre<strong>di</strong>ligere acque a substrato fine, con deflusso da nullo a moderato<br />
e con acqua relativamente torbida. Tali con<strong>di</strong>zioni, frequenti in corsi con alterazione del<br />
profilo idroqualitativo, sono penalizzanti per le <strong>specie</strong> più sensibili e possono favorire gli<br />
in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> carassio per riduzione dei fenomeni <strong>di</strong> competizione.<br />
Considerato un flagello negli anni ’80 del XX secolo per la tendenza a cibarsi delle uova<br />
delle altre <strong>specie</strong>, il carassio è oggi stabile o ad<strong>di</strong>rittura in declino all’interno del territorio<br />
provinciale.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 127
Abbondanza relativa nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento con le <strong>di</strong>fferenti tipologie <strong>di</strong> substrato.<br />
128 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> corrente.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> trasparenza dell’acqua.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 129
38. Carpa<br />
Cyprinus carpio<br />
130 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
La carpa, <strong>di</strong> provenienza asiatica, è stata introdotta in Italia in epoca romana. La <strong>specie</strong> è<br />
presente in 88 dei 159 punti <strong>di</strong> monitoraggio (55,3% del totale), risultando pari al 2,3% dei<br />
pesci complessivamente conteggiati.<br />
Risulta ben <strong>di</strong>stribuita, talvolta con abbondanze relative elevate, nel reticolo colatizio inferiore<br />
(canali <strong>di</strong> bonifica e corpi idrici del sistema inferiore della Muzza), nel Lambro e nel<br />
Po. È quasi sempre presente, pur con densità variabili, nelle acque lentiche e nei relativi<br />
emissari ed immissari; è viceversa meno frequente nell’Adda, nei fontanili e nel sistema<br />
superiore della Muzza. Dal punto <strong>di</strong> vista delle preferenze ambientali la <strong>specie</strong>, limnofila,<br />
sembra pre<strong>di</strong>ligere acque con substrati fini, a lento decorso e con acqua relativamente torbida.<br />
In tali situazioni le popolazioni <strong>di</strong> carpa apparirebbero in aumento, presumibilmente<br />
a causa della ridotta competizione esercitata dalle <strong>specie</strong> autoctone.<br />
L’avvento delle unità esotiche <strong>di</strong> recente introduzione, con particolare riferimento al siluro,<br />
sembrerebbe aver in qualche modo favorito l’espansione della <strong>specie</strong>, contribuendo tuttavia<br />
ad una destrutturazione delle sue popolazioni, con presenza quasi esclusiva <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui<br />
adulti.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 131
Abbondanza relativa nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento con le <strong>di</strong>fferenti tipologie <strong>di</strong> substrato.<br />
132 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> corrente.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> trasparenza dell’acqua.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 133
39. Carpa Erbivora (Amur)<br />
Ctenopharyngodon idellus<br />
134 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
La carpa erbivora, originaria del continente asiatico, è una <strong>specie</strong> esotica introdotta in Italia<br />
negli anni ‘70 del XX secolo. Non essendo in grado <strong>di</strong> riprodursi spontaneamente nelle<br />
acque italiane, la sua presenza è legata ad eventuali attività <strong>di</strong> semina.<br />
È attualmente segnalata, pur in regressione, nel punto <strong>di</strong> immissione dello scolmatore Belgiar<strong>di</strong>no<br />
nel fiume Adda (comune <strong>di</strong> Montanaso Lombardo), nella lanca <strong>di</strong> Soltarico e nelle<br />
porzioni lentiche dell’Adda Vecchia (comune <strong>di</strong> Zelo Buon Persico). Alcuni anni fa era inoltre<br />
stata censita nella “Morta del Faro” a Lo<strong>di</strong>, all’interno della quale ha creato <strong>di</strong>verse problematiche<br />
alle <strong>specie</strong> presenti a causa della rimozione delle piante acquatiche preesistenti,<br />
che risultavano fondamentali sia per la riproduzione che come aree trofiche e <strong>di</strong> rifugio.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 135
40. Pseudorasbora<br />
Pseudorasbora parva<br />
136 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
La pseudorasbora è una <strong>specie</strong> esotica <strong>di</strong> origine asiatica recentemente introdotta in Italia,<br />
che in breve tempo ha colonizzato la maggior parte dei corpi idrici del territorio provinciale.<br />
È presente in 94 dei 159 punti <strong>di</strong> monitoraggio (59,1% del totale), risultando pari all’8,1%<br />
dei pesci complessivamente conteggiati.<br />
È molto <strong>di</strong>ffusa, raggiungendo densità talvolta elevate, nella rete <strong>di</strong> bonifica della bassa<br />
lo<strong>di</strong>giana, nel Lambro, nelle acque lentiche (con i relativi emissari ed immissari), nei corpi<br />
idrici del sistema inferiore della Muzza e nel Po (compresi i tratti terminali dei principali<br />
affluenti). Presente anche nelle altre tipologie <strong>di</strong> corso non citate, mostra qualche <strong>di</strong>fficoltà<br />
<strong>di</strong> adattamento nelle acque a prevalente carattere sorgivo, risultando inoltre assente dai<br />
monitoraggi eseguiti nella porzione superiore dell’Adda; in questi ultimi tratti la <strong>specie</strong> è<br />
stata recentemente (2006) segnalata con certezza, pur risultando occasionale. La pseudorasbora,<br />
tipicamente potamale ed euriecia, sembrerebbe in grado <strong>di</strong> colonizzare con successo<br />
<strong>di</strong>fferenti tipologie ambientali, con pre<strong>di</strong>lezione per i corpi idrici con fondo costituito da<br />
fango e/o sabbia, a lento decorso e con acque torbide. Le maggiori densità sono raggiunte<br />
nei piccoli corsi, nei quali i rischi predatori risultano inferiori; il principale fattore limitante<br />
sembrerebbe legato alla temperatura dell’acqua, che se eccessivamente fredda non consentirebbe<br />
un adeguato successo riproduttivo.<br />
L’espansione della pseudorasbora è da ritenersi grave, in quanto la <strong>specie</strong> è <strong>di</strong>retta competitrice<br />
<strong>di</strong> <strong>specie</strong> autoctone gregarie quali il triotto, la scardola e l’alborella; può inoltre<br />
veicolare importanti patologie nei popolamenti locali.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 137
Abbondanza relativa nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento con le <strong>di</strong>fferenti tipologie <strong>di</strong> substrato.<br />
138 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> corrente.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> trasparenza dell’acqua.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 139
41. Rodeo Amaro<br />
Rhodeus amarus<br />
140 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Il rodeo amaro, <strong>specie</strong> esotica <strong>di</strong> provenienza est europea recentemente introdotta in Italia,<br />
in breve tempo ha colonizzato la maggior parte dei corpi idrici del territorio provinciale. È<br />
presente in 112 dei 159 punti <strong>di</strong> monitoraggio (70,4% del totale), risultando pari all’8,4%<br />
dei pesci complessivamente conteggiati.<br />
È costantemente presente nella rete <strong>di</strong> bonifica della bassa lo<strong>di</strong>giana e più in generale nel<br />
reticolo colatizio minore, nel Po (compresi i tratti terminali dei principali affluenti), nelle<br />
lanche e nelle morte (con relativi immissari ed emissari), nel sistema della Muzza e nel tratto<br />
inferiore dell’Adda. È meno frequente nel Lambro, nel tratto superiore dell’Adda e nei<br />
corsi a prevalente carattere sorgivo. Il rodeo amaro pre<strong>di</strong>lige corpi idrici con prevalenza<br />
della componente sabbiosa, associata a fango o ghiaia. Pur presente in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni<br />
<strong>di</strong> corrente, è <strong>di</strong> rinvenimento più probabile nelle acque a lento decorso. Trae vantaggio<br />
selettivo (per riduzione della competizione e/o della predazione operate da altre <strong>specie</strong>)<br />
dall’aumento dei valori <strong>di</strong> torbi<strong>di</strong>tà dell’acqua.<br />
L’espansione del rodeo amaro potrebbe determinare problemi alle <strong>specie</strong> autoctone a seguito<br />
dell’instaurarsi <strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong> competizione.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 141
Abbondanza relativa nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento con le <strong>di</strong>fferenti tipologie <strong>di</strong> substrato.<br />
142 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> corrente.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> trasparenza dell’acqua.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 143
42. Rutilo (Gardon)<br />
Rutilus rutilus<br />
144 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Il rutilo (o gardon) è una <strong>specie</strong> esotica d’oltralpe la cui introduzione è recente in Italia. È<br />
stata segnalata a partire dal 2006 nelle acque lo<strong>di</strong>giane, essendo stata censita nel colatore<br />
Muzza e quasi contemporaneamente nel tratto terminale dell’Adda a Castelnuovo Bocca<br />
d’Adda. È inoltre sicuramente presente lungo l’asta principale del fiume Po. Tra le problematiche<br />
legate alla presenza del rutilo, oltre all’instaurarsi <strong>di</strong> meccanismi <strong>di</strong> competizione<br />
con le <strong>specie</strong> locali, vi è il rischio <strong>di</strong> ibridazione con le <strong>specie</strong> autoctone del genere Rutilus,<br />
ossia pigo e triotto.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 145
43. Misgurno (Cobite <strong>di</strong> Stagno Orientale)<br />
Misgurnus anguillicaudatus<br />
146 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Il misgurno, o cobite <strong>di</strong> stagno orientale, è una <strong>specie</strong> esotica <strong>di</strong> provenienza asiatica recentemente<br />
introdotta in Italia e che in breve tempo ha colonizzato le porzioni inferiori del<br />
territorio provinciale. È presente in 16 dei 159 punti <strong>di</strong> monitoraggio (10,1% del totale),<br />
risultando pari all’1,1% dei pesci complessivamente conteggiati.<br />
Diffusosi presumibilmente a partire dal Po, trova le con<strong>di</strong>zioni ideali <strong>di</strong> sviluppo nei corpi<br />
minori della rete <strong>di</strong> bonifica della bassa lo<strong>di</strong>giana, all’interno dei quali può raggiungere densità<br />
rilevanti. È presente, pur con numerosità ridotte, lungo l’asta principale del Lambro; ha<br />
inoltre raggiunto le risorgive <strong>di</strong> terrazzo presenti nei pressi del bosco della Riserva Naturale<br />
<strong>di</strong> Monticchie (comune <strong>di</strong> Somaglia). L’assenza del misgurno nelle altre tipologie funzionali<br />
è presumibilmente solo temporanea: è probabile, nel tempo, che il misgurno riesca<br />
ad espandersi verso monte, favorito dalla relativa resilienza nei confronti delle alterazioni<br />
idroqualitative.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista delle preferenze ambientali, il misgurno si rinviene su substrati soffici (fangosi<br />
in prevalenza), con flussi <strong>di</strong> corrente da molto lenti a me<strong>di</strong> e con torbi<strong>di</strong>tà delle acque<br />
da moderate ad elevate.<br />
La progressiva espansione del misgurno desta forti preoccupazioni a causa della competizione<br />
<strong>di</strong>retta con il cobite comune e con il più raro cobite mascherato, in virtù della relativa<br />
voracità della <strong>specie</strong>, in grado <strong>di</strong> predare uova e/o avannotti e a causa della tendenza a costituire<br />
popolazioni molto numerose, che sottraggono spazio e cibo ai taxa autoctoni.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 147
Abbondanza relativa nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento con le <strong>di</strong>fferenti tipologie <strong>di</strong> substrato.<br />
148 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> corrente.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> trasparenza dell’acqua.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 149
44. Acerina<br />
Gymnocephalus cernuus<br />
150 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
L’acerina è una <strong>specie</strong> esotica <strong>di</strong> provenienza est europea recentemente introdotta in Italia.<br />
Segnalata verso la fine degli anni ’90 del secolo scorso nella Morta del Faro a Lo<strong>di</strong>, è attualmente<br />
presente con certezza nella porzione <strong>di</strong> fiume Adda limitrofa a tale sito. La sua<br />
introduzione è da ritenersi accidentale ed è probabilmente legata ad una contaminazione <strong>di</strong><br />
lotti da ripopolamento <strong>di</strong> persico reale. La <strong>specie</strong> ad oggi sembra acclimatata nel territorio<br />
provinciale, pur rimanendo estremamente localizzata.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 151
45. Lucioperca<br />
Sander lucioperca<br />
152 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Il lucioperca è una <strong>specie</strong> esotica proveniente dall’Europa continentale, introdotta in Italia<br />
(lago <strong>di</strong> Comabbio) nel 1902 e il cui arrivo all’interno del territorio della provincia <strong>di</strong> Lo<strong>di</strong><br />
è tuttavia da ritenersi temporalmente molto più vicino; la stessa è pertanto considerata tra<br />
le <strong>specie</strong> <strong>alloctone</strong> <strong>di</strong> recente introduzione. È presente in 7 dei 159 punti <strong>di</strong> monitoraggio<br />
(4,4% del totale) risultando pari allo 0,1% dei pesci complessivamente conteggiati.<br />
Diffuso nel Po e nei tratti terminali <strong>di</strong> Adda e Lambro, il lucioperca è recentemente segnalato<br />
con densità in incremento nel tratto <strong>di</strong> Adda nei pressi <strong>di</strong> Lo<strong>di</strong>, a valle della briglia <strong>di</strong><br />
Bisnate e nei pressi dell’immissione dello scolmatore Belgiar<strong>di</strong>no. Recente è anche la cattura<br />
<strong>di</strong> un soggetto giovane nella roggia Ghisella (Borghetto Lo<strong>di</strong>giano), affluente <strong>di</strong>retto del<br />
Lambro, ad in<strong>di</strong>care la presunta presenza della <strong>specie</strong> lungo l’asta principale dello stesso. Il<br />
lucioperca può inoltre essere presente in acque lentiche tra le quali è possibile citare la lanca<br />
<strong>di</strong> Soltarico. Dal punto <strong>di</strong> vista idroqualitativo, la <strong>specie</strong> non sembrerebbe particolarmente<br />
esigente. La progressiva espansione del lucioperca costituisce una grave minaccia per le <strong>specie</strong><br />
autoctone, dato il ruolo <strong>di</strong> predatore e il comportamento gregario che lo caratterizzano.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Abbondanza relativa nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 153
46. Persico Sole<br />
Lepomis gi bosus<br />
154 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Il persico sole è una <strong>specie</strong> esotica <strong>di</strong> provenienza americana introdotta in Italia tra la fine<br />
del XIX e l’inizio del XX secolo. È presente in 45 dei 159 punti <strong>di</strong> monitoraggio (28,3% del<br />
totale), risultando pari all’1,5% dei pesci complessivamente conteggiati.<br />
Ubiquitaria e molto abbondante nelle acque lentiche e nei relativi immissari ed emissari, la<br />
<strong>specie</strong> è <strong>di</strong>scretamente rappresentata lungo l’asta principale dell’Adda, pur con numerosità<br />
ridotte; è più rara nel sistema della Muzza (ad eccezione del canale principale in cui si rinviene<br />
comunemente) e nei corsi a prevalente carattere sorgivo, mentre è pressoché assente<br />
nel Lambro e nella rete <strong>di</strong> bonifica della bassa lo<strong>di</strong>giana. Dal punto <strong>di</strong> vista delle preferenze<br />
ambientali la <strong>specie</strong>, pur essendo più frequente in corsi con fondo fangoso, necessita obbligatoriamente<br />
<strong>di</strong> porzioni ghiaiose a livello delle quali deporre le uova. È in grado <strong>di</strong> colonizzare<br />
siti con velocità <strong>di</strong> corrente da nulle (preferite) a molto veloci, in quest’ultimo caso<br />
occupando le porzioni marginali dell’alveo bagnato, a deflusso più lento. Anche in merito<br />
alla trasparenza delle acque non emergono esigenze particolari; occorre a proposito tener<br />
conto che il persico sole ama collocarsi a profon<strong>di</strong>tà ridotte, a livello delle quali la visibilità<br />
è quasi sempre accettabile.<br />
La <strong>di</strong>stribuzione attuale del persico sole in provincia <strong>di</strong> Lo<strong>di</strong> è relativamente stabile, mostrando<br />
anzi alcuni segni <strong>di</strong> regressione nei siti con maggiore alterazione idroqualitativa e in<br />
quelli caratterizzati dalla rapida espansione <strong>di</strong> <strong>specie</strong> <strong>alloctone</strong> <strong>di</strong> recente introduzione. Nelle<br />
acque lentiche risulta tuttavia ancora infestante, tanto da limitare fortemente lo sviluppo<br />
<strong>di</strong> <strong>specie</strong> autoctone a causa della massiccia predazione <strong>di</strong> uova e avannotti.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 155
Abbondanza relativa nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento con le <strong>di</strong>fferenti tipologie <strong>di</strong> substrato.<br />
156 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> corrente.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> trasparenza dell’acqua.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 157
47. Persico Trota<br />
Micropterus salmoides<br />
158 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Il persico trota è una <strong>specie</strong> esotica <strong>di</strong> provenienza americana introdotta in Italia nel 1898.<br />
È presente in 19 dei 159 punti <strong>di</strong> monitoraggio (11,9% del totale), risultando pari allo 0,2%<br />
dei pesci complessivamente conteggiati.<br />
È <strong>di</strong>ffuso con buona frequenza e con <strong>di</strong>screte densità nelle acque lentiche, colonizzando<br />
anche i relativi immissari ed emissari e le limitrofe aste fluviali; è inoltre rinvenibile in alcuni<br />
corsi del sistema inferiore della Muzza. Dal punto <strong>di</strong> vista delle preferenze ambientali la<br />
<strong>specie</strong>, pur essendo più frequente in corsi con fondo fangoso, necessita obbligatoriamente<br />
<strong>di</strong> porzioni ghiaiose a livello delle quali deporre le uova. Pre<strong>di</strong>lige corpi idrici con acqua<br />
ferma o a lento deflusso, anche se può occasionalmente occupare porzioni lotiche. In merito<br />
ai valori <strong>di</strong> trasparenza, non emergono esigenze particolari: la caccia esercitata in superficie<br />
consente un’efficace predazione anche in siti con acque decisamente torbide.<br />
La <strong>di</strong>stribuzione attuale del persico trota nel territorio provinciale è relativamente stabile,<br />
mostrando anzi alcuni segni <strong>di</strong> regressione nei siti caratterizzati dalla rapida espansione <strong>di</strong><br />
<strong>specie</strong> <strong>alloctone</strong> <strong>di</strong> recente introduzione. Nelle acque lentiche può tuttavia costituire una<br />
minaccia, in quanto è in grado <strong>di</strong> competere con il luccio e <strong>di</strong> predarne gli sta<strong>di</strong> giovanili, e<br />
<strong>di</strong> ridurre le percentuali <strong>di</strong> reclutamento dei ciprini<strong>di</strong> autoctoni.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 159
Abbondanza relativa nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento con le <strong>di</strong>fferenti tipologie <strong>di</strong> substrato.<br />
160 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> corrente.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> trasparenza dell’acqua.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 161
48. Pesce Gatto<br />
Ameiurus melas<br />
162 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Il pesce gatto è una <strong>specie</strong> esotica originaria del continente americano, introdotta in Italia<br />
all’inizio del XX secolo. È presente in 21 dei 159 punti <strong>di</strong> monitoraggio (13,2% del totale),<br />
risultando pari allo 0,5% dei pesci complessivamente conteggiati.<br />
Si rinviene con frequenze elevate negli emissari e negli immissari <strong>di</strong> acque lentiche ed in<br />
parte degli specchi principali <strong>di</strong> lanche e morte, mentre risulta presente con minore frequenza<br />
nella rete colatizia inferiore. Dal punto <strong>di</strong> vista delle preferenze ambientali la <strong>specie</strong>,<br />
limnofila, pre<strong>di</strong>lige corsi a substrato sabbioso e/o fangoso, colonizzando siti con velocità <strong>di</strong><br />
corrente variabili e con torbi<strong>di</strong>tà anche elevata.<br />
La <strong>di</strong>stribuzione attuale del pesce gatto in provincia <strong>di</strong> Lo<strong>di</strong> parrebbe in regressione, a seguito<br />
della competizione e della predazione esercitata dalle <strong>specie</strong> esotiche <strong>di</strong> recente introduzione,<br />
che ne stanno determinando la scomparsa nel Po e nei tratti più meri<strong>di</strong>onali dei corsi<br />
lo<strong>di</strong>giani. Dove ancora presente, il pesce gatto può costituire popolazioni anche consistenti<br />
che possono arrecare danno alle <strong>specie</strong> ittiche autoctone per l’instaurarsi <strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong><br />
competizione e/o predazione.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 163
Abbondanza relativa nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento con le <strong>di</strong>fferenti tipologie <strong>di</strong> substrato.<br />
164 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> corrente.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> trasparenza dell’acqua.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 165
49. Pesce Gatto Punteggiato<br />
Ictalurus punctatus<br />
166 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Il pesce gatto punteggiato è una <strong>specie</strong> esotica <strong>di</strong> origine americana la cui introduzione è<br />
recente in Italia. Diffusosi dapprima all’interno dei Centri Privati <strong>di</strong> Pesca, l’ictaluride ha in<br />
alcuni casi raggiunto le acque libere mostrando talvolta segni <strong>di</strong> avvenuta acclimatazione.<br />
Nel biennio 2003-2004 è stato oggetto <strong>di</strong> una vera è propria esplosione demografica all’interno<br />
dello scolmatore Belgiar<strong>di</strong>no, probabilmente frutto <strong>di</strong> un elevato successo riproduttivo.<br />
Decorsa tale fase <strong>di</strong> “boom demografico”, la <strong>specie</strong> è tuttavia quasi scomparsa, risultando ad<br />
oggi spora<strong>di</strong>ca nei pressi della confluenza tra lo scolmatore e l’Adda e comparendo solo saltuariamente<br />
tra le catture dei pescatori <strong>di</strong>lettanti del tratto lo<strong>di</strong>giano del fiume. Altri luoghi<br />
con presenza accertata (pur occasionale) della <strong>specie</strong> sono una lanca interna al Bosco Valentino<br />
(Maleo) e il colatore Venere (Orio Litta). In entrambi i casi la presenza è probabilmente<br />
frutto <strong>di</strong> immissioni non autorizzate a scopo <strong>di</strong> pesca sportiva. Dal punto <strong>di</strong> vista trofico, la<br />
<strong>specie</strong> è onnivora, alimentandosi sia <strong>di</strong> animali vivi o morti (pesci, gamberi, invertebrati) che<br />
<strong>di</strong> componenti vegetali.<br />
Il regime alimentare opportunista potrebbe creare locali scompensi nelle comunità ittiche,<br />
soprattutto nel caso in cui si verificassero nuovamente esplosioni demografiche della <strong>specie</strong>.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 167
50. Siluro<br />
Silurus glanis<br />
168 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Il siluro è una <strong>specie</strong> esotica <strong>di</strong> provenienza est europea rinvenuta per la prima volta in Italia<br />
nel 1957 sull’Adda a Lecco e successivamente nel 1968 a Belgioioso sul Po. All’interno del<br />
territorio provinciale la <strong>specie</strong> è in rapida espansione: è presente in 55 dei 159 punti <strong>di</strong> monitoraggio<br />
(34,6% del totale) risultando pari al 2,6% dei pesci complessivamente conteggiati.<br />
Le maggiori densità sono raggiunte lungo il Po e nel tratto terminale dei principali affluenti.<br />
Tenuto conto del prevalente ruolo <strong>di</strong> predatore che caratterizza la <strong>specie</strong>, le numerosità<br />
osservate nel Grande Fiume sono da considerarsi estremamente preoccupanti. Il siluro risulta<br />
inoltre in espansione nel tratto me<strong>di</strong>ano e inferiore dell’Adda, nel sistema della Muzza<br />
(soprattutto a valle della centrale termoelettrica <strong>di</strong> Tavazzano-Montanaso) e nella rete <strong>di</strong><br />
bonifica della bassa lo<strong>di</strong>giana. La <strong>specie</strong> colonizza spora<strong>di</strong>camente le acque lentiche, a livello<br />
delle quali sembrerebbe non trovare idonee con<strong>di</strong>zioni riproduttive, mentre risulta rara<br />
o assente nei corsi a prevalente carattere sorgivo e nel tratto superiore dell’Adda. Il siluro<br />
è relativamente versatile, essendo in grado <strong>di</strong> colonizzare <strong>di</strong>fferenti tipologie <strong>di</strong> substrato<br />
(anche se quello che garantisce le maggiori frequenze <strong>di</strong> rinvenimento è costituito da ghiaia<br />
e sabbia), varie con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> flusso e trae un vantaggio selettivo dall’incremento dei valori<br />
<strong>di</strong> torbi<strong>di</strong>tà delle acque.<br />
Tra i fattori limitanti la sua <strong>di</strong>ffusione, un ruolo <strong>di</strong> prim’or<strong>di</strong>ne sembrerebbe svolto dal regime<br />
fresco tardo-primaverile delle acque, che potrebbe renderne <strong>di</strong>fficoltosa la riproduzione:<br />
in tal senso si spiegherebbe la pressoché totale assenza del siluro dal tratto superiore dell’Adda<br />
e dal sistema dei fontanili.<br />
La <strong>specie</strong>, ad oggi, sembrerebbe costituire una delle principali minacce per i pesci autoctoni,<br />
dato il ruolo <strong>di</strong> grande predatore e la contestuale possibilità <strong>di</strong> raggiungere nei siti idonei<br />
elevate densità. Tra le <strong>specie</strong> maggiormente a rischio, oltre a quelle gregarie <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a taglia,<br />
vi sono altri predatori quali la trota marmorata e il luccio.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 169
Abbondanza relativa nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento con le <strong>di</strong>fferenti tipologie <strong>di</strong> substrato.<br />
170 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> corrente.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> trasparenza dell’acqua.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 171
51. Gambusia<br />
Gambusia holbrooki<br />
172 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
La gambusia è una <strong>specie</strong> alloctona <strong>di</strong> provenienza americana introdotta in Italia negli anni<br />
’20 del secolo scorso allo scopo <strong>di</strong> combattere la malaria. È presente in 34 dei 159 punti <strong>di</strong><br />
monitoraggio (21,4% del totale), risultando pari allo 0,7% dei pesci complessivamente conteggiati.<br />
Ampiamente <strong>di</strong>ffusa lungo il reticolo inferiore del sistema della Muzza, probabilmente<br />
grazie all’incremento dei valori termici, è frequente anche lungo il Lambro oltre che<br />
in alcune lanche e morte. È più spora<strong>di</strong>ca nei fontanili, nel Po e nella rete <strong>di</strong> bonifica mentre<br />
risulta pressoché assente nelle porzioni me<strong>di</strong>ane e superiori dell’Adda e nel tratto superiore<br />
del sistema della Muzza.<br />
La gambusia è ovovivipara (non è legata pertanto a particolari substrati per la riproduzione)<br />
e può essere quin<strong>di</strong> rinvenuta in <strong>di</strong>fferenti tipologie <strong>di</strong> fondo, anche se sembrerebbe preferire<br />
zone fangose o comunque con presenza <strong>di</strong> substrati fini. La velocità <strong>di</strong> corrente pre<strong>di</strong>letta è<br />
in genere nulla o lenta, e anche nei tratti lotici la <strong>specie</strong> tende ad occupare le zone marginali,<br />
che presentano valori <strong>di</strong> velocità più ridotti.<br />
In merito alla trasparenza delle acque non sembrerebbero emergere esigenze particolari,<br />
tenuto conto che la gambusia tende a collocarsi preferibilmente nei pressi della superficie.<br />
Localmente impattante a causa della sua attività <strong>di</strong> predazione su uova e avannotti, la <strong>specie</strong><br />
appare stabile all’interno del territorio provinciale, mostrando segni <strong>di</strong> regressione solo<br />
nei siti in cui è in corso un aumento <strong>di</strong> potenziali predatori, in genere anch’essi <strong>di</strong> origine<br />
esotica.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 173
Abbondanza relativa nelle <strong>di</strong>fferenti tipologie funzionali.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento con le <strong>di</strong>fferenti tipologie <strong>di</strong> substrato.<br />
174 ● Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> corrente.<br />
Frequenza <strong>di</strong> rinvenimento in <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> trasparenza dell’acqua.<br />
Allegato B - Schede delle Specie Ittiche Censite ● 175