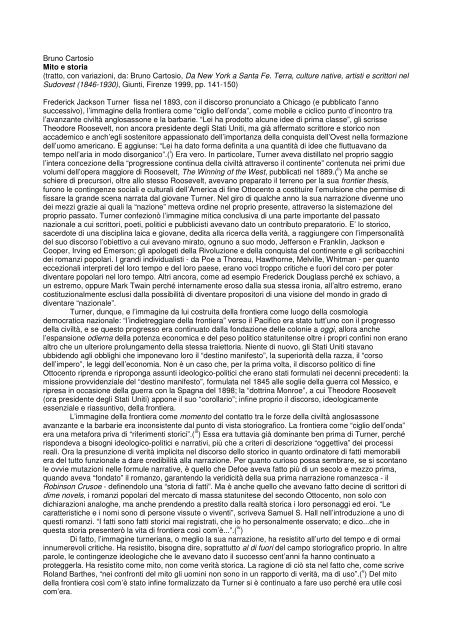Bruno Cartosio Mito e storia - Università degli studi di Bergamo
Bruno Cartosio Mito e storia - Università degli studi di Bergamo
Bruno Cartosio Mito e storia - Università degli studi di Bergamo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Bruno</strong> <strong>Cartosio</strong><br />
<strong>Mito</strong> e <strong>storia</strong><br />
(tratto, con variazioni, da: <strong>Bruno</strong> <strong>Cartosio</strong>, Da New York a Santa Fe. Terra, culture native, artisti e scrittori nel<br />
Sudovest (1846-1930), Giunti, Firenze 1999, pp. 141-150)<br />
Frederick Jackson Turner fissa nel 1893, con il <strong>di</strong>scorso pronunciato a Chicago (e pubblicato l’anno<br />
successivo), l’immagine della frontiera come “ciglio dell’onda”, come mobile e ciclico punto d’incontro tra<br />
l’avanzante civiltà anglosassone e la barbarie. “Lei ha prodotto alcune idee <strong>di</strong> prima classe”, gli scrisse<br />
Theodore Roosevelt, non ancora presidente <strong>degli</strong> Stati Uniti, ma già affermato scrittore e storico non<br />
accademico e anch’egli sostenitore appassionato dell’importanza della conquista dell’Ovest nella formazione<br />
dell’uomo americano. E aggiunse: “Lei ha dato forma definita a una quantità <strong>di</strong> idee che fluttuavano da<br />
tempo nell’aria in modo <strong>di</strong>sorganico”.( i ) Era vero. In particolare, Turner aveva <strong>di</strong>stillato nel proprio saggio<br />
l’intera concezione della “progressione continua della civiltà attraverso il continente” contenuta nei primi due<br />
volumi dell’opera maggiore <strong>di</strong> Roosevelt, The Winning of the West, pubblicati nel 1889.( ii ) Ma anche se<br />
schiere <strong>di</strong> precursori, oltre allo stesso Roosevelt, avevano preparato il terreno per la sua frontier thesis,<br />
furono le contingenze sociali e culturali dell’America <strong>di</strong> fine Ottocento a costituire l’emulsione che permise <strong>di</strong><br />
fissare la grande scena narrata dal giovane Turner. Nel giro <strong>di</strong> qualche anno la sua narrazione <strong>di</strong>venne uno<br />
dei mezzi grazie ai quali la “nazione” metteva or<strong>di</strong>ne nel proprio presente, attraverso la sistemazione del<br />
proprio passato. Turner confezionò l’immagine mitica conclusiva <strong>di</strong> una parte importante del passato<br />
nazionale a cui scrittori, poeti, politici e pubblicisti avevano dato un contributo preparatorio. E’ lo storico,<br />
sacerdote <strong>di</strong> una <strong>di</strong>sciplina laica e giovane, de<strong>di</strong>ta alla ricerca della verità, a raggiungere con l’impersonalità<br />
del suo <strong>di</strong>scorso l’obiettivo a cui avevano mirato, ognuno a suo modo, Jefferson e Franklin, Jackson e<br />
Cooper, Irving ed Emerson; gli apologeti della Rivoluzione e della conquista del continente e gli scribacchini<br />
dei romanzi popolari. I gran<strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidualisti - da Poe a Thoreau, Hawthorne, Melville, Whitman - per quanto<br />
eccezionali interpreti del loro tempo e del loro paese, erano voci troppo critiche e fuori del coro per poter<br />
<strong>di</strong>ventare popolari nel loro tempo. Altri ancora, come ad esempio Frederick Douglass perché ex schiavo, a<br />
un estremo, oppure Mark Twain perché internamente eroso dalla sua stessa ironia, all’altro estremo, erano<br />
costituzionalmente esclusi dalla possibilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare propositori <strong>di</strong> una visione del mondo in grado <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ventare “nazionale”.<br />
Turner, dunque, e l’immagine da lui costruita della frontiera come luogo della cosmologia<br />
democratica nazionale: “l’in<strong>di</strong>etreggiare della frontiera” verso il Pacifico era stato tutt’uno con il progresso<br />
della civiltà, e se questo progresso era continuato dalla fondazione delle colonie a oggi, allora anche<br />
l’espansione o<strong>di</strong>erna della potenza economica e del peso politico statunitense oltre i propri confini non erano<br />
altro che un ulteriore prolungamento della stessa traiettoria. Niente <strong>di</strong> nuovo, gli Stati Uniti stavano<br />
ubbidendo agli obblighi che imponevano loro il “destino manifesto”, la superiorità della razza, il “corso<br />
dell’impero”, le leggi dell’economia. Non è un caso che, per la prima volta, il <strong>di</strong>scorso politico <strong>di</strong> fine<br />
Ottocento riprenda e riproponga assunti ideologico-politici che erano stati formulati nei decenni precedenti: la<br />
missione provvidenziale del “destino manifesto”, formulata nel 1845 alle soglie della guerra col Messico, e<br />
ripresa in occasione della guerra con la Spagna del 1898; la “dottrina Monroe”, a cui Theodore Roosevelt<br />
(ora presidente <strong>degli</strong> Stati Uniti) appone il suo “corollario”; infine proprio il <strong>di</strong>scorso, ideologicamente<br />
essenziale e riassuntivo, della frontiera.<br />
L’immagine della frontiera come momento del contatto tra le forze della civiltà anglosassone<br />
avanzante e la barbarie era inconsistente dal punto <strong>di</strong> vista storiografico. La frontiera come “ciglio dell’onda”<br />
era una metafora priva <strong>di</strong> “riferimenti storici”.( iii ) Essa era tuttavia già dominante ben prima <strong>di</strong> Turner, perché<br />
rispondeva a bisogni ideologico-politici e narrativi, più che a criteri <strong>di</strong> descrizione “oggettiva” dei processi<br />
reali. Ora la presunzione <strong>di</strong> verità implicita nel <strong>di</strong>scorso dello storico in quanto or<strong>di</strong>natore <strong>di</strong> fatti memorabili<br />
era del tutto funzionale a dare cre<strong>di</strong>bilità alla narrazione. Per quanto curioso possa sembrare, se si scontano<br />
le ovvie mutazioni nelle formule narrative, è quello che Defoe aveva fatto più <strong>di</strong> un secolo e mezzo prima,<br />
quando aveva “fondato” il romanzo, garantendo la veri<strong>di</strong>cità della sua prima narrazione romanzesca - il<br />
Robinson Crusoe - definendolo una “<strong>storia</strong> <strong>di</strong> fatti”. Ma è anche quello che avevano fatto decine <strong>di</strong> scrittori <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>me novels, i romanzi popolari del mercato <strong>di</strong> massa statunitese del secondo Ottocento, non solo con<br />
<strong>di</strong>chiarazioni analoghe, ma anche prendendo a prestito dalla realtà storica i loro personaggi ed eroi. “Le<br />
caratteristiche e i nomi sono <strong>di</strong> persone vissute o viventi”, scriveva Samuel S. Hall nell’introduzione a uno <strong>di</strong><br />
questi romanzi. “I fatti sono fatti storici mai registrati, che io ho personalmente osservato; e <strong>di</strong>co...che in<br />
questa <strong>storia</strong> presenterò la vita <strong>di</strong> frontiera così com’è...”.( iv )<br />
Di fatto, l’immagine turneriana, o meglio la sua narrazione, ha resistito all’urto del tempo e <strong>di</strong> ormai<br />
innumerevoli critiche. Ha resistito, bisogna <strong>di</strong>re, soprattutto al <strong>di</strong> fuori del campo storiografico proprio. In altre<br />
parole, le contingenze ideologiche che le avevano dato il successo cent’anni fa hanno continuato a<br />
proteggerla. Ha resistito come mito, non come verità storica. La ragione <strong>di</strong> ciò sta nel fatto che, come scrive<br />
Roland Barthes, “nei confronti del mito gli uomini non sono in un rapporto <strong>di</strong> verità, ma <strong>di</strong> uso”.( v ) Del mito<br />
della frontiera così com’è stato infine formalizzato da Turner si è continuato a fare uso perché era utile così<br />
com’era.
“La mitologia”, scrive ancora Barthes, “può avere solo un fondamento storico, perché il mito è una<br />
parola scelta dalla <strong>storia</strong>: il mito non può sorgere dalla ‘natura’ delle cose”.( vi ) Il fondamento storico del mito<br />
della frontiera è fin troppo noto. E’ l’occupazione angloamericana del continente, dove però angloamericana<br />
sta, brachilogicamente, per il processo storico quasi bisecolare della presenza inglese sul territorio<br />
americano e per la costruzione da parte statunitense <strong>di</strong> un proprio mito fondativo nazionale che non può<br />
evitare <strong>di</strong> includere i progenitori coloniali, rigenerati e trasformati però in angloamericani dalla permanenza<br />
stessa sul suolo americano. Non è un caso che gli inglesi, i francesi e gli spagnoli, che pure hanno letto in<br />
chiave mitica vari aspetti del loro contatto col Nuovo mondo, non abbiano prodotto analoghe interpretazioni<br />
mitologizzanti della loro occupazione del continente americano: nessuna delle nazioni europee ha avuto<br />
bisogno <strong>di</strong> fare iniziare la propria <strong>storia</strong> in America e da lì costruire la propria identità (e nessun’altra nazione,<br />
aggiungiamo ancora, ha avuto l’ulteriore bisogno <strong>di</strong> ricostruire “sopra” una propria regione la propria identità<br />
nazionale dopo un trauma violento come fu la guerra civile e nel contesto <strong>di</strong> un’immigrazione <strong>di</strong> massa nelle<br />
sue metropoli).<br />
Il primo passaggio, tornando al <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong> Barthes, è quello che trasforma il reale storico in un reale<br />
naturale: “Il mito si costituisce attraverso la <strong>di</strong>spersione della qualità storica delle cose”.( vii ) Il mito, continua<br />
Barthes, svuota il reale della politica che ad esso apparteneva in quanto reale storico. Esso è dunque una<br />
“parola depoliticizzata”.( viii ) Ma si può precisare ulteriormente: quella parola che, in quanto è, è parola<br />
sociale, appare depoliticizzata, mentre invece è solo la parola dell’autorità che non ammette contestazione.<br />
Dunque è parola politica a tutti gli effetti, che sembra rimuovere da sé la politica e che invece rimuove<br />
soltanto se stessa dal campo della politica ponendosene al <strong>di</strong> sopra, sottraendosi cioè alla possibilità stessa<br />
della <strong>di</strong>alettica politica. La parola mitica, come l’epos bachtiniano, è resa “<strong>di</strong>stante” e “assoluta” - in questo<br />
senso, dunque, depoliticizzata - ma anche, in quanto tale, politicamente autoritaria.( ix )<br />
Il mito elaborato dal vincitore rende “naturali” i processi storico-politici che hanno portato alla sua<br />
vittoria e, ciò facendo, “abolisce la complessità <strong>degli</strong> atti umani, dà loro la semplicità delle essenze, sopprime<br />
ogni <strong>di</strong>alettica, ogni spinta a risalire al <strong>di</strong> là del visibile imme<strong>di</strong>ato, organizza un mondo senza contrad<strong>di</strong>zioni<br />
perché senza profon<strong>di</strong>tà, un mondo <strong>di</strong>spiegato nell’evidenza, istituisce una chiarezza felice: le cose<br />
sembrano significare da sole”.( x ) Il critico Alex Nemerov attinge alle formulazioni barthesiane per avviare un<br />
suo <strong>di</strong>scorso critico sull’Ovest nell’arte statunitense dell’Ottocento.( xi ) Come si vedrà, ad esempio nel caso <strong>di</strong><br />
Frederic Remington, si tratta per la gran parte <strong>di</strong> arte in qualche modo epica e quasi sempre mitologizzante.<br />
Ma questa è anche la chiave per leggere la contemporanea narrazione turneriana: senza profon<strong>di</strong>tà (si limita<br />
alla descrizione parziale e univoca <strong>di</strong> alcuni caratteri dell’occupazione territoriale fino alla valle del<br />
Mississippi, non <strong>di</strong> tutto l’Ovest); senza <strong>di</strong>alettica (anche se presenta la frontiera come mobile confine tra<br />
barbarie e civiltà, Turner non parla mai del “barbaro”, l’in<strong>di</strong>ano; e l’Io americano che dell’in<strong>di</strong>ano assume i<br />
mo<strong>di</strong> per sopravvivere nella foresta, lo fa solo temporaneamente, nella fase iniziale del ciclo rigenerativo,<br />
che deve essere negata perché si riattinga alla “civiltà”); senz’altro che una evidenza ricondotta a essenza o<br />
natura (gli in<strong>di</strong>scussi imperativi della razza e della provvidenza spingono avanti il colono, che è sempre<br />
soltanto in<strong>di</strong>viduo, mai mosso da pressioni economico-politiche più gran<strong>di</strong> <strong>di</strong> lui).<br />
Eppure è proprio questa parola apparentemente depoliticizzata - in realtà intrisa <strong>di</strong> una politica il cui<br />
fine è la legittimazione dell’esistente espansionistico - che si afferma. E può affermarsi solo perché è così,<br />
tale cioè da poter essere presentata come non politica, non <strong>di</strong> parte, ma generale; talmente “essenziale” da<br />
permettere a ognuno <strong>di</strong> riconoscersi in essa. Esattamente come tutti i romani dovevano essere in grado <strong>di</strong><br />
riconoscersi nella grandezza e nei destini <strong>di</strong> Roma attraverso il mito virgiliano della sua fondazione. E’<br />
questa qualità mitologica che è sopravvissuta all’abbattimento dell’e<strong>di</strong>ficio turneriano in sede storiografica.<br />
Ancora nel 1976, John Cawelti, uno storico delle forme letterarie, scriveva che “il paesaggio<br />
simbolico della formula western è un campo d’azione incentrato sul punto d’incontro tra civiltà e barbarie, Est<br />
e Ovest, società stabile e spazio senza legge. L’inse<strong>di</strong>amento o il gruppo <strong>di</strong> frontiera è un punto sia nello<br />
spazio, sia nel tempo”.( xii ) Che il genere letterario western ottocentesco fosse stato prodotto e fosse<br />
cresciuto su quella opposizione semplificata è un fatto noto. Tanto noto, come vedremo, da giustificare<br />
l’affermazione secondo cui Turner è il sistematore finale <strong>di</strong> un quadro interpretativo non solo esistente, ma<br />
<strong>di</strong>ffuso e dominante già prima della sua comparsa sulla scena. E’ a questo stesso quadro che si riferisce un<br />
altro critico recente, Stephen Tatum, quando <strong>stu<strong>di</strong></strong>a la “<strong>di</strong>alettica” tra il ban<strong>di</strong>to Billy the Kid, cioè la<br />
wilderness, e il suo uccisore, lo sceriffo Pat Garrett, rappresentante della civilization.( xiii ) In termini quasi<br />
perfettamente turneriani Tatum ipotizza l’esistenza <strong>di</strong> un “epico momento storico nel nostro passato<br />
nazionale, quando le forze opposte della civiltà e della barbarie si fronteggiarono e determinarono il corso<br />
della <strong>storia</strong> americana”.( xiv )<br />
Semplicemente, quel momento non è mai esistito nella <strong>storia</strong>. Non è neppure esistito in un passato<br />
tanto lontano da poter essere trattato come il “passato assoluto” dei poemi epici. Quando Virgilio scriveva,<br />
quel che narrava sarebbe dovuto avvenire tanto prima del suo tempo da non avere più alcun “contatto”<br />
documentale con esso. Invece, quando i mitografi della frontiera scrivono dell’Ovest, scrivono <strong>di</strong> fatto in<br />
presa <strong>di</strong>retta con gli avvenimenti, spesso impiegando note figure storiche come materiali per i loro miti, le<br />
loro epiche. In questo senso il fare delle cose e persone della “frontiera” una narrazione epica rivela<br />
l’operazione deliberatamente mitopoietica: non solo la parola che costruisce il mito, nei termini barthesiani,
ma anche la parola che, costruendo il mito nazionale, lo spoglia della sua complessità storica, della sua<br />
stessa storicità relegandolo, come <strong>di</strong>ce Bachtin, in una specie <strong>di</strong> passato assoluto. Ma la vera specificità<br />
statunitense sta nel fatto che l’”assolutezza” non può proprio essere quella del passato epico, perché gli eroi<br />
protagonisti della mitopoiesi nazionale sono tutti contemporanei. E’ il contesto in cui vengono collocati che<br />
quin<strong>di</strong> deve essere destoricizzato. Da qui la prassi curiosa <strong>di</strong> far fare agli uomini storici Daniel Boone, Davy<br />
Crockett, Kit Carson, Billy the Kid, Buffalo Bill Cody cose che non hanno mai fatto (e spesso che non<br />
avrebbero mai potuto fare), in ambienti che hanno soltanto vaghe colleganze con le realtà politiche, sociali,<br />
culturali - in una parola, storiche - in cui essi si muovevano realmente nello stesso tempo in cui i mitografi si<br />
sbizzarrivano su <strong>di</strong> loro.<br />
Il punto è che deve trattarsi, se non <strong>di</strong> un vero passato assoluto della nazione, <strong>di</strong> un “ieri” che non è<br />
temporalmente lontano ma spazialmente <strong>di</strong>staccato: in quell’imprecisa e lontana entità chiamata Ovest<br />
avvengono oggi cose che nell’Est appartengono, forse, e più o meno, a un passato lontano <strong>di</strong> cui rimangono<br />
poche tracce. Storie <strong>di</strong> scontri con gli in<strong>di</strong>ani e <strong>di</strong> conquista, <strong>di</strong> aristocratici e selvaggi, <strong>di</strong> civiltà e barbarie<br />
che servono alla Nazione per darsi, in certo modo, vestigia <strong>di</strong> un passato. La loro funzione è analoga al<br />
persistere dei monumenti e alla conservazione dei documenti nelle società europee: legittimazione<br />
dell’esistente attraverso la testimonianza data dall’esistenza del passato nel presente. La mitologia della<br />
frontiera serve, un po’ più precisamente, all’Est statunitense - che si pone come depositario della coscienza,<br />
oltre che del potere economico-politico della nazione - per riconoscersi come ormai <strong>di</strong>verso, ma anche per<br />
ricondurre a sé quel nuovo mondo in quanto configurabile nei termini <strong>di</strong> un proprio passato epico: se l’Ovest<br />
è oggi come noi siamo stati, allora potremo far <strong>di</strong>ventare anch’esso come noi siamo oggi e, forse anche più<br />
importante, se comportamenti e obiettivi sono gli stessi che noi abbiamo avuto - l’eliminazione dei selvaggi e<br />
la conquista del territorio - allora la qualità americana (l’Americanness) è un dato reale della nazione, una<br />
costante nella sua <strong>storia</strong>, un fattore esclusivo <strong>di</strong> identità spirituale. E’ questo il sostrato ideologico della<br />
raffigurazione turneriana della ciclicità nella <strong>storia</strong> della frontiera: la ciclicità come sicurezza, certezza della<br />
riproducibilità del modello e quin<strong>di</strong> soli<strong>di</strong>tà dei destini nazionali.<br />
La Americanness, a sua volta, deve avere i caratteri dell’eroismo e della virilità, esattamente come la<br />
romanità dei romani doveva essere ripercorribile fino a ritrovare la sua scaturigine nell’eroe troiano Enea,<br />
che arriva da Oriente a fertilizzare la nuova terra, della cui ricettività è simbolo la donna che egli sposa.<br />
L’eroe Enea o John Smith (o Daniel Boone, ma anche Hernán Cortez, volendo) arriva a fertilizzare con il suo<br />
seme la futura nuova sede dell’Impero. Questo eroe maschio deve essere combattente e valoroso, perché la<br />
sua è sempre una conquista territoriale e politico-militare, ma anche moralmente superiore e virile, per<br />
attrarre a sé i conquistati: “Come le vergini sabine, [il Messico] imparerà presto ad amare i suoi<br />
conquistatori”, scriveva il “New York Herald” dell’8 ottobre 1847, quando ancora era <strong>di</strong>battuta l’ipotesi <strong>di</strong><br />
“prendersi” tutto il Messico; e sulla stessa lunghezza d’onda il “Sun”, anch’esso <strong>di</strong> New York, scriveva<br />
qualche giorno dopo che “la razza [messicana] è del tutto abituata a essere conquistata...Liberare e<br />
innalzare, non schiavizzare e abbassare, è la nostra missione”.( xv )<br />
Detto qui per inciso, tuttavia, non è che questa rappresentazione non ponesse problemi in altri<br />
ambiti. Al <strong>di</strong> là della retorica e del richiamo nobilitante ai classici, al <strong>di</strong> sotto del livello metaforico-mitico, l’idea<br />
concreta della miscela razziale era respinta come ripugnante.( xvi ) Qualche giorno dopo aver evocato il Ratto<br />
delle sabine, tenendo conto delle tante inevitabili implicazioni della conquista sul terreno dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong><br />
citta<strong>di</strong>nanza, lo “Herald” pre<strong>di</strong>ceva quell’unione come “infelice e segnata da una cattiva stella”. Alcuni<br />
parlavano anche più chiaramente. Il su<strong>di</strong>sta John C. Calhoun <strong>di</strong>ceva in Congresso all’inizio <strong>di</strong> gennaio del<br />
1848: “Io so inoltre, signore, che non abbiamo mai pensato <strong>di</strong> incorporare nella nostra Unione nessun’altra<br />
razza che quella caucasica - la razza dei bianchi liberi. Incorporare il Messico, sarebbe il primo esempio <strong>di</strong><br />
incorporazione <strong>di</strong> una razza in<strong>di</strong>ana, dal momento che più della metà dei messicani sono in<strong>di</strong>ani e il resto è<br />
costituito <strong>di</strong> tribù miste. Io protesto contro una tale unione! Il nostro, signore, è il Governo <strong>di</strong> una razza<br />
bianca”. E qualche giorno prima, il “New York Evening Post” <strong>di</strong>retto da William Cullen Bryant aveva scritto: “I<br />
messicani sono in<strong>di</strong>ani - in<strong>di</strong>ani aborigeni. Sono gli in<strong>di</strong>ani che Cortez conquistò tremila (sic) anni fa, resi<br />
solo un po’ più malandrini da una civiltà bastarda...Non hanno neppure i ru<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> un’esistenza nazionale<br />
in<strong>di</strong>pendente. Gli aborigeni del nostro paese non hanno cercato e non possono cercare <strong>di</strong> vivere da<br />
in<strong>di</strong>pendenti fianco a fianco con noi. La Provvidenza ha deciso così ed è follia non prenderne atto. I<br />
messicani sono aborigeni in<strong>di</strong>ani e devono seguire il destino della loro razza”.( xvii )<br />
Questa concezione razziale, eroica e maschile del destino manifesto implica, naturalmente, il fatto<br />
che la frontiera venga fatta avanzare con le armi in pugno e che le donne non abbiano alcun ruolo nel mito;<br />
tantomeno le donne <strong>degli</strong> eroi: né la sposa <strong>di</strong> Daniel Boone, né quelle <strong>di</strong> Davy Crockett, né le tre sposate da<br />
Kit Carson (che oltretutto sono due in<strong>di</strong>ane e una messicana). Le armi, dunque, attuano la conquista e,<br />
subito dopo, la proteggono, rendendo possibile la società. Ma se questa è l’Eneide e, per quanto riguarda le<br />
armi, la realtà, non è certo la tesi turneriana della frontiera, che raccoglie i rivoli e frammenti precedenti per<br />
rielaborarli ulteriormente, come <strong>di</strong>cevo, in una nuova sintesi. Dalla lineare e ciclica narrazione turneriana,<br />
vengono dunque espunti sia l’in<strong>di</strong>ano, l’”altro” che si oppone all’eroe in tutte le epiche precedenti fino alle<br />
forme decadute dei <strong>di</strong>me novels, sia la particolare “alterità” implicita nella <strong>di</strong>alettica tra i sessi. Proprio<br />
l’aborrita mescolanza razziale che spaventava Calhoun e i suoi contemporanei sarà sottaciuta da Turner. La
questione non è che Turner non tiene conto del contributo e del ruolo delle donne “sulla frontiera”, esplorati<br />
soltanto decenni dopo da una nuova storiografia, quanto il concreto problema della miscegenation inevitabile<br />
nelle zone in cui avveniva il concreto contatto fisico tra i bianchi anglosassoni e le popolazioni locali, in<strong>di</strong>ane<br />
o messicane che fossero. In un contesto tanto sensibile alla questione razziale come quello entro cui scrive<br />
Turner, il ratto delle Sabine era <strong>di</strong>ventato innominabile.<br />
Quel “momento” ipostatizzato da Tatum non è esistito. La “frontiera” non è un momento, né la serie<br />
ciclica <strong>di</strong> momenti, ipostatizzata da Turner, che si succedono sempre più lontani nella prospettiva <strong>di</strong> un<br />
osservatore il cui occhio si trovi sull’Atlantico. La “frontiera” è sempre un luogo, o meglio una quantità <strong>di</strong><br />
luoghi fisici, geografici, nei quali forme <strong>di</strong>verse <strong>di</strong> cultura, socialità e interessi si sono incontrati e trasformati<br />
in tempi <strong>di</strong>versi e senza interruzioni, senza alcun parallelismo tra le progressioni nel tempo e nello spazio.<br />
Gli in<strong>di</strong>vidui che hanno agito nei luoghi fisici del contatto si sono sempre trovati ad agire anche in ambienti<br />
socialmente definiti. Rispetto a questa semplice verità, l’autore de L’ultimo dei mohicani è molto più avvertito<br />
<strong>di</strong> Turner. Scrive Patricia Nelson Limerick: “La frontiera <strong>di</strong> Turner era un processo, non un luogo. Quando la<br />
‘civiltà’ aveva vinto sul ‘selvaggio’ in un certo posto, il processo - e l’attenzione dello storico - si spostava. Il<br />
ripensare la <strong>storia</strong> dell’Ovest ci permette <strong>di</strong> pensare all’Ovest come luogo, come tanti ambienti complicati<br />
abitati da nativi che guardavano alle loro terre come al centro, non come al margine”.( xviii ) Non si tratta solo <strong>di</strong><br />
rovesciare la prospettiva, <strong>di</strong> adottare il punto <strong>di</strong> vista <strong>di</strong> chi “si trova già lì”, invece che quello <strong>di</strong> chi “arriva da<br />
fuori”. Visto in questa luce l’Ovest statunitense <strong>di</strong>venta “un importante terreno d’incontro, il punto in cui<br />
l’America in<strong>di</strong>ana, l’America latina, l’Angloamerica, l’Afroamerica e l’Asia si intersecano. In fatto <strong>di</strong> rapporti tra<br />
le razze, l’Ovest potrebbe far apparire come una riunione <strong>di</strong> famiglia il faccia a faccia tra immigrati europei e<br />
nativisti americani nelle città del Nordest <strong>di</strong> fine Ottocento. Allo stesso modo, per <strong>di</strong>versità <strong>di</strong> lingue, religioni<br />
e culture, l’Ovest superava anche il Sud”.( xix )<br />
Ridurre questa complessità, e storicità, alla contrapposizione semplice tra civiltà e barbarie non può<br />
che essere forzatura interpretativa, oppure velo censorio steso su una complessità rifiutata perché percepita<br />
come minacciosa. Si torna dunque al mito come semplificazione: “Il mito non nega le cose”, <strong>di</strong>ce ancora<br />
Roland Barthes, “anzi, la sua funzione è <strong>di</strong> parlarne: semplicemente le purifica, le fa innocenti, le istituisce<br />
come natura e come eternità, dà loro una chiarezza che non è quella della spiegazione, ma quella della<br />
constatazione: se io constato l’imperialità francese senza spiegarla, mi ci vuole ben poco per trovarla<br />
naturale, qualcosa che va da sé: ed eccomi rassicurato”.( xx ) Vedremo come all’imperialità francese del<br />
<strong>di</strong>scorso barthesiano si possa sostituire l’espansionismo statunitense e raggiungere lo stesso obiettivo<br />
rassicurante e consolatorio: tutto era predestinato ed è avvenuto tutto per il bene della nazione.<br />
Per Richard Slotkin che, contrariamente a Roland Barthes, ha lavorato proprio sul rapporto tra realtà<br />
storica dell’Ovest e costruzione mitica nazionale, “un mito è una narrazione che concentra in una singola<br />
esperienza drammatizzata l’intera <strong>storia</strong> <strong>di</strong> un popolo sulla sua terra”.( xxi ) Slotkin si riferiva in particolare<br />
all’esperienza dell’in<strong>di</strong>viduo Daniel Boone, che viene “elevata” a mito nazionale. In realtà, non è mai l’intera<br />
<strong>storia</strong> <strong>di</strong> un popolo che viene mitizzata. Lo stesso Slotkin, tre<strong>di</strong>ci anni più tar<strong>di</strong>, correggeva la formulazione<br />
appena citata, precisando che nei miti si raccolgono gli “elementi essenziali della visione del mondo tipica <strong>di</strong><br />
una cultura” e che il mito è una “rappresentazione parziale che si fa passare per l’intera verità”.( xxii ) Sarebbe<br />
stato meglio <strong>di</strong>re subcultura, intendendo la visione del mondo tipica <strong>di</strong> un gruppo, o riconducibile a un gruppo<br />
oppure a una componente sociale dominante. D’altro canto, l’accento da lui stesso posto subito dopo sulla<br />
parzialità sembra portare anche il suo <strong>di</strong>scorso proprio in quella <strong>di</strong>rezione. In effetti è sempre soltanto una<br />
parte della “<strong>storia</strong>” nazionale che viene ridotta a mito: sono quasi sempre - per lo meno nelle culture<br />
occidentali - i “fatti” delle guerre e della conquista, della fondazione della nazione stessa attraverso<br />
l’affermazione della <strong>di</strong>nastia originaria. Sono cioè i pilastri ideologici su cui i gruppi dominanti fanno poggiare<br />
la propria legittimazione in quanto tali<br />
La produzione del mito nazionale, da Virgilio in poi, è frutto della penna <strong>di</strong> uno o più autori, non è un<br />
“folk process” ma un “literary myth”,( xxiii ) che poi magari utilizza tra i suoi materiali anche quelli che i processi<br />
della mitopoiesi popolare elaborano in parte autonomamente e in parte attraverso l’interazione con i miti<br />
letterari, sempre in un qualche rapporto con la <strong>storia</strong>. Nel caso <strong>di</strong> Daniel Boone, il colonizzatore per<br />
antonomasia dei territori al <strong>di</strong> là dei monti Appalacchi, il produttore originario del mito fu un maestro e<br />
speculatore fon<strong>di</strong>ario <strong>di</strong> nome John Filson, che nel 1784 pubblicò The Adventures of Col. Daniel Boon in<br />
appen<strong>di</strong>ce al proprio The Discovery, Settlement and Present State of Kentucke. Quel breve racconto che si<br />
presenta come autobiografico - <strong>di</strong> fatto è la “razionalizzazione” a opera <strong>di</strong> Filson della testimonianza a lui<br />
resa dallo stesso Boone - fu ripetutamente ristampato, plagiato, imitato e usato come modello narrativo e<br />
tematico nei decenni successivi in un processo che fissò i tratti <strong>di</strong> quei “personaggi letterari [che], per essere<br />
cre<strong>di</strong>bili come eroi americani, avrebbero dovuto essere ra<strong>di</strong>cati nel territorio selvaggio, invece che tra le<br />
raffinatezze della civiltà europea”.( xxiv )<br />
Tra l’altro, lo stesso processo ripetitivo-creativo sarebbe continuato nei decenni successivi alla<br />
guerra civile, quando l’impren<strong>di</strong>toria e<strong>di</strong>toriale avrebbe sfornato migliaia <strong>di</strong> romanzucoli western pressoché<br />
uguali nei personaggi e nella formula per un pubblico popolare crescente. In quel lungo processo più che<br />
secolare, dopo Daniel Boone, altri uomini dell’Ovest vennero elevati da autori ed e<strong>di</strong>tori molto <strong>di</strong>sinvolti al
ango <strong>di</strong> interpreti esemplari - simbolici - del destino espansionistico della nazione, da Davy Crockett a Kit<br />
Carson, a Buffalo Bill. Questo processo - i mo<strong>di</strong> della costruzione e del prolungamento del mito della<br />
frontiera, l’introduzione delle varianti nel corso del tempo, le con<strong>di</strong>zioni della produzione materiale dei miti e<br />
della loro <strong>di</strong>ffusione - è interamente analizzabile in quanto tale, come <strong>di</strong>mostrano le opere <strong>di</strong> Richard Slotkin.<br />
Uno dei tratti caratteristici, forse il dominante, <strong>di</strong> tale processo è stato la sua promozionalità, il suo essere<br />
calato in una logica <strong>di</strong> funzionalità sociale-ideologica alle prospettive <strong>di</strong> conquista del continente. Il che non<br />
equivale a <strong>di</strong>re che esso sia stato semplice o lineare, né che la sua ricezione da parte del pubblico popolare<br />
sia stata univoca.<br />
Il processo si arricchì strada facendo <strong>di</strong> tutte le possibilità materiali <strong>di</strong> produzione che l’evoluzione<br />
sociale e tecnica offriva, dal libro al libro economico a grande <strong>di</strong>ffusione, alle arti figurative, all’illustrazione<br />
sulla stampa perio<strong>di</strong>ca, agli spettacoli <strong>di</strong> massa. E, com’è ovvio, ognuna delle modalità <strong>di</strong> produzione e<br />
circolazione dettò a sua volta particolari specificità narrative e visuali, in sostanza alterando<br />
progressivamente il messaggio e l’immagine complessiva e fissando varianti anche significative nel <strong>di</strong>scorso.<br />
Inoltre, soprattutto per quanto riguardava i romanzi, la stessa evoluzione della composizione sociale, in<br />
particolare nelle città d’immigrazione, portava sempre più alla lettura i ceti popolari e quin<strong>di</strong>, nella lettura,<br />
domande e aspettative non previste, con effetti altrettanto impreve<strong>di</strong>bili: in sostanza, le <strong>di</strong>verse componenti<br />
del pubblico - a cui arrivavano anche altri messaggi <strong>di</strong> segno culturale e politico <strong>di</strong>verso dall’interno delle<br />
proprie comunità e a cui l’industria culturale offriva anche romanzi <strong>di</strong> ambientazione urbana - piegavano a sé<br />
e alle proprie visuali il messaggio, l’avventura, gli stessi stereotipi razziali <strong>di</strong> cui erano impregnati i racconti <strong>di</strong><br />
ambientazione western. In altre parole, dalla sostanziale uniformità ideologica <strong>di</strong> questi ultimi non<br />
<strong>di</strong>scendeva meccanicamente l’uniformazione ideologica dei suoi maggiori consumatori.( xxv ) La<br />
promozionalità del messaggio non impedì sempre il raggiungimento <strong>di</strong> livelli espressivi elevati e complessi.<br />
Tuttavia, a volte, l’aspetto propagan<strong>di</strong>stico o ideologicamente subalterno <strong>di</strong> per sé assente dalle opere -<br />
penso soprattutto ai pittori <strong>di</strong> Taos e <strong>di</strong> Santa Fe, <strong>di</strong> cui si <strong>di</strong>scuterà più avanti - fu sovrimposto alle opere<br />
stesse dai loro committenti e dai loro utilizzatori a fini commerciali. A testimonianza, potremmo concludere,<br />
del fatto che se il mito è parola, e la parola è sociale, il mito non nasce, né vive nel vuoto, ma nel pieno della<br />
società e della cultura in cui è prodotto e utilizzato. Di nuovo: il mito sarà “astorico”, ma la sua elaborazione<br />
avviene interamente nella <strong>storia</strong>, nel fitto dei rapporti sociali <strong>di</strong> produzione e <strong>di</strong> potere. In tutti i casi, fino al<br />
rovesciamento storiografico <strong>degli</strong> anni recenti, molto raramente il <strong>di</strong>scorso sull’Ovest è stato “libero” dalle<br />
implicazioni a cui ho fatto riferimento nelle pagine precedenti.<br />
i . Frederick J. Turner, The Significance of the Frontier in American History, in Id., The Frontier in<br />
American History, New York, Henry Holt, 1953 (1920) (La frontiera nella <strong>storia</strong> americana, Bologna, Il<br />
Mulino, 1959); Theodore Roosevelt a Turner , 10 febbraio 1894, cit. in Ray A. Billington, The Genesis of the<br />
Frontier Thesis: A Study in Historical Creativity, San Marino, Cal., The Huntington Library, 1971, pp. 82-3.<br />
ii . La cit. è dalla recensione <strong>di</strong> Turner all’opera <strong>di</strong> Roosevelt, in “The Dial” (August 1889) riportata in<br />
R.A. Billington, The Genesis of the Frontier Thesis, cit., pp. 39-40. Si vedano anche Edmund Morris, The<br />
Rise of Theodore Roosevelt, New York, Coward, McCann & Geoghegan, 1979, pp. 465-66 e Richard<br />
Slotkin, Nostalgia and Progress: Theodore Roosevelt’s Myth of the Frontier, in “American Quarterly”, Vol. 33,<br />
N. 5 (Winter 1981), pp. 608-37.<br />
iii . Richard Slotkin, The Fatal Environment: The Myth of the Frontier in the Age of Industrialization,<br />
1800-1890, New York, Harper, 1994, p. 20.<br />
iv . Samuel S. Hall, Kit Carson, Jr., the Crack Shot of the West (1875), cit. in Philip Durham, Dime<br />
Novels: An American Heritage, in “The Western Humanities Review”, Vol. IX, N. 1(Winter 1955), p. 43.<br />
v . Roland Barthes, Miti d’oggi, Torino, Einau<strong>di</strong>, 1994, p. 224.<br />
vi . Ivi, p. 192.<br />
vii . Ivi, p. 223.<br />
viii . Ibidem.<br />
ix . Michail Bachtin, Epos e romanzo, in Id., Estetica e romanzo, a cura <strong>di</strong> Clara Strada Janovic,<br />
Torino, Einau<strong>di</strong>, 1979, p. 462: “L’idealizzazione del passato nei generi letterari alti ha un carattere ufficiale.<br />
Tutte le espressioni esterne della forza e della verità dominanti (<strong>di</strong> tutto ciò che è compiuto) sono<br />
organizzate entro la categoria assiologico-gerarchica del passato, nell’immagine della lontananza (dal gesto<br />
e dalla veste allo stile, tutto è simbolo del potere)”. Come si vedrà, la lontananza, nel nostro caso, sarà<br />
spaziale e non temporale: l’Ovest lontano nello spazio viene trattato come se fosse lontano nel tempo,<br />
appartenente a un passato concluso, quin<strong>di</strong> narrabile secondo le modalità dell’epica. Ancora Bachtin: “Nel<br />
mondo epico non c’è posto per alcuna incompiutezza, apertura, problematicità”.<br />
x . R. Barthes, Miti d’oggi, cit., p. 223-24.<br />
xi . Alex Nemerov, “Doing the ‘Old America’”: The Image of the American West, 1880-1920, in William<br />
H. Truettner, ed., The West as America: Reinterpreting Images of the Frontier, 1820-1920, Washington,<br />
Smithsonian Institution Press, 1991, pp. 285-343.
xii . John G. Cawelti, Adventure, Mystery, and Romance. Formula Stories as Art and Popular Culture,<br />
Chicago, University of Chicago Press, 1977, p. 193.<br />
xiii . Stephen Tatum, Inventing Billy the Kid. Visions of the Outlaw in America, 1881-1981,<br />
Albuquerque, University of New Mexico Press, 1982, pp. 41-2.<br />
xiv . Ibidem. Però non è propriamente turneriana la <strong>di</strong>alettica stessa che Tatum istituisce tra le<br />
opposte forze della wilderness e della civiltà.<br />
xv . “New York Herald”, 8 ottobre 1847 e New York “Sun”, 22 ottobre 1847, cit. in F. Merk, Manifest<br />
Destiny and Mission in American History, New York, Vintage Books, 1966, pp. 122-23.<br />
xvi . Si vedano David J. Weber, “Scarce More Than Apes”: Historical Roots of Anglo-American<br />
Stereotypes of Mexicans, in Id., Myth and the History of the Hispanic Southwest, Albuquerque, University of<br />
New Mexico Press, 1990 (“Poco più che scimmie”. Ra<strong>di</strong>ci storiche <strong>degli</strong> stereotipi angloamericani sui<br />
messicani delle zone <strong>di</strong> frontiera, in “Ácoma”, Anno II, N. 4, Primavera 1995, pp. 25-33); Ronald Takaki, Iron<br />
Cages. Race and Culture in 19th-Century America, New York, Oxford University Press, 1990; Reginald<br />
Horsman, Race and Manifest Destiny. The Origins of American Racial Anglo-Saxonism, Cambridge, Mass.,<br />
Harvard University Press, 1981.<br />
xvii . “Herald” cit. in R. Slotkin, The Fatal Environment, cit., p. 188; Calhoun e “Post” cit. in F. Merk,<br />
Manifest Destiny, cit., pp. 162, 158.<br />
xviii . Patricia Nelson Limerick, The Legacy of Conquest. The Unbroken Past of the American West,<br />
New York, W.W. Norton, 1987, p. 26.<br />
xix . Ivi, p. 27.<br />
xx . R. Barthes, Miti d’oggi, cit., p. 223.<br />
xxi . R. Slotkin, Regeneration Through Violence. The Mythology of the American Frontier, 1600-1860,<br />
Hanover, NH, Wesleyan University Press, 1973, p. 269.<br />
xxii . R. Slotkin, Myth and the Production of History, in Myra Jehlen and Sacvan Bercovitch, eds.,<br />
Ideology and Classic American Literature, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 70, 74.<br />
xxiii . R. Slotkin, Regeneration Through Violence, cit., p. 278.<br />
xxiv . Ivi, p. 321. John Filson, The Discovery, Settlement and Present State of Kentucke...To Which Is<br />
Added, an Appen<strong>di</strong>x, Containing, I. The Adventures of Col. Daniel Boon..., Wilmington, Del., James Adams,<br />
1784.<br />
xxv . Si veda Michael Denning, Mechanic Accents: Dime Novels and Working-Class Culture in<br />
America, London, Verso, 1987: anche se l’oggetto della sua analisi non sono i romanzi western, le sue<br />
osservazioni sulla <strong>di</strong>alettica industria culturale-pubblico sono pertinenti al <strong>di</strong>scorso qui svolto.