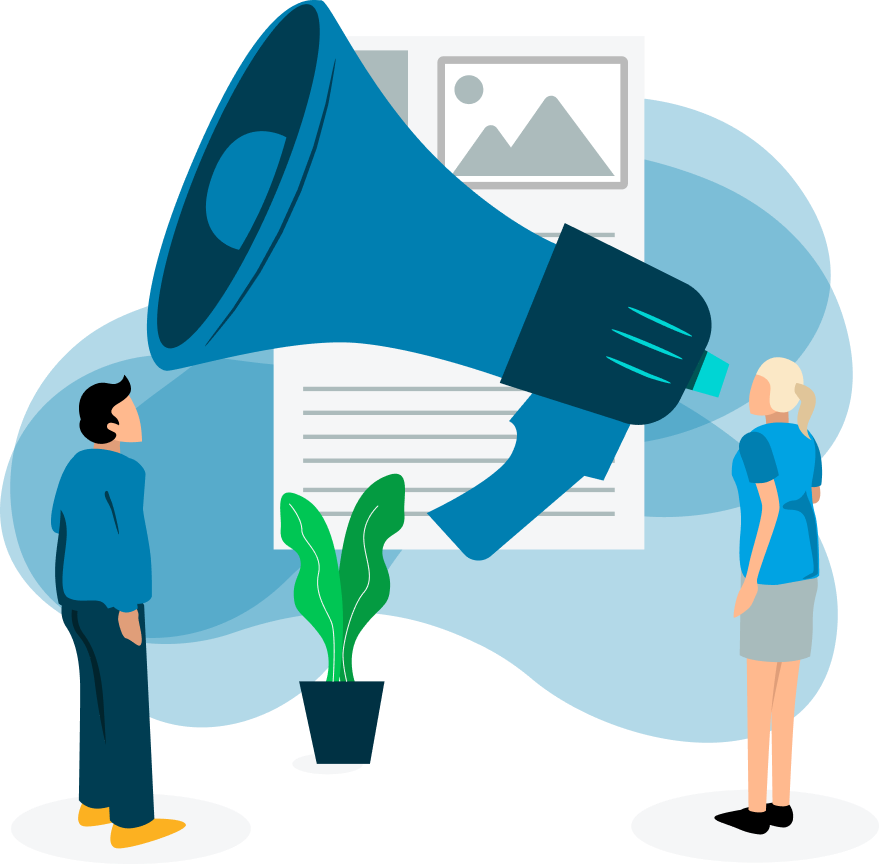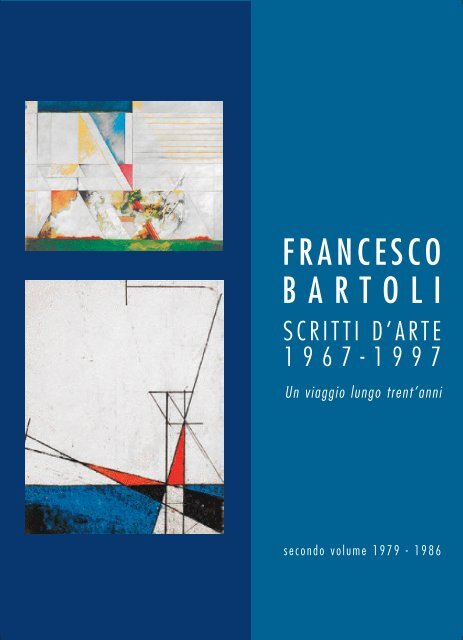Volume 2 - MAC Francesco Bartoli
Volume 2 - MAC Francesco Bartoli
Volume 2 - MAC Francesco Bartoli
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
F R A N C E S C O<br />
B A R T O L I<br />
S C R I T T I D ’ A RT E<br />
1 9 6 7 - 1 9 9 7<br />
Un viaggio lungo trent’anni<br />
secondo volume 1979 - 1986
Dall’astratto io me ne vo volando adesso,<br />
in foglie e fiori, verso lo sconfinato<br />
e il soprannaturale.<br />
Osvaldo Licini
Questa pubblicazione è stata possibile grazie al concreto sostegno<br />
del Comune di Mantova, della Provincia di Mantova<br />
e della Fondazione Banca Agricola Mantovana.<br />
Un particolare ringraziamento è dovuto a Palazzo Te, alla Casa del Mantegna<br />
e alla Camera di Commercio che hanno permesso<br />
l’utilizzazione di alcune immagini di opere delle loro collezioni.<br />
Si ringrazia inoltre, per la disponibilità, l’Archivio Sartori<br />
che ha reso possibile reperire alcuni “scritti”<br />
che qui vengono pubblicati.<br />
Per la loro competenza e disponibilità un grande apprezzamento è rivolto a<br />
Claudio Antoniazzi, Annarosa Enzi Baratta, Pierluigi <strong>Bartoli</strong>, Sonia Costantini, Susanna Sassi<br />
e a Gianluigi Arcari per il prezioso supporto.<br />
Artefice fondamentale di questo lavoro, Ester Mantovani <strong>Bartoli</strong>,<br />
con grande competenza e affetto, ha ricostruito, passo passo,<br />
il lavoro di <strong>Francesco</strong>.<br />
La disponibilità degli artisti e dei famigliari ha contribuito alla ricchezza delle informazioni<br />
contenute in questo lavoro. Un ringraziamento particolare è rivolto a Franco Bassignani,<br />
Edoardo Bassoli, Carla Bernardelli, Claudio Bondioli Bettinelli, Anna Bolognesi, Carlo Bonfà,<br />
Ferdinando Capisani, Adriano Castelli, Sonia Costantini, <strong>Francesco</strong> Dalmaschio,<br />
Gabriella Facciotto, Italo Lanfredini, Ernesto Lojero, Gianni Madella, Augusto Morari,<br />
Luigi Mutti, Giorgio Nenci, Teresa Noto, Roberto Pedrazzoli, Concetto Pozzati,<br />
Maria Rosa Schirolli, Sergio Sermidi, Gianluigi Troletti, Valentino Vago.<br />
Un ringraziamento particolare è rivolto a Giorgio Fasol per aver messo a disposizione<br />
le immagini delle opere di Rodolfo Aricò, a Gianfranco Ferlisi per il testo<br />
“L’Area Mantovana: primo approccio ad un’ipotesi di attivazione”.<br />
Ad Enrica Zacchi un grazie per la fattiva collaborazione.<br />
Progetto grafico e coordinamento editoriale<br />
Eristeo Banali<br />
Stampa<br />
Publi Paolini, Mantova
FRANCESCO<br />
B A R T O L I<br />
S C R I T T I D ’ A RT E<br />
1 9 6 7 - 1 9 9 7<br />
Un viaggio lungo trent’anni<br />
a cura di<br />
Eristeo Banali<br />
2° volume<br />
1979-1986
Per una lettura delle arti: gli scritti<br />
Eristeo Banali<br />
Da Gino Gorza a Giuliano Giuman<br />
(dal primo volume: Presentazione)<br />
[...] Nel Settantanove, alla Casa del Mantegna, il mondo incantato di Giosetta Fioroni, la fiaba, la dimensione fantastica sono argomenti<br />
di affascinamento: i Teatrini come case e teche, sarcofaghi e stanze, ipogei della memoria, presenze senza tempo, capaci d’incantare<br />
e sorprendere, dormienti, quasi fossero sulla soglia del nascere e, situate nella lontananza, macchinassero un incanto, nascondessero<br />
un segreto; o come se, al contrario, fossero state recise da una falsa vita e tesaurizzate in uno scrigno protettivo, in una<br />
stanza – ripostiglio.<br />
All’inizio degli anni Ottanta, con un articolo sulla Gazzetta di Mantova, ritorna su Giulio Perina e alla sua “Pittura en plain air”; scrive di<br />
Gianni Del Bue e della sua distrazione… dalla terra, dal suolo, dalla linea dell’orizzonte … dalla superficie e, in occasione della mostra<br />
di Defendi Semeghini, a Palazzo Ducale a Mantova nella primavera dell’Ottantuno, pubblica “Dai sogni alla scena metropolitana”.<br />
Per Giordano Di Capi, in occasione della mostra antologica a Palazzo Te, nell’ottobre Ottantadue, scrive un saggio dal titolo Ai confini<br />
dell’astratto, che risulterà fondamentale per la conoscenza del lavoro dell’artista. Nell’Ottantuno, su Arte centro, sul lavoro di Carlo Cioni<br />
ancora un saggio dal titolo La forma dell’invisibile. Nell’Ottantacinque, per la mostra di Palazzo Vecchio a Firenze, approfondisce ulteriormente<br />
lo studio dell’opera di Carlo Cioni nel testo dal titolo Racconto sul nero. Per Osvaldo Licini scrive: Pittura come ornamento e<br />
irrealtà, La natura la iena e l’equilibrista e Il personaggio liciano: un invito al silenzio. Nell’Ottanta, con Presagi della scena, scritto per<br />
la mostra alla Casa del Mantegna, ritorna su Rodolfo Aricò, e le sue architetture armoniche e con Irrealtà del naturale, ritorna sull’opera<br />
di Giuseppe Facciotto, in occasione della mostra di Palazzo Te. In questo periodo, per Renzo Schirolli scrive tre interventi: Materie<br />
e cerniere per la mostra alla Galleria d’Arte Contemporanea di Suzzara, Risanare l’ombra per la mostra Renzo Schirolli negli anni<br />
cinquanta alla Galleria Einaudi a Mantova e un breve testo, dedicato a artificio e ascolto del naturale scritto per la mostra Arte contemporanea<br />
in Palazzo Ducale a Mantova, nell’ ottobre Ottantanove.<br />
Sul lavoro di Ferruccio Bolognesi scrive due saggi: Un sistema magico, testo contenuto in Vestire i sogni, rassegna di bozzetti e di costumi<br />
teatrali, Centro di Documentazione Arti Contemporanee, quaderno 1, aprile1982, uscito in occasione della mostra Simulazione<br />
d’ombre, fili lamiera pittura teatro tenutasi alla Casa del Mantegna nell’Ottantacinque; mentre il secondo, senza titolo, viene redatto<br />
appositamente per la mostra Simulazione d’ombre.<br />
Scrive di Valentino Vago Ritmiche dell’ascesa in occasione della mostra al Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano; Svolte e ritorni<br />
per la mostra Giovanni Bernardelli opere 1935-1982 a Suzzara nell’Ottantatre, e a Ferrara l’anno successivo; Sulla soglia delle figure<br />
per la mostra di Sonia Costantini alla Galleria “Einaudi”; Ad occhi chiusi, Sculture di Enzo Nenci in un articolo comparso sulla Gazzetta<br />
di Mantova.<br />
Nell’Ottantatre alla Casa del Mantegna, viene presentato il libro Dopo il tutto di Concetto Pozzati, relatore con <strong>Francesco</strong> <strong>Bartoli</strong> l’amico<br />
Gino Baratta. La conversazione che ne nasce diventa l’argomento di uno scritto sul parlare e il fare di Pozzati. Sempre per Pozzati<br />
nell’Ottantotto scrive A che punto siamo con i fiori per la mostra tenutasi alla Galleria Il chiodo, a Mantova, e poi L’angelo, la model-<br />
375
la dove la domanda emblematica Ma il gioco non è cieco? diventa consonanza irrinunciabile al viaggiare verso orizzonti ineluttabili,<br />
dimensioni che contemplano i suoi Tempi di piacere residuo. Dell’Ottantaquattro è il saggio Kandinskij tra apocalisse e astrazione,<br />
pubblicato da Umberto Artioli in Il ritmo e la voce.<br />
In questi anni per la Gazzetta di Mantova scrive Sensazione di uno scultore chiarista in occasione della mostra alla Galleria Arcari di<br />
Mantova; per la mostra Disegno mantovano del ‘900 scrive del [...] disegno, quasi mai posto al servizio della scultura [...], di Aurelio<br />
Nordera e pubblica sul catalogo Nudo seduto; per Carlo Bondioli Bettinelli scrive Echi riflessi e per Ernesto Treccani, Il volto rinato,<br />
pubblicato nel catalogo della mostra La fiaba di Narciso allestita alla Casa del Mantegna nel 1987. Scrive un articolo sulla Gazzetta di<br />
Mantova dal titolo Dall’immagine alla luce: la ricerca di Sergio Sermidi. Di Gianni Madella registra un mutamento di rotta del flusso<br />
di energie, orientando la sua ricerca verso …lo spazio comune di oggi della vita di relazione, dei percorsi della civiltà tecnologica, dell’assembramento<br />
urbano.<br />
Per Vasco Bendini, in occasione della mostra Sette stanze – un giardino tenutasi alla Casa del Mantegna, scrive Nel silenzio della scienza,<br />
dove s’addentra nelle stazioni bendiniane indicandole come ragioni tematiche del suo lavoro: il sentimento come storia, la formalità<br />
organica del mondo, lo storicismo interrogante, il vedere altro e più a fondo; nell’Ottantasei, in Venti disegni erotici<br />
(1956-1984), con una dichiarazione di poetica, Gianluigi Arcari Editore, pubblica Paesaggi con Baubo.<br />
In occasione della mostra Pino Castagna 1964-1985 tenutasi a Palazzo Te nell’ottobre dell’Ottantacinque scrive un saggio leggendo<br />
l’attenzione dello scultore quando è …rivolta a scandire i dinamismi delle materie lavorate, quel che in termini scenici potremmo<br />
chiamare gestualità e fors’anche recitazione, e l’altra intesa a sondare le potenze intime dell’universo naturale, le forze latenti sotto<br />
la pelle dei corpi e nelle masse, nella pietra e nel metallo, per estrarne emergenze, personaggi appunto (e ancor meglio “persone”,<br />
forme che risuonano, per-sonant), cariche di un’aura incantata e inattesa. [...]<br />
(N.d.r. Molte immagini poste a corredo dei testi sono state “prese” dalle pubblicazioni seguite direttamente da <strong>Francesco</strong> <strong>Bartoli</strong>. Nel compilare le didascalie non sempre<br />
è stato possibile reperire tutti i dati tecnici e dare qualità alle riproduzioni).<br />
376
“... per via di racconti e nuove funzioni<br />
vien fuori un mondo immaginario<br />
teso fra le soglie del tempo,<br />
fluido ed espansivo<br />
come lo scorrere degli istanti ...”<br />
F. <strong>Bartoli</strong>, da “Di piombo e di cera” (pag. 498)
1979<br />
Da Gino Gorza<br />
a La fatica della pittura<br />
Figure e calchi<br />
Gino Gorza<br />
Disegni come bruciature<br />
Carlo Bondioli Bettinelli<br />
Marionetta, cuore<br />
Giosetta Fioroni<br />
Il disegno e la scena<br />
Raffigurare per indizi<br />
Lucia Tampellini<br />
La fatica della pittura
Figure e calchi<br />
Gino Gorza (1)<br />
L’anamorfo è palesemente l’elemento costitutivo, dominante addirittura<br />
benché talora sotterraneo, di un lungo itinerario di pitture<br />
ed oggetti. Non però l’anamorfo forgiato per l’inganno, consenziente<br />
- trasgressivo verso la tradizione prospettica, bensì<br />
una figura che riemerge, un oggetto che staziona nel flusso del<br />
G. Gorza, Gabbiano, 1966, tecnica mista su legno, cm 41x75.<br />
380<br />
visibile. Un calco dell’invisibile, forma della forza. Come la materia<br />
primigenia non conosce prospettive e neppure allegorie. È<br />
éternelle femme, matermateria-matrice, spietata e arrendevole,<br />
vergine e madre, alternativamente.<br />
Anamorfosi, e cioè trasformazione, riformazione, rinascita.<br />
Ritorno della figura, ma anche sua macinazione nell’infinita molteplicità<br />
dell’uno.<br />
Emergenza della forza nella circolarità delle effigi.<br />
L’itinerario, questo itinerario, si suppone iscritto nella storia<br />
dell’‘anima’ (lontanissima, antichissima psyché), vale a dire<br />
nella fatica del respiro, del pneuma. Ànemos / soffio, vento cosmico.<br />
Faticosamente l’anima si lavora nella geometria del dissimile,<br />
seguendo la grammatica d’una manifestazione che non si chiude,<br />
in perpetuo accadimento, processuale. Geometria della performance,<br />
del comportamento d’una forma ardente. Grammatica<br />
oscura e deviante, che accoppia gli opposti, l’ombra e la luce,<br />
anzi è luce-buio, oscurità luminosa, notte che non tollera l’amministrazione<br />
del giorno.<br />
Non è monumentale, benché suggerisca alte tensioni per vibrazioni<br />
minime e sottili increspature. Per battiti e gotici trasalimenti.<br />
Si consideri il momento inaugurale, la prima bagnante. Di che<br />
cosa parla quella tela-preludio? Ha configurazione germinale<br />
d’uovo, ma medita una rotazione. E sta di spalle, ripiegata sulla<br />
propria crescita. In più bagnante, creatura legata all’acqua, ad un<br />
rito lustrale. Si alimenta dunque di analogie e, per dir meglio,<br />
vive nelle simultaneità. Non è il battesimo un atto di illuminazione,<br />
il momento di risalita verso la luce? La materia animata è<br />
scintilla che si sprigiona, esce dal buio. Ha a che fare col fuoco.<br />
La fatica dell’anima equivale al lavoro del corpo, questo “semovente”,<br />
dice Gorza. Le sue fatalità sono la manifestazione e l’annientamento.<br />
E tuttavia “corpo” è parola troppo greve poiché, in<br />
definitiva, non si tratta tanto di una avventura delle icone quanto<br />
del lavoro e del respiro che le produce, d’una certa modalità<br />
ed energetica di produzione che non ha nome ed ha tutti i nomi.<br />
Difatti il je grammaticale è pronuncia improbabile dove agisce<br />
una morfologia della genesi che sta agli antipodi del principio di<br />
determinazione. Ed ancor più importa che questo processo sia la<br />
pittura stessa, una forza senza nome, una tecnica, se così la si<br />
vuol chiamare (ma meglio sarebbe dire dettato), che attraversa
G. Gorza, Bivalve, 1969<br />
smalto su legno, 2 elementi, cm 40x45 cadauno.<br />
la mano, il pittore, e lo rende strumento “cieco e puro”, cosa tra<br />
le cose, come voleva Rilke.<br />
A conferma, rileggo la pagina conclusiva di Terza persona. Vi<br />
trovo enunciato il doppio movimento del decifratore di enigmi,<br />
dell’ermeneuta infinito, protagonista d’una peripezia circolare.<br />
Qui la duplice attitudine della pittura che interroga - descrive e<br />
cancella viene affidata all’etimo di un verbo: bandire.<br />
Accanto alla radice tedesca della parola (da cui il senso di segnalare<br />
e comunicare, mettere in mostra!), interviene la complicazione<br />
d’un contagio francese: sicché il “manifestare” è anche un “allontanare”,<br />
un “rivelare” di nuovo il senza-patria: “La voce bandire<br />
è appropriata ad una retorica del quadro; divulga ed esilia. Che si<br />
murasse la pittura in un’ombra definitiva non riguarda il culto dei<br />
morti più che i riti della pittura. L’accecamento di un’immagine<br />
istruita e pubblicata rimemora il senso di un atto consumato”.<br />
Ora, quel che mi colpisce in questa “comunicazione”, è lo scorrimento<br />
della luminosità nella notte della materia, il rinascere ansioso<br />
della forma nei cicli d’una manifestazione incessante. Corpi<br />
emergono nella salienza dei tempi e dei moti ed escono da un<br />
vuoto ogni volta increato, da una platitude apparentemente immobile<br />
che è la prodigiosa potenza dello zero. Così la vita, l’anima,<br />
imprime sigilli nell’indifferenziato.<br />
Rigorosi dettati ritmici, non riconducibili alla grammatica della<br />
norma ma a quella, certamente, dei paragrammatismi, presiedono<br />
all’articolazione del soffio e danno vita ad una pasigrafia intensiva<br />
e geroglifica: scrittura un tempo (all’epoca delle Impron-<br />
381<br />
te) molto materica ed ora aerea ed umbratile, non per questo<br />
però astratta. L’invisibile si dona, sia pure angolosamente, all’universo<br />
dei sensi e, fisicizzandosi, appare tuttavia imprendibile.<br />
La retorica dell’immutabile viene piegata a dire, non dico il contrario,<br />
ma un diverso. Si veda il caso delle cerniere, delle articolazioni<br />
verticali dei bivalvi o della dormiente: la simmetria enuncia<br />
lo scorrimento. Non asse rigido sul quale riposa una frontalità<br />
ieratica, ma pernio piuttosto e inclinazione che rovescia e ruota<br />
la figura. Così la ripiegata dormiente è anche, virtualmente, colei<br />
che veglia, che agisce nel tempo. È figura di geometra; misura<br />
certo con lavoro difficile e stremato - porzioni di spazio e di vita,<br />
è un luogo in un universo senza luogo. Segnala numeri e cifre.<br />
Ma di che cosa è manifestazione la dormiente? E con lei, che<br />
cosa dicono tutte le altre figure? Quale “gramma” vi è impresso<br />
e vi si calca? Penso ad una scheggia del cerchio, alla fiamma. Ma<br />
è difficile disegnarne la configurazione, poiché - anagrammaticamente<br />
- si dissemina, disperdendo le sue tensioni costitutive.<br />
Il fatto è che appare sulla soglia, fra visibile e invisibile, in stratificazioni<br />
di memorie proiettate nel futuro. Ed è ermetica: nel<br />
senso che invia messaggi e consegna didascalie.<br />
Gramma del soffio nella configurazione dell’ala, della pinna,<br />
della freccia, ed infine - in raggrumato colore - del fuoco: oro che<br />
brucia, non oro che riposa.<br />
(1) Scritto in occasione della mostra “Gino Gorza. Per analogia”, tenutasi<br />
presso la Galleria d’Arte “Marin”, piazza Carignano 2, Torino, maggio 1979.
Disegni come bruciature<br />
Carlo Bondioli Bettinelli (1)<br />
Il rigore e la purezza del segno, la castigatezza delle forme rappresentano<br />
le qualità sicure e da sempre riconosciute all’opera grafica<br />
di Carlo Bondioli. Si tratta di risultati così evidenti da suggerire<br />
subito la definizione di uno stile aristocratico e forse, in chi<br />
guarda, il rischio di una formula. Davanti ai suoi fogli così calcinati<br />
di bianchi si finisce per dimenticare i contenuti che hanno dato origine<br />
al disegno, quei dati emotivi ed ancora impuri da cui la mano<br />
è partita per tracciare l’architettura di una visione. Tutto, si direbbe,<br />
parla a sfavore dell’improvvisazione e della spontaneità; soprattutto<br />
contro la sensuosità del naturale. Eppure Bondioli è artista<br />
di paesaggi e di figure, resta attaccato al ‘motivo’ realistico, alla<br />
verità dei soggetti, come dimostra la serie dei Venti disegni di Bocenago,<br />
esposti alla Bottega d’arte di Gianluigi Arcari: disegni, questi,<br />
tanto più sorprendenti a confronto delle prove più note, dal<br />
momento che sono proprio delle improvvisazioni, degli appunti<br />
tracciati nel vivo di una situazione visiva, in plen-air: un gioco sottile<br />
dentro la mobilità dell’estemporaneo, una rara concessione, per<br />
un disegnatore-incisore della sua natura, al piacere dell’abbozzo,<br />
dell’accensione improvvisa. Tuttavia, nonostante questo piacere e<br />
questo gioco, non viene meno l’equilibrio dello stile, con i suoi effetti<br />
di assottigliamento e di rarefazione del tema. I contenuti appaiono<br />
ancora una volta scavalcati nella purezza dei segni. Perché<br />
mai? Quale relazione si è istituita fra l’artista e il paesaggio? Che<br />
cosa accade nel tragitto dall’oggetto allo sguardo al foglio perché<br />
vada perduta la carne delle cose e resti in piedi soltanto una impalcatura,<br />
in certo modo lo schema luminoso degli oggetti?<br />
Questi disegni aiutano, più di altri forse (ma andrebbe vista anche<br />
un’altra serie di improvvisazioni, ispirate al paesaggio inglese),<br />
a tentare una risposta poiché danno il primo momento<br />
della registrazione grafica del reale, quando ancora non sono intervenute<br />
le operazioni di aggiustamento (per lo più di ordine ‘armonico’),<br />
le calibrature del rifacimento in laboratorio, i calcoli sui<br />
neri e sui bianchi che caratterizzano invece l’incisione, la deliberata<br />
artificiosità e malizia dell’acquaforte.<br />
Ora, questi disegni dell’estate ’78 a Bocenago, introducono, mi<br />
sembra, nel luogo di una scommessa. Scommessa e sfida lanciata<br />
alla mutevolezza del visibile, al deperire e fluire delle forme nel<br />
quotidiano. Quasi un contro-impressionismo esercitato sul campo<br />
dell’amico-nemico: la natura. C’è in Bondioli una resistenza for-<br />
382<br />
tissima al commercio disattento delle cose, una resistenza che si<br />
vela, anzi si maschera, dietro l’abito della discrezione; ed è piuttosto<br />
ostilità a pubblicare, a far circolare i segni nella palude dei<br />
consumi, nella opacità della corruzione visiva. Una ostilità che, più<br />
intimamente, diventa scontro con l’effimera e ostinata ricerca di<br />
durate e di permanenze nel cuore dei fenomeni. Ecco, sta qui probabilmente<br />
una delle ragioni per cui il disegnatore si sottrae, in<br />
moltissime occasioni, alla seduzione del colore, a quella sgargianza<br />
cromatica che è manifestazione dell’inessenziale e ‘apparenza’,<br />
rifrazione ed eco di una energia primaria, la luce, che va ritrovata<br />
più in profondità, là dove non sussistono le variabili di superficie<br />
e lo spettro è totalmente bianco.<br />
Così lo sguardo lavora sul motivo per togliere delle quantità e far<br />
emergere delle essenze. O, per dire più esattamente, le quantità<br />
e le configurazioni oggettive (i paesaggi, le figure, eccetera) vengono<br />
mantenute soltanto come appoggi per rendere visibile un<br />
valore altrimenti imprendibile. Si lavora sui vuoti piuttosto che sui<br />
pieni. È d’altronde significativo che i paesaggi si iscrivano nelle regioni<br />
del silenzio: mai una figura in movimento, un contrassegno<br />
aneddotico, come se l’occhio, spalancato su tempi lunghissimi, lasciasse<br />
perdere le emergenze e i rumori del caso.<br />
Fa parte del gioco dell’improvvisazione aver mantenuto una geografia<br />
riconoscibile, un certo sapore di cose, montagne ed erbe,<br />
ma come filtrati da una pratica di volatilizzazione. La grafìa è difatti<br />
essenziale, continua ad esserlo, perché insegue degli itinerari<br />
luminosi: brucia letteralmente i volumi, scava contorni e superfici,<br />
in una scansione mordente, inverosimile, di scuri e di chiari. I corpi<br />
sono plaghe d’ombra, sagome stilettate, oggetti quasi fossili per<br />
la secchezza incisiva della scrittura. Ed è la bruciatura, non il<br />
reale, ad imporre in ultima analisi la sua morfologia: tant’è vero<br />
che in certi casi l’immagine tende a smarginare, ad uscire di centro,<br />
a disporsi irregolarmente, come fa appunto una macchia luminosa<br />
per eccesso di sovraesposizione. Dove sono i pesi, se, ad<br />
esempio, i primi piani tendono a svanire? Se la linea di terra partecipa<br />
essa stessa al dilagare senza confini della bruciatura? Perciò<br />
si ha l’esito di una dilatazione massima nella quantità più piccola,<br />
della tensione nel minimo.<br />
A riprova tentiamo un esercizio: proviamo ad isolare un particolare<br />
e lo immaginiamo più grande. Mentalmente tiene: i bianchi e i neri<br />
restano ancora calcinanti, bruciano il foglio. I paesaggi sono tensioni.<br />
(1) Articolo comparso sulla Gazzetta di Mantova del 10 novembre 1979.
Marionetta, cuore<br />
Giosetta Fioroni (1)<br />
Teatrini come case e teche, sarcofaghi e stanze, ipogei della memoria.<br />
L’edificio scenico di Giosetta Fioroni assume le dimensioni<br />
ridotte del quadro, è palcoscenico chiuso, sbarrato da una<br />
quarta parete di cristallo, invisibile ma ostile, trasparente e inaccessibile<br />
tranne che allo sguardo. Vi trova posto l’evento magico<br />
della seduzione; un evento che ha in più la rapidità del lampo.<br />
Ricordo il fascio di luce spiovente sul grande uccello impagliato,<br />
lama diagonale nello spazio: dove quasi si congela, mantenendo<br />
un’inclinazione minerale e fissata, come se il cronometro dell’esistenza<br />
non avesse ormai senso, o per dir meglio valesse soltanto<br />
il tempo assoluto dell’epifania: e questo esigesse la cattura<br />
della rivelazione.<br />
383<br />
Simultaneità dei frammenti. Le associazioni si annodano per incastro,<br />
seguendo l’imperativo sintetico della condensazione e<br />
della metafora. Il teatro è una casa, e la casa una stanza, un interno,<br />
un ripostiglio, una busta. Un’architettura del dentro. Le<br />
analogie fioriscono l’una nel corpo dell’altra, si moltiplicano ma<br />
respingono il percorso rettilineo dell’azione, l’idea di sequenza. È<br />
la scena della morte resa manifesta di colpo, un dove ultralucido<br />
in cui non serve la scansione consecutiva della peripezia teatrale,<br />
poiché basta un segno per far apparire un quadro e materializzare<br />
fulmineamente un fantasma. Il ‘miracolo scenografico’<br />
balza dal germe luminoso della figura, pari a quello suscitato<br />
dalla magia del nome, con Madama Pace. Così il teatrino, tanto<br />
estraneo alle ragioni dello scorrimento lineare, si sottrae alle<br />
leggi del dramma, al conflitto agito in presenza e al movimento,<br />
nonché alla chiusa definitiva dell’agnizione. Non potendo<br />
G. Fioroni, Palmizio immaginario, 1979, acquarello, cm 24x18. G. Fioroni, I 3 Regni, 1979, acquarello, cm 24x18.
sciogliere le forze in gioco, finisce anche per allontanare la conquista<br />
piena dell’origine. Né principio né fine, ma l’ipertensione<br />
della magia.<br />
V’è accumulo intanto nella coppa del teatrino. Sono paesaggi miniaturizzati,<br />
attrezzerie di proporzioni ridottissime, oggetti minimi<br />
per bambole e marionette. Arredi microscopici. Chi aspetta<br />
personaggi umani trova invece delle piccole cose, dei resti, e talora<br />
profili di cose, anzi un vocabolario di immagini e un alfabeto<br />
di figure, poiché di cose concrete e palpabili poi non si tratta,<br />
ma di segni, di elementi funzionali alla grammatica del teatro, di<br />
questo teatro sospeso, e alla vita del giocattolo; così come più<br />
tardi, nelle carte di magìa, altri segni, magari prelevati dall’universo<br />
della natura, confluiscono irresistibilmente nel mondo<br />
della fiaba. Sempre in ogni caso si tratta di inneschi del sortilegio.<br />
Ora queste parvenze non sono né morte né vive, ma in certo<br />
G. Fioroni, Il cavallo alato, 1979, acquarello, cm 24x18.<br />
384<br />
G. Fioroni, Biancaneve, 1969, smalti e olio su tela, cm 100x100.<br />
senso vite ‘arrestate’, e dormienti, quasi fossero sulla soglia del<br />
nascere e, situate nella lontananza, macchinassero un incanto,<br />
nascondessero un segreto; o come se, al contrario, fossero state<br />
recise da una falsa vita e tesaurizzate in uno scrigno protettivo,<br />
in una stanza-ripostiglio. Cadute le proporzioni ed eluse le distanze<br />
consuete, scompaiono anche i pesi, sicché restano solo i<br />
fiati e i respiri delle cose, apparenze che acquistano spesso la<br />
frusciante liquidità d’un rigo di colore o si assottigliano nell’andamento<br />
di un profilo. Trasmutazione di soffi in geroglifici: un cavallo<br />
alato, la silhouette d’un albero. I profili servono a catturare:<br />
ospitano anime e trasportano “spiriti di campagna”. Il teatrino<br />
stesso è il primo e il più grande di questi profili e perimetri: un<br />
contorno di contorni.<br />
Tutta l’attrezzeria è convocata sul fondale della scena. Ma dov’è<br />
la Marionetta? Se il marionettista è una energia ex - machina ed<br />
anzi il funzionamento stesso della visione (una spia dietro la<br />
quinta e un accumulatore di ricordi), della marionetta sembra<br />
non esservi traccia, salvo che nei documenti biografici e in sbiadite<br />
fotografie, ossia nelle carte cifrate e discretamente ambigue<br />
che vengono sapientemente disseminate intorno all’opera: la
Strega di Biancaneve con la Sorellastra di Cenerentola, oppure il<br />
manichino surrealista alla galleria Cordier.<br />
Forse la Marionetta vive davvero sul filo del ricordo e andrà cercata,<br />
se il filo non si spezza, nell’ordine delle grafie e dei contorni,<br />
fra le essenze dei profili. Maghe e fattucchiere amano<br />
corde e codinzoli: “...la marionetta strega Baba-Maliarda vestita<br />
di cenci di relitti della Mamma dimenava lo strascico sollevato<br />
dal filo urlando ’Raperonzolo, Raperonzolo, metti fuori il tuo CO-<br />
DINZOLO’ ”. Tuttavia sono troppi i fili nel coro dei pupazzi e nella<br />
folla dei personaggi della fiaba quando si cerca l’unico profilo<br />
d’una creatura principe e complice dell’artista: la traccia di qualcuno<br />
o qualcosa che fa credere d’essere assente e punta su un<br />
inedito travestimento, su una nuova clownerie.<br />
La marionetta era giocattolo e statuetta, un tempo; pietra e<br />
terra. Kaspar un contadino e Pierrot uno spirito del suolo, un fluido<br />
inquieto e mercuriale, traghettatore d’anime. Appare certa la<br />
sua consuetudine con le salme e i dormienti. Era la vita nascosta<br />
che attendeva di rinascere. Ma s’è verificata una eclisse nel Moderno.<br />
Dopo l’identificazione kleistiana della marionetta con il libero<br />
fluire della forza di vita, lo Spirito astratto se n’è impadronito,<br />
trasferendola nella scena cinetico-visiva di Craig, nello<br />
splendore d’un cielo oltreumano. Da spirito della terra e del sangue<br />
è divenuta pura essenza celeste. Si apre il tempo dell’esilio<br />
ed Arp piange la morte di Kaspar. La statuetta è andata in frantumi,<br />
come la bambola e il giocattolo, spossessata della sua<br />
anima. C’è, però, chi va a riprendersela e la riporta nella regione<br />
della vita, nel centro misterioso dove ferve la genesi della<br />
creazione. Klee monta il teatrino degli “spiriti elettrici” e Schlemmer,<br />
nel comporre l’album del Figurales Kabinett, disegna con un<br />
tratto sicuro un cuore sulla corazza del danzatore, sotto l’otto rovesciato,<br />
simbolo della corrente cosmica. Il cuore, dicono i testi<br />
egizi, era la sola parte del corpo che si lasciava intatta nella cavità<br />
della mummia, al suo posto, per testimoniare contro la<br />
morte.<br />
E Giosetta? Ecco l’indagatrice degli interni e la custode di poupées<br />
attizzare il fuoco del cuore, non più di legno duro ma di materia<br />
ardente. Ha aperto il costume della marionetta e vi ha colto<br />
lo spirito della terra, dimenticando l’involucro meccanico. Col<br />
tòpos della fiamma inaugura nel ’57 una serie di quadri e nel<br />
’60 imprime un cuore rosso di smalto sulla prima pagina dell’<br />
385<br />
“Observateur”: una sagoma e un territorio. Un segno essenziale<br />
che deriva da rinuncia e dal potere di metamorfosi, da voluta dimenticanza<br />
e da fantasia di spostamento. Al posto della marionetta<br />
sta infatti un cuore o il grande “pennuto” (se ne parla nella<br />
lettera alla “cara K.”, del novembre 1972).<br />
È vero: i cuori tornano a recitare negli anni Sessanta (Twombly,<br />
Novelli, Jim Dine, Oldenburg...), ma quelli di Giosetta sono diversi.<br />
Non hanno nulla di stereotipato e di popolare poiché appartengono<br />
all’orizzonte dell’interieur e discendono dalla mitografia<br />
dei teatrini. Rispetto a Novelli, col quale pure intrattengono<br />
sensibili affinità di segno e di scrittura ( a chi era dedicato<br />
l’augurio “Buon viaggio ragazza mia” del paese delle meraviglie<br />
del ’65?), ignorano i traumi della mescalina e i riti ossessivi degli<br />
stregoni Guarani; e neppure si lasciano corrodere da tensioni autodistruttive<br />
o trasudano bianchi acidi d’insonnia. Se alla fine<br />
quello di Novelli sarà un cuore scoppiato e se la sua esplosione<br />
innescherà proiettili di fiori e di aquiloni sulle tele della lotta e<br />
dello scacco ( i quadri del Sessantotto ), da quest’altra parte v’è<br />
il demone della conservazione ed il cuore è una coppa che trattiene<br />
tesori, un organo ‘discenditivo’.<br />
Il cuore è in prima istanza naturalmente l’amore. Come il ramoscello<br />
secco di Stendhal disceso nella miniera di Salisburgo per<br />
illuminarsi di cristalli, il ‘cuore’ di Giosetta allunga le radici nel<br />
suolo, per confondersi nella terra e diventare materia. “De<br />
L’Amour: le (cœur) d’Alexandrine Petit 1807 - vie d’Henry Brulard”<br />
, leggiamo su una tavola. E da qui viene la recitazione visiva<br />
sui quadri, quell’aggraziata offerta dei sentimenti e primo<br />
grado manifesto dell’emozione che la mano deposita sulla superficie<br />
come una pellicola di garza.<br />
Ma il cuore è, nella logica della metamorfosi, anche la forma dell’apparire<br />
e del trasformare. La formatività in atto della magia<br />
evocativa. Che cosa dicono le istruzioni? Che la scintilla del meraviglioso<br />
si accende al comparire delle “fate in forma di CUORE”<br />
nel buio dell’indicibile. Il cuore è la forma che lascia trasparire e,<br />
per un attimo, rivela. Filtro che inghiotte e rigenera. Ed allora si<br />
dilata fino ad ospitare altre presenze-apparenze, assorbendole<br />
nel suo perimetro. “Si moltiplica sempre” perchè ha la forza d’attrazione<br />
e il suo mettere in luce è irresistibile. Qualche volta compie<br />
l’esercizio funambolico di ospitare perfino se stesso: un cuore<br />
sulla scena del cuore, contemporaneamente perimetro ed attore.
G. Fioroni, Invenzione del filtro d’amore, 1979, acquarello, cm 24x18 (copertina).<br />
386
G. Fioroni, Il ripostiglio proibito, 1979<br />
acquarello, cm 24x18.<br />
È un cuore che riflette la propria natura, si raddoppia in uno specchio<br />
più grande, sullo schermo-palcoscenico della pittura.<br />
Vien fuori in quel momento il piacere raffinato di esporsi a sé e<br />
agli altri, per godere della propria bravura.<br />
Scatta la vertigine esibitiva della finzione, il narcisismo dell’atto-<br />
387<br />
re, dell’antico ypocritès e del clown.<br />
Ecco, il cuore si mostra: mai aussi je suis peintre!<br />
(1) Scritto in occasione della mostra “Fiaba di magìa. Opere 1962-<br />
1972”, Casa del Mantegna, Mantova e Galleria civica di Suzzara (Mantova),<br />
novembre-dicembre 1979.
Il disegno e la scena (1)<br />
A differenza del design industriale, il bozzetto di scena non ammette<br />
l’idea di serie e di ripetizione. Partecipa esso stesso della<br />
natura effimera dell’oggetto cui allude, di uno spazio minacciato<br />
dal tempo e di una realtà che muore con la chiusura della rappresentazione.<br />
Aiuta a ricordare un evento irripetibile o contiene<br />
il progetto d’una invenzione: in questo doppio senso è un luogo<br />
denso di pensieri, una virtualità. Interrogarsi sul rapporto disegno-spettacolo<br />
vuol dire indagare sostanzialmente la natura<br />
delle immagini e degli oggetti concreti nell’hic et nunc della<br />
scena, poiché dal disegno (coreografico, registico, scenografico,<br />
architettonico, ecc.), prende vita lo spazio in cui gli attori si muovono,<br />
recitano e delineano figure col proprio corpo.<br />
Ciò che vien da dire allora, in primo luogo, è che l’immagine teatrale<br />
contemporanea ha perduto docilità e trasparenza. Essa è un<br />
dato conflittuale, un oggetto visivo col quale ci si scontra. Un<br />
ostacolo attivo. Ma qui occorre precisare. Poiché la legge del<br />
conflitto costituisce da sempre uno dei cardini dell’evento teatrale.<br />
Difatti, senza l’intervento di una controforza che ponga in<br />
scacco il flusso dell’azione, si avrebbe la proliferazione infinita<br />
del racconto o il tempo assoluto della lirica, ma non la speciale<br />
Il disegno per la scena, Quadratura del Bibiena.<br />
388<br />
tensione del tempo teatrale, fatto di soste, inceppamenti, rilanci<br />
e culminazioni. Ora quel che caratterizza il pensiero scenico attuale,<br />
nel campo dell’immagine, non è certo la scoperta, ma il<br />
sovrapotenziamento della categoria, ormai non più privilegio<br />
della parola drammaturgica, ma principio costruttivo dell’edificio<br />
plastico o pittorico della rappresentazione, degli attrezzi, dei praticabili,<br />
dei fondali, degli elementi di raccordo fra palcoscenico e<br />
sala, e così via. Difatti una caratteristica saliente della scena contemporanea<br />
è costituita dalla presenza di oggetti simili a personaggi,<br />
dotati di una grande forza d’urto, spesso antagonistici nei<br />
confronti dell’attore e del pubblico. Mentre, in passato, il cubo<br />
scenico era un involucro illustrativo entro cui ambientare segni<br />
teatrali di portata superiore, essendo al servizio della parola e<br />
della musica cui la cultura attribuiva un’altissima funzione spirituale,<br />
ora lo spazio non si limita ad ospitare i tradizionali detentori<br />
della peripezia drammatica, ma genera esso stesso dei conflitti.<br />
Immagini e oggetti, o quel che si suole definire “atmosfera<br />
scenica”, si caricano di forze e di antiforze. Che operi in accordo<br />
o in frizione con l’attore, lo spazio comunque si anima e<br />
talora produce, come nelle esperienze cinetico-visive, il tempo e<br />
il movimento. Tale ruolo è soprattutto visibile nella particolare visione<br />
assegnata all’oggetto.<br />
Attraverso l’oggetto-personaggio e la sua “rivolta”, si disegna la<br />
chiusura dei modelli razionalistici del pensiero nati con l’Umanesimo<br />
e s’incrina la dottrina antropomorfica del mondo. Da qui<br />
viene l’esigenza di un mutato rapporto con la vita: un rapporto<br />
in cui riaffiora l’interrogazione sul senso delle cose. Per di più<br />
l’immagine sfugge alla determinazione, non si lascia catturare in<br />
una formula otticamente conclusa: vive, si trasforma, negandosi<br />
al dominio del disegno razionalistico che pretende di amministrare<br />
anche il linguaggio dell’arte.<br />
Un esempio evidente della genesi figurativa di molta scena contemporanea<br />
può essere indicato nella ricerca di Mario Ricci, i cui<br />
esordi si collocano al di fuori della pratica attoriale, in quel nucleo<br />
problematico che, dall’inglese Craig, al quale risale la prima<br />
sistematica formulazione di teatro astratto, fino all’atlante dei<br />
movimenti della danza proposto da Schlemmer, è andato tematizzandosi<br />
nel motivo della marionettizzazione dell’attore. Prima<br />
ancora di far posto alla marionetta, Ricci si occupa anzi di spostamenti<br />
semplici e, mettendo in scena brevissimi spettacoli di
forme astratte (con sculture e oggetti tridimensionali, quindi con<br />
un massimo di spersonalizzazione), analizza gli elementi primari<br />
del movimento, i dati nucleari del linguaggio teatrale. L’uso<br />
dell’automatismo e dell’oggetto meccanizzato porta più tardi in<br />
gioco, con un decisivo arricchimento delle ipotesi di lavoro, il<br />
tema del caso, dell’effrazione della regola, dell’imprevisto. Il che<br />
avviene, per altro, grazie ad una significativa convergenza di interessi<br />
con gli artisti di “Grammatica”, Novelli e Perilli. Di lì a<br />
poco, il regista approda al problema dell’attore, del corpo vivente<br />
sulla scena, tema ormai classico dopo Schlemmer, Moholy-<br />
Nagy e Vera Idelson che, alla fine degli anni Trenta, aveva riassunto<br />
la questione nei termini seguenti: “Gordon Craig e Maeterlinck<br />
- i portatori del teatro simbolista - presagendo la marionetta<br />
non ne compresero il valore reale e caddero nell’errore di<br />
questo movimento: statuerismo”, idolatria della fissità scultorea<br />
e dell’inorganico. “Nel teatro moderno - aggiungeva, ed è questo<br />
il problema di Ricci - possiamo gestire simultaneamente i<br />
due dinamismi: l’umano e il meccanico, quello dell’attore uomo<br />
e quello della marionetta, creando su due e più piani, sia simultaneamente<br />
sia per sovrapposizione, una specie di contrappunto<br />
dinamico-plastico e ritmico”.<br />
Dato il carattere sacro della statua, della marionetta “divina”, un<br />
simile confronto fra Umano e Immobile contribuì a rilanciare<br />
suggestivamente un’idea di teatro tragico che pareva estinta<br />
nell’universo laico della modernità: tragico perché escludeva, nei<br />
modi peculiari dell’immaginazione figurativa, la soluzione rassicurante<br />
del dramma, essendo le polarità opposte dell’umano e<br />
del cosmico interagenti, in perpetua conflittualità.<br />
L’automatico e l’oggettuale dunque, come energia di scontro; e,<br />
oltre a ciò, l’analisi dell’immagine e del movimento quale premessa<br />
alla rigenerazione del teatro. È questo, di Ricci e dell’intera<br />
“scuola romana”, un momento di scambio fra le due figurazioni,<br />
della pittura e del teatro fra i più intensi del secondo dopoguerra.<br />
Basterà ricordare, sul versante del disegno, gli esercizi di<br />
Perilli, Novelli e Scialoja (le sequenze ritmiche, il tempo del segno<br />
sulla superficie), e per quanto concerne la teatralità, la ripresa da<br />
parte di un Carella delle anticipazioni di un Prampolini o di un<br />
Balla: l’idea dell’attore-spazio, la drammatizzazione della luce.<br />
La tentazione ‘figurativa’ ha determinato però, a lungo andare,<br />
almeno in un certo giro di esperienze, una sorta di dittatura dello<br />
389<br />
sguardo, un otticismo eccessivo, benché non si possa negare che<br />
proprio dalle arti visive sia venuto un apporto rilevante per la<br />
nuova scena. Si è cercata perciò una maggiore fisicizzazione,<br />
esplorando inedite modalità spaziali, coinvolgenti e polisensoriali,<br />
in cui lo spettatore si trovasse immerso pur restando consapevole<br />
in ogni momento della finzione scenica. È quel che accade,<br />
per esempio, con Quartucci, la cui ambizione è stata, ed è,<br />
quella di creare una spazialità espansa, in costante proliferazione:<br />
luogo di immersione sensoriale e insieme di straniamento,<br />
di viva partecipazione al gioco costruttivo dell’azione, ma di rifiuto<br />
altrettanto vigile ad identificarsi coi personaggi.<br />
Di importanza capitale la presenza dell’oggetto anche nel lavoro<br />
teatrale di Carmelo Bene e di Luca Ronconi, ben difficilmente<br />
iscrivibili nell’area dell’Immagine, ed anzi duramente polemici<br />
nei confronti di certi gruppi sperimentali.<br />
Bene si circonda di figure, di una attrezzeria sgargiante e ricchissima,<br />
irrealizzante e artificiale. È il ciarpame, il magazzino delle<br />
Spettacolo nella sala del teatro del Buontalenti al Palazzo degli Uffizi di Firenze.
Orlando Furioso, testo di Edoardo Sanguineti e Luca Ronconi, 1968 (foto Signon).<br />
390
suppellettili del grande attore, l’archivio del teatro. Con questo<br />
repertorio scenico, da fantomatica sartorìa barocca e liberty , instaura<br />
un gioco linguistico, fatto di citazioni, aggressivo. L’autore<br />
vi si trova impigliato, impedito, avviluppato, ma anche travestito,<br />
superdecorato, specchiato. L’oggetto muto, cangiante e insieme<br />
ottuso, è costretto a seguire il dettato della recitazione; viene<br />
Baruchello, Cinq ans apres, inchiostro nero su carta e plexiglas (3 livelli), cm 40x40x3.<br />
391<br />
agitato, mosso, spostato fino a diventare una potenziata materializzazione<br />
della voce e del gesto, d’una parola fisicizzata e<br />
comportamentale, che prolifera da se stessa, sulle proprie tracce<br />
materiche, si riproduce per autocitazione. Ma a differenza di<br />
altri registi, Bene, convoca paragrafi e frammenti figurali, non<br />
cita globalmente il reperto visivo; e quando cita, subito trasfor-
ma, rende irriconoscibile, rifà. Che si tratti di un motivo simbolista<br />
di Beardsley o di un elemento cubofuturista, questo viene<br />
sottoposto a rigenerazione, in certo modo tramutato e fatto rivivere<br />
nella realtà autonoma dell’opera teatrale. Dalla cultura dell’archivio<br />
alla cultura viva, o, se si vuole, da una cultura divenuta<br />
abitudinaria e ottusa esistenza, datità congelata, all’artificio:<br />
una poetica, questa della riscrittura, intorno alla quale si è imperniato<br />
l’intervento scenico di Marotta in alcune opere di Bene,<br />
per esempio in “Nostra Signora”.<br />
Perciò si può dire che la scenografia beniana, è, all’inizio, cosa<br />
morta, suppellettile opaca, membrana impediente, mentre si<br />
anima poi e rinasce, come materia della scrittura scenica, resistente<br />
da lavorare, ma infine travolta dal corpo e dalla recitazione<br />
dell’attore. L’oggetto e l’immagine, dunque, come materia di<br />
lavoro, non come pretesto edonistico, godimento ottico, puro e<br />
semplice plaisir. Dal già fatto, dal preesistente, prende avvìo<br />
anche la strutturazione oggettuale di Ronconi. Soltanto che il<br />
ready-made è chiaramente riconoscibile, mantiene la sua identità,<br />
e per di più un’identità ad altissimo grado, come nel Riccardo<br />
III, poiché si tratta di scultura di un’opera che rivive intatta<br />
anche dopo la rappresentazione.<br />
Potrebbe parere estraneità ed invece è integrazione, poiché, per<br />
Ronconi, anche la scenografia è personaggio, architettura recitante<br />
ed infine tessera attiva di una grande macchina spettacolare.<br />
E non a caso, proprio ad uno scultore di “macchine”, di edifici<br />
e percorsi spaziali, si è rivolto nell’allestimento delle opere di<br />
Shakespeare e Giordano Bruno: Mario Ceroli; e di nuovo a scultori<br />
per le messinscene di Kleist, Eschilo, Seneca e Sternheim:<br />
Job e Arnaldo Pomodoro.<br />
Il momento forse più radicale di un simile atteggiamento cade,<br />
data l’irriducibile qualità stilistica dell’oggetto, nel lavoro in comune<br />
con Ceroli, che ha rimontato e ambientato per l’Enrico III le<br />
sue precedenti invenzioni: la gabbia a tre parallelepipedi concentrici,<br />
la sfilata delle sagome lignee della Cina, la sfera pacioliana.<br />
Se le sculture di Ceroli sono già di per sé delle citazioni (e rinvii<br />
alla storia delle immagini), l’inserimento plastico per Ronconi<br />
serve a costituire l’universo in cui ospitare il dramma, da far interagire<br />
col testo, nel lavoro d’incastro fra sistemi situati in parallelo,<br />
in consonanza/dissonanza: soprattutto architettura percorribile,<br />
serie di praticabili, attrezzi per il movimento.<br />
392<br />
Sussiste poi tutto un versante del lavoro teatrale, lontano anch’esso<br />
dal teatro dell’immagine, i cui legami con la pittura e il<br />
disegno si svolgono in modo più interno, filtrati e tradotti nel<br />
linguaggio specifico del volto, del gesto e delle positure degli<br />
attori: e qui i riferimenti si moltiplicano, andando da Magritte a<br />
Duchamp a Bacon, dalla figurazione orientale a quella manieristica<br />
e barocca. Per esempio in Michele Perriera, per il cui teatro,<br />
certo non casualmente, sono stati rintracciati echi e suggestioni<br />
di Füssli, Rosso Fiorentino, Burri, coniugati secondo una<br />
complessa partitura di rinvii archetipi e ironìa.<br />
Di fronte al teatro la pittura: a sua volta anch’essa rifà lo spettacolo,<br />
riflette sui miti e sulla magìa spettacolare. È una lunga tradizione<br />
del moderno: comincia con Manet, Degas, Seurat, e prosegue<br />
ininterrottamente. Dentro la cornice il boccascena, il teatro<br />
nel teatro: rito multiplo in cui figure e meccanismi spettacolari<br />
si prestano ad una analisi della finzione. Esibizione del cerimoniale<br />
borghese dello spettatore, come nell’affiche di Brunetta<br />
sulla ‘prima’ alla Scala. E soprattutto, sul versante d’una strenua<br />
ricerca formale, i ‘teatrini’ di Melotti e di Fontana, di Baruchello<br />
o di Baj.<br />
(1) Scritto contenuto in “Disegno italiano. Forma, progetto e produzione”,<br />
edizioni Redoff, Milano 1979.
Raffigurare per indizi<br />
Lucia Tampellini (1)<br />
È più reale una cosa o la sua rappresentazione? La foglia vera o<br />
l’immagine riprodotta? Per Lucia Tampellini non lo sono né l’una<br />
né l’altra, poiché entrambe vengono accolte a pari titolo nell’universo<br />
della finzione. C’è piuttosto un doppio livello della<br />
menzogna: quello risaputo ed inerte dell’oggetto chiuso in se<br />
stesso, che ha fatto corpo con l’abitudine, tanto da coagularsi intorno<br />
ad un senso; e quello inventivo della immaginazione che<br />
rifiuta di oggettualizzarsi. Si vela anzi e scorre dietro le effigi,<br />
sotto i simulacri.<br />
Dove la cosa si spezza, lì stanno le risorse dell’immagine.<br />
L’invenzione assomiglia a una busta e a un diaframma: una soglia<br />
che dà sul luogo delle sorprese, un limite di per sé meraviglioso<br />
poiché rende enigmatico ciò che promette e rinchiude.<br />
Dietro il velo la cosa scompare per riacquistare lo statuto dell’oscuro<br />
e del doppio.<br />
Le materie e i frammenti oggettuali appuntati sulle superfici o custoditi<br />
sul fondo delle teche non sono più gli stessi, cessano di appartenere<br />
alla realtà da cui provengono. Diventano segni, forme<br />
ed elementi di scrittura. E all’interno della scrittura entrano in<br />
gioco delle latenze, dei sensi dimenticati o possibili, delle virtualità.<br />
Le forme inoltre restano sospese, le frasi pronunciate e subito<br />
interrotte. Nel tempo e nello spazio aurorale dell’immagine<br />
nulla ha modo di appesantirsi nel tutto tondo della presenza, nell’esaurimento<br />
di una pronuncia. Se intravedo una figura, è in realtà<br />
il suo volto velato a lasciarsi cogliere, qualcosa che non è ciò<br />
che sembra. Parrebbe un corpo ed è invece un riflesso.<br />
Osservo un collage, un ricalco da Piero: una folla di figure, armi,<br />
uomini, cavalli. Ma quali figure? Trovo soltanto contorni, margini<br />
e profili. La sostanza, la carne dei personaggi è come svanita,<br />
scomparsa. Al suo posto affiorano tanti tasselli colorati; segnali e<br />
indizi. Chiamano qualcosa che è stato o sta per nascere? Non so<br />
dirlo, ma credo sia importante l’attesa, non la risposta. Per di più<br />
si tratta di indizi racchiusi in una sorta di involucro, di segnali sottilmente<br />
disposti lungo una sequenza di superfici senza peso. Difatti<br />
anche l’involucro è privo di rilievo: un puro contorno che fa<br />
pensare ad una stanza senza muri, ad un edificio trasparente,<br />
come se lo sguardo abitasse lo spazio aereo.<br />
393<br />
In un altro collage viene proposta “la battaglia” di un pittore che<br />
odiava gli oggetti e delirava per piani spaziali. Marcel Schwob lo<br />
ricorda scrivendo che “nessuno capiva i suoi quadri. Non si vedeva<br />
che un intreccio di curve. Non si scorgevano più né la terra,<br />
né le piante, né gli animali, né gli uomini”. Prismatizzava, segmentava<br />
ogni cosa. Ed anche nel collage si procede per via di<br />
tagli, così da avere una parte e non tutta la battaglia. Il frammento<br />
è poi piegato, strappato in qualche punto, costretto a seguire<br />
delle linee di sviluppo che non sono fredde analisi, ma<br />
reinterpretano e rilanciano la composizione. Linee di frattura, ferite<br />
nel corpo del quadro. Tutt’attorno gira una catena di luoghi<br />
immaginari e corrono metodicamente dei riquadri. Si aggiunge<br />
qualcosa che non c’era e al tempo stesso si riconosce il modello,<br />
la catena costruita intuitivamente restituisce l’ossessione più<br />
acuta di Uccello, l’icona-fantasma riassuntiva del suo delirio: la figura<br />
del “mazzocchio”. Ed è un bella sorpresa.<br />
Questo corpo smaterializzato, diamantino, emergente per via di<br />
riflessi e di rispecchiamenti parla in favore dello svanimento<br />
delle forme, del loro morire e rinascere, ripresentarsi senza fine.<br />
Valgono dunque la figura memoria e la figura presentimento,<br />
come stazioni da cui ricominciare.<br />
Che cosa in realtà ricomincia? Che cosa sta in sospensione se<br />
non una tensione al racconto?<br />
Su un altro foglio è disegnato un petalo di rosa, un poco accartocciato,<br />
sfiorito. Una spoglia. Eppure non designa il termine<br />
estremo di un tragitto. È vero anzi il contrario: è lo spunto sul<br />
quale si aprono figurazioni: non uno, ma una serie di racconti.<br />
Quel petalo catalizza pagine ed oggetti, che vi si raccolgono circolarmente<br />
o si ammucchiano di lato. Tanti fogli di diario, con<br />
suggestioni di storie: a destra “Chateau d’Antibes”, “Abbaye de<br />
Senanque”, ”Paris”, ”Avignon”, e così via.<br />
La superficie funziona come un campo d’attrazione per immagini<br />
in attesa e il petalo di rosa ne è la forza inaugurale, il magnete.<br />
Lucia mi ha lasciato un appunto sotto la rubrica Del ritrovarsi:<br />
“dietro le immagini / l’ombra dell’immagine / la funzione / ho<br />
ancora il racconto / il costruito / la trama / la traccia / il supporto<br />
/ il silenzio.”<br />
(1) Scritto in occasione della mostra collettiva “Arcipelago”, tenutasi<br />
presso la Galleria Civica, Modena, 26 gennaio-24 febbraio 1979.
La fatica della pittura (1)<br />
“Mi consacrerò ormai esclusivamente al teatro / come lo concepisco<br />
io / un teatro di sangue” 1 , scrive Artaud nel febbraio del<br />
‘48. Ed anche: “vedrete il mio corpo attuale / volare in pezzi /<br />
e ricomporsi / sotto diecimila aspetti / notori / un corpo<br />
nuovo” 2 .<br />
Il teatro e nient’altro.<br />
Quell’ormai e quell’esclusivamente, così estremi, dialogano per<br />
l’ultima volta con una pratica sacrificale, la pittura, sulle cui ragioni<br />
l’Autore non intende più soffermarsi; vi dialogano, ma per<br />
respingerla lontano, con i suoi effetti mortali, con le sue procedure<br />
volte a sanare la natura. Non l’uomo.<br />
Perché mortali? E perché fatalmente insufficienti nei confronti<br />
del corpo proprio?<br />
Occorre fare un salto indietro, di almeno un anno.<br />
Tutto il 1947 è infatti ricco per Artaud di “ragioni pittoriche”: senz’altro<br />
uno dei più intensi da questo punto di vista, anche in rapporto<br />
all’epoca giovanile e alla successiva fase metafisica, a cui<br />
pure risalgono l’idea del quadro come prefigurazione della scena<br />
“ardente” e la nozione, non meno decisiva, di “teatro muto”.<br />
È di quell’anno la stesura del Van Gogh - Le suicidé de la société,<br />
il mirabile testo composto dopo la scoperta (folgorante) dell’opera<br />
vangoghiana all’Orangerie: un testo di difficile classificazione,<br />
simultaneamente saggio, invettiva, racconto, lettera, dialogo,<br />
meditazione sulla “poesia” e poesia in atto. Teoria della<br />
creazione e processo creativo al tempo stesso. Leggendolo si ha<br />
l’impressione di immergerci in una colata scritturale. Contemporaneamente,<br />
però, questa fluenzialità della parola scritta (che ha<br />
ben poco da spartire, tuttavia, con la normalità della pagina),<br />
questa irruenza della parola risulta sottoposta ad un ferreo martellamento,<br />
ad un lavoro di compressione compositiva, di concentrazione<br />
del segno. È lavorata e nient’affatto abbandonata a<br />
se stessa, fatta defluire scompostamente. C’è anzi, all’interno del<br />
Suicidé – e qui anticipo un’osservazione che sarà tanto più evidente<br />
nell’interpretazione tematica – un movimento di andata e<br />
ritorno, un respiro a registro duplice, ora largo ora contratto, ora<br />
lento ora fulmineo: una sorta di musicale dissonanza e di scontro/incontro<br />
di opposti.<br />
Si tratta inoltre d’una parola d’istigazione, nel senso che spinge<br />
394<br />
ad andare oltre il linguaggio, al di là della parola piena, sia perché<br />
culmina in formazioni neofasiche, in inediti grumi di parole,<br />
in glossolalie, sia perché rinvia ad altro da sé, mentre denuncia<br />
la propria miseria descrittiva ed interpella le ragioni della vita,<br />
della realtà “vera”. E proprio in una simile tensione all’eccedenza,<br />
che è, per la lingua, un andare attraverso e insieme fuori di<br />
sé, un esplodere e un mettersi da parte, si situa una pratica antifantasma<br />
del segno.<br />
“Non ci sono fantasmi nei quadri di Van Gogh, né visioni né allucinazioni”<br />
3 . Lo stesso può ripetersi per la parola artaudiana, così<br />
intrisa di materie corporee: suono, rumore, ritmica respiratoria,<br />
giacché, proprio restando dentro lo statuto della lingua, accogliendo<br />
e modellando il codice in articolazioni essenziali, si illumina<br />
l’oscurità installatasi tra i segni e le cose.<br />
Di mezzo c’è infatti la mediazione della viva voce, della phoné,<br />
d’una parola articolata e pensata attraverso la recitazione. Paule<br />
Thévenin ne è buona testimone. Fu lei a trascrivere sotto dettatura<br />
un testo che veniva facendosi, o meglio ri-facendosi sulla<br />
traccia di appunti e di note composte febbrilmente da Artaud nei<br />
giorni successivi alla apertura della mostra. Sicché la parola fu<br />
prima manoscritta, poi detta ed infine riscritta, dattilografata e<br />
stampata, ricorretta in ogni caso, sempre, da una “redazione vocale”,<br />
come sottolinea la Thévenin che ha ricomposto con cura<br />
infinita le varie fasi della crescita testuale nell’edizione critica del<br />
Dossier4 .<br />
Artaud, si potrebbe dire parafrasandolo, parla-scrive “corto”, sta<br />
addosso alle cose, così come Van Gogh peint court: “dipinge<br />
corto, convulso, serrato, addossato: semplifica, infine tratteggia,<br />
e organizza la sua melodia. [...] / E tuttavia non è vero! / Non<br />
tratteggia, non organizza, non ha gamma. Dipinge corto ma la<br />
sua efficacia è lunga. La pennellata più che infinita. Il disegno<br />
corre all’infinito sotto la sua rotazione sempre più precipitosa” 5 .<br />
Il peindre court è dunque questo restare dentro la soglia del<br />
testo, del procedimento pittorico, per oltrepassarlo, scuoterlo a<br />
tal punto da moltiplicarne la potenza. Col Suicidé, occorre ripetere,<br />
non si esce da una trama testuale, ma questa trama viene<br />
sottoposta al registro paragrammaticale della irregolarità. Voglio<br />
dire che la grammatica vi è continuamente convocata e al<br />
tempo stesso oltrepassata. Anzi, per essere più precisi, la grammaticalità<br />
convive fianco a fianco col paragrammatismo, ne è la
piattaforma e il luogo di nascita. Quando le invenzioni glossolaliche<br />
esplodono, mettono a fuoco tutto un materiale linguistico,<br />
fonetico e semantico, che l’Autore è andato adunando, a strati<br />
sempre più densi, nel processo dell’invenzione. Nella glossolalia<br />
viene così a convergere un fascio di tensioni che si agitano negli<br />
antefatti discorsivi6 e si diramano poi nelle riprese e nelle calcolatissime<br />
aggiunte dei post-scripta. Post-scripta di post-scripta.<br />
Agisce inoltre, a molti livelli, un processo ininterrotto di fissionalità,<br />
di ribaltamento. Nomi, concetti, figure, immagini si spaccano<br />
in due. C’è un divaricarsi dei segni in polarità opposte, cui bisogna<br />
prestare attenzione.<br />
Il rovesciamento degli estremi riguarda tutta una serie di luoghi<br />
tematici. Per restare nel Van Gogh, basterà considerare le situazioni-limite<br />
connesse ai topoi ossessivi di “natura”, “pittura”,<br />
“uomo”, “vita”, “realtà”. L’opposizione vita vera / vita falsa è<br />
una di queste tipiche dicotomie. Da un lato, lo si registra più<br />
Antonin Artaud, Le Totem 53, 1945, matita e gessi colorati, cm 63x48.<br />
395<br />
volte, sta la decadenza, la debolezza, l’impietramento di pratiche<br />
e valori.<br />
C’è stato d’inerzia e di fissità. Dall’altro quei medesimi universi,<br />
della natura e dell’arte, si schiudono, in profondità, alla fatica<br />
della rigenerazione. Riaccendere i Princìpi appare possibile solo a<br />
patto di uno smantellamento, dentro un paesaggio di rovine e di<br />
corpi svuotati. La maschera, la falsa effigie, è muro da abbattere<br />
e, insieme, materia da strizzare per aprire un varco alla scintilla<br />
che vi sta imprigionata. Anche la lingua.<br />
“Tutta la scrittura è porcheria”, suona la notissima sentenza del<br />
primo Artaud. Ma di questa porcheria può darsi un uso compiaciuto,<br />
estetizzante, maligno (è l’accusa rivolta all’Autore di Jabberwochy:<br />
“un profittatore che ha voluto pascersi intellettualmente,<br />
lui, già ben pasciuto d’un pasto ben abbondante, pascersi<br />
del dolore altrui”), un uso che non ha nulla da spartire con la<br />
‘fame’, la creazione dal basso, dalle scorie e col fuoco, d’una lingua<br />
nuova, che è frutto di fatica e di orrore. “Si può inventare la<br />
propria lingua – cito da una lettera del ‘45 – e far parlare la lingua<br />
pura con un senso extragrammaticale, ma bisogna che questo<br />
senso sia valido in sé, cioè provenga da orrore, – orrore questa<br />
vecchia serva di fatica, questo senso di gogna sotterrato che<br />
fa venir fuori i versi dalla propria malattia: l’essere, e non sopporta<br />
che lo si dimentichi7 .<br />
La stesura del Van Gogh, tenuto conto dei suoi scarti e della<br />
struttura finalmente adottata, poggia sul doppio movimento<br />
della frantumazione e del coagulo. Le proporzioni si accavallano,<br />
dialogano quasi e si incalzano, in capitoli e paragrafi. Poi, di<br />
colpo, la materia verbale (vocale) si inerpica in costruzioni vertiginose,<br />
in figure intensive di pura consistenza vibratoria e transrazionale.<br />
Restare perciò dentro il testo vorrà dire mantenersi dentro la ‘fucina’<br />
di Artaud, esattamente come lui stesso rigettava la leggenda,<br />
il mito di Van Gogh, per essere a contatto, in presa diretta,<br />
con l’opera scritta e pittorica dell’artista olandese, con le sue<br />
lettere e i suoi quadri. In lui, certo, la distanza è annullata anche<br />
da una spiritata volontà di identificazione, di scambio, che è una<br />
costante delle sue pagine sugli ‘illuminati’ (da Paolo Uccello, a<br />
Nerval a Poe). Ma accanto ad un simile ed interamente fantastico<br />
addossamento mentale, agisce la coscienza di una necessaria<br />
traversata testuale, poiché la traccia dell’esperienza vango-
ghiana è consegnata al linguaggio specifico della pittura. Non<br />
solo: proprio questo linguaggio l’ha resa possibile.<br />
Se poi la presenza dell’immagine segna la debolezza d’un codice<br />
fatalmente condannato alla rappresentazione, la forza di Van<br />
Gogh, la singolarità del suo gesto, sono consistiti appunto nell’aver<br />
afferrato il ‘motivo’, la figura, e nel metterli a morte, nello<br />
svuotarli.<br />
È dunque di un attraversamento che bisogna parlare, non di un<br />
accostamento per metafora e per somiglianza. Con insistenza<br />
davvero estrema, nel corso delle stesure provvisorie e della redazione<br />
definitiva, Artaud sottolinea8 questo attraversare e andare<br />
oltre, questo superamento per implosione: “[...] Van Gogh<br />
finirà davvero col risultare il più intensamente pittore di tutti i<br />
pittori, il solo a non aver voluto oltrepassare la pittura come<br />
mezzo specifico dell’opera e rigorosa cornice dei suoi mezzi. / È<br />
il solo, d’altra parte, assolutamente l’unico che ha oltrepassato la<br />
pittura, l’atto inerte del rappresentare la natura, per far zampillare,<br />
in questa rappresentazione esclusiva di essa, una forza vorticosa,<br />
un elemento strappato alla viva carne”.<br />
Artaud chiede quindi al lettore di stare vicino ai resti, alle tracce,<br />
ai documenti. Ha ragione J. Derrida a voler salvaguardare la “proprietà”<br />
della traccia, la solidarietà fra l’ergon, l’opera, e l’energeia,<br />
l’azione, la forza che produce9 . La prossimità forma-vita. È<br />
questa, d’altronde, un’antica persuasione di Artaud, più volte ribadita<br />
anche a proposito della pittura, per Piero di Cosimo e<br />
Mantegna, non meno che per Masson o Balthus10 . Una scrittura,<br />
un testo (benché un simile termine sia ai suoi occhi così compromesso),<br />
un dipinto si iscrivono nel teatro della creazione,<br />
della metamorfosi infinita dell’essere, allorché “la forma è ancora<br />
ardente perché prossima all’essenza che le ha dato origine” 11 .<br />
Se raffreddata, la traccia si oggettiva nelle figure dell’Inerte e<br />
della Menzogna.<br />
Restare nel testo assume allora quest’altro significato: gettarsi<br />
nella genesi, dentro il suo movimento insurrezionale. Sicché l’architettura<br />
del discorso vive per le tensioni che le consentono di<br />
mantenersi nel calor bianco di una accensione prolungata. La<br />
struttura del paragrafo e del capitolo è dinamica: si apre, si chiude,<br />
torna ad aprirsi. Lo scrivere, voglio dire, è un gesto e un’azione,<br />
una sorta di action writing. Si lacera e lascia trasparire, decostruendosi,<br />
un senza fondo di energia. La ‘rappresentazione’,<br />
396<br />
il suo velo e la sua finzione, vengono sì gettati nell’abisso, ma<br />
perché parlino di una potenza che li eccede.<br />
La pittura vangoghiana, così come la interpreta Artaud, ricorre all’immagine,<br />
intesse il velo della forma e si addentra nei segreti<br />
dell’armonìa. Subito dopo, però, scatena un evento di segno contrario,<br />
così violento che il quadro, prima colmo di figure e stipato<br />
di segni, si svuota di senso. Ecco come prosegue e finisce il<br />
brano appena citato sul “dipingere corto”: il disegno “non ha<br />
senso né melodia. La sua musica ha lasciato la tela, la sua pittura<br />
ha svuotato il quadro per penetrare nella vita” 12 .<br />
Al primo tempo segnato dall’accumulo compositivo segue dunque<br />
il momento, senza armonìa piuttosto che disarmonico, del<br />
silenzio, della attesa di vita. Non solo la pittura si è trasferita altrove,<br />
ma ha anche sacrificato la tela, facendone il luogo della<br />
concellazione.<br />
Una messa a morte dell’opera? Una pittura che annienta la pittura<br />
e si scontra col proprio statuto rappresentativo? Che cos’è<br />
dunque la pittura?<br />
Anche qui la nozione si sdoppia. Non soltanto perché Artaud separa<br />
una pittura vera da una falsa, decaduta e inerte: distinzione<br />
per altro ossessivamente ribadita fin dall’epoca giovanile nell’aprirsi<br />
delle dicotomie fra linearismo e magìa, sentimento medievale<br />
del tragico e gelo cartesiano di neoclassici e cubisti13 ; o,<br />
negli anni della maturità, fra cultura messicana e Occidente. Il<br />
fatto è invece che lo sdoppiamento opera nel cuore stesso dell’azione<br />
pittorica segnandola di una opposizione irriducibile.<br />
“Qual è la tecnica del pittore?”, si chiede Artaud. Alla domanda<br />
fa seguire due risposte simultanee, tra loro paratatticamente<br />
congiunte, benché latrici di polarità estreme ed opposte. Ciò che<br />
le riunisce è una sorta di ottica coagulante in forza della quale i<br />
contrari vengono fusi e rilanciati uno contro l’altro. Per un verso<br />
quella tecnica si identifica col moto della materia allo stato puro,<br />
con la physis scatenata. Egli dice: “La natura”. Per un altro verso<br />
c’è la precipitazione dell’oggetto nelle pratiche di dominio della<br />
materia. “La gamma colorata del pittore – prosegue immediatamente<br />
– i suoi pennelli, il disegno, la ricerca di certi effetti” 14 .<br />
Avrà modo poi, l’Autore, di tornare più volte sulla caratterizzazione<br />
del mestiere, elencando mezzi e convenzioni della pittura,<br />
il suo statuto insuperabile (intendo la fatalità della figura e della<br />
significazione), e tutti gli elementi d’una compiuta professionali-
tà che appare tanto più autentica quanto più Van Gogh seppe<br />
conservare la semplicità originaria del dipingere, il suo articolarsi<br />
in segni ‘primi’ tenendosi lontano sia dall’eclettismo che dalle<br />
pronunce metaforiche e mitologizzanti, ‘alte’, di artisti a lui contemporanei<br />
(“non ha nulla d’impressionista, di simbolista, di romantico,<br />
di preraffaellita”) 15 . Tornerà a passare in rassegna gli<br />
strumenti di questo operaio della pittura (Car ce maître est un<br />
terrible ouvrier) 16 : tavolozza, pennelli, tela, tubi di colore, eccetera,<br />
e quando citerà un autoritratto, lo ricorderà accanto al cavalletto<br />
negli anni di Parigi; e spiegherà poi con quanta ostinazione<br />
Van Gogh si portasse a dipingere sul motivo per introdurvisi<br />
materialmente, seppellendosi nella matrice della terra. Nelle<br />
mani di Van Gogh gli strumenti si trasformano in mezzi di trasvalutazione.<br />
La tecnica è sì natura, ma natura potenziata e materia<br />
dominata.<br />
Tra natura e pittore il rapporto assume carattere agonale, violento.<br />
La pittura è guerra, polemos. Eccita gli elementi e le immagini<br />
che trova. Il pennello non deposita sulla tela i tratti delle<br />
apparenze, non accarezza né riscrive. Il suo movimento è piuttosto<br />
quello d’una macina: è martello, punteruolo, mazza, maglio.<br />
Un’arma, anziché uno strumento servile.<br />
“I suoi colori sono di piombo fuso, di calce viva frullata e frustata,<br />
lavorata con la spatola, martellata, bulinata, ferita con lo stiletto,<br />
il tagliacarne, il bisturi” 17 . Artaud elenca i colori, ne segna i<br />
registri, le armonìe e i contrasti, in pagine che tendono a riprodurne,<br />
per empatia, il ritmo convulsivo e il ‘suono’, ciò che a lui<br />
sembra il tratto vitale dominante del grande stile: il tropo della<br />
ripetizione ritmica, il ritorno d’una cromìa su se stessa, su un<br />
fondo di orchestrazione. L’enunciazione non serve a descrivere<br />
ma a creare un flusso e un martellamento. Si veda ad esempio<br />
questa ‘frase’ (poi espunta) sul tono aureo: “[...] Veronese, giallo<br />
oro, giallo oro, giallo oro, giallo oro, giacinto dei crepuscoli provenzali,<br />
poi giallo oro, verde erba, verde smeraldo, blu di Prussia,<br />
blu cobalto, sempre la stessa gamma ostinata ritorna...” 18 .<br />
A parte la valenza mitica, accesa e simbolica, dell’oro e del giallo<br />
(le cromìe giocano sempre un ruolo decisivo), conviene osservare<br />
il significato alternativamente forte e debole assegnato<br />
a termini come “natura”, “oggetto”, “cosa”, cui si lega anche<br />
l’oscillazione semantica della parola “motivo”.<br />
Il passaggio dal visivo al musicale, con l’eclissi dell’esteriorità ot-<br />
397<br />
tica e dell’effigie, segna in genere l’ascesa dal debole al forte,<br />
nonché il trasvalutarsi dell’immagine in una sinestesia di tono<br />
mistico. Quando motivo sta ad indicare l’argomento, l’oggetto<br />
puramente visivo della rappresentazione, tutta una costellazione<br />
di elementi negativi lo accompagna. È inerzia, freddezza, petrosità,<br />
vita mancata. Rappresenta l’esistente da riplasmare. È, oltre<br />
a ciò, il momento separato, l’universo in cui si è spento il senso<br />
della comunione e della simpatia cosmica.<br />
Motivo nell’accezione del senso comune: ciò che si vede. Per<br />
metamorfosarlo in sostanza musicale, occorre prenderne possesso,<br />
annullare la distanza tra cosa e pittore. Ecco dunque il “povero”,<br />
il “puro” Van Gogh portarsi ‘dentro’ il motivo, cancellare la<br />
separatezza di soggetto-oggetto. Doppiamente illuminato (dal<br />
suo sapere di solitario e da una corona di fuoco: nello spostamento<br />
simbolico d’un episodio biografico), lo vediamo esercitare<br />
la ‘logica’ della fusione che è d’una figura che porta la ‘salute’:<br />
“[...] non è certo delirante passeggiare di notte con un cappello<br />
illuminato da dodici candele per dipingere sul motivo un<br />
paesaggio” 19 .<br />
Qui irrompe il momento dell’orchestrazione pittorica. Il colore si<br />
fa musica, suono e ritmo. “Che cos’è infine il motivo? Se non<br />
qualcosa come un’ombra ferrea del mottetto d’una antica musica<br />
indicibile, come il leitmotiv d’un tema disperato del suo soggetto?”<br />
20 .<br />
Il “motivo” musicalmente potenziato, divenuto canto primordiale,<br />
Leitmotiv, vince l’opaca gravità della materia bruta: la disfa in<br />
vibrazioni. Il grande Stile, la forma tragica. Il “motivo” si metamorfosa<br />
così nell’architettura stessa del ‘dramma’ pittorico, nella<br />
sua intima struttura compositiva. Non ha forse osservato anche<br />
Nietzsche che “si è artisti al prezzo di sentire come contenuto,<br />
come la cosa stessa quel che i non-artisti chiamano forma”? e<br />
che, in tal modo, si finisce per appartenere “a un mondo rovesciato:<br />
giacché ormai il contenuto diventa per qualcuno qualcosa<br />
di puramente formale compresa la nostra vita” 21 .<br />
Il pensiero artaudiano si muove esplicitamente nel campo della<br />
tradizione sapienziale, di una esperienza ‘illuminata’ dei segni e<br />
delle parole di una cultura organica che intende la relazione fra<br />
corpi come trasmissione sensibile di forme animate, mediante<br />
una ritmica di flussi d’energia e non per via di concetti. Non solo<br />
Artaud fa defluire la pittura nella musica, compenetrando suono
e luce, esplosione vocale e arsura luminosa, ma trasferisce l’intera<br />
pratica del dipingere nel mare d’una liquidità vorticosa e<br />
inesauribile, nel magma di flussi e pulsioni. E tuttavia flussi non<br />
abbandonati a se stessi, bensì ardui e “bulinati”, anzi respiri e<br />
fiati che lavorano.<br />
L’acqua della pittura22 : così si esprime Artaud. Di fronte alla natura,<br />
all’inerte, la pittura scioglie e rifonde, corrode e torna a far<br />
coagulare. È corrente e soffio sprigionati dal corpo che si sacrifica<br />
in una materialistica unio mystica con le cose.<br />
Povero, santo, puro e illuminato: questi ed altri ancora (vergine,<br />
martirizzato, extralucido, organista, eccetera23 ) sono gli appellativi<br />
di Van Gogh, il solitario che si dona: nuovo Dioniso cui sono<br />
ignote le macchinazioni del sesso, della penuria e del peccato,<br />
della produzione e dell’accumulo: ignote perché pratica una saggezza<br />
sconosciuta. Il pittore celebra, con l’offerta del proprio soffio<br />
(un soffio che è però crudele, martellante un respiro che sfigura,<br />
un acido corrosivo), le nozze mistiche con la natura e fa del<br />
proprio corpo uno strumento di nascita, il campo d’un rito.<br />
Benché siano nominati in più punti, gli autoritratti di Van Gogh<br />
non danno luogo, nel Suicidé, ad un commento altrettanto ossessivo<br />
quanto, ad esempio, il Campo di grano. Per di più, quando<br />
ci si imbatte in un riferimento preciso (je pense à celui avec<br />
un chapeau mou), veniamo rinviati all’epoca parigina del pittore<br />
piuttosto che alle tele di Arles. Anche gli accenni all’ultima<br />
epoca (la mano bruciata e fasciata, l’orecchio amputato e bendato,<br />
la “figura rossa di sangue”, l’occhio visionario) sono proposti<br />
nel contesto della martirizzazione. Il suicida è anche, sempre,<br />
un suicidato. Tutto il discorso insomma viene piegato a parlare di<br />
un “eroe” 24 che annuncia la rinascita, a descrivere il destino di un<br />
profeta, già alle soglie della scena ardente. Van Gogh è l’ignaro<br />
che sa, ma al quale si impedisce di agire per sé.<br />
La congiura familiare e psichiatrica gli vieta di pensare. Lo costringe<br />
dentro i confini della tela e del motivo. Che cosa fa il dottor<br />
Gachet, il medico che avrebbe dovuto curarlo? Nient’altro che<br />
impedirgli di vivere, di star solo. Gachet non trova di meglio,<br />
quando il ‘malato’ potrebbe agire nel fervido isolamento del suo<br />
corpo, che separarlo da sé, ordinargli di uscire, di farsi derubare:<br />
“invece di raccomandargli riposo e solitudine, lo mandava a dipingere<br />
sul motivo un giorno in cui sapeva bene che Van Gogh<br />
avrebbe fatto meglio a coricarsi” 25 .<br />
398<br />
L’iconografia degli autoritratti, calata nella storia della follia e<br />
della vampirizzazione, è dunque funzionale, nel Suicidé, al tema<br />
dell’eroe suicida (to) della (dalla) società, ad uno Zarathustra assassinato,<br />
spinto a cadere. Non a caso il tratto più penetrante del<br />
suo volto di “macellaio”, la “pupilla”, lo sguardo, non trova altro<br />
riscontro per Artaud che nell’occhio di Nietzsche: occhio surriscaldato,<br />
“avvitato”, “capace di svestire l’anima” 26 , ma condannato<br />
anche al furto dell’Altro, prigioniero d’una macchinazione.<br />
Questa tematica del corpo proprio, sulla cui spogliazione insiste<br />
così intensamente la riflessione artaudiana, non viene però abbandonata.<br />
Rifluisce in un altro testo composto durante l’estate:<br />
uno scritto anch’esso relativo alla pittura, all’arte figurativa, ai disegni<br />
questa volta di Artaud, ai ritratti ed agli autoritratti esposti<br />
alla Galleria Loeb nel mese di luglio. Ha un titolo pregnante (Le<br />
visage humain) e si apparenta, per l’eccitazione compositiva, al<br />
Suicidé, del quale si potrebbe considerare con buoni motivi un<br />
capitolo parallelo, un prolungamento o una digressione conclusiva27<br />
. Allo stesso modo finiscono per far parte di questo stesso<br />
Dossier le lettere a Breton del febbraio-aprile 1947, interi passi<br />
delle quali nient’altro sono che rifacimenti e stesure provvisorie,<br />
estravaganti, del Van Gogh; o, se si vuole, varianti e stralci28 lanciati<br />
nella polemica suscitata dalla rassegna Le surréalisme en<br />
1947, per la quale Artaud era stato invitato a redigere un testo,<br />
ma da cui si era dissociato protestando violentemente contro il<br />
progetto settario e snobisticamente esoterico del gruppo. Così a<br />
lui pareva. Stese per l’occasione una nota, che si rifiutò poi di<br />
consegnare, sulla febbre terrestre e “uterina” dei surrealisti a lui<br />
congeniale, aggiungendovi un breve commentario sui propri disegni<br />
di “analfabeta”; e lì finiva per lanciare un ponte verso Masson,<br />
Dalì, Picasso, Chagall, eccetera, argomentando sul mito del<br />
ritorno, sulla rinascita del totem sepolto29 .<br />
Ora, date le implicazioni personali nell’esercizio disegnativo e la<br />
particolare configurazione della mostra, la tematica del corpo si<br />
consegna interamente al tópos del volto: “Il viso umano / è una<br />
forza vuota, un / campo di morte” 30 . Sono i primi versi, l’incipit<br />
della lunga poesia destinata alla recitazione, sostanziata da vigorosi<br />
elementi mimici e gestuali. Artaud parla di sé, del suo lavoro<br />
per rifare il corpo, un corpo che deve essere abbattuto, fatto<br />
morire. Qui il pittore di Arles torna prepotentemente in scena ed<br />
è il Van Gogh degli autoritratti.
Scomparsa l’effigie della natura sotto la specie paesistica, si accampa<br />
la forza di vita custodita nel viso-ipogeo. “Il viso umano<br />
/ porta difatti una specie / di morte perpetua / [...] / sta proprio<br />
al pittore / salvarlo / restituendogli i suoi ritratti” 31 .<br />
Dietro i lineamenti “troppo umani” sta sepolto un segreto che va<br />
portato alla luce: l’anima, il suo “dente osseo” 32 . L’imperativo artaudiano,<br />
già pronunciato in una lettera memorabile (anch’essa<br />
mai spedita) a Pablo Picasso, trova in Van Gogh una figura esemplare,<br />
un esploratore degli abissi ed un pittore che fa vibrare<br />
“l’albero interno” e traccia disegni simili a “colpi di sonda o / di<br />
raspa dati / in tutti i sensi / del caso, della possibi / lità, della<br />
sorte, o del / destino” 33 .<br />
L’extralucido è finalmente còlto in un atteggiamento chiave:<br />
nella solitudine dello scavo, illuminato dalla febbre, prossimo all’enigma<br />
e vicino a scioglierlo. Mai il volto era apparso così puro:<br />
lui soltanto, l’uomo di Arles, “ha saputo trarre da una testa /<br />
Antonin Artaud, Le thèatre de la cruauté, 1946, matita e gessi, cm 64,5x49,4.<br />
399<br />
umana un ritratto / che sia il / fumo esplosivo del / battito d’un<br />
cuore / scoppiato. / Il suo” 34 . Tanta appartenenza a sé viene invece<br />
esclusa, almeno in parte, dal Suicidé, dove la strategia agonale<br />
della pittura urta contro i no dell’esistenza ed obbliga l’ouvrier<br />
a dissolversi in altri corpi, a dare il proprio soffio.<br />
Le visage humain è così un testo ‘ponte’ fra il saggio sulla pittura<br />
e gli ultimi atti della poetica teatrale.<br />
Resta intatta però, nel Suicidé, la meccanica della fatica, il processo<br />
della seconda morte e della seconda nascita: seconde perchè<br />
il Demiurgo, nella mitografia gnostica dell’Autore, ha già,<br />
una volta, espropriato l’uomo del morire e del nascere. Rimane<br />
ugualmente integra la volontà di contagio. In un certo senso,<br />
anzi la dimensione sacrificale attribuita alla vita vangoghiana<br />
rende effetti ancor più potenti, essendo l’energia sottratta al lavoro<br />
autocreativo e divenendo il corpo proprio oggetto di un divieto<br />
e luogo di una impossibilità.<br />
Si è appena visto, a proposito del “motivo”, che il termine compare<br />
in duplice articolazione e che, ad un certo punto, il senso<br />
comune del vocabolo, costretto com’è ad ospitare un valore intensivo,<br />
si ribalta in qualcos’altro, venendo ad indicare la vita sepolta,<br />
il rimosso, dando luogo infine ad una serie di equivalenze<br />
sulla tastiera del dizionario cosmogonico: luce e musica, ‘al di là’<br />
dell’esistenza, cembalo, timpano cosmico, articolazione prima,<br />
parola prima delle parole. Si è anche osservato tuttavia che una<br />
simile latitudine di significati è conquistata attraversando, a<br />
“colpi di sonda” 35 , l’opacità del senso comune, abbattendo il<br />
muro delle effigi. Vi si arriva fendendo la ‘rappresentazione’: e<br />
ciò Artaud chiama realismo radicale, outracier, “rappresentazione<br />
esclusiva” 36 , che è altra cosa, anzi il contrario preciso della pittura<br />
“pura” e “lineare”, designata con l’espressione antitragica di<br />
“rappresentazione inerte”.<br />
A metà esatta del Suicidé questa convinzione viene sostenuta<br />
con l’autorità della parola vangoghiana. Tre frammenti delle lettere<br />
a Théo interrompono la scrittura dell’Autore, vengono a spaziarla<br />
e ad installarvisi. “Descrivere un quadro di Van Gogh, a che<br />
scopo!” 37 . Se altre volte Artaud coniuga e fonde la parola dell’altro<br />
con la sua, amplificandola nel giro dei sinonimi e del commento<br />
(come accade nella pagina in cui compare il tema dell’adunamento<br />
della materia, dell’entasser des corps, che è<br />
espressione prelevata dal lessico del pittore), ora è convocata in
primo piano la parola stessa del peintre-écrivain, la “forza personale”<br />
del suo pugno. Premono, in tal senso, la volontà di concretezza<br />
e una tensione non meno strenua, da parte dell’interprete,<br />
di cogliere il nocciolo della poetica di Van Gogh per farla<br />
coagulare intorno ai motivi cardinali del teatro. Che cosa vengono<br />
a dire infatti i tre frammenti scelti da Artaud38 ? Nel primo si<br />
erge una tematica ben nota: quella dello scontro, della lotta pittura-natura,<br />
della realtà che è pietra e muraglia da abbattere. La<br />
pratica del disegnare è formulata come un andare oltre la soglia<br />
dell’immagine, come “l’azione di aprirsi un passaggio attraverso<br />
un muro di ferro invisibile”, a colpi di lima. Poi, nelle successive<br />
citazioni, l’accento cade sulla dissonanza e sul coagulo, vale a<br />
dire sulle tensioni estreme che si incrociano nel luogo della genesi<br />
creativa. Da un lato il Caffè di notte (“un luogo dove ci si<br />
può rovinare, diventare folli, commettere delitti”, “qualcosa<br />
come la potenza tenebrosa di uno scannatoio”), e dall’altro il<br />
Giardino di Daubigny: un interno e un esterno. “Caffè” e “giardino”<br />
visualizzano l’esplodere e il ricomporsi delle forze, l’atmosfera<br />
di “pallido zolfo”, la “fornace infernale”, l’area della macinazione,<br />
la nigredo, e, sull’altro polo, lo stato aureo della natura<br />
piena e rifatta, le “immense distese di grano dopo la pioggia”. Il<br />
collage è montato con cura: Artaud ravvisa nella “fornace” vangoghiana<br />
il prestigioso antecedente di una scena, la sua, che altrove<br />
aveva raffigurato con le immagini della piazza pubblica,<br />
della Morgue, del ventre, della sala anatomica; e un simile precedente<br />
si impone ben più radicalmente del bretoniano tavolo<br />
d’anatomia, diventato, nell’accezione accolta dai surrealisti ortodossi,<br />
il luogo d’un incontro d’amore: un topos addirittura platonico39<br />
.<br />
Dopo aver disegnato la parabola del corpo vampirizzato, sullo<br />
sfondo d’una cannibalesca magia comunitaria, ed essersi soffermato<br />
sulla lettura di alcune tele, Artaud scandisce le ragioni della<br />
sua interpretazione. Autorità e reticenze accompagnano, a questo<br />
punto, la riapertura del discorso: l’autorità dell’epistolario a<br />
Théo e il ribaltamento che la parola, la sua, è in ogni caso impotente<br />
a dire. “Non descriverò dunque un quadro di Van Gogh<br />
dopo Van Gogh, ma dirò perché Van Gogh è pittore” 40 .<br />
Se la pittura è pulsionalità, scatenamento di “correnti”, frangersi<br />
di soffi (ed Artaud ha avuto modo di ripeterlo nelle pagine<br />
precedenti), come lavorano questi flussi? La pittura è corrosione<br />
400<br />
e bruciatura. Onda, respiro, mare, sangue sono fra i termini più<br />
frequentemente convocati, insieme a martellamento, suono,<br />
fulminato, vulcano, per designare le trame dei segni e dei tragitti<br />
cromatici. Più avanti una glossolalia esploderà, proiettando<br />
in primo piano la figura sacrificale dell’”operaio” e mettendo a<br />
fuoco – in schegge di materia sillabica – la “purezza” e la”verità”<br />
del martirizzato: “Senza letteratura, ho visto la figura di Van<br />
Gogh, rossa di sangue nello scoppiettio dei suoi paesaggi, venirmi<br />
incontro, // kohan / taver / tensur / purtan” 41 .<br />
Artaud parla dunque di corpi frantumati, di architetture abbattute,<br />
decentrate. L’azione dello strizzare qualifica un simile scatenamento.<br />
Tutta la materia viene raccolta, fatta ribollire, strangolata,<br />
liberata dalle impurità. Ma, contemporaneamente, accanto<br />
al lavorìo eccentrico, si mette in moto una ben diversa tensione.<br />
Ecco il primo movimento: Van Gogh “ha adunato la natura, l’ha<br />
fatta come traspirare e sudare: ha fatto sprizzare in fasci sulla tela,<br />
in mucchi quasi monumentali di colori, il secolare macinamento<br />
d’elementi, la spaventosa pressione elementare d’apostrofi, di<br />
striature, di virgole di barre di cui non si può credere che, dopo di<br />
lui, gli aspetti naturali non siano costituiti”.<br />
Ed ora il secondo movimento: “E di quanti sgomitamenti repressi,<br />
urti oculari presi sul vivo, cigliazioni afferrate nel motivo, le<br />
correnti luminose delle forze che lavorano la realtà [sottolineatura<br />
nostra] hanno dovuto rovesciare lo sbarramento prima d’essere<br />
infine compresse, e in certo modo issate sulla tela, e accettate?”<br />
42 .<br />
La fluidità del solve non sta senza il coagula, lo sprofondare<br />
senza la riemersione alla chiarezza. E se è vero che Artaud concepisce<br />
l’ergersi delle “correnti” dentro la trama (anche) di convinzioni<br />
mitiche ed alchemiche, quest’alchimia così poco esoterica<br />
e settaria negli ultimi anni agisce nell’incastro dei contrari,<br />
in un chiasmo della fatica.<br />
Prosegue in questa cornice la lettura ‘terrestre’ delle opere di<br />
Van Gogh: terrestre perché è la materia (la “terra” in primo<br />
luogo, i paesaggi, gli oggetti, le cose prese dalla quotidianità) ad<br />
issarsi sulla tela. È la terra come principio: il ‘femminile’, il basso.<br />
In questo senso l’Autore parla di un mito che viene dalla realtà<br />
“più terra-a-terra” della vita43 , di forza mitica estratta dalle cose,<br />
da non confondere col mito inteso come invenzione spiritualistica<br />
e simbolo. Che è poi ciò che separa Van Gogh dall’uomo dei
Tropici, Gauguin, secondo Artaud44 . La terra-anima è il totem che<br />
ritorna, l’eternelle femme45 , già al centro della sua interpretazione<br />
della picassiana Donna che piange e di Guernica.<br />
È un prezioso appunto, salvato da Paule Thévenin, quello che,<br />
quasi in epigrammatico promemoria, lascia trasparire l’intenzione<br />
artaudiana di leggere i disegni di Van Gogh come se fossero<br />
dei totem:<br />
Van Gogh<br />
dessins totems<br />
où je raconte foudre46 .<br />
Per Guernica aveva scritto: “Sento il tam tam di pietra d’esseri di<br />
Picasso. Non vi risale forse la sfinge, la donna che ci animò?” 47 .<br />
Quali le opere capitali di Van Gogh e come si situano in una simile<br />
prospettiva? Benché abbia presente tutto il lavoro degli anni<br />
estremi ed in ispecie del triennio 1888-1890, da Arles ad Auvers,<br />
l’interprete prolunga l’attenzione quasi unicamente su due tele: la<br />
Camera da letto e il Campo di grano con volo di corvi. Le altre (ad<br />
esempio Les Alyscamps, la Notte stellata, e così via) suggeriscono<br />
annotazioni folgoranti, rapidissime e precipitate infine nella<br />
vertigine del commento generale.<br />
Anche qui c’è da supporre un calcolo preciso, come documenta<br />
con chiarezza il confronto delle stesure. Nella redazione definitiva<br />
(ed è un caso, non l’unico), scompare del tutto la lunga nota<br />
dedicata al Caffè di Arles (l’esterno, di notte), che era reinvenzione<br />
applicata minutamente ai dettagli del quadro, una nota<br />
per di più molto tecnica, teatralmente registica, tant’è che da<br />
quel passo veniva a Van Gogh l’appellativo di metteur en<br />
scène48 !<br />
La Chambre à coucher viene introdotta per la prima volta, come<br />
se la frase componesse un preludio, nella pagina forse più composita<br />
ed iconograficamente multipla del libro. Tre quadri insieme,<br />
fatti dissolvere, confusi l’uno nell’altro. Lo sguardo di Artaud<br />
è certo passato e ripassato sulle immagini della Stanza e dei Canali<br />
di Arles, fondendole in una sola continuità visiva. Si tratta di<br />
un intervento mentale che incrocia e sovrappone le immagini<br />
per via di interne associazioni cromatiche: dal verde veronese<br />
del letto all’azzurro umido d’una barca, alla liquidità di una riva.<br />
Qui la Chambre è data attraverso una fortissima sineddoche,<br />
riassunta in un oggetto-emblema, in una nota che costituisce il<br />
nucleo da cui vien fatto irradiare tutto il senso del quadro.<br />
401<br />
Questa nota timbrica è il cuscino, la macchia colorata al centro<br />
della stanza: “questo piumino rosa-gambero che Van Gogh fa<br />
così dolcemente spumeggiare in un punto preciso del letto” 49 .<br />
Non solo oggetto magico: è ancor più un grumo-colore, un ‘soffio’<br />
lavorato e filtrato. Da dove viene? Non ha astanza percettiva,<br />
bensì tutta mentale e psichica. Emerge dal fondo, scrive Artaud,<br />
da uno scavo. È un colore in risalita dalle profondità del cervello<br />
del pittore: qualcosa come una emanazione materiale delle<br />
sue facoltà visionarie, di quell’occhio interno che è produttore di<br />
“vera realtà”. Trasferito sul piano del linguaggio visivo quel<br />
grumo costituisce una sorta di “immagine prima delle immagini”,<br />
se così si può dire, una condensazione di energia pari a quella<br />
operata, con materiali vocali, nelle glossolalie: un modo d’essere,<br />
in pittura, della lingua “nuova e inaudita”.<br />
In ogni caso non si tratta di un emblema edenico, felice. Tutta la<br />
fatica del pittore è stata necessaria per trarlo fuori e modellarlo.<br />
Dietro la sua finale lucentezza, come si legge più avanti, c’è lo<br />
“scrupolo chirurgico” del vecchio artista, una operazione di<br />
“oscura alchimia” 50 . Ora la interpretazione si distende ampiamente<br />
sui motivi figurali e disegna una topografia di lavoro: la<br />
stanza raffigura il Grand Oeuvre; così la tela ospita la macchinazione<br />
salvifica d’una metamorfosi tuttavia mortale. È la scena<br />
della rappresentazione, ma di quale ‘rappresentazione’!<br />
Se, fino ad ora, una serie di luoghi tematici prelevati dalla pittura<br />
si adunava a fianco del teatro della crudeltà, alla sua configurazione<br />
circolare, in questo momento del testo la Chambre à<br />
coucher richiama ed assorbe i motivi del carcere e dello scannatoio,<br />
ma li assume e li rilancia in una dimensione tutta particolare:<br />
quella d’una santità semplice, à la bonne franquette, popolaresca.<br />
Sì certo: tanta pulizia lascia lontano le scorie, i depositi<br />
malati. Ma questa ‘semplicità’ ha anche la nettezza e la secchezza<br />
d’uno strumento da taglio, il profumo d’un filtro a lungo<br />
fermentato. L’atmosfera sembra serena. Soltanto è da aggiungere<br />
che tanta tranquillità è apparente: la conclusione d’un lavoro,<br />
un riposo provvisorio; o, se si vuole, il momento in cui si prepara<br />
un’esplosione. È l’altra faccia del forsennato Van Gogh.<br />
Il bianco del muro, ad esempio, potrebbe parlare in nome del<br />
candore e della ingenuità. Ma non è così, almeno qui. Questo<br />
bianco è colore di calcinazione. È bianco d’ossario, di pietra meteorica,<br />
di macina. “Ci sono delle levità d’un bianco gessoso più
terribili degli antichi supplizi” 51 . Vi balena lo splendore del totem,<br />
che è sinonimo, nell’Artaud ultimo, del “corpo in folgore”, del<br />
Mômo.<br />
La collazione delle varianti suggerisce riscontri curiosi. Mentre<br />
nei primi appunti dominano le gamme tenere ed intermediarie<br />
(i rosa, i verdi, gli azzurri), i gialli “di mandorla”, nella scrittura<br />
definitiva il registro cromatico appare assai più netto ed essenziale:<br />
due colori soltanto. Il raffronto dimostra che Artaud è passato<br />
da una prima idea di accordi tenui, effettivamente più vicini<br />
al tessuto coloristico del quadro, ad una sorta di scarnificazione.<br />
Ha isolato il rosso e il bianco. Per esaltarli. Li ha assimilati alla<br />
vetrosità brillante, diamantina, all’arsura della droga. Infine troviamo<br />
vernici, perle, lacche: “Occulta perfino la sua camera da<br />
letto, così adorabilmente contadina [...]. Rustico anche il colore<br />
del vecchio cuscino, d’un rosso d’ostrica, di riccio, di gambero:<br />
quel colore rossastro del Sud, d’un rosso di pepe bruciato, [...]<br />
vernice indescrivibile.<br />
Col suo muro di perle chiare, su cui è appeso un panno di tela ruvida<br />
come un vecchio feticcio contadino, inaccessibile ma consolante,<br />
questa camera fa pensare al Grand Oeuvre” 52 .<br />
Su tutt’altro polo si dispone invece il commento al Campo di<br />
grano: il polo del travaglio più intenso, del fervore e dell’assassinamento.<br />
Doppio soffocamento per altro: dall’alto e dal basso. Van<br />
Gogh vi lavora come se gettasse fuori tutti i suoi fiati, la sua malattia,<br />
tutti i microbi del suo corpo di appestato.<br />
Al posto del bianco e del rosso, un’emulsione violacea, vinosa;<br />
ed il nero. Le cromìe sono cariche di valenze alchemiche. Così<br />
anche le figure: innanzitutto i corvi, portatori di nigredo, trituranti<br />
e mortiferi. Che altro sono poi questi corvi? La nerezza luttuosa,<br />
peccaminosa ed escrementizia rinvia all’Altro, al grande Avvelenatore.<br />
Sono dunque il male, la malattia, il prodotto dello Spirito.<br />
Laddove l’Altro opera per insinuazione, penetrando nei corpi<br />
e devitalizzandoli, per Artaud, al contrario, il corpo esplode, fa<br />
essudare la sporcizia; e la trasforma in materia corrosiva. La febbre<br />
della malattia è fervore ed acquista perciò statuto attivistico<br />
e centrifugo: non solo è espulsa ma serve, viene costretta a lavorare.<br />
La morte, da immobile, si dinamizza, fa risuonare il leitmotiv,<br />
“batte colpi di cembalo”.<br />
Lusso, festino, vino acido, nardo, aceto guasto: le immagini della<br />
dissoluzione si accumulano convulsivamente nel paesaggio. La<br />
402<br />
terra sanguina, ‘si lamenta’ sotto i colpi. Mater-materia, di<br />
nuovo. Ma innegabilmente c’è di più: assomiglia alla “biancheria<br />
sporca” 53 , fluttua e dilaga, straripa a fiotti sotto una linea di<br />
orizzonte sempre più bassa, stringente. Il cielo scompare, lasciando<br />
in primo piano una massa terremotata di zolle e di<br />
grano, mosso dal vento. Scatta ora una nuova equivalenza: terramare.<br />
Ma il mare vero è la pittura. Il paesaggio si liquefa perché<br />
contagiato dai colori, dalla pittura-emulsione, dal soffio.<br />
Così il nemico della pittura ‘lineare’, della pittura che resta pittura<br />
e niente altro, precipita la techne nella fluttuazione del solvecoagula,<br />
di un flusso e riflusso miticamente iscritto sullo spartito<br />
nuziale della putrefactio. Che è, fuor di metafora, l’architettura<br />
stilistica (chiasmatica) di un sublime portato verso i registri<br />
della irregolarità e del paragrammatismo.<br />
La pittura è questa fluenzialità precipitata nelle forme, un fascio<br />
di correnti ‘laboriose’ che traggono fuori il diamante. Come a dire<br />
che i tesori non stanno nei sovramondi, al di sopra o al di sotto<br />
della materia. Non è vero che la vita ‘vera’ sia chissà dove. Lo si<br />
può credere finché sussiste il dualismo forma/forza, conscio/inconscio.<br />
In una concezione materialistica della pittura tutto ciò<br />
non ha più senso. Che è quanto Artaud immaginosamente dice<br />
nel prodigioso apologo dell’ultimo post-scriptum, dissolvendo<br />
Parigi con la forza della pittura, della ‘visione’, e facendo apparire<br />
la pietra levigata del lapis: “[...] l’atmosfera dell’aria e delle<br />
strade divenne quasi liquida gelatinosa, instabile, [...] la luce<br />
delle stelle e della volta del cielo disparve. [...] Ma non cadde,<br />
forse, una delle sere di cui parlo, nel boulevard della Madelaine,<br />
all’incrocio con rue des Mathurins, un’enorme pietra bianca<br />
come venuta da una recente eruzione del vulcano Popocatepetl?”<br />
54 .<br />
Il Messico, la cultura organica, i totem, Van Gogh.<br />
* Questo intervento (tratto da “Il Verri”, 13-16 [1979], è stato pronunciato il<br />
1° novembre 1978 ai “Colloqui Internazionali” di Padula. Titolo della manifestazione:<br />
Teatro, spazio, ambiente. È stato poi ripubblicato in “Europe”<br />
(1984) con il titolo Le travail de la peinture.<br />
1. Lettera a Paule Thévenin, in A. Artaud, Oeuvres Complètes (OC), vol. XIII,<br />
Paris, 1974.<br />
2. Ibidem, p. 118.<br />
3. A. Artaud, Van Gogh – Le suicidé de la societé (d’ora in poi abbreviato in<br />
VG), in OC, vol. XIII, p. 43.<br />
4. Dossier de Van Gogh – Le suicidé de la società (da qui in avanti DVG), in<br />
OC, vol. XIII, pp. 149ss.
5. DVG, pp. 210-11.<br />
6. Negli antefatti vengono assorbiti, come si vedrà, anche frammenti di scrittura<br />
e pensieri dell’epistolario vangoghiano. L’opera del pittore (insistiamo:<br />
non soltanto quella figurativa) diventa materia da riplasmare, da gettare nel<br />
crogiuolo d’una rinnovata creazione. Deriva da qui un ulteriore significato<br />
dell’identificazione di Artaud con Van Gogh. Questa attitudine è stata colta e<br />
sottolineata con insistenza, relativamente ai dipinti, da G.A. Goldschmidt (Un<br />
cauchemar génésique, “Obliques”, 10-11, s.d., p. 162): “Pour Artaud l’oeuvre<br />
de van Gogh est à son tour une ‘forme germinale’, pour employer la belle<br />
expression d’Etienne Gilson, une forme germinale comparable à celles qu’ont<br />
été les ‘motifs’ pour Van Gogh valent comme incitation fondamentale, vues<br />
per le poète, elles deviennent virtuelles, nécessités intérieures comprimées<br />
vers l’éclatement poétique”. Da segnalare anche, sul medesimo numero di<br />
“Obliques”, il saggio di J. Sojcher, Le jugement et la Répétition.<br />
7. A. Artaud, Al paese dei Tarahumara e altri scritti, a cura di R. J. Maxwell<br />
– C. Rugafiori, Milano 1966, p. 167.<br />
8. VG, p. 47.<br />
9. J. Derrida, La scrittura e la differenza, trad. it. di G. Pozzi, Torino 1971, p.<br />
247.<br />
10. Specialmente negli scritti ‘messicani’, Messages révolutionnaires, in OC,<br />
vol. VIII.<br />
11. A. Artaud, La jeune peinture française et la tradition (1936), in OC, vol.<br />
VIII, p. 250.<br />
12. DVG, p. 211.<br />
13. I dubbi sul cubismo e il rigetto delle costanti classicistiche della cultura<br />
occidentale fanno tutt’uno, in Artaud, con la critica negativa del razionalismo,<br />
rinascimentale e postrinascimentale, di cui l’arte francese gli appare costituire<br />
una esemplare manifestazione. Così gli interessano, di quest’arte, le eccezioni<br />
e non la regola: eccezioni significativamente spostate verso la tradizione<br />
nordica e tedesca in particolare. A Delacroix, ad esempio, vien dato l’appellativo<br />
di “genio della razza” proprio perché è, fra tutti i pittori del suo<br />
tempo, il meno francese nell’essenza. Non altrimenti Courbet conta per i segreti<br />
“fosfori” della pittura, per i “bitumi”, gli impasti “bruti” e “frenetici” del<br />
colore, di una brutalità stravolta che trova termini di paragone con le oscure<br />
cromie di Cranach. Il peccato maggiore del cubismo ed in specie del manierismo<br />
che ne è derivato, vien fatto consistere nel divorzio dai sensi e dai<br />
“nervi”, nell’adozione d’una geometria che ammette “sensazioni di natura<br />
puramente intellettuale” (Les valeurs picturales et le Louvre [1921], in OC,<br />
vol. II, pp. 234-35). Una caduta di tensione, da cui neppure Picasso è, per Artaud,<br />
esente in certi anni. Ma se il furore picassiano delle primitive tele cubiste<br />
s’è come appannato nei dipinti della stagione successiva (un tempo<br />
“una forza prodigiosa di vita crepitava nelle loro linee dense, una realtà sconosciuta<br />
e profonda, in cui l’anima intera si ritrovava”, mentre, ora, “Picasso<br />
non ci evoca che il passato. La sua pittura è un residuo, una ‘decantazione’<br />
della pittura”. Exposition Picasso [1924], in OC, vol. II, pp. 264-65); più tardi,<br />
nel 1946, il drammaturgo torna a vedere in Picasso un grande modello dell’arte<br />
“genesica”. Specialissimo infine il giudizio su Braque: un pittore che<br />
non si impegna nella creazione d’un “mondo nuovo”, ma di alta qualità analitica<br />
e dalla freddezza esemplare. A lui va il merito di aver mostrato che<br />
l’universo, così com’è, è una creazione sbagliata: azzerata la pittura “ha saputo<br />
sorprendere la meccanica interna del cosmo già fatto, anziché produrne<br />
un altro”. Un pittore senza passione, senza dramma, eppure lucidissimo.<br />
(A. Artaud, Lettre à Georges Braque, in OC, vol. XIV, t. I, pp. 157-59).<br />
14. DVG, p. 210.<br />
15. Ibidem.<br />
16. Ibidem, p. 212.<br />
17. Ibidem.<br />
18. Ibidem, p. 213.<br />
19. VG, p. 18.<br />
20. Ibidem, pp. 43-44.<br />
403<br />
21. F. Nietzsche, La volontà di potenza, p. 818; cfr. F. Masini, Lo scriba del<br />
caos, Bologna 1978, p. 252.<br />
22. VG, p. 59.<br />
23. Ibidem, pp. 16, 18, 38, 38, 49, 59, ecc.; DVG, passim.<br />
24. Cfr. P. Thévenin, Entendre/Voir/Lire, “Tel Quel”, 39-40.<br />
25. VG, p. 62.<br />
26. Ibidem, p. 59.<br />
27. Catalogo Portraits et Dessins, 4-20 (luglio 1947), Galerie Pierre Loeb,<br />
Paris.<br />
28. A. Artaud, Lettres à André Breton, “L’éphémère”, 8 (1968), pp. 3-51.<br />
29. A. Artaud, Une note sur la peinture surrealiste en géneral – Des commentaires<br />
des mes dessins, “Tel Quel”, 15, pp. 75-78. Nel DVG, p. 169, un<br />
passo, poi sacrificato nella redazione finale, è interamente dedicato al tema<br />
del totem: “Totem discriminatif de la puissance. / Perdu sur un sol d’argile<br />
lilacé noir, avec transudation d’épiderme couleur rouge labial, punctuations<br />
très rates d’or ou d’argent, et par-dessus tout toujours la teinte charbonneuse<br />
des bas-fonds, terrains perdus, jamais visités après, non sûrement avant<br />
le déluge. / Totem de protestation contre…”.<br />
30. A. Artaud, Le visage hamain, in Catalogo Portraits et Dessins…<br />
31. Ibidem.<br />
32. A. Artaud, Lettre à Pablo Picasso, in OC, vol. XI, p. 175.<br />
33. Artaud, Le visage humain…<br />
34. Ibidem.<br />
35. Ibidem.<br />
36. DVG, p. 210 e VG, p. 46.<br />
37. VG, p. 39.<br />
38. Si tratta di brani estrapolati dall’epistolario a Théo. Tre lettere: la prima<br />
senza data (ma 1882-83), la seconda dell’8-X-1888, la terza del 23-VII-1890.<br />
39. Cfr. L. Gabellone, L’oggetto surrealista, Torino 1977, pp. 37ss.<br />
40. VG, p. 42.<br />
41. Ibidem, p. 49.<br />
42. Ibidem, p. 43.<br />
43. Ibidem, p. 29.<br />
44. Ibidem, pp. 29-30; DVG, p. 175.<br />
45. Artaud, Lettre à Pablo Picasso…<br />
46. OC, vol. XIV, II, p. 239. Già in nota al VG, in OC, vol. XIII, p. 365.<br />
47. Artaud, Lettre à Pablo Picasso…<br />
48. DVG, pp. 209-10.<br />
49. VG, p. 39.<br />
50. Ibidem, p. 34.<br />
51. Ibidem, p. 46.<br />
52. Ibidem, pp. 45-46.<br />
53. Ibidem, p. 27.<br />
54. Ibidem, pp. 63-64.<br />
(1) ll saggio è tratto da “Figure della melanconia e dell’ardore. Saggi di<br />
ermeneutica teatrale”, Labirinti 34, Dipartimento di Scienze Filologiche<br />
e Storiche, Università degli Studi di Trento, ottobre 1998, pp. 107-128.
1980<br />
Da Gianni Del Bue<br />
ad Arte temporale e arte<br />
spaziale. Pittura<br />
Distrazione (nota)<br />
Gianni Del Bue<br />
Natura e memoria<br />
Giulio Perina<br />
“Angelo Giuseppe Facciotto. Scritture<br />
(1943-1945)”<br />
Irrealtà del naturale<br />
Giuseppe Facciotto<br />
Racconti per trasparenza<br />
Cristina Kanz<br />
Pittura come ornamento e irrealtà<br />
Osvaldo Licini<br />
La natura, la iena e l’equilibrista<br />
Osvaldo Licini<br />
Raccontare per frammenti. Fotopoesie<br />
di Fulvio Milani<br />
Presagi della scena<br />
Rodolfo Aricò<br />
Arte temporale e arte spaziale<br />
Pittura
Distrazione (nota)<br />
Gianni Del Bue (1)<br />
Di Del Bue è magistrale, per me, la distrazione. Distrazione per<br />
molte cose e in special modo per ciò da cui non ci si dovrebbe<br />
distrarre, e cioè dalla terra, dal suolo, dalla linea dell’orizzonte; e,<br />
trattandosi di un pittore, dalla superficie. Senonchè, come spesso<br />
succede, il distratto sogna quel che non vede. Di più: è convinto<br />
di saperla lunga sui suoi inciampi. Anzi, proprio lì, in mezzo<br />
agli oggetti ostili, vuol dimostrare una competenza superlativa e<br />
ce la mette tutta per farci cambiare opinione. Non solo ne parla,<br />
ma argomenta, recita, si mette in scena.<br />
Del resto gli va sempre bene, perché il distratto, in quanto tale,<br />
G. Del Bue, Caro duca, 1979, tecnica mista, cm 100x150.<br />
406<br />
non è mai in un luogo preciso. Neppure lui sa dov’è. E perciò ha<br />
acquisito una straordinaria abilità. Riesce a tenersi ritto, quando<br />
magari sta camminando sull’acqua o spiccando un salto. Tanto<br />
sbadato a terra, quanto ingegnoso per aria: dove dà spettacolo<br />
sapendo di darlo.<br />
Allora non lo si può più considerare un distratto, ma uno che distrae.<br />
La voce ‘distrarre’ mi illumina su questo punto. Essa combina<br />
il trascinamento con la dispersione. Segnala la voluta dilapidazione<br />
di un tesoro. Allarga le maglie d’una tela troppo fitta;<br />
strappa, attorciglia i fili. Ed anche: distrarre vuol dire dislocare,<br />
spostare, rendere fluido l’immobile. Dargli velocità. Ed infine:<br />
sviare. Certo dalla via diritta e per ragioni di gioco. Giacchè ‘distrarsi’<br />
indica, e non a caso, il sospendere la realtà a vantaggio<br />
del piacere.<br />
Trascinare costituisce, lo si sa bene, una virtù poetica, da almeno<br />
un secolo, come diceva quel tale (così lo chiamava Picasso<br />
con finta sbadataggine): “Cette peinture serà de l’Ame, résumant<br />
tout, parfums, sons, couleurs, de la peinture accrochant la<br />
peinture et tirant”. Con voluta interpolazione.<br />
Pittura che uncina e pittura che tira: mi sembra la definizione<br />
esatta. I colori tirano le figure e le figure i colori. E le immagini<br />
sono ami, corde, cappi, fiocine, nubi e raggi. Ma anche draghi,<br />
ali, artigli. Un arsenale e un bestiario. Tutto il quadro una corrente,<br />
una rotazione spettacolare.<br />
E il suolo?<br />
Non è neppure da chiedere: è una formazione di tappeti volanti.<br />
Qualche anno fa Del Bue introduceva nel corpo delle immagini,<br />
delle sue grandi figure poligonali, degli elementi di disturbo. Se<br />
ne ricavava un effetto di turbamento e di instabilità, come se la<br />
tela improvvisamente si decentrasse e insieme la massa iconica<br />
lievitasse verso l’esterno.<br />
Ora quel procedimento a shock, quella iniezione di motilità inquieta<br />
viene sperimentata sul continuum dello spazio pittorico.<br />
Ripudiata l’immagine come fatto primario e strutturante, il pittore<br />
sembra puntare all’opposto su una ricerca di disturbo costante<br />
del segno, sui motivi per così dire ritmici della dissoluzione.<br />
Sulla tela rien ne se tient: le fitte stesure delle grafie non procedono<br />
per successione ma per contiguità simultanea, si incastrano<br />
e innervano le une nelle altre, tendono a confondersi, a perdere<br />
identità. La texture viene contraddetta nel suo principio ri-
G. Del Bue, Grande allegoria, 1981, tecnica mista, cm 200x150.<br />
407
G. Del Bue, Psicamore, 1980, tecnica mista, cm 100x100.<br />
petitivo e ciò nonostante mantenuta presente.<br />
Ecco perché queste superfici danno effetti di ridondanza e di sconfinamento. Non<br />
sono rappresentazioni dello spazio, ma frammenti e porzioni di spazi possibili, al<br />
limite inverificabili. L’insistito, sistematico sconfinamento del segno ne è una<br />
prova: l’abbondanza degli elementi congiuntivi, il travalicamento delle bordature<br />
e il richiamo ritmico delle serie di tracciati ci dicono che il discorso continua<br />
altrove. Lo vediamo ingrandirsi e debordare, tendere all’occupazione di nuove<br />
zone su cui estendere senza soluzione di continuità la propria sregolatezza. E se<br />
è così, che cosa ha di fronte l’osservatore se non una superficie-segnale o il dato<br />
sintomatico di uno spazio enormemente più vasto di quello offerto dagli indici<br />
contenuti dalla tela?<br />
Una sequenza di shock dunque. Lo scarto e la distorsione come materiali del ritmo.<br />
Il pittore, portando all’estrema conseguenza la propria riflessione sulla doppia polarità<br />
del segno, sulla molteplice risonanza dell’uno, in quanto non si dà tensione<br />
senza rilassamento del tessuto figurale, sembra voler sorprendere il valore del<br />
ritmo, la sostanza ultima della iterazione, nella zona delle contiguità, là dove si so-<br />
408<br />
vrappongono ed entrano in frizione gli elementi<br />
della catena. L’infinita successione del procedimento<br />
ripetitivo è inconquistabile e dunque va<br />
intaccata nel suo spazio ‘critico’, nel luogo del rilancio<br />
e del salto in avanti; che poi è anche il<br />
luogo della lassità. Da qui l’esercitarsi su dei<br />
campioni limitati di spazio che sono di per sé<br />
delle dichiarazioni abbastanza scoperte sul come<br />
viene condotta la meccanica dell’inseguimento.<br />
In certo senso ogni quadro è la chiave di una ripetizione<br />
che si prolunga altrove e si ispessisce<br />
in profondità, circolarmente. La superficie, a tramatura<br />
policentrica, non viene orientata sulla<br />
direttrice di qualche percorso privilegiato o<br />
verso direzioni esclusive: si dilata invece dappertutto<br />
come un campo sonoro o un segnale<br />
luminoso.<br />
Peso-luce appunto, entità oppositiva.<br />
(1) Scritto in occasione della mostra “Gianni Del<br />
Bue”, svoltasi presso la galleria “Marin”, Torino, gennaio<br />
1980.
Natura e memoria<br />
Giulio Perina (1)<br />
Pittura en plain air, quella di Perina, ma più propriamente - si<br />
direbbe - à fleur de terre, sul filo della terra e ben salda sulla<br />
linea dell’orizzonte. O addirittura al di sotto dell’orizzonte, come<br />
capita di vedere abbastanza spesso nei quadri dell’ultimo decennio,<br />
dove il fuoco visivo, quand’anche accenni ad un moto<br />
d’ascesa, resta pur sempre ancorato al suolo, ai suoi pesi e all’intrico<br />
avvolgente di piante, arbusti e pietre.<br />
Tre anni fa, proprio all’inizio del ’77, è cominciato un nuovo pensiero<br />
pittorico che non saprei definire altrimenti che come un<br />
pensiero sulle rocce. Sulle rocce, e cioè sulla carne scoperta della<br />
montagna (ed altrove, in rarissimi nudi, sulla petrosità della<br />
carne), sulla pietra scorciata in vedute parziali e anche ravvicinata<br />
per effetto di decise abbreviazioni prospettiche. Pezzi di un<br />
gran corpo, piuttosto che il corpo tutt’intero. Una pietra, la costa<br />
d’un dirupo, una fuga di massi: vedute per lo più affioranti nello<br />
spacco della vegetazione. Ecco gli scorci frangere lucentezze diamantine,<br />
bagliori di vetrata: dunque viventi nell’ordine del colore<br />
e della luce.<br />
Ed è singolare che ad inaugurare la serie non sia stata una tela<br />
dipinta sul vero, ma uno studio, una sperimentazione al chiuso,<br />
ossia un’opera fondata sull’esercizio della pittura e sulla memoria<br />
anziché sull’immediatezza dell’osservazione. Ne viene una<br />
prima evidenza: il colore ha imposto in certo modo la roccia, l’ha<br />
convocata e partorita da sé, come un’immagine necessitata dall’interno.<br />
Segno evidente che un tema, per nascere, deve innanzi<br />
tutto costituirsi come traccia psichica. È grumo mentale e<br />
materia pittorica che, a forza di interrogazioni, genera immagini:<br />
il colore crea la roccia, non viceversa.<br />
In Perina l’osservazione si prolunga nella memoria dell’osservazione.<br />
Né questa può vivere a lungo da sola. L’una richiama l’altra,<br />
circolarmente. Sicché il segno vien fuori da una doppia emozione:<br />
è testimonianza del naturale e insieme ricordo, evocazione.<br />
Fantasma ed appunto, diario.<br />
Lo si constata chiaramente, una volta di più, visitando la mostra<br />
recente dei piccoli formati ("Alla Torre", dicembre ’79). Perina vi<br />
raduna due serie di oli, li mette a confronto, schematizzando attraverso<br />
l’immagine la duplicità dei suoi registri: da un lato nove<br />
409<br />
cartoni dell’agosto ’78, dipinti sul motivo, dall’altro undici quadri<br />
del medesimo soggetto, ma composti a memoria esattamente<br />
un anno dopo. Fra i due gruppi gli scarti sono al tempo stesso<br />
minimi e massimi. Minimi perché l’architettura visiva rimane<br />
pressoché costante, tutta presa com’è nel circuito di una scena<br />
invariata (i canonici “quattro passi” e non più, di cui s’è parlato<br />
in altra occasione), nel giro di una natura avvolgente che lo<br />
sguardo spia dall’interno, insinuandovisi come una sonda in<br />
emersione; massimi perché il colore subisce, nel corso della rimemorizzazione,<br />
un prestito mentale che accresce la corrosività<br />
dei tracciati e brucia la figurazione.<br />
E qui salta all’occhio un dato ulteriore: la densità degli impasti.<br />
Le superfici sono cariche, spesse, a strati multipli, quasi che il dipinto<br />
crescesse su un’immagine sottostante. Si ha perfino l’impressione,<br />
in qualche caso, di un intervento che cancella ed annienta,<br />
di una natura in rovina. O per dir meglio, l’iconografia<br />
del bosco e della montagna fa da supporto, ma non di più, alla<br />
vita del colore. Poco importa che un corpo contenuto scompaia,<br />
che quel dato paesaggio venga meno, poiché lo sovrasta la<br />
piena di un altro paesaggio in risalita: un’immagine sensitiva,<br />
materica, setacciata, filtrata dalla tecnica e dal ricordo.<br />
È probabilmente maturata una convergenza. Voglio dire che le<br />
procedure del pastello, quelle speciali procedure che l’artista è<br />
G. Perina, Paesaggio, 1953, olio su cartone, cm 43x46.
venuto praticando dal ’70 in poi, sono confluite negli oli, nel<br />
modo di intendere le miscele, di far pasta alta sulla tela. V’è infatti<br />
uno strettissimo addossamento della materia alla mano che<br />
la lavora. Ragionando per temi e iconografie, la situazione è<br />
quella del coinvolgimento, della progressiva perdita della distanza,<br />
dello stare in mezzo al paesaggio. Ma riflettendo sulle forme,<br />
occorre dire che il coinvolgimento è in prima istanza uno stare in<br />
mezzo al colore. Sono dita colorate al lavoro. La mano preme direttamente<br />
sul foglio, sfrega la pasta, ne trascina i grumi, la<br />
spiaccica in filamenti, macchie e nebulose. Il colore si assembra,<br />
brulica e dentro il formicolio dei segni nascono le figure; o più<br />
esattamente, rinascono.<br />
Fra gli esiti migliori, senz’altro rimarchevoli quelli legati allo scambio<br />
e all’incrocio dei registri, fra osservazione e rifacimento, fra<br />
dato concreto e sua traccia mentale. Perciò non sono distanti<br />
G. Perina, Collina d’autunno, 1959, olio su tela, cm 50x70.<br />
410<br />
dalle opere esposte a Parma, nel maggio ’78, di cui rappresentano<br />
uno sviluppo, un andar ancora più dentro il rapporto pitturanatura:<br />
un rapporto che R. Tassi definisce con le ragioni del “transfert”,<br />
dello spostamento dalla natura al fantasma: i pastelli – annota<br />
– “formano la parte più segreta e forse la più nuova dell’opera<br />
di Perina”, precisando che ciò avviene “per la forza luminosa<br />
e per l’intensità espressiva con cui il colore dà tutte le sue<br />
valenze pure e naturali, per la stravolta e ispirata bellezza con cui<br />
si combina nelle strutture dell’immagine, per il lirismo acceso che<br />
può arrivare fino a trasferire l’immagine da natura a fantasia, e<br />
suggerire l’apparizione del fantasma colorato e diurno di una coscienza<br />
non toccata dall’angoscia. In essa il mistero resta quello<br />
delle pietre preziose e dei sogni ad occhi aperti”.<br />
Così scrivendo, Tassi vuol segnalare implicitamente una distanza,<br />
sottolineare la temperie affatto opposta in cui Perina si trova ca-
G. Perina, Collina, 1961, olio su cartone, cm 47x68.<br />
lato rispetto ad un pittore che pure ama ed ammira senza riserve:<br />
Constable. Certo ha ragione il critico, poiché Constable, nella<br />
sua interpretazione, è temperamento notturno, segretamente<br />
soggiogato da fantasie di inabissamento, da materie oscure e<br />
putride: le acque stagnanti, il legno, l’aria gonfia di umori e di<br />
acque, con il cielo bianco di folgori. Mentre quest’altra pittura, lo<br />
si diceva nell’esordio, sta à ras de terre, sopra il suolo, con frenata<br />
attitudine ascenditiva. Simile a ciò che nasce e rinasce allo<br />
spettacolo naturale, lo sguardo si fa largo nella vegetazione.<br />
La pietra invece dell’acqua, la pianta viva al posto del legno fradicio.<br />
L’aria soffia anche qui, con verità però terrestre. I cieli s’assottigliano<br />
in strisce esigue di cobalto, viola, blu ai bordi della<br />
411<br />
tela. Non cieli propriamente, ma tracce di cielo, confini appena<br />
segnati, margini ed orli. Oppure frammenti gettati nell’onda del<br />
paesaggio e scaglie rifratte nel groviglio delle vigne e sui cumuli<br />
di pietre. L’indeterminato fa da cornice al suo contrario, al limite<br />
e alla gravità delle cose. L’immateriale al materiale, l’azzurro<br />
al verde, la profondità al primo piano. L’affinità con Constable<br />
andrà perciò cercata altrove. Non nelle regioni della notte<br />
ma in quelle del metodo, della pratica pittorica. Nell’idea della<br />
pittura come registrazione e catena di studi, negli atti emozionati<br />
di conoscenza.<br />
(1) Articolo comparso sulla Gazzetta di Mantova, 15 marzo 1980.
“Angelo Giuseppe Facciotto. Scritture (1943-1945)” (1)<br />
Scritture ultime di Facciotto: lettere, appunti, disegni, promemoria,<br />
frammenti poetici e note dappertutto. Sui fogli d’ufficio, nei<br />
quaderni privati, sul retro dei dipinti. Vi è adunato il senso di una<br />
stagione interrotta, di un’epoca di continuo fondata sulla doppia<br />
pronuncia della mancanza e della presenza: sulla fragilità del pittore<br />
e sulla potenza della pittura. V’è il non essere, l’annichilamento,<br />
il sentirsi impari alla esaltata necessità d’un amore, ma<br />
vi insorge anche l’ostinata convinzione che quell’amore si nutre<br />
di sconfitte e tanto meglio vive quanto più è minato dall’impossibilità.<br />
Riordinando le sue opere e riflettendo sui disordini del<br />
destino, Facciotto non trova che difetti, imperfezioni, fallimenti.<br />
Anche alle soglie della seconda personale, il niente è il suo<br />
G. Facciotto, I miei genitori, manoscritto autografo a penna, 1943, mm 240x165.<br />
412<br />
metro di misura: uno zero, come scrive a Borgese. Ma per tre<br />
anni si ostina a raccogliere ed archiviare le tracce di quell’impossibile<br />
niente, poiché il suo niente è attivo: un vuoto da cui<br />
tutto, ancora, può germinare. Posizione omologa ed al tempo<br />
stesso rovesciata rispetto al ’36: anche allora egli faceva questione<br />
di un’attesa, di qualcosa che s’era rivelato e doveva calarsi<br />
in un evento. Ma là si trattava di pienezza, di sovrabbondanza<br />
della visione, mentre ora, nel ’43, la coscienza trova d’essere in<br />
difetto e sa che occorre star dentro l’obliquità dell’errore. Far sì<br />
che le tracce producano il miracolo.<br />
Da qui proviene un’incentivazione critica, l’emergere d’una poetica<br />
che implica distruzione e archivio. Segnati alcuni punti fermi,<br />
l’artista decide di ricominciare.<br />
Valuta anche il senso della propria chiarezza e fa un’osservazione<br />
decisiva, trasferendola dal piano delle tenuità cromatiche a quello<br />
dello splendore, passa cioè ad una inedita illuminazione del vitale,<br />
alla verità della natura come trasalimento. Perciò parla di<br />
“nitore estatico”, convogliandovi attorno tutta una costellazione<br />
di valori per così dire ultranaturali che acquistano caratteri d’ossessività<br />
e di esaltazione: “qualcosa di eterno e di fatale”, di<br />
“astratto”; “un’idea fissa”. Di modo che termini altrimenti inconciliabili<br />
arrivano a convivere: i suoi luoghi fermi, le costanti dell’immaginazione<br />
con le “furie disperate”. Sempre gli stessi motivi<br />
certo, ma sottoposti a più inquietata e sospesa interrogazione.<br />
S’indovina poi, qua e là fra le corrispondenze e le memorie, uno<br />
spostamento di geografia pittorica intorno al ’43, non contradditorio<br />
verso le scelte precedenti e tuttavia incidente sulla inclinazione<br />
del segno pittorico e dei disegni: una più insistita attenzione<br />
ai modelli lombardi, il cui cenno potrebbe forse apparire<br />
d’occasione e legato alle sole circostanze dei rapporti con Milano,<br />
ma che esteriore non può essere se vi si associano altri elementi,<br />
anch’essi frammentari e piuttosto indizi che prove certe.<br />
Ribaditi però, nelle ragioni tematiche, dall’abbassarsi dello sguardo<br />
ad una umile quotidianità, uno sguardo girato verso gli interni<br />
e le cose d’affezione, con un loro ribaltarsi in primo piano e disporsi<br />
in forme trasognate e trasversali. Declinazione evidente<br />
non solo negli oggetti, ma nelle figure e nei ritratti, mentre nei<br />
paesaggi si assiepano fitte barriere in primo piano, specie nei disegni<br />
del ’45. Negli autoritratti il volto infine si dà a vedere per<br />
via laterale, con occhi inquisitivi ed obliqui.
G. Facciotto, 1944, manoscritto autografo a penna, mm 185x135.<br />
Dalle carte vien incontro una gran folla di pensieri, molti dei<br />
quali in riflusso e talora in incrocio con le tesi di poetica degli antecedenti<br />
anni cruciali (del ’34 - ’36 e del ’38 - ’39), tanto da indurre<br />
una scansione più fluida fra le tappe del dodicennio creativo.<br />
Ritornano le argomentazioni sul colore, sulla “verità” dell’ispirazione,<br />
sul mestiere e sulla tecnica, sull’arte mantovana. Ed<br />
altre vi si legano, nuove soprattutto per il tono interrogativo e<br />
autocritico.<br />
Se la sosta fra le carte del triennio porta a cogliere spessori biografici<br />
e temi di cronaca, il loro vero motivo di interesse va molto<br />
oltre i confini d’una vita segreta e si colloca su ben altro versante.<br />
Le scritture fanno in realtà corpo strettissimo con l’esercizio<br />
dell’immagine, giacché per Facciotto (e qui sta la radice morale<br />
413<br />
e non mimetica del suo lavoro) anche la biografia è materia che<br />
si fa visione. Può stupire che egli si soffermi su fatti minuti, che<br />
ci torni sopra e ci si arrovelli, lui che aveva un’idea così acuta del<br />
far pittura da non trovare altri paragoni possibili che con gli stati<br />
davvero estremi ed opposti degli idioti o degli spiriti di genio. Il<br />
fatto è che quelle minuzie quasi mai contano per se stesse, valgono<br />
in controluce e in trasparenza su uno schermo di riferimento:<br />
la pittura. Sono le sue grandi o minime metafore. Quando<br />
ci consegna un tema d’amore, si può essere certi che, in un<br />
altro passo, vi corrisponde una equivalenza più alta: quella dell’arte.<br />
Che è un modo per moltiplicare la potenza dei segni e<br />
delle parole, di produrre un accumulo di immagini.<br />
L’edizione di queste pagine nasce anche da una scommessa ed<br />
ha un’ipotesi da verificare: dar conto di un Facciotto estremo, più<br />
dubitativo ma anche più tragico e visionario. Fra i pensieri seguiti<br />
alle mostre del ’43 e i pochi dipinti (ma i moltissimi disegni) del<br />
’45, pare aver corso una diversa avventura: quella di una sensibilità<br />
incline ad eccessi sensitivi e in grado di avvertire, anche sul<br />
piano della natura, i soprassalti dei fenomeni di mutazione.<br />
(1) Presentazione del catalogo “Angelo Giuseppe Facciotto. Scritture<br />
(1943-1945)”, scritta in occasione della mostra tenutasi presso “Gianluigi<br />
Arcari”, via Cappello 10/a, Mantova, 31 maggio-4 ottobre 1980.
Irrealtà del naturale<br />
Giuseppe Facciotto (1)<br />
È una prerogativa di Facciotto, della sua pittura come della sua<br />
parola, dare insieme la cosa e il fantasma della cosa, attenersi<br />
alla concretezza d’una sensazione, tuffandola però nel risentimento<br />
d’una perdita imminente. Facciotto è sì il pittore dell’attimo,<br />
dell’impressione istantanea, della registrazione bruciante,<br />
capace di rifare sulla tela la pienezza d’un gesto, di fissare d’un<br />
colpo la totalità della visione. Ma dietro la pienezza, anche nei<br />
G. Facciotto, Doppio ritratto (Nene ed Ezio), s.d., olio su cartone, cm 60x70.<br />
414<br />
momenti più felici, s’avverte una incrinatura, una febbre di ricominciamento.<br />
C’è il bisogno di tornare a calarsi nei paesaggi, di<br />
fondersi con oggetti e figure.<br />
In ogni momento egli avverte la minaccia della separazione, del<br />
restare impietrato di fronte all’immagine. La pittura - egli afferma<br />
-, quando non è "illuminata", resta inerte tecnica riproduttiva.<br />
Una pratica sterile, antifusionale.<br />
“È dannoso - scrive in un appunto - guardare Monet e Renoir per<br />
poi andare sul paesaggio e rifare gli stessi verdi. La pittura purtroppo<br />
non si risolve coi pennelli”. Per lui, infatti, la questione è
di aprirsi all’evento della rivelazione (del “vero”), di scoprire<br />
un’anima nel campo dei fenomeni: una irrealtà1 che è poi la verità<br />
magicamente trovata nella carne della natura.<br />
“La mia idea è che in arte - prosegue subito la nota - la tecnica<br />
non esiste” 2 , così come non esistono, secondo il pittore, l’imitazione,<br />
il calcolo, la fredda progettazione. Tutto, nel quadro e nel<br />
disegno, deve risultare da rapidità esecutiva, dev’essere fulmineo<br />
e inconsapevole, automatico e immediato3 .<br />
Eppure Facciotto amava la tecnica. Innumerevoli testimonianze,<br />
non solo sue, lo confermano. Aveva addirittura un culto fanatico<br />
per la preparazione dei cartoni e delle tavole4 . Meglio: amava il<br />
mestiere, la naturalezza e la sapienza del fare. Ma tecnica e mestiere<br />
metteva ogni volta in questione, osservando da un lato che<br />
“in pittura si possono usare anche le dita, un cucchiaio” e sostenendo<br />
dall’altro, come s’è visto, che la tecnica, in arte, non conta.<br />
Così addensava ombre e tentava, rinnovando l’interrogazione<br />
sugli strumenti, di rendere fluido l’immobile, di evitare le “formule”.<br />
Formula: persino Cézanne, così ammirato in certi anni,<br />
aveva irrigidito la sapienza dei veneziani creando una ricetta<br />
senza “via d’uscita”. Ragion per cui Facciotto non riteneva di<br />
dover guardare ai cubisti, cui imputava di aver frainteso quel non<br />
so che di cosmico che animava le forme di Cézanne.<br />
Egli vuole, al contrario, svuotare e cancellare i suoi stessi programmi,<br />
negare il primato della teoria e del sistema.<br />
Una scelta decisa e “critica” 5 , questa, caparbiamente inseguita. E<br />
tradotta nei paragrafi d’una poetica che non cessa di ripiegarsi<br />
sui propri presupposti, di tornare alle premesse per farne oggetto<br />
di riflessione. Una poetica percorsa dall’ammonimento che la<br />
pittura si perde quando l’intelligenza non ridiscenda e scompaia<br />
nel grembo dell’emozione. Perciò tanto la parola scritta quanto<br />
il segno rappresentativo vengono sottoposti a un esercizio di<br />
umiliazione, di abbassamento, spinti a fare i conti col tono<br />
medio, che assai spesso coincide col quotidiano e col naturale, e<br />
sempre con la “verità” della sensazione.<br />
Anzi, proprio il dibattito fra altezza e caduta costituisce un nodo<br />
centrale del discorso. Da un lato s’inarca la vertigine dell’unica illuminazione<br />
(che è poi il lampo di compenetrazione con la Natura),<br />
dall’altro quella luce vien piegata a comprendere i luoghi<br />
comuni dell’esistenza. Un chiasmo di eccezione e normalità. Così<br />
Facciotto si affanna a dire che i “geni”, i “grandi”, i “maestri”<br />
415<br />
G. Facciotto, Autoritratto, 1938 ca., olio su cartone, cm 68x50.<br />
sono tali perché praticano una lingua quasi inavvertita e sanno<br />
stare tra le cose: coloro che intrecciano la singolarità con la parola<br />
familiare e anonima.<br />
Essere qualcuno o uno qualunque? 6 La divaricazione sembrerebbe<br />
radicale; dà luogo invece ad una disgiunzione produttiva, ad<br />
una aspirazione all’unità, cioè all’assoluto naturale, nel pensiero<br />
dell’autore: una assolutezza che è azzeramento del soggetto, valore<br />
neutro perché fluido, giacché il segno, quando fluisce con lo<br />
stesso respiro delle cose, perde il sigillo della proprietà e del<br />
nome. Duplicità, si capisce, irrisolvibile, poiché un polo non può<br />
stare senza l’altro, ha bisogno di bruciarsi nella tensione contraria.<br />
Come l’oggetto nel suo fantasma.<br />
In tal modo Facciotto s’è costruita, oltreché una poetica, una mitografia.<br />
Una mitografia che ha funzionato fin da principio sotto
l’etichetta del pittore "candido" e puro, "sereno". Aggettivi che<br />
colpiscono nel segno, i primi due, poiché toccano un registro<br />
della sua scrittura e ne indicano la volontà d’approdo, mentre<br />
non danno conto della genesi dell’opera e neppure delle scansioni<br />
che segnano il tragitto temporale di una evoluzione pittorica<br />
sia pure fatalmente breve, tutta circoscritta com’è nell’arco<br />
di poco più di un decennio, dal ’34 al ’45, a tener conto delle<br />
prove maggiori.<br />
Restano, però, fortunatamente i taccuini di Facciotto (non tutti, a<br />
causa della dispersione della sua opera dopo la morte). Restano<br />
gli abbozzi, gli schizzi, gli appunti, i progetti, i pro-memoria, le<br />
autorecensioni immaginarie7 e i registri. Vale a dire le tracce del<br />
processo creativo, dalle quali si ricava l’idea di una periodizzazione,<br />
di un movimento, di una storia interna. Storia coerente ma<br />
non per questo senza strappi, fratture e slanci rinnovati.<br />
Allo stato spesso magmatico, come accumulo apparentemente<br />
sincronico di frammenti, la documentazione è a sua volta un universo<br />
di resistenze.<br />
G. Facciotto, Natura morta bianca, 1942, olio su cartone, cm 50x60.<br />
416<br />
Il fatto è che Facciotto, per sua natura pittorica, si insedia nel<br />
cuore di una mobilità già di per se stessa produttrice di articolazioni<br />
plurime, di diramazioni e di simultanee variazioni di registro.<br />
Sicché è arduo ancorarlo a una partitura conclusa di segni, perimetrarlo<br />
dentro un’epoca, fargli percorrere delle ordinate stazioni<br />
diacroniche: v’è il rischio di scoprire, di lì a poco, che una stessa<br />
immagine, una certa inquadratura, aveva già ispirato il pittore.<br />
Né conviene trar partito certissimo dal criterio di qualità, giacché,<br />
anche qui, certe prove di grande intensità non si pongono<br />
al culmine di un decennio ma ‘aprono’ un’epoca o fanno stazione<br />
in se stesse. Valga per tutte l’esempio del Nudo disteso col<br />
gatto che, sul fondamento del registro autografo8 , va riportato al<br />
1935 c., vale a dire al momento di un dibattito di posizioni. Un<br />
nudo interamente dato per trasparenze aeree, per via di smaterializzazioni<br />
cromatiche, senza ingombri di paste e di velature<br />
sovrapposte, dall’impianto nitido eppure privo di peso, quasi si<br />
trattasse di un sogno (tra un De Pisis e un Modigliani) di fronte<br />
alla figura. La stanza è divenuta un paesaggio mentale, gli oggetti<br />
non sono più oggetti nè soltanto carni le carni, ma velari e<br />
sipari, campi di colore. Viene subito alla mente una metafisica<br />
del vero, quella “vita irreale” che il pittore sentiva battere dentro<br />
di sé proprio trasferendosi nell’eccitazione dei fenomeni. Se<br />
v’è, sia pure in eco lontana, un’iconografia altamente stilizzata,<br />
da italiana scuola di Parigi (la nudità dispiegata sulla diagonale,<br />
una nudità anche come enigma), quell’iconografia esce però<br />
dall’architettura dei contorni, non ha marcata grafia che la contenga,<br />
risolvendosi invece in una ritmica dello spazio e del colore.<br />
In più il nudo è figura esibita su un ventaglio di poche quinte<br />
spaziali che si incernierano di lato, come se l’angolo, la lateralità,<br />
il margine fossero la sorgente della rappresentazione.<br />
Qualche anno più tardi, alcune nature morte e paesaggi faranno<br />
leva su un’analoga ‘battuta’ laterale, per i loro piani d’appoggio<br />
e di germinazione.<br />
Si può dire intanto che la fluidità della pittura facciottiana, l’impianto<br />
mobile dei dipinti, non tende affatto a privilegiare il centrifugo<br />
a scapito della concentrazione. Sempre, in tutte le stagioni,<br />
anche in quella della "preistoria" (e si ha modo di constatarlo<br />
fin dall’isolato miracolo di Paesaggio con cipresso, 1926-<br />
27), sussiste un luogo d’ancoramento, un punto dello spazio che<br />
fa da culminazione; e che, in assenza d’una cerniera dominante,
viene ad assumere funzione organizzatrice una sequenza ritmica<br />
di rimandi, una scansione di battute, un discorso in rima cromatica.<br />
C’è amalgama, conversione del multiplo all’uno, condensazione.<br />
I larghi spazi, lo straripamento d’atmosfere, le variazioni,<br />
gli slarghi e le ‘fughe’ han modo di esprimersi dandosi<br />
il limite d’un puntello, la certezza benché minima d’un segmento.<br />
Questo segmento potrà essere in parte occultato, dato di<br />
sbieco, in un angolo della superficie, ma potrà anche esporsi deliberatamente,<br />
come quinta esplicita o primo piano orizzontale,<br />
parapetto visivo e valico da sormontare. Il limite (o cornice, che<br />
è cornice di risonanza) è per lo più esso stesso ritmato, modulato<br />
su un valore eccentrico, su un salto, come se lo spazio ulteriore<br />
dovesse essere sottoposto ad una interpellanza, messo in<br />
agitazione per rivelarsi. Talvolta si ha l’impressione di dover superare<br />
un breve varco prima d’imbattersi, di attraversare il luogo<br />
di partenza per la lettura: una breve sospensione nel vuoto, una<br />
pausa, prima del disteso racconto. Qualche volta, perfino violentemente<br />
(come capita di vedere in alcuni disegni sia del ’36-’37<br />
che del ’44-’45), un’immagine compatta viene eretta sulla verticale<br />
e al centro della composizione: un albero, un incrocio di<br />
strade, un chiasmo figurale, una persona. Nei casi più complessi<br />
un reticolo e una gabbia visiva, non tanto col compito di indurre<br />
una prospettiva a cavaliere, quanto per disporre un filtro e<br />
ordinare la cadenza del visibile. Uno stimolo ottico e dinamico,<br />
che decanta e rilancia.<br />
Se un motivo torna prepotentemente ad insistere nella pittura di<br />
Facciotto, c’è da scommettere che, insieme ad altre urgenze fantastiche,<br />
agisca l’interesse compositivo per questo cardine della<br />
visione: il tema figurale della cerniera e dell’appoggio; del valico<br />
che aggancia l’occhio per rendere più acuto l’apprendimento<br />
della realtà, del lontano. In alcune nature morte degli ultimi anni<br />
(Natura morta - in bianco, 1942, e Piccola cucina, 1945) l’accentuazione<br />
dei piani inclinati è la conseguenza di un simile<br />
pensiero (i tralicci assiepati di fronte allo sguardo), pensiero a tal<br />
punto irriducibile che una totalità viene declinata verso l’incipit<br />
e la nota d’esordio. Anche la serie degli autoritratti disegnati fra<br />
il ’43 e il ’45 mostra un tormentato rapporto della mano (una<br />
metafora forse della pittura9 ) con lo sguardo, una relazione fra il<br />
gesto che occulta e l’accrescimento di tensione. Ma, a voler dare<br />
una sola stringente campionatura all’interno di un tòpos costan-<br />
417<br />
G. Facciotto, Autoritratto con Gabriella in azzurro, 1942 ca., olio su cartone,<br />
cm 50x69.<br />
te, appaiono significativi gli oli e i disegni ispirati ad un paesaggio<br />
del Dosso, la Casa Rubini, di cui esistono infinite versioni. L’argomento<br />
dà origine ad un ampio capitolo stilistico, fin dal 1930:<br />
sempre, in queste opere, case e campi vengono fatti emergere<br />
dietro una cortina di rami, oltre un cancello, che in qualche caso<br />
(nei disegni) viene rinforzato da un raddoppiamento, dalla nota<br />
aggiunta di un secondo cancello, al di qua della strada. Battutapausa-esordio.<br />
Ed è la speciale calibratura di questa soglia a regolare<br />
lo sviluppo delle partiture successive, oltreché a segnare,<br />
nel tempo, l’evoluzione del discorso formale: nella tela del ’34<br />
(coll. A. Pasino), la nota d’apertura è giocata su una tenera modulazione<br />
di verdi e in certo modo su un valore d’assenza (il tratto<br />
appena velato o scoperto di tela: cosa assai rara, ma presente<br />
in un’altra opera del medesimo anno, in Paesaggio verde con<br />
ciminiera). Un lieve accordo d’introduzione al secondo campo visivo,<br />
fortemente ravvicinato e radiante. Nel ’38 invece (coll. A.<br />
Morari) le immagini si distribuiscono su fasce orizzontali, con un<br />
più accentuato spessore di corpi, mentre nel ’40 (versione maggiore,<br />
coll. G. Venturini) v’è una rapidissima partenza esecutiva<br />
(anche nel gesto), proprio sul bordo della raffigurazione, con un<br />
immediato controcanto in orizzontale e tre battute in verticale<br />
che aprono su uno sconfinamento paesistico, di cui la casa è<br />
quinta affiancata. Una serie di appoggi, dunque, al servizio della<br />
variazione di spartito.
“La pittura è canto”, musica, leggiamo in una nota. Non<br />
“grido” 10 . Ma il canto si serve di limiti e di interdizioni, per dispiegarsi.<br />
Paesaggio col cipresso documenta, senza ombra di dubbio, l’originalità<br />
di questo pensiero del limite e lo riconduce, al tempo<br />
stesso, alla matrice dell’insegnamento bignottiano11 : il retroterra<br />
d’impressionismo locale per il giovane Facciotto. Castiglione,<br />
d’altronde, rappresenta uno strato resistente della sua memoria<br />
figurativa, tanto più robusto quando viene a formarsi nell’Alto<br />
Mantovano, agli inizi del Trenta, un clima di incontri “chiaristi”<br />
che favoriscono il progetto di nuova pittura. Una proposta sostanziata<br />
dall’esempio di Del Bon (e in seguito di Lilloni), con la<br />
mediazione del critico (e pittore) O. Marini e dello scultore Mutti.<br />
L’idea diviene presto progetto e sogno anche per Facciotto: qualcosa<br />
di simile ad una divaricata avventura, a confronto della più<br />
recente tradizione mantovana di paesaggio.<br />
G. Facciotto, Ritratto dei genitori (incompiuto), s.d., olio su cartone, cm 50x70.<br />
418<br />
“Parve accarezzare per qualche tempo - scrive E. Faccioli - l’idea<br />
di un Principato di Castiglione (insieme a Marini, Mutti e alla Nodari).<br />
Ma più tardi, con Lilloni e Del Bon, che proprio nel Principato<br />
andavano a villeggiare, si mise sulle piste di Semeghini, lo<br />
inseguì fino a Mazzorbo” 12 .<br />
Tuttavia, dentro la novità del “chiarismo” milanese e veneziano,<br />
una novità in grado di segnare un largo momento collettivo dell’arte<br />
mantovana13 , si macinano anche motivi della tradizione,<br />
recente e lontana, della pittura; e Bignotti, per Facciotto, fa parte<br />
di questa tradizione: è il suo ponte verso il post-impressionismo,<br />
ma soprattutto l’iniziazione al processo pittorico: il primo maestro<br />
di vedute dall’alto, dei verdi declinanti al grigio, d’una figurazione<br />
che è poesia14 .<br />
Si è detto che il piccolo quadro del ’26 - ’27 è un “miracolo”. Rimane<br />
difatti isolato e in fortissimo anticipo sulla pittura successiva<br />
dell’autore. Tale dovette considerarlo anche Facciotto che
mai lo incluse in una mostra e pur registrandone ripetutamente<br />
la presenza nel registro autografo delle opere, lasciò un’ampia<br />
spaziatura di silenzio fra la data della sua composizione e gli<br />
anni Trenta.<br />
All’aprirsi del nuovo decennio, sull’asse Mantova - Castiglione,<br />
egli inaugura davvero la ricerca pittorica sua propria. La certezza<br />
della vocazione è in principio fissata nell’esecuzione di esili bozzetti<br />
colorati, in disegni per così dire dipinti, in piccole tavole<br />
(Paesaggio, 1930) e ritratti (Lidia col cappello, 1932).<br />
Contemporaneamente va registrato un intenso scambio di esperienze.<br />
Se a Castiglione Marini tiene le fila dei rapporti col “chiarismo”,<br />
a Mantova tutta una giovane generazione respira aria<br />
meno provinciale, cultura non solo nazionale, ma anche europea<br />
(pensando a Persico). Cavicchini, Bergonzoni, Bini, Perina, Di<br />
Capi, in ispecie, dibattono i nuovi orientamenti, ciascuno con inclinazioni<br />
diverse e persino oppositive.<br />
G. Facciotto, Nudo diteso con gatto, 1935 ca., olio su cartone, cm 41x64.<br />
419<br />
Neppure si può dire che essi dimentichino quel che le arti figurative<br />
mantovane sono state e sono. Basta scorrere, per esempio<br />
Artisti15 di Sandro Bini (che tenterà di far attecchire a Mantova,<br />
più tardi, un altro ramo milanese, Birolli, ma ci riuscirà in<br />
parte col solo Perina), per constatare che il cordone ombelicale<br />
con la provincia, anche per chi sta per andarsene, non è stato interamente<br />
spezzato. Si insiste su Giorgi, nel caso di Bini sul controluce<br />
di Milano. Si tien conto dei Lomini, Polpatelli, Guindani e<br />
Zanfrognini16 , come di artisti con i quali è lecito fare confronti,<br />
magari per scoprirsi distanti, mentre nei diari segreti non si<br />
legge quasi nulla della più importante presenza artistica del<br />
primo Novecento: Vindizio Nodari Pesenti17 . Questi fa isola a sè<br />
ed è legato piuttosto ad altro giro di relazioni ufficiali e private<br />
(Guindani, ad esempio).<br />
Con Di Capi le testimonianze portano a credere che il dibattito riguardi<br />
il problema dei calibri compositivi in pittura, dell’ordine e
della proprietà linguistica, nell’idea, propria di Di Capi, che risalendo<br />
dalle avanguardie ai ‘classici’ della realtà, in Ottocento<br />
inoltrato, si possa e si debba reimpostare la pittura sul principio<br />
dell’analisi. Ecco allora gli esercizi di incernieramento spaziale, i<br />
dosaggi al millimetro dei colori e dei segni (che fanno pensare<br />
anche a Chardin: quindi ad una riflessione a lungo tragitto sulla<br />
storia della pittura), le smorzature di tono, per ricavarne le essenze<br />
cromatiche e quasi la sezione aurea delle forme: elementi<br />
che costituiscono un motivo di tangenza, di comune indagine<br />
e infine di spostamento, nella diversificazione delle scelte, fra Di<br />
Capi e Facciotto. Fra ’32 e ’35 questo insieme d’argomenti (e Cavicchini<br />
dovette discuterli dalla sua prospettiva novecentista)<br />
viene affrontato insieme, quando ancora una certa disponibilità<br />
verso la linea di Sironi è ritenuta possibile. Alle porte, batte però<br />
un altro novecentismo: quello magico e bontempelliano, d’insurrezione<br />
verso la Sarfatti.<br />
L’Ottocento francese. Corot.<br />
A chi allude Facciotto se non a Di Capi e ai mantovani, scrivendo<br />
a Marini nel ’35? In quella lettera dà notizia d’un comune innamoramento:<br />
“Troverai modo di convincerti - scrive - che non<br />
abbiamo torto ad entusiasmarci per Corot. Osserva con quanta<br />
sobrietà di colore è fatto quel mulino colla strada. E pensare che<br />
è un pittore del primo 800” 18 . L’intenzione è trasparente: coordinare<br />
chiarezza e sobrietà, effusione lirica e impegno costruttivo,<br />
Castiglione e Mantova.<br />
Che cosa v’è in comune fra Facciotto e Di Capi? Innanzitutto<br />
l’idea di “mestiere”, di nobiltà della pittura; benchè questa teoria<br />
del mestiere, che attraversa gli anni Venti e Trenta come una<br />
cifra di rinnovato classicismo per molti, sia poi intesa dai due in<br />
modo affatto speciale (come dimensione dell’ordine primitivo e<br />
dell’artigianale). Nè le conseguenze sono le stesse: mentre Facciotto<br />
dirà che ogni amore, e tra gli amori anche quello che lo<br />
lega al mestiere, va cancellato e fatto naufragare nell’empito di<br />
fusione col naturale, Di Capi isserà quel tòpos a tema stesso e<br />
stile dell’opera. Cosa che diverrà chiarissima, intorno al ’50, nei<br />
dipinti che Facciotto non vide, dipinti in cui la trama neocubista<br />
dell’immagine rivela l’istanza dell’analisi come esigenza primaria<br />
di tutto il lavoro di Di Capi.<br />
Il “musicale” Facciotto e l’ “architettonico” Di Capi, inoltre, nutrivano<br />
insieme il culto del sobrio e della tenuta del quadro, che<br />
420<br />
doveva svilupparsi come un serrato microcosmo, un tout se tient<br />
concentrato. Infine, se non temessimo di forzare una temperatura<br />
d’amicizia, diremmo che l’uno rappresenta per certi versi l’<br />
‘impossibile’ dell’altro, il suo partito di contraggenio. Nell’indipendenza<br />
trovavano motivi di intesa, anche se la misura dell’eternità<br />
doveva essere micidiale per Di Capi, così alieno dall’abbandonarsi<br />
all’aneddoto e al particolare descrittivo, che poteva<br />
viceversa riuscire compatibile alla poetica dell’istantaneità di<br />
Facciotto.<br />
Per quanto concerne Cavicchini, i motivi di consonanza sono certo<br />
presenti, ma forse meno immediati.Vengono a porsi su un livello<br />
di ‘cultura’ piuttosto che di anima pittorica: su quel piano<br />
di esperienze che Facciotto intende mantenere sempre segreto.<br />
Il piano dell’intelligenza critica e storica. È lo stesso Cavicchini, in<br />
una sua recensione, a fare i nomi che interessano, quando legge<br />
in Facciotto i segni di Signorini, Fattori e Fontanesi (e certo l’artista<br />
poteva consentire), ravvisando chiaramente la centralità di<br />
una temperie “cosmica” dell’ispirazione, che impedisce di insistere<br />
troppo su debiti e ascendenze. Con Perina, infine, fa occasione<br />
di discorso il concetto di ‘imitazione’: mentre questi vuol<br />
passare attraverso il “sistema” ricevuto dall’impressionismo,<br />
darsi insomma una base ottica, stretta alle categorie operative<br />
di un Monet o di un Cézanne (e le cala nel ‘motivo’ per ricostruire<br />
la natura e farne sprizzare le energie), al contrario Facciotto<br />
insegue una tecnica dell’automatismo che non ammette mediazioni<br />
grammaticali, se non molto lontane, alle spalle. Alla<br />
memoria d’una sintassi egli contrappone l’arte della dimenticanza,<br />
al risentimento della grammatica l’imitazione della natura.<br />
Così almeno gli pare. Facciotto senza modelli?<br />
Pare difficile sostenerlo, per quanto la decantazione delle influenze<br />
sia molto ardua da attuare. La più esplicita, sia detto ora<br />
anzitempo, è quella di Semeghini: poiché a lui e a pochi altri sono<br />
dedicate alcune citazioni figurali: scorci ed immagini di Burano e<br />
Mazzorbo, ripensati sempre ad una potenza diversa, e tuttavia<br />
nascenti, con alta probabilità, da suggestioni semeghiniane. Ma<br />
appunto suggestioni. Meglio dire allora che Semeghini, come per<br />
traslato Van Gogh e Gauguin (in taluni autoritratti e nature<br />
morte), rappresenta un polo di orientamento mentale, un segnale<br />
di direzione. Seduzione, imitazione, dimenticanza: una triade di<br />
attitudini che Facciotto discute per apprendere o respingere e che
sono parte del clima culturale di un’epoca mantovana.<br />
Quando, nel ’35, non è stata chiarita del tutto la posizione definitiva,<br />
Facciotto si dibatte fra molteplici innamoramenti, ma già<br />
sufficientemente circoscritti e declinati in pronuncia "chiarista" e<br />
veneziana. In più la sua inchiesta riguarda i modi in cui una antica<br />
tradizione è stata ripresa lungo l’esperienza romantica e<br />
tardo-ottocentesca: “lo non so - scrive - quale sia la strada da seguire;<br />
mi sento attratto da tutti i più grandi [Delacroix compariva<br />
qualche riga avanti, n.d.a.], ma fra questi sento che sono ancora<br />
sempre i veneziani. Tutti qui si sono abbeverati, Cézanne<br />
compreso. Lanciarmi sulla pittura di questo mi sembra un grave<br />
errore” (Lettera a O. Marini, 28 - 11 -’35).<br />
Le attrazioni non sono superate neppure l’anno successivo. Ciò<br />
G. Facciotto, Piccola cucina, 1945, olio su cartone, cm 25x34,5.<br />
421<br />
nonostante appare esplicito il corso (in negativo) della riflessione:<br />
“Questi autori francesi mi seducono, ma non è con questi che<br />
io mi accoderò” (Lettera a corrispondente anonimo, 26 - 5 -’36).<br />
Nel frattempo il pittore è uscito allo scoperto, esponendo alla<br />
sua prima collettiva del ’34 Uomo che mangia ed altre opere<br />
oggi perdute. Da questo olio, come da successivi nudi e figure, si<br />
ricava una smaterializzazione delle forme che insiste sulle<br />
ombre colorate e su un ordito quasi invisibile. Il traliccio dell’immagine,<br />
piuttosto che plastico, è difatti aereo, disincarnato. Le<br />
superfici dei corpi, dei panneggi, degli oggetti, vengono tradotte<br />
in quantità luminose, in tessere e vele. Prevalgono accenti di<br />
accordo e di consonanza, di modo che ad una cromia elevata a<br />
tono maggiore fanno eco varianti di profondità e di risonanza.
G. Facciotto, Torcello, 1942, olio su cartone, cm 40x50.<br />
Anche in Pagliai in Toscana del ’36 la pittura si dispiega sui registri<br />
di rarefazione e radianza, nell’annullamento della prospettiva<br />
e della gravità. La superficie impone davvero una severa<br />
legge compositiva, invitando ad agire sulle sue dimensioni proporzionali<br />
anziché sui dati d’illusionismo.<br />
È forse questo il momento di più meditata vicinanza a Di Capi, a<br />
un Di Capi però annegato nel giro d’un canto luminoso e travolto<br />
nelle sue stesse analisi spaziali. Eppure una così alta misura di<br />
accordi, una così calibrata essenzialità non corrispondono interamente<br />
alle aspirazioni dell’artista. Egli sente il dramma della separazione<br />
dalle cose. Il regìme secco dell’immaginazione non gli<br />
422<br />
basta. Vuole l’immersione.<br />
Ecco due confessioni dell’estate ’36: "Un giorno gli squallidi oggetti<br />
del mio studio mi si scandirono dinnanzi agli occhi nelle<br />
loro linee precise e mi apparvero nel loro colore esaltato. Quel<br />
giorno - continua il frammento - io capii che avrei fatto qualcosa<br />
in pittura" (12-6-1936). Poche settimane prima aveva annotato:<br />
“Tu a un certo punto senti che la materia cede e che il pennello<br />
corre come se ubbidisse alla tua visione (...) Ma verrà<br />
tempo, lo sento, che forzerò la materia. (...) Allora andrò pazzo<br />
di gioia per le campagne, mi mescolerò alle messi, affonderò<br />
nell’erba ubertosa e fresca, vivrò la vita delle più umili e degne
estie. La vita primitiva. La vita antisociale” (31-5-1936).<br />
Sono presagi decisivi: ubertoso, fresco, primitivo, esaltato. Che<br />
significano se non una rinnovata ed ancor più radicale volontà<br />
di compenetrazione con la ‘natura’, di comunione con l’Altro, di<br />
solarità annegata negli umori della terra, di fertilità e di fecondazione?<br />
Fantasie di interramento agitarono spesso Facciotto. E si vuol dire<br />
anche interramento della pittura, dell’opera; riconduzione, come<br />
ha spiegato E. Faccioli, alla matrice della vita, al Femminile.<br />
Quali sono i desideri dei pittori, i gesti che essi vorrebbero compiere?<br />
Ecco la risposta: “lasciare le proprie tavole nel luogo dove<br />
furono dipinte”, abbandonarle in “campagna” 19 .<br />
Ne deriva una complicazione e un arricchimento nei regimi dell’immaginario.<br />
Ora, dal ’37 e soprattutto dal ’38 in poi (fino ai dubbi e all’incupirsi<br />
dell’umor "malinconico", che si potrebbe chiamare, per<br />
usare parole sue, “disperato”, attorno all’autunno del ’43), una<br />
lunga e continuata catena di invenzioni espone una nuova immagine:<br />
una visione che lievita, fermenta, si rigonfia.<br />
Prende quota la pittura “anfibia” d’acque e di arie, con conseguenze<br />
strutturali per l’immagine che esce dall’à plat sonoro, dal<br />
piano quasi musivo del primo triennio, per inoltrarsi in gorghi<br />
misurati e trasalimenti, secondo una spazialità vicina all’ordine<br />
dello sferico. E s’avvita talora in moti ellittici, ascenditivi (Colline<br />
a Sant’Andrea, per esempio).<br />
Si vedano, a riprova, i pastelli e i disegni (a carboncino) dei paesaggi<br />
morenici, le figurazioni di viottoli e viali aperti su un fianco,<br />
le fughe di balze e strade, di cui si indagano le ventate d’alberi,<br />
gli ampi ventagli laterali, il germinare di cespugli, gli snodi<br />
e i crocicchi (Strada in collina, Steccato). La sofficità ondulante<br />
dei terreni, le mareggiate di campi e grani sono in funzione del<br />
prorompimento prospettico, ma di un prorompimento anche in<br />
avanti e circolare.<br />
V’è esaltazione, ma non disordine: rotazione piuttosto e circolarità<br />
di elementi: quel “cosmico” che Facciotto aveva tanto inseguito<br />
è ora raggiunto.<br />
Un analogo spirito di totalità animata vive nelle nature morte,<br />
dove gli oggetti si irradiano in una compagine di ritmi e di pulsazioni<br />
fin dentro le quinte degli sfondi e talvolta pencolano nell’assorbente<br />
tessuto dei piani d’appoggio.<br />
423<br />
Si capisce allora come Facciotto abbia sottolineato l’importanza<br />
del segnale-Semeghini, non per affiancare quella lezione, ma<br />
per materiarla di altre eccitazioni, con un suo senso differente<br />
dell’equilibrio: spostando i fuochi e giocando sugli scarti. Certo vi<br />
sono aneddoti, brevi episodi, frammenti narrativi dentro il racconto<br />
più grande degli elementi (figurine e barche nelle vedute<br />
di laguna; l’esile voluta di fumo, ad es., nella Casa Rubini del<br />
’40), ma il particolare si lega, là dove riesce, all’insieme e tanto<br />
più ha forza (anche quella di sottolineare la cadenza dell’effimero),<br />
quanto più esibisce una necessità di struttura compositiva. È<br />
il caso, per esempio, di certi campanili di Angeli, Mazzorbo e Burano,<br />
che, a guardar bene, rappresentano il fuoco ultimo della visione,<br />
un punto di arrivo quasi inavvertito, cui si risale percorrendo<br />
l’arabesco portante della composizione.<br />
Perdurano, in quest’epoca, anche gli ordini paralleli, a gradi, dei<br />
piani di rappresentazione, la cui metrica segreta è però una diagonale,<br />
o un accenno di obliquità, un lieve spostamento d’asse.<br />
G. Facciotto, Fiori con libro di Maria, 1940 ca., olio su cartone, cm 60x50.
Tanto che, volendo segnalare un tema ricorrente dell’orditura<br />
spaziale, specie per i Canali di Mazzorbo, le periferie e le strade<br />
in collina, lo si potrà indicare in una grafia serpentinata e inconclusa<br />
che annoda le presenze dei primi piani per dissolverle in<br />
enunciati di fuga. Un altro dato abbastanza costante è l’appoggio<br />
dei gravi su un’icona accostata alla cornice, sicché il paesaggio o<br />
la figura sembra accennare ad un moto di assestamento; o di risveglio.<br />
Soluzione più volte adottata, e talvolta contestata nell’ultimo<br />
periodo, se si tien conto dell’intervento cancellatorio<br />
(del’45) su un Pontile a Torcello, inteso ad allentare la pressione<br />
dei pesi su un fianco. Sopravviene nel ’43 l’opportunità delle mostre<br />
personali. Facciotto comincia a tracciare bilanci e a stabilire<br />
sequenze. Progetta nuovi studi. Fra ’42 e ’43 vien scoprendo una<br />
gestualità assai più risentita che nel passato e diretta, una sorta<br />
di scrittura colorata sul quadro, che è preludio ai più tesi momenti<br />
disegnativi dell’estremo triennio. L’attenzione si sposta, in<br />
qualche caso significativo (Burano, coll. Arcari) verso le alterazioni<br />
e i mutamenti d’atmosfera, i fenomeni di rapida trasformazione,<br />
i miraggi (Arcobaleno, coll. Baratta). Trascorrimenti di nubi<br />
(Nubi e campi, coll. Panina). O interni, stanze e nature morte bagnate<br />
da una luce radente, tutta mentale. V’è talora anche irruzione<br />
di frontalità (Albero centrale, 1944). Facciotto non accarezza<br />
più fertilità paesistiche: c’è un sondarle in profondità per<br />
cavarne anche riverberi psichici, quasi simboli quotidiani (Piccola<br />
cucina, ’45). Ha fretta, non solo di accumulare e di conservare,<br />
per antica consuetudine con l’archivio privato delle memorie,<br />
ma di verificare e di scegliere; di vagliare e tracciare altre prospettive.<br />
Negli ultimi mesi di frenetica registrazione grafica (e di<br />
malattia) gli accenti visionari si intersecano alla contemplazione<br />
del naturale. Potrebbe essere una nuova, la terza stagione di<br />
Facciotto. Ma è stagione rimasta aperta e meglio ravvisabile nei<br />
disegni che nei dipinti. “È inverno - egli conclude - e fuori c’è la<br />
neve/una luce irreale entra e batte sulla tavola azzurra e le cose<br />
assumono un non so che di magico”.<br />
1. Irreale è aggettivo frequentemente usato da Facciotto, non per indicare una<br />
dimensione contrapposta alla realtà, alla natura, ma al contrario la sua sostanza<br />
più profonda, tratta fuori, per magia artistica (l’arte è una alchimia naturale) dalle<br />
cose. Valore analogo, negli scritti, ha anche l’aggettivo astratto. Ambedue le<br />
parole indicano processi e situazioni formali del tutto opposti a "naturalistico".<br />
2. cfr., fra le carte dell’Archivio Sigurtà-Facciotto, A 38. Riprodotto nel cat. Fac-<br />
424<br />
ciotto, Rivalta, 1969.<br />
3. cfr. E. Faccioli, scritti vari, in bibliografia su questo catalogo.<br />
4. Tra gli appunti inediti sono conservati fogli contenenti annotazioni di formati,<br />
materiali, tecniche ecc.. Per il dibattito sulla tecnica, in particolare, si rinvia agli<br />
scritti del ’43-’45, in via di pubblicazione presso l’ed. Arcari (G. Facciotto, Scritture,<br />
1943-45, Mantova, 1980).<br />
5. v. Scritture cit., alla carta A49.<br />
Ibid., paragrafo 19: “È venuto il tempo per me di diventare un uomo qualunque,<br />
come ogni altro uomo (…). O è venuto il tempo di arrischiare il tutto per tutto”,<br />
eccetera, considerazioni vicine ma non identiche, in un taccuino di disegni e scritti<br />
(Coll. Gianna Panini Milano), composto tra il 1933 e il ’36. Qualcuno ha il senso<br />
di : “maestro”, “artista”. Si associa anche il riconoscimento della genialità. Il qualunque,<br />
l’uno qualunque, sono invece contrassegni non solo d’anonimato quotidiano<br />
ma di vicinanza alla inconsapevolezza naturale, all’animalità, alla follia.<br />
Con questo significato compare anche il termine neutro.<br />
6. v. Scritture cit., alla carta A9 “una pulizia, un ordine, un nitore estatico vi è in<br />
questa mostra di Facciotto”, eccetera.<br />
7. "Elenco dei dipinti e notizie raccolte quest’anno 1942", p. 2, retto. (1935 col<br />
punto interrogativo). Il punto interrogativo, per lo più, non indica uno spostamento<br />
d’anni ma di mesi. Cfr. la trascrizione del registro autografo, con ordinamento<br />
per anni, nel cat. Facciotto cit., al n.38. L’Elenco si trova nell’archivio Facciotto-Sigurtà.<br />
8. L’accostamento fra l’artigianato, il lavoro della mano, e la pittura, l’arte, è assai<br />
frequente negli autografi. Del resto è di Facciotto la persuasione che si può anche<br />
dipingere con le dita. V. su questo punto Scritture cit., paragrafo 33 e nota relativa.<br />
9. Espressioni impiegate dall’autore nel recensire U. Bignotti (minuta e non copia<br />
manoscritta: A 16).<br />
10. Per un profilo dell’opera di Umberto Bignotti valga il rinvio allo studio (l’unico<br />
fino ad ora) di A. Puerari, nel cat. Mostra dei Pittori, Scultori e Incisori Mantovani<br />
"800" e "900", Mantova, 1939. Cfr. inoltre la testimonianza, proposta in<br />
questo catalogo, di Alessandro Dal Prato.<br />
11. E. Faccioli, articolo su G. Perina, in "Gazzetta di Mantova", novembre 1950,<br />
riprodotto nel cat. Giulio Perina - mostra antologica, a c. di R. Tassi, Mantova,<br />
1975.<br />
12. G. Tonna, introduzione al cat. Chiaristi Mantovani, Castelgoffredo (Mantova),<br />
1966.<br />
13. Espressioni e concetti impiegati da Facciotto a proposito di Umberto Bignotti.<br />
(cfr. A16, A 55).<br />
14. S. Bini, Artisti, Edizioni "Libreria del Milione", Milano 1922, pp. 13-27.<br />
15. cfr. C. Perina, Mantova - Le Arti, vol. III, Mantova, 1965; R. Margonari, Lomini,<br />
Mantova, 1978; R. Margonari, Bresciani da Gazoldo, Mantova, 1979; F. Solmi,<br />
Guindani, Mantova,1979; E. Faccioli, scritti vari sugli artisti mantovani, in parte citati<br />
nella biobliografia in appendice a questo catalogo; A. Dal Prato, Mario Polpatelli,<br />
un pittore dimenticato, in "Civiltà Mantovana", Quaderno 67-68, 1978, pp.<br />
74 ss. Nelle pubblicazioni sopracitate sono presenti altri e essenziali rinvii bibliografici.<br />
16. v. G.M. Erbesato, Biografia attraverso il carteggio, in cat. Vindizio Nodari Pesenti<br />
(1979-1961), Mantova, 1979.<br />
17. cfr. carta autografa A 33 (archivio Facciotto-Sigurtà).<br />
18. Cfr. Scritture cit., carta A 26 (lettera a U. Bernasconi, del ’43)<br />
(1) Scritto in occasione della mostra personale “Giuseppe Facciotto.<br />
Opere 1934-1945”, tenutasi a Palazzo Te, Galleria d’Arte Moderna di<br />
Mantova, maggio-giugno 1980.
Racconti per trasparenza<br />
Christina Kanz (1)<br />
Il segno e nient’altro. Un segno che sia luce. È stata questa una<br />
delle principali ossessioni pittoriche di De Luigi, protagonista insieme<br />
a Lucio Fontana (ma con inclinazione affatto diversa) dell’avventura<br />
“spazialista” del secondo dopoguerra. Egli sosteneva<br />
anche, con singolare inversione litografica, che “forse la luce è<br />
l’anima; l’ombra, lo spirito”. Christina Kanz, le cui opere sono<br />
esposte in questi giorni alla Loggia di Giulio Romano (una ventina<br />
di dipinti dal ’76 all’80), deve aver meditato su simili proposizioni,<br />
trovandovi, lei tedesca, delle ragioni di consonanza con<br />
la sua cultura d’origine: una consonanza che agisce, ci sembra,<br />
sul piano delle tensioni immaginative piuttosto che nel repertorio<br />
delle procedure stilistiche. Se in comune v’è infatti la riflessione<br />
sul colore, su una luce che è processo e mutazione delle<br />
forme, l’attenzione della Kanz è tutta rivolta ai fenomeni di cangianza,<br />
al mutamento che non ha principio né fine, mentre in De<br />
Luigi quel che conta è il dramma di un’emergenza: la luce che irrompe<br />
dal buio, l’energia liberata dalla fatica dello scavo. Il grattage<br />
appunto, l’urto dei contrari. In questi quadri invece si esprime<br />
una sotterranea vocazione narrativa, un racconto fatto per<br />
cromie trasparenti, tanto più mobile quanto più aereo è il segnale<br />
in spostamento. La serie dei gesti ripetuti costituisce una<br />
trama, scandisce una partitura, di cui è protagonista il deposito<br />
traslucido di una traccia verticale che, occupando lo spazio della<br />
tela, crea una frase ritmica. Al tempo stesso sperimenta la sua<br />
forza espansiva. Ogni quadro è un’azione che rimanda ad un’altra<br />
azione.<br />
Tela viola-rosso veneziano è il titolo di un’opera del ’79, dove è<br />
davvero in gioco, come in altri lavori, il dialogo fra una superficie,<br />
un suono cromatico di fondo, e un segno che la percorre mutando<br />
di continuo i margini della propria identità. Avvia un accordo:<br />
e con l’accordo prende vita una serie di eventi, una sequenza<br />
di incidenti luminosi che non esprimono il conflitto dei<br />
contrari, ma il distendersi e velarsi/disvelarsi di un principio di<br />
riunificazione. Come a dire che il mistero non è più sotto la superficie,<br />
ma agisce allo scoperto, in una conseguente e tuttavia<br />
imprendibile peripezia.<br />
Da questo bisogno di evidenza deriva un ispessimento sensitivo<br />
425<br />
del segno. Qui si spiega anche il rapporto – documentato in una<br />
stringata sezione della mostra – con Morris Louis, vale a dire con<br />
una pittura tesa a sondare la forza irradiante del colore in un<br />
campo percettivo assoluto. E giacché il quadro si costruisce interamente<br />
sulla processualità della scia cromatica, ne viene una<br />
secca cancellazione di figure ed emblemi.<br />
Quando accenna a comparire (a tale proposito si può vedere la<br />
serie degli Acquarelli Salzburg, dipinti nel ’76), la figura diventa<br />
il campo di una frantumazione. Dà luogo ad una storia di dissolvenze.<br />
Si ha allora l’impressione che Christina Kanz costruisca<br />
delle favole di metamorfosi, delle avventure intorno al tema<br />
della fluidità: fiabe che – per una segreta simpatia fra segni e<br />
luoghi – documentano in modi antimimetici l’incontro con alcune<br />
città elettive: con la mozartiana Salisburgo e col sensuoso luminismo<br />
di Venezia. Ma i riconoscimenti, come la pittrice si è<br />
scoperta a dire, sono postumi: motivo di divinazione più che di<br />
pronuncia discorsiva, di un desiderio che resta inaccessibile alla<br />
parola, secondo l’opinione di G.G. Lemarie che ha presentato<br />
Christina in catalogo.<br />
(1) Articolo comparso sulla Gazzetta di Mantova del 20 settembre 1980.
Pittura come ornamento e irrealtà<br />
Osvaldo Licini (1)<br />
È Giuseppe Marchiori a parlarci più volte, nelle pagine di corrispondenza<br />
e nei saggi, dell’amore, anzi dell’esaltazione quasi fanatica<br />
di Licini per la pittura visionaria, per certe figurazioni mistiche<br />
del Medioevo e del primo Umanesimo1 : un’adesione tanto<br />
profonda ed eccitata da manifestarsi, anche nei momenti di più<br />
alta disciplina ascetica, con i toni rapiti della rivelazione. Mentre<br />
alcuni artisti del “Milione” 2 puntavano sulla convergenza fra<br />
astrattismo e razionalità della forma, facendo del comporre il<br />
tema centrale della loro invenzione, in lui continuava ad operare<br />
la riflessione sul simbolo, sullo spessore allusivo dei segni. Un<br />
interesse che resta attivo anche quando la poetica esplicita indurrebbe<br />
a pensare che egli agisca su un solo livello, tutto spo-<br />
O. Licini, Nudo, 1925, olio su tela, cm 60x81.<br />
426<br />
stato cioè verso protocolli di rigorosa formatività. Cosa, questa,<br />
senz’altro vera se si considera la complessità e insieme la coerenza<br />
interna con cui nascono - in ogni epoca dell’avventura liciniana<br />
- le articolazioni retoriche dell’immagine; come esse si<br />
svolgano e diano luogo ad una catena di temi solidali, generantisi<br />
in certo modo l’uno dall’altro, per intima proliferazione.<br />
Accanto alla fantasia retorica va tenuto conto però di un’altra germinazione,<br />
di tutto un carico metaforico che quelle stesse figure<br />
stilistiche convogliano dentro di sé.<br />
Se Licini non ne parla o vi accenna velatamente, ciò dipende -<br />
in alcuni anni - da una serie di ragioni, per lo più di ordine negativo.<br />
In primo luogo dal fatto che egli deve azzerare un codice<br />
pittorico cui è rimasto legato, sia pure in modo affatto speciale,<br />
fino alle soglie degli anni Trenta: per esempio quella nozione<br />
di realismo, da lui declinata nel senso delle magie3 , che lo
aveva accompagnato fino alla confluenza nel gruppo sarfattiano<br />
di Novecento. V’era poi, urgentissimo, il bisogno di dar vita ad un<br />
vocabolario di nuovi segni, ad una grafia elementare disancorata<br />
da obblighi referenziali, mimetici, naturalistici. Infine, specie<br />
nel quadriennio 1935-1938, la decisione di dar battaglia sul fronte<br />
degli astrattisti lombardi, la solidarietà con il manifesto di<br />
Belli, insieme ai problemi di natura costruttiva, consigliavano di<br />
sottolineare nelle dichiarazioni pubbliche taluni temi piuttosto<br />
che altri. Del resto è l’autore stesso ad autorizzarci. A proposito<br />
di Kn4 non scrive forse che la sua positività sta “nella negazione<br />
totale di ciò che oggi si intende per cultura”? Nell’essere, quell’opera,<br />
una cancellazione dell’esistente?<br />
Eccolo insistere allora sul tasto delle cerebralità, del mentalismo,<br />
del lavoro di “testa”; e affermare risolutamente, nella celebre<br />
lettera aperta del ’35, che i “quadri non rappresentano nulla” e<br />
che “la geometria può diventare sentimento, poesia più interessante<br />
di quella espressa dalla faccia dell’uomo’” 5 .<br />
Ed è qui, nella stretta associazione istituita dal pittore tra geometria<br />
e immaginazione, tra forme pure e fantasia, che appaiono<br />
preziose le indicazioni di Marchiori. Ci rivelano l’entusiasmo<br />
per i deliri prospettici di Paolo Uccello, le grafie goticheggianti<br />
del Sassetta e Pisanello6 , gli spazi radianti dei neoplatonici. Si<br />
potrà osservare certo che le tavole del Miracolo dell’ostia sono<br />
raccomandatissime in ambito surrealista (più volte riprodotte e<br />
commentate sulla Révolution bretoniana o su Minotaure) e che<br />
Licini non è il solo ad ispirarvisi. Ciò che dà tuttavia alle predilezioni<br />
dell’autore una pronuncia inconfondibile è l’insieme dei riferimenti<br />
ai “primitivi”, quella catena di opere anteriori al pieno<br />
Rinascimento e al trionfo della Rappresentazione che aiuta a disegnare<br />
una mappa di motivi iconografici incidenti sulla storia<br />
delle immagini liciniane. Non solo: grazie ad esse si aduna altro<br />
materiale intorno ai “sogni”, a quell’universo mitografico che gli<br />
scritti dell’artista invitano ad interrogare in chiave eminentemente<br />
letteraria. Intanto risulta subito significativa la presenza<br />
del capitolo dei "primitivi" accanto alla lettura dei grandi isolati<br />
(e veggenti) dell’Ottocento, da Hölderlin a Novalis a Mallarmé:<br />
fonti gli uni e gli altri di una imagerie estatica che tende ad<br />
esprimersi nella cifra del geroglifico e dell’enigma.<br />
Proviamo ad elencare alcuni di quei luoghi contemplativi: i mosaici<br />
di Sant’Apollinare, gli affreschi di Santa Maria Antiqua, Le<br />
427<br />
O. Licini, Marina, 1931, olio su tela, cm 26x20,5 (particolare).<br />
nozze mistiche di S. <strong>Francesco</strong> del Sassetta, i dipinti dell’Angelico:<br />
opere sulle quali è certa l’attenzione di Licini nel corso dell’epoca<br />
astratta. Che cosa lo spinge ad interessarsene? Se si scorrono<br />
gli scritti del ’35, che pure tacciono su simili modelli, veniamo<br />
ad imbatterci in una categoria che da quei riferimenti può<br />
trarre un ulteriore chiarimento. Si tratta del concetto di iperdecorazione<br />
e di splendore: “A che serve un quadro - si chiede l’artista<br />
- se non a superdecorare un muro?”. E continua: superfici<br />
che “non rappresentino nulla, ma che a guardarle procurino un<br />
vero riposo allo spirito” 7 .<br />
Come si vede, è in gioco un’idea di astanza, di intransitività che ha<br />
molto in comune con le dottrine mistiche della figurazione. Il colore,<br />
non la linea, svolge un’azione magica. È l’autore a ricordarlo.<br />
Il colore non descrive, ma significa per sé: sprigiona una forza rapinosa,<br />
esalta ed innalza. Esige il silenzio della rivelazione.<br />
Quando tocca simili argomenti, il discorso evita di sostarvi a
O. Licini, Addentare su fondo grigio, 1936, olio su tela, cm 90x66,5.<br />
lungo. Ricorre piuttosto alla reticenza, pone tra parentesi, si vela<br />
di ironie ed autoironie. Ma lascia anche trasparire delle tracce,<br />
degli enunciati germinali che andranno a confluire, qualche anno<br />
più tardi, in proposizioni più ricche di mitologemi. Intanto si afferma<br />
che il tragitto dell’arte è ascensivo, verticale; che il compito<br />
della pittura è di ribaltare la logica del concreto, di riunire i<br />
contrari, di far miracoli, forzando il possibile verso l’impossibile.<br />
E tutto ciò vien detto insistendo sul funzionamento del significante,<br />
delle linee e del colore: un significante che ha l’evidenza<br />
dell’ornato e della decorazione.<br />
Manca il quadro mitico, ma la grammatica lo fa presupporre o<br />
perlomeno lo annuncia.<br />
Che Licini avesse ben chiaro un itinerario da percorrere, lo si de-<br />
428<br />
sume anche dalle scelte sul terreno della contemporaneità: Matisse,<br />
Kandinsky, Mondrian. Con i correttivi in area dada-surrealista:<br />
Man Ray, Arp. Come a dire il versante fusionale dell’astrattismo,<br />
debitamente filtrato nell’esercizio dello humour, dei controsensi<br />
e del calembour.<br />
Se si tien conto poi, al di là delle testimonianze di poetica, dei<br />
temi presenti nella sua pittura, di tutta una geometria simbolica<br />
incentrata sulle figure del chiasmo, della circolarità e dell’alternanza<br />
ritmica, si vedrà che il discorso procede intorno ad alcune<br />
grandi metafore visive della trasformazione, della metamorfosi<br />
e del tempo cosmico8 .<br />
Le tele fra 1930 e 1935 appaiono istoriate, intessute, contornate<br />
e percorse da tracciati ritmici. I grandi campi notturni e aerei
vengono suddivisi in settori, i settori posti in agitazione tra loro<br />
da una linea che mentre avanza, al tempo stesso ruota su di sé,<br />
si allontana e si avvicina agli assi dominanti della composizione.<br />
Per sottrazioni e accumuli, ritmicamente alternati, lo spazio è<br />
dato come inesauribile, pronunciato e sospeso nell’infinità della<br />
tensione ciclica.<br />
Fin dal 1931, in uno dei quadri inaugurali della ricerca astratta,<br />
l’emblema lunare accompagna lo sbocciare delle linee verso l’alto<br />
Schemi astratti su fondo bianco, iscrivendo la verticalità sotto<br />
il segno dell’inversione e del mutamento. Così in Notturno n. 1<br />
(1931-32) una cerniera ellittica lega l’architettura in crescita dei<br />
O. Licini, Angelo ribelle su fondo rosso, 1946, olio su tela, cm 91,5x72,5.<br />
429<br />
triangoli. Entrano in gioco le polarità di segno opposto, non per<br />
creare una dialettica che alla fine si concluda in un luogo o in un<br />
macrosegno unitario e totalizzante, ma per mettere fronte a<br />
fronte energie differenti ed eccitarne l’intersezione, il metamorfico<br />
cerchio dei bilanciamenti. La geometria obbedisce insomma<br />
ad un immaginario dell’antifrasi, del confuso, del chiasmo. In<br />
Ritmo rosso (1932) compaiono una mano ed un piede, l’una,<br />
bianca, al vertice di un triangolo, l’altro (nero) sul luogo di giuntura<br />
di due rettangoli, quasi una microstruttura dei futuri Mulini<br />
a vento; poi un triangolo-freccia ed un cerchio, ossia la linearità<br />
e la rotazione: tutti elementi che però non si danno in netta op-
posizione, segnati, come sono, internamente da una frattura, da<br />
incidenti che ne interrompono la compattezza. Non solo: vengono<br />
tutti assorbiti nella mobilità metrica di un’unica frase, il cui<br />
culmine è forse da vedere nel moto serpentinato d’una freccia<br />
che punta su una stella-bersaglio. Analogamente, quando il pittore<br />
riflette sui simboli del tempo (e andrà visto in questo caso<br />
il Notturno n. 2, 1932), gli emblemi rinviano l’uno all’altro, in<br />
coppie complementari e dinamiche, come il disco e il quadrato,<br />
un disco che ospita una falce lunare e un quadrato attraversato<br />
dalla diagonale, dal segno dell’addentamento, minato cioè dall’erosione<br />
del più e del meno.<br />
Gli esempi potrebbero essere moltiplicati, fino alle opere centrali<br />
della metà del decennio: Il bilico, Obelisco, il Drago e così via.<br />
Ma quel che preme sottolineare è il darsi dell’intero repertorio<br />
lessicale in una calligrafia e in un cromatismo irraggianti, volti ad<br />
oltrepassare i parametri della misurabilità.<br />
La questione, allora, è proprio quella posta dall’autore nella pagina<br />
appena ricordata: l’emergenza di un ornato che non è costruzione<br />
plastica, d’una pittura che vuol operare sul versante<br />
contrario allo statuto architettonico. Sicchè nella netta presa di<br />
posizione nei confronti del funzionalismo, nel collocarsi più dalla<br />
parte di Carlo Belli che dell’amico Sartoris, a favore di una “poesia”<br />
alleata alla musica ed estranea alle leggi della tridimensionalità,<br />
è vivo l’urgere del tèlos estatico della figurazione.<br />
“L’arte non deve avere nessun significato”. La pittura costituisce<br />
una pratica “irrazionale, contrariamente a quel che è l’architettura”.<br />
Non si tratta - rimarchiamo - di un discorso sui generi artistici,<br />
sulle possibili analogie, differenze e cooperazioni fra procedure<br />
specifiche della visione. Nè l’ornamentazione di cui si parla ha<br />
qualche attinenza col dibattito allora vivacissimo sul décor vero<br />
e proprio. Tant’è che, a riprova, può essere addotta la simpatia<br />
da parte di Licini per le superfici di misura minima, i formati ridotti<br />
(si pensi alla serie, la più clamorosa forse, delle tele-portafortuna<br />
e dei quadri-talismano). Per lui infatti la tensione va cercata<br />
lontano dall’elemento sensibile e dalle proporzioni materiali.<br />
Viene richiesta in prima istanza la fusione fra lo sguardo che<br />
contempla ed il fatto pittorico, senza mediazioni concettuali. Il<br />
che non suona a discapito dell’interpretazione, quanto a sostegno<br />
di una speciale forma di lettura che nasca dal desiderio, da<br />
un "piacere" immediato, e si svolga poi, se è necessario, nelle<br />
430<br />
forme del commento, dell’analisi in cifra9 .<br />
La demarcazione fra “decorare” e “costruire” appartiene, nella<br />
sua formulazione più stringente, al pensiero mistico, al sentimento<br />
del colore e della linea dei primitivi, così come, d’altronde,<br />
era venuta illustrandola proprio in quegli anni Lionello Venturi,<br />
in un libro che Licini aveva letto con viva partecipazione10 . E<br />
Matisse, evidentemente, rappresentava un luogo di confronto<br />
inevitabile intorno al problema.<br />
Viene da lui infatti (e nella formulazione più limpida) l’equivalenza<br />
assoluta fra ornare ed esprimere, unitamente al principio<br />
dell’annientamento del supporto mediante la decorazione. L’ornato<br />
si impadronisce dello spazio percettivo e lo annulla. Anche<br />
Licini dirà qualcosa di analogo a proposito di Modigliani11 , così<br />
come i suoi procedimenti pittorici tenderanno a cancellare i confini<br />
della tela, in un progressivo azzeramento della superficie fisica<br />
del dipinto a vantaggio della sua densità mentale.<br />
Matisse: “Per me l’espressione non consiste nella passione che<br />
si accenderà su un volto o che si affermerà con un movimento<br />
violento. L’espressione è in tutta la disposizione del mio quadro<br />
(…). La composizione è l’arte del sistemare in modo decorativo<br />
i diversi elementi che il pittore ha a disposizione per esprimere<br />
i suoi sentimenti” 12 . E Licini: “La pittura è l’arte dei colori e delle<br />
forme, liberamente concepite, ed è anche un atto di volontà e di<br />
creazione”, eccetera.<br />
Lo sviluppo successivo dell’opera pittorica non abbandona mai,<br />
anzi articola e approfondisce ancor più questa topica dello splendore.<br />
Perché mai, ci si chiede, Licini dovrebbe “garantire” - come<br />
sostiene - le sue Amalassunte in “oro ed argento”, se non agisse<br />
in lui la profonda consonanza col mondo dei visionari? Perché<br />
fiori e gemme popolano gli ultimi cieli? Da dove viene la partitura<br />
preziosa, quasi da lapidario, delle sue immagini? Perché infine<br />
ha tanto respiro il gusto, anche nella parola scritta, per la<br />
voce ermetica, il senhal, il termine che depsicologizza?<br />
Non si creda però ad una consonanza astorica e felice. Di mezzo<br />
sta, come sappiamo, la ‘testa’ di Licini, la sua malinconia di funambolo.<br />
Il leopardismo non concede spazi ai progetti della Modernità<br />
e attraversa, con disincantata memoria, i paesaggi impietrati<br />
della ragione positiva. Di qui viene il suo appello alla funzione<br />
disintossicante della menzogna, della maschera, dell’artificio<br />
superiore. Di qui la mobilità del fumista, il maledettismo del-
l’angelo-demone, l’issarsi a “500.000 metri d’altezza, nella zona<br />
siderale”, verso l’irrealtà. E il leopardismo scava baratri non solo<br />
nel presente, ma anche fra l’attualità e quel passato che pure è<br />
sentito consanguineo e vitale.<br />
“L’importante è che la menzogna sia geniale”.<br />
L’impiego della nozione di frode, accanto a quella della bellezza<br />
e dello splendore, segna lo stacco necessario della coscienza dai<br />
neoplatonici, dal loro tuffo nella vertigine della “Emanazione”; o<br />
se si vuole, rilancia l’ossessione decorativa nelle regioni accidentate<br />
della rivolta e del male. Accetta la sfida dell’impuro. Giacché<br />
irrealtà non vuol dire, per Licini, dimenticanza del vivente;<br />
significa invece una realtà più essenziale e decisiva, magari sepolta<br />
e dimenticata, che occorre far riemergere e tornare a modellare<br />
con precisa coscienza linguistica: con la forza d’una lette-<br />
O. Licini, Angelo ribelle su fondo rosso, 1953 (particolare).<br />
431<br />
ra che bruci la distanza fra il segno e la cosa, faccia scaturire il<br />
non-nato13 , e il possibile. Non a caso questo pensiero si lega alle<br />
peripezie di esilio, di lontananza e peregrinazione; e, conseguentemente,<br />
la “superrealtà” cui si tende è animata dalle pulsazioni<br />
dell’eros e della mater-materia, dall’agitarsi della chora.<br />
Qual è il volto della “misteriosa bellezza”? Ecco la risposta del<br />
pittore, in rapporto a Matisse: “entusiasmo, gioia di vivere, sensualità,<br />
lirismo, senso pagano dell’esistenza” 14 .<br />
In tal modo la vicinanza ai primitivi, ai bizantini e ai senesi, riceve<br />
la sua spiegazione ontologica: come approssimazione all’essenza,<br />
alla realtà originaria, giacché gli artisti medievali appaiono<br />
più prossimi dei moderni al fuoco della creazione.<br />
Ed è chiaro: non è la religiosità ad essere interpellata, quanto la sacralità<br />
dell’esperienza; con essa viene interrogato lo sguardo, che<br />
andrà spostato altrove e rovesciato, reso perfino più disumano.<br />
Dai primitivi ai grandi romantici: il secondo anello della catena è<br />
costituito da quei “naufraghi” in cui agisce il demone del ritorno.<br />
Licini ha in loro una fonte primaria di riflessione, nonostante la<br />
violenza con cui attacca l’Ottocento, le sue convenzioni patetiche<br />
e la tradizione dello psicologismo. Si potrebbe dire, per un certo<br />
verso, che egli tende a geometrizzarne gli umori, a disseccarne<br />
i depositi sentimentali, per estrarne una sostanza più duratura.<br />
Non ha in mente l’uomo, vuole piuttosto oltrepassarlo. L’uomo<br />
gli pare una malattia. Parafrasando un poeta maledetto, lo definisce<br />
“una buona iena con tendenza alla poesia”.<br />
L’esercizio di effrazione comincia nel ’13, durante l’adesione al<br />
futurismo, con i “racconti di Bruto”. In virtù di acidi palazzeschiani<br />
e ubueschi, Licini-Bruto compie la prima immersione spettacolare<br />
nell’animalità della vita e nella materia, una materia che<br />
viene tuttavia lavorata (ciò è decisivo), oltreché con furia, con la<br />
sottigliezza dell’araldica e di una pirotecnica teatralità.<br />
Bruto attraversa l’esistente, lo mette a fuoco, ma non può fare a<br />
meno di tradurlo in segni. Il suo gesto ha la fatalità della scrittura,<br />
rifà il vocabolario delle cose. In questa metamorfosi scritturale è<br />
da vedere una delle costanti del lavoro di Licini, fin dai primi anni.<br />
La materia, il terrestre, ricostituiti nella forma dell’emblema e<br />
della metafora. Una traccia d’orizzonte è sempre visibile nelle<br />
Amalassunte e nei Missili lunari: ed è confine talora eccitato dal<br />
taglio della diagonale o dalla M di due seni culminanti.<br />
Se v’è un tema negativo, questo è sicuramente l’opacità del
mondo di cui la pittura può farsi complice. Qui esplode l’intemperanza<br />
di Licini, anche a rischio di un’ingiustizia. È il caso, per<br />
esempio, di un suo giudizio sul lavoro di Morandi alla fine del<br />
Trenta, di Morandi che pure aveva percorso un itinerario parallelo<br />
nella stagione futurista e in quella immediatamente successiva.<br />
Orrore delle nebbie, dei colori cinerei, dell’offuscamento, si<br />
direbbe: “Cos’è questo velo, questo tedio, che Morandi mette davanti<br />
ai quadri? (...) Osservando a fondo mi accorgo che le tanto<br />
celebrate sottigliezze e raffinatezze coloristiche e tonali non sono<br />
che delle superficiali, sorde e scolorite poltigliette,” eccetera15 .<br />
La paura della gravità attizza il movimento contrario: l’amore per<br />
il motto di spirito e le virtù dell’equilibrista. Non si tratta però di<br />
un dinamismo fine a se stesso o di biomeccanica spettacolarità.<br />
O. Licini, Notturno, 1954, olio su cartone, cm 32,5x23.<br />
432<br />
Internamente vi agisce il sentimento della perdita: una perdita<br />
che riguarda soprattutto la Natura, le sorgenti del divenire.<br />
Che significa la tematica del drago e, strettamente allacciata a<br />
questa, la costellazione volante dei castelli in aria, degli aquiloni<br />
e dei sagittari? Perchè la solidarietà fra addentare e volare?<br />
Come può l’Olandese solcare acque celesti? L’inabissamento, il<br />
motivo della discesa, cui il simbolismo del drago rinvia (ma il<br />
drago è anche un emblema del tempo circolare, del serpente),<br />
attiva già il tragitto rigenerativo: è la prima tappa del riconoscimento<br />
raggiunta dall’eroe. Solo dopo aver attinto alle radici<br />
dell’“essere”, dopo essersi per così dire rifatto nel ventre materno,<br />
può tentare la risalita. Questa la peripezia. Ma prima di essa,<br />
come si diceva, il dramma.
Non è certo senza motivo se la data di inizio della più intima ricerca<br />
liciniana coincide con l’apparizione dell’arcangelo folgorato,<br />
di un nunzio (Gabriele e non un altro) precipitato in un paesaggio<br />
apocalittico (1919, ma il quadro viene ripreso nel biennio<br />
’28-’30). La figura scomparirà per alcuni decenni, sostituita da<br />
tutta una catena di immagini intermedie (l’ala, il triangolo, la T,<br />
ecc.) e anche da cifre e lettere mutilate, per lo più appartenenti<br />
al regime notturno, e dunque connesse ad un processo di gestazione,<br />
per riemergere soltanto nel secondo dopoguerra; ed in<br />
accezione gloriosa con gli angeli di Santa Rosa e di San Domingo.<br />
Ma quel che importa, ai fini del nostro discorso, è che questa<br />
rinascita fa tutt’uno, nella ‘fabula’ del pittore, con la redenzione<br />
della materia, con l’ascesa dell’elemento terrestre.<br />
O. Licini, Fiore fantastico n. 2, 1957, olio su carta, cm 19,5x26..<br />
433<br />
L’infero si tramuta nell’angelico o, per dir meglio, prende forma<br />
un’entità doppia, un corpo insieme ctonio e spirituale: erede di<br />
tutta una stirpe di presenze umbratili, di traghettatori d’anime e<br />
mercuriali Pierrot.<br />
Se nella fase astratta Licini lavora con maggior accanimento sui<br />
problemi di struttura, occorre ricondurre la sua indagine anche<br />
ad una contemporanea investigazione delle “radici” (rivelatrici in<br />
questo senso, fra 1936-’37, le Archipitture, cui seguiranno di lì a<br />
poco le Memorie d’oltretomba) e tener conto infine di dove vada<br />
a confluire, nel secondo grande periodo di "silenzio" (1940-’45),<br />
la sua scienza compositiva.<br />
Il documento illuminante è la lettera a Ciliberti del 194116 , dove<br />
l’immagine goethiana delle “madri” implica la regione dell’ar-
ché, lo scrigno delle memorie sepolte e dei tesori dimenticati.<br />
Memoria, questa, funzionante almeno in due sensi: come mitica<br />
immersione nel principio femminile e come riscoperta della<br />
scrittura, di un alfabeto primo del reale.<br />
La svolta potrebbe parere improvvisa, ma non lo è, se non nei<br />
termini di una rinnovata accensione. Alle spalle sta la preistoria<br />
di Licini (anche il “cuore” e la “merda” di Bruto), così come premono<br />
i refusés, i quadri del cosiddetto periodo “realista”, le<br />
opere fatte sul “vero” che erano state accantonate a conclusione<br />
del secondo decennio di lavoro; opere che non solo contenevano<br />
in germe i segni futuri (nei nudi, nel citatissimo capro o<br />
nelle mappe di certe nature morte e paesaggi, come “La ruota”),<br />
ma scavavano nei medesimi “sogni”, dentro il circuito di un naturale,<br />
investigato allora con i criteri della somiglianza.<br />
L’ispirazione è difatti antinaturalistica e non antinaturale, vuol<br />
cogliere sempre il sostrato delle immagini. Non si comprenderebbe<br />
altrimenti l’elogio riservato ai pittori dell’espressione e<br />
della forza, ai “costruttori”: a Courbet, Van Gogh, Cézanne e Picasso,<br />
nonostante l’estrema lontananza dalle loro risoluzioni formali<br />
più evidenti. Resta poi sempre e in ogni caso Matisse, vale<br />
a dire la coincidenza fra espressione e decorazione (ben al di là<br />
dei Loos e dei Van de Velde), la chiave di volta del suo progetto<br />
linguistico.<br />
“Vuol sapere Carrà chi furono i miei veri maestri? Glieli dico subito,<br />
ma Lei lo sa già perfettamente: Cézanne, Van Gogh, Matisse.<br />
I maestri di Morandi sono: Chardin, Corot, Cézanne” 17 . Tutto<br />
ciò ribadito in piena ricerca astratta, oltre le frontiere del purovisibilismo.<br />
Ora, giacché l’immaginazione tende a spostarsi dall’ordine sensibile<br />
al dominio dell’invisibile, dalle forme dell’apparenza alle<br />
forze permanenti che le generano, la grammatica della pittura<br />
non potrà che avvalersi di tipologie universali, capaci di attraversare<br />
l’orizzontalità del presente per attingere un più alto spessore<br />
simbolico; o anche: riscattare il fenomeno nella prospettiva<br />
del sovrapersonale e del tipico, animando le materie pesanti di<br />
un respiro e di un ritmo “cosmici”. Ecco perché le figure nuove,<br />
i loro gesti e i loro volti (dai primi personaggi agli angeli), hanno<br />
densità psichica mentre sono privi di caratterizzazione sentimentale.<br />
I visi duri come idoli mettono a morte la fisiognomica<br />
dei caratteri e simpatizzano invece con la recitazione ed il rac-<br />
434<br />
conto impersonali.<br />
Talora l’orizzonte ironico di una imprecazione, trasfigurata nel<br />
calligramma araldico dei portafortuna, indica la soglia da cui si<br />
accede alla irrealtà. Prelevate da Rimbaud o da Jarry, le lettere<br />
di MERDA disegnano la griglia prospettica, anzi il parapetto, dell’osservatore<br />
sospeso. E mentre esorcizzano la gravità del quotidiano,<br />
inaugurano le avventure aeree di inedite combinazioni alfabetiche.<br />
Nella dissoluzione delle gerarchie visive (e mentali) che questo<br />
processo comporta, è soprattutto la metafora a svolgere un ruolo<br />
centrale. Frantuma e riconiuga tessere figurali. Disloca, taglia e<br />
condensa.<br />
Intanto, insieme al funzionamento rigenerativo della sineddoche<br />
(non tutto il corpo, ma un frammento intensivo), è in atto la redenzione<br />
del principio notturno. Il rito inaugurale è celebrato<br />
dagli olandesi, dopo i quali emergono gli emblemi e i ritmi reversibili<br />
del capitolo amalassuntiano. Nelle invenzioni sintetiche<br />
che vengono alla luce si condensano energie di specie contraria,<br />
come nell’immagine errante/erotica del piede che si prolunga in<br />
una mano.<br />
Laddove i “fantasmi ebbri di energia”, operanti nella Parigi di<br />
Tzara e Breton, innescavano movimenti dissociativi e centrifughi,<br />
qui la dislocazione delle forme è investita da una controforza<br />
coagulante, riassimilativa. Le fasi del tempo si aprono e chiudono,<br />
continuano a pulsare nel giro dei ciclici ritorni. Si consideri,<br />
per sostare su un esempio, la frase ritmica della pupilla di Amalassunta,<br />
il moto dei suoi numeri ermetici: lo sguardo non solo<br />
ruota nel chiasmo calante-crescente delle stazioni lunari (6, 9, 3<br />
ecc.), ma si carica e dilata nella ripetizione di identiche cifre. Un<br />
modo ulteriore, anche questo, di far valere un’indicazione stilistica<br />
dell’arte prerinascimentale: la crescita di radianza per<br />
mezzo di iterate battute ritmiche ornamentali.<br />
Come la riduzione dell’immagine ad alcuni elementi nucleari<br />
crea una più alta concentrazione e accresce il desiderio di ciò che<br />
viene taciuto (basta una lettera, la Q, per suggerire un corpo),<br />
allo stesso modo il tracciato di un movimento appare più acuto<br />
quand’ è abbreviato o sospeso in uno stato d’attesa. È la tecnica<br />
dell’eccitazione fissata. Il racconto costruito sulla virtualità degli<br />
spostamenti propone una infinita erranza. Ed il viaggio, grazie<br />
alle cadenze ritmiche delle figure e alle astrazioni gestuali, ha
spesso l’andamento della danza: una danza affatto speciale, poiché<br />
non v’è tanto un corpo che dia spettacolo nello spazio quanto<br />
una molteplicità di luoghi animati, sia in quel corpo che in<br />
quello spazio. Non si tratta neppure di una coreografia che respira<br />
all’unisono: alla mobilità di un elemento può corrispondere<br />
infatti la ieratica (ed orfica) immobilità di un altro, alla chioma<br />
volante di una luna il silenzio d’una mano aperta nella quale<br />
è esposto, come su una tavola, il sigillo di un cuore. Positure non<br />
imitative, ma immaginative: assorbite nei campi dell’astrazione<br />
e del tipico18 . Se tutto ciò è vero, i fiori fantastici e i missili lunari<br />
non rappresentano delle entità futuribili né sono annunci di un<br />
avvenire meccanico. Condensano invece dei soffi di vita e sono<br />
trasfigurazioni dell’organico.<br />
O. Licini, Missile lunare, 1958, olio su carta, cm 22x28,5.<br />
435<br />
Ai percorsi erratici dell’Incostante (1933) il Missile (dal 1953c. in<br />
poi) sostituisce tragitti più lineari e fulminanti; costruisce edifici<br />
diamantini. Il movimento si riduce davvero ad un istante, sospende<br />
perfino la circolazione del tempo universale radunando<br />
tutte le epoche in un punto. Per usare le parole di Benjamin, potremmo<br />
dire che la pittura “si tiene immobile sulla soglia del<br />
tempo”. È l’ora messianica preparata dalle scritture ermetiche e<br />
riassunta nella figura della triangolarità (Notturno n. 2, Alba,<br />
Estasi del 1956; Ritmo (missili-marina) del 1957-58).<br />
La parola di Licini aiuta ad intuire: “Tutta la vita / che almeno la<br />
morte / non sia menzognera”.<br />
Sarà perciò lecito, col sostegno di questa parola, suggerire un<br />
percorso mitografico, vedere nelle stazioni stilistiche delle varie
“epoche” (e nei silenzi in cui venivano preparate) le tappe di un<br />
pensiero della rinascita: originale ma significativamente parallelo<br />
agli itinerari di altri solitari. Non è un caso che anche altrove<br />
il ritorno ai princìpi sia inteso come riattivazione del mito e faccia<br />
propria la segretezza di Hermes, la “sapienza” dei numeri e<br />
delle lettere; e che, come in Licini, si attraversi il tema dell’Assunzione19<br />
: tema riproposto in area surrealista, ma di sostenuta<br />
ascendenza romantica (con Nerval, ad esempio). Conosciamo le<br />
ragioni di questo pensiero e del suo controdiscorso, volto a rifare<br />
il linguaggio vivo della creazione, il suo essere obliato: enigmatico<br />
e scintillante, come l’ha descritto Foucault, entro una dispersione<br />
infinita. Questa “insopprimibile metafisica” resiste in<br />
Licini.<br />
Ma è, ancora una volta, metafisica eterodossa, priva di un codice<br />
iniziatico costante (se pure di iniziatico in senso stretto si<br />
possa parlare), e costruita, stando ai documenti finora indagati,<br />
con mobilissima virtù eclettica. Una sorgente primaria è semmai<br />
da vedere nella letteratura ed in ispecie nella poesia, lontano dai<br />
prestiti felici della réverie. Concludiamo perciò con l’elogio di<br />
Maldoror. “Arithmétique! algèbre! géometrie! (...) celui qui vous<br />
connait, ne veut plus rien des biens de la terre; ne désire plus<br />
que de s’élever, d’un volléger, en construisant une hélice ascendante,<br />
vers la voute sphérique des cieux ».<br />
1. G. Marchiori, Licini - con 21 lettere inedite del pittore, De Luca, Roma, 1960;<br />
vedi inoltre A. Sartoris, Licini archipittore, in "Origini", Roma, n. 5-6, 1941.<br />
2. Per l’analisi complessiva dell’astrattismo italiano si rinvia a P. Fossati, L’immagine<br />
sospesa – Pittura e scultura astratte in Italia 1934-1940, Einaudi, Torino,<br />
1971. Da vedere anche il catalogo Arte astratta italiana 1909-1959, Galleria Nazionale<br />
d’Arte Moderna, Roma, aprile-maggio 1980, con interventi di Giovanna<br />
De Feo (per A. Burri e G. Capogrossi), Ida Panicelli (G. Turcato e L. Fontana), Livia<br />
Velani (G. Balla, A. Magnelli, E. Prampolini) e Pia Vivarelli (O. Licini e A. Soldati).<br />
3. Sul rapporto Licini e la cultura italiana del primo dopoguerra cfr. il catalogo Letteratura-Arte.<br />
Miti del ’900, a c. di Zeno Birolli, Edizioni Padiglione d’Arte Contemporanea<br />
di Milano e Idea Editions, Milano, 1979. Un cenno anche nel recente<br />
catalogo La Metafisica: gli anni Venti, a c. di R. Barilli e F. Solmi, (Pittura e scultura),<br />
Bologna, 1980.<br />
4. C. Belli, Kn, Edizioni del Milione, Milano, 1935 (n.ed. con un avviso dell’autore<br />
e due lettere inedite di Kandinksij su "Kn", Scheiwiller, Milano, 1972). Di C. Belli<br />
é uscita anche, nel 1978, la Lettera sulla nascita dell’astrattismo italiano per i tipi<br />
di Scheiwiller.<br />
5. Lettera aperta al Milione, comparsa sul n. 39 del "Bollettino del Milione", Milano,<br />
1935. Cfr. O. Licini, Errante erotico eretico - Gli scritti letterari e tutte le lettere,<br />
a c. di G. Baratta, F. <strong>Bartoli</strong> e Z. Birolli, Milano, Feltrinelli, 1974, pp. 99 e 194.<br />
Per i cataloghi delle opere ci limitiamo a tre indicazioni essenziali: Osvaldo Licini,<br />
a c. di Z. Birolli e A. Passoni; Giuseppe Marchiori, I cieli segreti di Osvaldo Licini,<br />
con catalogo generale delle opere, Alfieri, Venezia, 1968; Osvaldo Licini, Mu-<br />
436<br />
seum am Ostwal. Dortmund, 1974.<br />
6. "Come gli affreschi di Santa Maria Antiqua, considerati un termine di confronto<br />
assoluto, altre pitture assumevano talora per lui un’importanza decisiva, quasi<br />
una ragione di essere o di non essere. Una di queste era: "Le nozze di San <strong>Francesco</strong><br />
con la povertà", del Sassetta, nel castello di Chantilly. Licini non ammetteva<br />
indugi. Durante la visita al castello (...) voleva correre immediatamente alla<br />
Tribuna, dove si trova l’opera del Sassetta. (…) Finalmente, arrivato davanti all’amato<br />
Sassetta, Licini si abbandonava all’ammirazione, mentre custode e turisti<br />
erano già in un’altra stanza, indignati di quel rumoroso entusiasmo. Licini non voleva<br />
più andarsene. E ci volle del bello e del buono per deciderlo ad allontanarsi<br />
dall’oggetto della sua fervida e intensa contemplazione. Chantilly s’identificava,<br />
per lui, col Sassetta" (G. Marchiori, Licini - con 21 lettere inedite del pittore,<br />
op. cit., p. 14).<br />
7. O. Licini, op. cit., p. 99.<br />
8. Sul motivo della memoria e sulle forme del tempo nell’opera di Licini, v. lo<br />
scritto di Zeno Birolli, Storia e temporalità circolare, in O. Licini, op. cit., pp. 11-<br />
31. Per quanto riguarda i temi legati all’immaginario ‘notturno’ e i procedimenti<br />
retorici, rinvio ai saggi contenuti in quel volume, che costituisce il punto d’avvio<br />
di questo intervento.<br />
9. Il motivo ermeneutico é presente nella parte finale della lettera a Franco Ciliberti<br />
(1° febbraio 1941, in O. Licini, op. cit., p. 161).<br />
10. L. Venturi, Il gusto dei primitivi, Bologna, 1926 (n.ed., Einaudi, Torino, 1972,<br />
con prefazione di G.C. Argan). Cfr. anche: R. Assunto, La critica d’arte nel pensiero<br />
medievale, Il Saggiatore, Milano. 1961.<br />
11. Ricordo di Modigliani, in O. Licini. op. cit.. p. 91.<br />
12. H. Matisse. Scritti e pensieri sull’arte. Raccolti e annotati da D. Fourcade. Einaudi,<br />
Torino, 1979, p. 6.<br />
13. Cfr., oltre alle celebri pagine di Klee, G. Agamben, Stanze - La parola e il fantasma<br />
nella cultura occidentale, Einaudi, Torino, 1977, pp. 54-70.<br />
14. O. Licini, op. cit., p. 205.<br />
15. Lettera a G. Marchiori, 3 marzo 1939 (O. Licini, op. cit., p.142).<br />
16. La riportiamo per intero: "Ti scrivo dalle viscere della terra, la «regione delle<br />
Madri» forse, dove sono disceso per conservare incolumi alcuni valori immateriali,<br />
non convertibili, certo, che appartengono al dominio dello spirito umano. In<br />
questa profondità ancora verde, la landa dell’originario forse, io cercherò di recuperare<br />
il segreto primitivo del nostro significato nel cosmo. Perciò estinzione<br />
del contingente, per ora. Voi non mi vedrete cosi presto a Milano, né con la<br />
spada, né con le larve, né con gli emblemi. Cessato il pericolo, non dubitate, riapparirò<br />
alla superficie con la «diafanità sovressenziale» e «senza ombra». Solo allora<br />
potrò mostrarti le mie prede: i segni rari che non hanno nome; alfabeti e<br />
scritture enigmatiche; rappresentazioni totemiche, che solo tu con la tua scienza<br />
potrai decifrare. Quella sarà la nostra ora" (O. Licini, op. cit., p. 161).<br />
17. Correzioni a Carrà, in "Bollettino del Milione", n. 41, Milano, 1935 (O. Licini,<br />
op. cit., p. 100).<br />
18. Per il primato del principio immaginativo nella danza orientale, a cui molte<br />
figure liciniane fanno pensare, cfr. C. Sachs. Storia della danza, prefazione di D.<br />
Carpitella, Il Saggiatore, Milano, 1966, specialmente alle pp. 250 e 55.; N. Savarese,<br />
Il teatro al di là del mare, Studio Forma, Torino, 1980, ai capp. L’attore, La<br />
danza, Il rito, con particolare riferimento ai saggi ivi contenuti di Barrault, Claudel,<br />
Barba, Jung e Mejerchol’d. Un principio analogo guida anche la definizione<br />
del movimento nella pittura bizantina.<br />
19. L’analisi iconologica del tema in M. Calvesi, Duchamp invisibile - La costruzione<br />
del simbolo, Officina Edizioni, Roma, 1975, passim.<br />
(1) Scritto in occasione della mostra “Osvaldo Licini”, tenutasi presso la<br />
Galleria Civica d’Arte Moderna, Palazzo dei Diamanti, Ferrara, 19 ottobre-14<br />
dicembre 1980.
La natura, la iena e l’equilibrista<br />
Osvaldo Licini (1)<br />
Post-romantico e non anti-romantico, nemico della psicologia e<br />
non del sentimento, Licini crede, a differenza di Carlo Belli, nella<br />
vitalità dell’Ottocento, di un suo Ottocento ermetico e sulfureo.<br />
Ci crede assumendo la prospettiva dello sguardo postumo, con<br />
occhi appena disincantati e con autoironica affezione. Leopardi,<br />
in un suo disegno, volta le spalle alla luna e fuma un sigaro. In<br />
un altro due lune orbitano dietro il cilindro. Ma l’ironia non cancella<br />
il senso; lo prolunga invece o lo rende, per così dire, ancor<br />
più vibrante, poiché è Leopardi-Licini che fuma ed il luogo del<br />
pensiero rimane sempre lo stesso.<br />
Il tempo minato dalla colpa, il secolo della décadence e dei tramonti,<br />
ospita per il pittore presagi di incominciamento, luci di<br />
aurore. Si configura spesso come l’alba di un mondo in cui «il solitario»<br />
sta alla periferia dell’universo, su un orlo da cui si interroga<br />
e dubita. Anche la geografia pittorica è ricca di nuovi indizi.<br />
Perciò l’errante non esita, lui che pure inveisce contro il «banale,<br />
lurido naturalismo» e contro l’accademia impressionista<br />
degli anni Trenta, ad indicare in Gustave Courbet uno dei suoi<br />
maestri. E Courbet, lo sappiamo, è stato un inizio per Duchamp:<br />
il Courbet di Sar Péladan, non di Prudhomme. Così il cubismo, in<br />
questa dottrina degli inizi, non è la fondazione di un sistema<br />
quanto l’avvio di una interrogazione.<br />
Il fatto è che tra l’assolutismo di Kn e l’irrealismo liciniano, nonostante<br />
la stretta convergenza di proposizioni polemiche e negative,<br />
passa una differenza capitale intorno ad un tema che riconduce<br />
al Romanticismo: questo tema è la Natura, la materia.<br />
Mentre per il rosminiano-platonizzante Belli la dissociazione fra<br />
natura ed arte va posta in modo irrevocabile (“l’arte è fuori della<br />
natura”; “l’arte è tutta astrazione e niente materia: la vita è tutta<br />
materia e niente astrazione”), la pronuncia di Licini batte invece<br />
sulla coniunctio, sui legami segreti, sul come della somiglianza.<br />
Convergenza e dissenso su cui interviene, da un diverso orizzonte,<br />
anche Kandinsky. Tacere sulla Natura, non dimenticarla:<br />
ecco una persuasione costante. Stare nel circuito vitale e, al<br />
tempo stesso, oltrepassare il codice della imitazione. Il tuffo<br />
nella vita e il ritorno alle «sorgenti» sono essenziali per l’artista.<br />
Ed è, la sua, bisogna aggiungere, un’immersione da attuare in si-<br />
437<br />
lenzio, invocando riti di lontananza e di segretezza, giacché sulla<br />
Natura occorre essere reticenti. Non a caso, nel ’37, in piena fase<br />
astratta, lo sentiamo dichiararsi a favore di una equivalenza e<br />
sostenere che l’arte è, come tutte le cose della natura, «enigmatica,<br />
menzognera, bella ma con frode». Di lì a poco (è ben<br />
noto), potrà scrivere dalle «viscere della terra», tentare le porte<br />
della Notte, agitare la grande lettera, la M, per ri-scrivere il<br />
mondo. I quadri sono «macchine infernali», non solo e non tanto<br />
nel senso esplicito del sarcasmo e dell’invettiva, ma proprio in<br />
quello - mitico - di uno sprofondamento nelle regioni infere del<br />
«suo» Holderlin, dell’aorgico.<br />
La materia resta il sottosuolo imparlabile ma necessario, un’energia<br />
da superare e da far vibrare fantasmaticamente puntando<br />
sulle forze «misteriose» della menzogna, e cioè sul cambiamento<br />
e sulla metamorfosi. Ma una cosa è la vita come sorgente,<br />
un’altra la natura impietrata e umanizzata, poiché l’uomo, cosi<br />
com’è, ha perduto la chiave del ritmo e della musica. «Dimostreremo<br />
che la geometria può diventare (...) una poesia più interessante<br />
della faccia dell’uomo». Il volto umano s’è difatti inaridito<br />
e, psicologizzandosi, ha perduto la sacralità della «vera vita».<br />
Ritorna qui, ci sembra, in questo spostamento di interesse dall’immagine<br />
del volto ai ritmi dell’astratto (ma l’astratto convoca,<br />
si badi, un bestiario fantastico), quel motivo cardinale che sta<br />
sotteso al progetto di disumanizzazione di tanta parte dell’arte<br />
contemporanea, a quel progetto che, a cominciare dai romantici,<br />
da Kleist per esempio, vuol essere rottura del senso e disarticolazione<br />
dell’inanimato. Non per nulla Licini chiama in causa, più<br />
volte, autori «petrosi» come Rimbaud, Lautréamont o Reverdy.<br />
Ma l’opzione astratta, ci si chiede, sposta definitivamente quell’interesse<br />
in nome della «decorazione» o è una trappola sottile<br />
per ingannare-sedurre il lettore? Licini non si pronuncia, sospende<br />
il problema mentre dialoga con gli ‘amici’ del Milione. Di<br />
fatto, però, l’aniconismo accoglie ‘impurità’ mitiche e opera infine<br />
con una tensione rigenerativa: che è un modo per far passare,<br />
attraverso il formalismo, una diversa nozione di purezza.<br />
L’astratto tende a «forgiare» (il verbo è caro a Licini) qualcos’altro,<br />
un volto che è altro, ad energetizzare corpi ed immagini: un<br />
volto e un corpo di cui intanto si sondano le energie, i movimenti<br />
«impossibili», le attitudini oltre e più che umane.<br />
Prima di continuare in una simile inchiesta, conviene ritornare al
punto di partenza e domandarci di che natura sia il romanticismo<br />
‘postumo’ dell’artista, quali figure del sentimento metta in<br />
campo. Una prima, non ardua difficoltà è costituita da affermazioni<br />
che suonano perentoriamente negative (e in un certo contesto<br />
lo sono senz’altro), tali da liquidare la questione.<br />
«Siamo astrattisti - sostiene l’autore - perché riteniamo che classicismo,<br />
romanticismo, realismo ecc. siano cieli chiusi ed è ozioso<br />
ritornarci sopra». Anche le voci e gli emblemi canonici del<br />
mal du siècle, incontrano sorte analoga. Vengono sbeffeggiati,<br />
imbastarditi, sconvolti: l’amore, il cuore, la poesia: «"Poeta del<br />
cazzo", scrisse una volta Palazzeschi non so più dove. Che significa<br />
tutto questo? Che la poesia è finita, è morta».<br />
Assistiamo ad un processo di desublimazione, allo scompigliamento<br />
dei ruoli. Se il cuore finisce, nelle storie di Bruto, in una<br />
latrina, nondimeno continua a mostrarsi, a dar spettacolo, mentre<br />
al suo posto si assesta, come si sa, la riflessione sul cuore,<br />
anzi la riflessione costruttiva tout court, l’intenzionalità retorica:<br />
il «cervello». L’inversione fa sì che la pittura, nell’assumere abito<br />
cartesiano, inventari protocolli rigorosamente asemantici, almeno<br />
ufficialmente (“quadri che non rappresentino nulla”). Ma la<br />
poetica dice troppo poco, in questo caso, sulla pittura, poiché nel<br />
bandire l’inganno del sogno non aggiunge che lo sguardo resta<br />
ancora lautréamontianamente aperto, ferocemente spalancato<br />
sul cuore. Tanta la paura dello spossessamento ipnotico.<br />
Il ‘cervello’ di Licini è tutt’altro che perduto nei candidi cieli platonici<br />
(in senso cattolico e rosminiano, beninteso). Erige geometrie<br />
aggressive, ribalta «i piani dell’essere» e, nutrendosi di sensi<br />
corporei, li richiama continuamente alla fatica dello scontro e<br />
della riunificazione.<br />
Termini e titoli quali addentare o assaggiare, geometrie aguzze<br />
e taglienti, definiscono il campo di una sfida in cui la gravità vien<br />
costretta a purificarsi, a pronunciarsi sul registro d’un principio opposto.<br />
Talora, quando Licini vuol definire l’artista, ricorre alla nomenclatura<br />
del bestiario e gioca sull’allitterazione anima/animalità.<br />
Rovescia e confonde. «Fatta la debita proporzione - egli dichiara<br />
- risulta che l’uomo è una buona iena con tendenza alla<br />
poesia». Lautréamont, con evidenza. A lui si deve l’epiteto iena<br />
per i poeti, per Maldoror e sé medesimo: si vous croyez apercevoir<br />
quelque marque de douleur ou de crainte sur mon visage<br />
d’hyène (...) soyez détrompé. C’è da precisare però che in Licini<br />
438<br />
la iena aggredisce apertamente se stessa, l’immagine propria:<br />
«Seguiterò a fare e a disfare, e a divorare - preferibilmente me<br />
stesso - per conservarmi degno di te» (in una lettera a Sartoris<br />
del ’41).<br />
Tuttavia questa ‘iena’ è talvolta smemorata, non sa resistere agli<br />
incanti di primo grado della natura, all’infinito musicale degli<br />
elementi. Anche la materia, in certi momenti, sa cantare da sola.<br />
Nel Nord, da cui Licini scrive nel ’31, in un anno cioè insospettabile<br />
di empatie naturalistiche, egli si lascia travolgere dalla seduzione<br />
del paesaggio. L’istrione, come egli ammette, è Wagner:<br />
«A 800 metri sul livello del mare, in vascello, sopra i monti,<br />
le immense mitologiche selve sotto i piedi, cieli capovolti nelle<br />
acque, solo a bordo, la luna fra le nuvole come una pazza! Dove<br />
eri tu? Ti saresti lasciato prendere come me dalla gran rete romantica?<br />
Re Nibelungici apparvero; tutto il corteo di principesse<br />
della favola: a suon di corni, Wagner attaccò la grande orchestra.<br />
Questo ho provato» (lettera da Goteborg, ottobre 1931). E all’amico<br />
Acruto: «Ma la cosa più bella, tu sai che sono i tramonti.<br />
Non finiscono mai. Sono ore pericolosissime per i sensi. Miraggio,<br />
incantesimo, poesia e... canto». Ai labirinti di pietra e di<br />
mare della Svezia si associa poi un’altra ‘allucinazione’, questa<br />
volta pittorica: ad innescare la molla dell’incanto è «la luce che<br />
viene dalle stelle» di Rembrandt, il «Veronese nero», come lo<br />
chiama Licini per stringere in un ossimoro due tensioni antagoniste<br />
della tradizione pittorica. Cadono in quegli stessi anni pochi<br />
versi sulla notte (la Fuggitiva), frammenti faticosi e più volte riscritti<br />
in cui è dato cogliere una crescente intimità nell’oscillazione<br />
pronominale delle varianti, sintatticamente irrisolte, dalla<br />
terza alla seconda persona: «Sulla pietra mi sono disteso / io e<br />
la mia notte amica / Nuda nel suo mistero / avvinta a me sarai»<br />
(var. «sarà»).<br />
È vero che simili trasporti, specie nelle lettere, sono immediatamente<br />
rintuzzati da un giro di frase scherzoso, da un epiteto burlesco<br />
e sdrammatizzante (per es.: «A Stoccolma ho incontrato un<br />
altro romanticone: Bruno Barilli»), ma, a guardar bene, espressioni<br />
di questo genere, servono al gioco delle reticenze: mettono<br />
tra parentesi l’oggetto del discorso piuttosto che negarlo. Del<br />
resto quando Licini deve indicare le matrici della sua prima fase<br />
pittorica, fa tre nomi precisi: Cézanne, Van Gogh e Matisse.<br />
E su quest’ultimo insiste particolarmente, dichiarando d’essere
stato, nei primissimi anni, lui stesso fauve.<br />
Al di là delle differenze morfologiche più che evidenti, è il loro<br />
vitalismo mitico ad attrarlo. Senza l’abbraccio della mater-materia<br />
il pittore è impotente. Anche Picasso, nella lettura che ne fa<br />
Licini, è iniziato a quel dèmone.<br />
«Solo con lentezza giunsi a scoprire - aveva confessato Matisse<br />
- il segreto della mia arte. Consiste nel meditare in contatto con<br />
la natura, per esprimere un sogno sempre ispirato alla realtà».<br />
Ed ancora: «avere in me il modello», «rispettare la grandezza e<br />
il carattere sacro di ogni cosa vivente».<br />
Potremmo accumulare altri riscontri ed addentrarci nella fitta<br />
rete dei riverberi matissiani sul pensiero (e sull’opera) del pittore<br />
delle Marche. I punti di contatto nonché stretti appaiono continui<br />
nel tempo: basterebbe richiamare, ad esempio, il legame<br />
fra decorazione e ‘sentimento’ per darne conto sufficiente; oppure<br />
insistere sulla funzione ‘rasserenante’ del quadro, sulla richiesta<br />
fatta al lettore di un punto di vista estatico, senza-tempo;<br />
ed ancora sottolineare il predominio accordato alle procedure<br />
asimmetriche, alla costruzione dell’immagine per via di rimandi<br />
interni e rifrazioni lineari a partire da un nucleo generatore. Potrebbe<br />
essere registrata inoltre una serie di sintonie, più che di<br />
prestiti, intorno a cui si istituisce una certa idea comune di orfismo,<br />
non ultima quella di produrre uno slancio di immensità in<br />
uno spazio minimo ed araldico.<br />
Tuttavia il riferimento a Matisse, al pittore che si diceva votato<br />
alle altezze (“La verticale è nel mio spirito”), ha qui uno scopo<br />
più limitato. Serve a cogliere un nodo, o se si vuole un luogo di<br />
passaggio, nella formulazione della tesi che la Natura è un momento<br />
insostituibile del fatto pittorico.<br />
Da quel che si è detto, dovrebbe risultare chiaro che la Natura è<br />
intesa come principio cosmogonico, energia e chora scatenata,<br />
eros allo stato puro.<br />
In lei ci si perde, ma con lei ci si unisce anche, in un abbraccio<br />
che è possesso continuamente invocato e perduto. V’è infatti<br />
nella peripezia mitografica di Licini un doppio stazionamento<br />
prima dell’ “esperienza ultima”: quello scandito nelle tappe della<br />
fusione sognata e del risveglio, della Notte e dell’Alba. Lo si<br />
vede, per esempio, nelle sue poesie, in cui l’aurora viene a dissolvere<br />
l’ora visionaria: “un sogno breve / o Fuggitiva addio / La<br />
nostra alba un grido / la sua cima ai falchi”.<br />
439<br />
Ora proprio questo sentimento di un’attesa che potrà sfociare<br />
nella pienezza della rivelazione, benché il tempo della veglia<br />
non conceda di cogliere che sparsi sintomi e frammenti della totalità,<br />
accompagna il tragitto della pittura liciniana. Non solo: a<br />
caratterizzare un simile percorso, a dargli il suo senso proprio, la<br />
sua speciale inflessione tematica, interviene il tòpos del messaggero,<br />
dell’angelo. Il motivo apre e chiude l’avventura più documentata<br />
dell’autore: dall’Angelo Gabriele del 1919 all’Angelo<br />
di S. Domingo del 1957. Esso incontra una serie di metamorfosi,<br />
di formulazioni successive, che non s’arresta certo negli anni dell’opzione<br />
astratta per quanto si travesta sotto forme quasi irriconoscibili,<br />
fino alla riemersione del dopoguerra. Si tratta, siamo<br />
tentati di dire, di un processo di gestazione vera e propria, non<br />
solo formale ma figurale, poiché convoca e mette in agitazione<br />
tutto un archivio di emblemi della discesa, dell’inghiottimento e<br />
della fecondazione: il serpente e il drago, l’ala dentata, la bocca,<br />
i1 mulino a vento, l’ade, il sottosuolo e così via.<br />
Emblemi e metafore di valore plurimo, sempre ricondotte alla<br />
vertigine dell’errare (volo, navigazione celeste, ascesa, circolarità),<br />
dell’equilibrio alogico e del non finito: figure quindi complesse,<br />
antifrastiche, fluide, dove l’elemento satanico-tellurico<br />
non viene perimetrato in se stesso, ma coniugato e posto in frizione<br />
con tema “superiore”; temprato, anzi “garantito”, come<br />
scrive l’autore, in oro ed argento. Da qui deriva il necessario<br />
splendore della geometria: che è sapienza iniziatica al “volto misterioso<br />
della bellezza”, non scienza. Eccesso decorativo appunto.<br />
Prismi e fiori di luce sbocceranno sui fondi neri, insieme e<br />
dopo le Amalassunte. Come in Novalis e Nerval, le cavità ctonie<br />
e le viscere del drago rinchiudono segreti di fuoco. Sono fucine<br />
di talismani.<br />
Quel che sorprende, ogni volta che ci si trova a sfogliare le tavole<br />
liciniane, è l’assenza di una «tradizione» privilegiata di riferimento,<br />
di un codice vincolante. Vi traspare un pensiero in crescita,<br />
aperto alle suggestioni più varie, ricchissimo, multiplo, ma<br />
eclettico nelle matrici. Mentre in altri autori ‘ermetici’ è pur possibile<br />
scoprire le tracce di una dottrina dominante, qui vengono<br />
ad incrociarsi - quasi sicuramente - tessere provenienti da tradizioni<br />
diverse, frammenti che di volta in volta, per via traversa ed<br />
in modo quasi irrelato, richiamano l’iconografia astrologica, cabalistica<br />
o pitagorica. Lo stesso cammino biografico del pittore,
così caratterizzato dalla solitudine e dall’isolamento, presenta<br />
uno strato segreto cui è assai difficile accedere.<br />
Resta fertile invece il terreno letterario, cioè quel registro di risonanza<br />
entro cui Licini muove le figure; ed in cui prende corpo<br />
non tanto il segno pittorico, com’è naturale, quanto il «sogno»,<br />
la sua visione del mondo. La letteratura è per lui uno scrigno, un<br />
archivio di miti (fa sua la spleenetica sentenza di Mallarmé:<br />
hélas! et j’ai lu tous les livres), qualcosa come un itinerario della<br />
mente: un serbatoio da cui estrarre nomi, immagini verbali e mitologie:<br />
la fonte iconologica della pittura. La letteratura è insomma<br />
un repertorio enciclopedico di temi e in quanto tale viene ripercorsa<br />
come una fonte di verità inappellabili, di aforismi e di<br />
assiomi. Ciò non toglie tuttavia che alcuni suoi testi, come le pagine<br />
di Bruto, e certi sintagmi siano il risultato di un lavoro stilistico<br />
sulla parola. In questo senso amalassunta, ricalco in apparenza<br />
neutro di un nome proprio, costituisce un evento esemplare<br />
e straordinariamente intenso, ponendosi da un lato, sul<br />
versante dell’immagine, in rapporto col capitolo surrealista (ortodosso<br />
e non) delle Assunte, e richiamandosi per un altro<br />
aspetto alla stirpe verbale degli esiliati: alla famiglia di Maldoror,<br />
del Mal-aimé e di Amalécyte: Et, protégeant tout seul ma mère<br />
Amalécyte, / le ressème à ses pieds les dents du vieux dragon,<br />
grida l’Antéros delle Chimères.<br />
Sono quegli esiliati a portare profezie nel mondo manifestato, ad<br />
esibire enigmi, imponendo su di essi il silenzio. Se un’essenza<br />
dell’angelo è la lettera sacra, poiché dipende dall’esistenza di<br />
questa lettera la sua condizione di portatore e custode, di mediatore<br />
fra i diversi gradi della creazione, si capisce come la riappropriazione<br />
della lettera costituisca una delle rivendicazioni più<br />
alte del satanismo; o possa configurarsi come una prova di redenzione.<br />
Gli angeli dipinti da Licini nel ’19 mostrano un’inquietudine che<br />
è assente nelle pagine della Bibbia. Nel primo dei due quadri è<br />
raffigurato Gabriele, il nunzio maggiormente dotato di virtù ermeneutiche.<br />
Nel secondo compare un angelo privato dei suoi<br />
contrassegni celesti, in fuga e di spalle, ma col capo rivolto verso<br />
l’alto. Sullo sfondo, fra le nuvole, un disco incandescente di luce<br />
bianca allude ad un’ora topica, culminante. Anche il volto di Gabriele<br />
dà l’impressione di un moto bruscamente interrotto, di un<br />
crollo, mentre la spada puntata sul fianco sembra infliggere es-<br />
440<br />
sa stessa una ferita al suo corpo.<br />
Da dove viene questa iconografia? L’esegesi biblica attenta agli<br />
apocrifi e alla tradizione gnostica potrebbe scorgervi la raffigurazione<br />
di un rituale di veglia. Scrive infatti G. Scholem citando lo<br />
Zohar: “a mezzanotte (...) da Nord si leva un vento, e una scintilla<br />
scaturisce dalla forza del Nord, dal fuoco di Dio, che non è<br />
altro che quello della potestà del giudizio, e colpisce sotto l’ala<br />
l’arcangelo Gabriele”. La folgore inviata da Elohim dà inizio al<br />
tempo della contemplazione durante l’esilio. E di esilio, di attesa,<br />
sembra effettivamente parlare una delle due tele con l’angelo<br />
in fuga. Anche la spada è facilmente assimilabile al fuoco<br />
del dio ebraico, essendo un simbolo noto della giustizia. Tutto il<br />
resto rimane però abbastanza oscuro.<br />
Evitando di soffermarci ora su ulteriori particolari di queste tele<br />
assai complesse e tormentate (Licini tornò a considerarle fra il<br />
1928 e il ’29, ritracciando l’immagine dell’arcangelo, mutandone<br />
la posizione e l’attitudine, ma mantenendo il suo sguardo rivolto<br />
all’astro luminoso), si può azzardare l’ipotesi di una speranza<br />
di rinnovamento, di una idea di attesa che, attraverso la metafora<br />
dell’angelo, punta alla riconquista delle capacità estatiche<br />
nell’epoca del Moderno, cioè nell’età di eclissi del vivente. Di<br />
colpo, però, dopo i ripensamenti iconografici del ’28-’29, la figura<br />
esplicita dell’angelo scompare. Vi saranno metafore di secondo<br />
grado, come Uccello o ala. Soltanto a distanza di quindici anni<br />
O. Licini, Amalassunta con cravatta, 1949 (particolare).
gli olandesi volanti restituiscono tematicamente la presenza di<br />
un mediatore fra terra e cielo, fra finito e infinito, micro e macrocosmo,<br />
come ha spiegato Birolli nella sua lettura del mito dell’Olandese.<br />
Soltanto allora si assiste alla spettacolarizzazione di<br />
cifre, lettere ed oggetti magici. Di più: le materie pesanti appaiono<br />
filtrate, il Femminile assunto in una araldica estatica, l’impuro<br />
innalzato agli splendori di Amalassunta-Diana.<br />
Che cosa è accaduto nel frattempo? La fase astratta ha ospitato<br />
un’opera di rimozione?<br />
Il ‘testo’ risponde in modo negativo. Infatti un dato assolutamente<br />
lampante nell’opera di Licini è la persistenza, da un’epoca<br />
all’altra della sua pittura, di alcuni nuclei figurati, anzi di poche<br />
strutture ritmiche che crescono, si metamorfosano e creano nel<br />
Dal volume “O. Licini, errante, erotico, eretico”, appunti di <strong>Francesco</strong> <strong>Bartoli</strong>, (particolare).<br />
441<br />
loro dispiegarsi famiglie e costellazioni solidali. La formatività in<br />
atto produce metafore consecutive ed è la sua natura ritmicagenerativa<br />
a costituire la chiave di volta della performance<br />
grammaticale.<br />
La geometria sperimenta una catena di situazioni acrobatiche<br />
sullo sfondo di fluidi campi simbolici. Nella mutabilità relativa<br />
delle scene domina la costante del funambolismo. C’è una sorta<br />
di volontà dimostrativa, a livello di segno, nel creare spettacoli<br />
antifunzionali e fantasmagorie abbacinanti. Il ‘geometra’ è<br />
anche un equilibrista che saggia il proprio dominio costruttivo e<br />
lo estende, con garbata indifferenza, su regioni molteplici. Eleva<br />
castelli in aria, architetture ascendenti e traslucide, che in realtà<br />
sono serpenti, frecce, draghi, macchine trituranti e assimilative.<br />
La linea mette alla prova capacità prensili, ribaltanti: cattura, assorbe,<br />
moltiplica, disgrega e ricostruisce. Sprigiona vitalità mercuriale,<br />
trasporta materie ed oggetti, li rende fantasmi.<br />
Si aggiunga l’intenzione esibitiva, attoriale, recitativa del ritmo.<br />
Non troviamo il funambolo come creatura, ma il tracciato dei<br />
suoi percorsi: il suo repertorio di gesti e movimenti, quel tesoro<br />
che verrà trasmesso ai personaggi della stagione successiva.<br />
Anche Bruto aveva ostentato virtù di saltimbanco. Ora, però, gli<br />
acidi corrosivi appaiono come decantati. Il paradosso assume cadenze<br />
meno fragorose e rampanti. Se gli sketch di Bruto disegnavano<br />
traiettorie rettilinee, puntute, in progresso d’accelerazione<br />
(Baratta), il movimento ha qui un respiro rotatorio e labirintico,<br />
continuo. Quando staziona, è in eccesso non in arresto,<br />
poiché contrae una tensione, implode in un moto interiore.<br />
Questa metrica, espandendosi come per eco sulla tela, crea poi<br />
delle topografie simboliche. Fa emergere alberi e croci, obelischi<br />
e ruote del tempo. La diagonale, che costituisce l’asse di molte<br />
composizioni, riunisce in sé non solo la verticale e l’orizzontale,<br />
ma il movimento rettilineo e quello rotatorio. Il funambolo si<br />
esercita sotto e sopra la corda, teso contemporaneamente fra<br />
due tentazioni.<br />
Propensione teatrale, esibitiva, si diceva. Nelle tele più antiche<br />
essa è documentata nell’impianto scenografico, nell’uso delle<br />
quinte laterali, simmetriche, quasi di addobbi per incorniciare un<br />
episodio. Effetti artificiali di illuminazione, giochi di controluci da<br />
palcoscenico sono presenti nelle opere del 1917; e qualche conseguenza<br />
formale è ancora visibile negli arcangeli di due anni
più tardi, dove la cortina delle nubi si spalanca come un sipario.<br />
È di quegli anni anche la fascinazione esercitata da Parade, dai<br />
giocolieri di Picasso, da Petruska e dalle figure di Cocteau. La<br />
stessa Parigi, per Licini, ha l’evidenza del teatro: è la scena moderna,<br />
la metropoli non industriale, in cui l’arte del trucco ringiovanisce<br />
e salva. Parigi è Baudelaire, col suo Théatre du Séraphin:<br />
non il luogo della natura, ma dell’antinatura, della natura resa<br />
più bella dall’artificio: la città interlocutrice di Monte Vidon Corrado,<br />
il suo vero pendant dialettico. Solo in questo senso si poteva<br />
amare Léger senza seguirlo.<br />
Sotto la spinta dell’ ‘irrealtà’ il teatro liciniano si spoglia: non è<br />
uno spazio da vedere ma un luogo da immaginare: un teatro<br />
della mente.<br />
Ed ecco: nell’atto di interiorizzarsi, si dilata a scena cosmica. Il pierrot<br />
che vi si esibisce, mostra volto astrale, come nella Composizione<br />
del 1934 (coll. A. Giovanardi), e corpo erratico: l’incostante.<br />
Nel 1954, eseguendo un Omaggio a Cavalcanti, Licini riformula<br />
l’emblema amalassuntiano del piede e della mano per trarne<br />
fuori il ritratto del poeta sospetto di averroismo. È un volto pieno<br />
d’occhi e di vento, simile all’ala di un serafino disegnata da un<br />
gotico. Mentre il busto rimane saldamente ancorato alla terra ed<br />
anzi sprofondato in essa come un’erma gigantesca, il viso irradia<br />
una fortissima tensione estatica: nuova visualizzazione, questa,<br />
della scena mentale ed autoritratto fantastico per via di transfert.<br />
Agisce un emozionato collegamento con l’“eretico” dello Stil<br />
Nuovo, anch’egli attore di un teatro invisibile e inquisitore di lettere<br />
«spiritate».<br />
La diagonale, si è detto, funziona metaforicamente come un<br />
orlo. È il confine fra mondi ancora inconciliati, secondo un’urgenza<br />
simbolica che va sempre più ispessendosi dopo le Archipitture,<br />
con i dipinti della memoria e dell’oltretomba. Inizia allora il<br />
viaggio negli abissi della Natura romantica e l’incontro è frontale.<br />
Chi discende nel regno delle «Madri», nella «verde landa dell’originario»,<br />
può contare però sul sapere del numero e del ritmo.<br />
L’errante mette in azione la sua agilità di traghettatore d’anime,<br />
è ombra senz’ombra, come Hermes. Ha in mente di rubare lettere<br />
e cifre con le quali costruire portafortuna, piccoli quadri magici,<br />
pentacoli. Sa che la materia può acquistare il soffio dell’anima<br />
in virtù della lettera e del geroglifico.<br />
Si tratta di un gesto decisivo, documentato nella mirabile lettera<br />
442<br />
a Ciliberti, di cui diamo la conclusione: «Potrò mostrarti le mie<br />
prede: i segni rari che non hanno nome; alfabeti e scritture enigmatiche;<br />
rappresentazioni totemiche, che solo tu con la tua<br />
scienza potrai decifrare».<br />
Il totem: lo spirito parentale, il principio, l’origine. L’anima della<br />
comunità. Il suo volto è impersonale, inciso di geroglifici, una<br />
maschera sacra. Anche le Amalassunte e gli Angeli mostreranno<br />
un volto ieratico, quello radioso e sovrumano, superindividuale e<br />
radiante dei corpi in folgore. L’equilibrista, il funambolo hanno<br />
rappresentato una tappa di questo processo di trasformazione.<br />
«Dopo il romanticismo il buffone, il saltimbanco ed il clown sono<br />
state le immagini iperboliche e volontariamente deformanti che<br />
gli artisti hanno dato di se stessi e dell’arte. Il loro è un autoritratto<br />
travestito».<br />
L’interpretazione di Starobinski aderisce, non c’è dubbio, alla ripresa<br />
del mito fattane da Licini, largamente immerso per suo<br />
conto nel paesaggio culturale delineato dal critico francese. Di diverso<br />
e di singolare, rispetto agli autori presentati nel Portrait de<br />
l’artiste en saltimbanque, v’è il ricorso alla simbolica del funambolo<br />
in termini di pura sintassi ritmica. Il pittore ha in certo modo<br />
smaterializzato l’iconografia del circo, estraendone la gestualità<br />
e fissandola nella linea e nel colore. C’è il sublime e il suo contrario.<br />
Non v’è infatti rinuncia dei protocolli comici dell’antico repertorio:<br />
La patetica, Amalassunta che ride, con trombetta,<br />
mentre fuma o è felice. Si sviluppa una fisiognomica su questo<br />
registro durante l’ultimo decennio, accanto alle partiture sacrali.<br />
Ed è una prova, anche questa, della cosmicità di una ispirazione:<br />
far posto a tutti i sensi e dissolverli in un chiasmo senza fine.<br />
Non termineremmo però con Nietzsche, in questo caso, nonostante<br />
il funambolo, benché Licini ne abbia conosciuto e amato<br />
il pensiero. La menzogna liciniana è un enigma che nasconde<br />
ancora la verità, la pienezza è conquistabile benché indicibile.<br />
Per lui soltanto i fantasmi dell’esistenza sono maschere vuote e<br />
false: «un angelo fatto di tutto / a prendermi scenderà / angelo<br />
o demonio / che sia / fa lo stesso / poco importa».<br />
(1) Scritto contenuto nel periodico d’arte “Acrobat Mime Parfait”, edizioni<br />
Acrobat, Bologna, numero 0, trimestrale, gruppo IV/70.
F. Milani, Fotopoesia, 1980.<br />
Raccontare per frammenti.<br />
Fotopoesie di Fulvio Milani (1)<br />
Se i procedimenti più radicali della scrittura visuale tendono a far esplodere la materialità<br />
della lettera col dare spessore ai segni alfabetici e col dissolvere la verbalità nel dominio dell’immagine,<br />
altre ricerche, in campo sia poetico che figurativo fanno leva piuttosto sulle interferenze,<br />
sui rapporti di specularità e gli effetti di contatto tra una serie e l’altra. La parola,<br />
ad esempio, non è negata in quanto tale, ma costretta a subire i contraccolpi del linguaggio<br />
visivo, ad interrogare ed interrogarsi intorno a ciò che un altro codice propone come tema di<br />
investigazione e rebus da sciogliere. Si stabilisce in tal modo una sorta di intrattenimento,<br />
una relazione: da un lato v’è l’emergere d’una cifra muta che sfida la parola, dall’altra si tenta<br />
di comprenderla o quanto meno di stabilire uno spazio di complicità, di scambio attivo, di<br />
443
movimento parallelo.<br />
Una situazione, questa, posta in modo esemplare nella recente mostra di fotopoesie di Fulvio Milani<br />
(Galleria “Il Chiodo”). In tante stazioni quante sono le tappe in cui viene scandito il nastro figurale<br />
(7 studi con/fusi), la scrittura accompagna e commenta un processo catturato dalla registrazione<br />
fotografica. Non si limita però a fiancheggiarlo. Lo assedia invece, talora lo anticipa e<br />
lancia una serie di insidie, contrapponendogli la evidenza della propria trama, una cadenza di<br />
444<br />
F. Milani, Fotopoesia, 1980.
itmi e di sincopi. Vien così messa in dubbio la lettura a senso<br />
unico: dallo spazio della figura allo scorrimento del testo. E si dubita<br />
perché il diritto all’incipit, nella separatezza delle serie, è invocato<br />
contemporaneamente da entrambe: se la parola, nella<br />
prima tavola, si assume la responsabilità di pronunciare la nota<br />
di esordio dell’intero progetto (un’ipotesi di riattivazione: “ri-coniugare<br />
/ (...) / riprendendo le sproporzioni / realtà celata”),<br />
anche l’immagine esibisce una analoga investitura. Si teatralizza<br />
come auctor. Sicché il rapporto diventa subito circolare, di doppia<br />
sobillazione.<br />
Interpellante ed al tempo stesso evocato dal potere delle parole,<br />
il dettato fotografico si dispone lungo una serrata parabola<br />
narrativa.<br />
Ordina un’azione in una sequenza retoricamente calibrata di<br />
tappe: esordio, svolgimento, culmine ed epilogo. Su un boccascena<br />
ricondotto alla misura interiore della stanza, mai visto totalmente<br />
e sempre abbuiato sul fondo, un corpo femminile<br />
mima l’accesso alla visione: alla pienezza della scena e agli strumenti<br />
della conoscenza. Quel corpo è però ombra, silhouette,<br />
doppio. Quando irrompe in primo piano, si fa cogliere per frammenti,<br />
spezza i simboli e si rituffa infine nell’oscurità, nella penombra<br />
senza misura che sta oltre i sipari laterali.<br />
Neppure il teatro, luogo deputato della rappresentazione, può<br />
dunque dar nome a ciò che per un attimo lo ha attraversato. Per<br />
quanto la fotografia abbia cercato di mordere l’immagine puntando<br />
sugli effetti di contrasto, questa resta imprendibile e fantasmatica.<br />
Un puro movimento.<br />
Mentre analizza una convenzione figurativa (l’artificio della<br />
scena), l’autore riflette su una figura, anzi su un tema centrale<br />
della vita psichica: la corsa all’immagine perduta, lo sIittamento<br />
metonimico verso l’arché negata. Fatalità della ripetizione e discorso<br />
sul discorso.<br />
“Ho scritto sul nulla”: questa tematizzazione iniziale prefigura lo<br />
scacco dell’ultima tavola, quel “viaggio/ non ancora inizio” che<br />
è “già arrivo”.<br />
Pur rassodandosi attorno all’azione e colpendo ogni volta il bersaglio<br />
(la messa a fuoco è infatti ostinatamente centrale), la fotografia<br />
costruisce infatti un edificio vuoto, la struttura della peripezia<br />
inutile.<br />
Alla compattezza lineare dei quadri fotografici entro cui viene<br />
445<br />
scandito l’evento mitico che lo eccede, fanno eco i depositi scritturali<br />
nelle zone traslucide delle tavole. Sono brandelli e resti di<br />
una discorsività che è stata amputata, ricondotta quasi sempre<br />
alla pronuncia del verso breve, dal quaternario all’ottonario, e<br />
per di più riflessa per distorsione dietro le lastre. Ed è strategia<br />
divergente: mentre l’immagine tenta di catturare il non-dicibile<br />
serrando le maglie della rappresentazione, la parola discorsiva<br />
viene decentrata, interrotta da spaziature, inquietata nelle domande<br />
e nelle sospensioni. Ricorrono i lemmi ad alta tensione<br />
dei discorsi sulla profondità. C’è tutta la nuova retorica dell’eccentrico,<br />
ma è un arsenale impietrato. Gli spazi bianchi, i riflessi<br />
e le ombre, i simboli geometrici sospesi e i salti dimensionali<br />
della scrittura segmentano la normale amministrazione dei sintagmi,<br />
confondendone la lettura e l’ascolto.<br />
E ci si aggirerebbe senza fine nel labirinto dei segni devitalizzati,<br />
se non intervenisse a bloccarli una precisa tensione stilistica<br />
volta a incidere, a rimodellare icone e lettere: quello “scolpire la<br />
parola” che costituisce, a ben guardare, la nota più originale del<br />
lavoro di Milani. Un incidere e uno scolpire che decide sul ritaglio,<br />
aduna frammenti e racconta per via di sineddoche. Il che<br />
porta a pensare, come ha osservato Gino Baratta nella nota in<br />
catalogo, che l’anelito nasconda una passione impossibile: impossibile<br />
perché la Notte si sottrae al freddo calcolo dei segni.<br />
.<br />
(1) Articolo comparso sulla Gazzetta di Mantova del 9 settembre 1980
Presagi della scena<br />
Rodolfo Aricò (1)<br />
La pittura e il teatro: una relazione sotterranea e produttiva, non<br />
un rapporto di identità. Parlarne vorrà dire addentrarsi nelle ragioni<br />
della somiglianza, soprattutto scoprire una mappa di comuni<br />
metafore e presagi. Pirandello, Calderon, Ionesco, Tardieu.<br />
Basterebbero questi nomi, espliciti e documentabili, a dire quanto<br />
sia intensa, specialmente nell’ultimo decennio, la frequentazione<br />
dell’universo teatrale da parte di Aricò. “Pour avancer je<br />
tourne sur moi-meme/Cyclone par l’immobile habité“, leggiamo<br />
nei Testimoni invisibili di Jean Tardieu. Ed è, questo un pensiero<br />
che trova ragioni di conoscenza con le riflessioni del pittore,<br />
un tema assimilabile al suo tòpos del retrocedere per avanzare,<br />
del discendere per risalire e compiere circolarmente un itinerario<br />
di conoscenza.<br />
Stare sulla soglia, occupare il margine, addensarsi alla tessitura<br />
della tela: ecco alcune attitudini dello sguardo che appare, al<br />
tempo stesso, come medialità costruttiva della pittura. “Amo -<br />
scrive Aricò - che un quadro si legga osservandolo da vicino. Non<br />
capisco come si possa esaurire un’opera con una veloce occhiata<br />
lontana.<br />
Nell’esecuzione è fissata gran parte della sua essenza, pura”. È<br />
vero: la superficie richiede avvicinamento, rottura delle distanze,<br />
immersione: quest’opera in cui le procedure della fusionalità<br />
hanno così larga parte e dove l’unità, la dominante di colore, è<br />
l’esito d’una germinazione cromatica, di una crescita per strati ed<br />
assorbenze; dove il campo, severamente bloccato in margini taglienti<br />
e in esatti perimetri, è sorgente di valori radianti e materializza<br />
una sorta di esaltazione fissata, un’addensamento del delirio<br />
visivo nella fermezza ieratica della frontalità.<br />
La soglia, si diceva. Qui sta anche, in una simile figura, una riserva<br />
di ambiguità, una entità duplice e conflittuale (“l’homme<br />
est l’etre entr’ouvert (…). La porte schématise deux possibilités”<br />
– Bachelard), un bifrontismo dell’immagine. Ma è davvero il<br />
caso di parlare di un’immagine e non piuttosto di uno spazio in<br />
cui all’immagine non è dato tempo di coaugularsi, di maturare<br />
in un corpo definitivo, di pietrificarsi in un simulacro e in un’effige?<br />
Sta di fatto che lo sguardo (sguardo potenziato e intensivo)<br />
è colto contemporaneamente da una doppia vertigine: catturato<br />
446<br />
R. Aricò, Timpano, 1980, tecnica mista su carta.<br />
R. Aricò, Timpano, 1979, tecnica mista su carta, cm 30x40.
per un verso dall’evidenza di un perno centrale, dall’autorità di<br />
una figura e di un macrosogno, e per un altro sospinto a perdersi<br />
nella liquida motilità della superficie dipinta, nella profondità<br />
degli spessori, in corpi soffici ed aerei. Sicchè, venendo meno la<br />
perentorietà di un punto di sostanza, la visione corre sui paesaggi<br />
cromatici e prospettici. Il sogno, tutto esibito in apparenza<br />
è rianimato da uno spostamento e da una riapertura di cifra. Ciò<br />
che si è osservato da una stazione non è ancora tutta la sostanza<br />
vivente della pittura. C’è una sospesa emergenza che afferra<br />
e dà il senso del rischio e dell’attesa.<br />
Vien da pensare al Quattrocento di Aricò, alla sua riflessione sul<br />
motivo del “mazzocchio”. Come dimenticare che quell’icona ha<br />
ospitato un’erranza, che è stata l’approdo di una lunga, ragionata<br />
follia? E che ha funzionato altresì come un magico corpo e un<br />
talismano? Un oggetto purissimo e impossibile nel paesaggio<br />
della peste? Ed ancora: un reticolo diamantino, un astratto erbis<br />
pictus?<br />
E dopo Paolo Uccello (o “Paolo degli Uccelli”, come amava chiamarlo<br />
Artaud per indicarne la febbre prospettica), la scena di Sebastiano<br />
Serlio: ma riattivata nell’utopia visionaria di Gordon<br />
Craig. Il Serlio osservato con gli occhi di Blake. Ed insieme vien<br />
da ricordare la strenua scritturale della messa in scena appiana,<br />
dove il motivo della costruzione si lega all’eccitazione mistica per<br />
un assoluto che è luce e suono, partitura musicale.<br />
Ambedue volti, Craig ed Appia, al disvelamento delle architetture<br />
“armoniche” del movimento universale, a cogliere il “geroglifico”<br />
della vita; entrambi “umanisti” eterodossi, capaci di rovesciare<br />
la scienza in sapienza, proiettati verso un avvenire che è<br />
riannodamento con l’arché sepolta. Se nelle rovine del presente,<br />
fra le macerie della modernità, domina il calcolo computistico<br />
dello scientismo, la geometria patisce gli effetti di uno spossessamento:<br />
da un’anima del mondo è divenuta strumento<br />
d’amministrazione quantitativa. La scienza designa la mancanzaad-essere,<br />
il gelido dissezionamento del reale, l’amputazione del<br />
desiderio, laddove il sapere, la saggezza, apre spazi di rigenerazione<br />
e mette in moto i dispositivi dell’immaginario. Certo non<br />
v’è coincidenza fra le dottrine di Appia e di Craig e la poetica di<br />
Aricò, non foss’altro per la lontananza dal clima metafisico in cui<br />
essi erano immersi. Vogliamo dire però che quelle dottrine costituiscono<br />
dei luoghi di riferimento, dei presagi per la pittura.<br />
447<br />
Così come altri presagi sono disseminati, talora con lucida ironia,<br />
lungo il percorso del suo lavoro: gli utopici progetti di Ledoux, le<br />
carceri di Piranesi e l’ ”Idea di tutte le perfezioni” di Bibiena. Anticipazioni<br />
di quel “tornare ad essere” che anima con tanta forza<br />
il suo zibaldone.<br />
Ma v’è, accanto alla suggestione dello spazio teatrale, anche il<br />
fascino della parola del pensiero drammaturgico. Una drammaturgia<br />
che collocandosi sulla linea dell’assurdo investiga la dimensione<br />
del sublime decaduto e del tragico. Anche ad essa il<br />
pittore affida un ruolo indicativo, il carico di un’insurrezione. Non<br />
è forse Amedeox ad innescare il processo di volatilizzazione<br />
della materia, in nome di una “vita altra” e dell’immaginazione?<br />
Ma a pagare infine col volo l’eccesso di fantasia? E non è ancora<br />
Berenger, il secondo personaggio ioneschiano convocato da<br />
Aricò, a sostenere i diritti del sogno, quello sprigionamento<br />
dell’”universo del dentro” che, separato dall’esistente, rischia di<br />
perdere peso e di dissolversi nei cieli dell’astrazione? D’essere insomma<br />
solamente un pensato, di non vivere?<br />
Limpida appare qui la sintonia con la parola di Ionesco, poiché la<br />
ponderalità, il peso dell’immagine, la necessità di dar carne e<br />
sangue ai fantasmi mentali sono un leit-motiv della pittura-oggetto:<br />
un’aspirazione che guidò, fra l’altro, Pendus 68, quel programma<br />
di mostra “impossibile” e il lavoro di contraggenio che<br />
fu l’idea (e la creazione) di ingombri tridimensionali negli spazi<br />
di esposizione: progetto che se fu interrotto, non di meno sta<br />
ancor lì a testimoniare, proprio a ridosso di una nuova stagione<br />
(l’epoca di Casa prima e delle Aree), un’urgenza di emanazione<br />
il desiderio di irraggiamento spaziale che si ritrova poi nella pittura.<br />
Concepito come un’amalgama di forza immaginativa e di<br />
ispessita sensorialità, come gesto mentale e fisico, l’opera è una<br />
metafora che si incarna in figure avanzanti. Pesare, avvertiva la<br />
nota in catalogo, significa anche pensare, considerare.<br />
Ma di quale pensiero si tratta? Che significa tirar fuori figure dalla<br />
mente? Intanto ci interessa notare che il fantasma, l’immagine<br />
del dentro, declinandosi secondo i registri dell’oggettualità, vuol<br />
avere la stanza del vivente, porsi a fronte con l’esistenza. Un’esistenza<br />
che si disegna spesso come la dimensione dell’inautentico,<br />
della petrosità. Vien fuori allora in questa istanza di confronto<br />
e scontro, una ulteriore sintonia con la drammaturgia della caduta<br />
con quel teatro dell’ ”invincibile” a cui si ricollega l’eserci-
zio di riscrittura d’un dramma assai amato, La vita è sogno, da<br />
Calderon ad Hofmannsthal, sul quale si è soffermato di recente<br />
Aricò negli acquarelli. Risentimenti e trascrizioni nello specifico<br />
d’una grammatica visiva, dell’assenza di un testo. Lo “spirito del<br />
dramma”, per usare un’espressione cara ai riteatralizzatori, si trasferisce<br />
nel colore, passa dalla scena reale e dalla parola recitata<br />
alla muta superficie della pittura; così come – con scarto non<br />
solo estetico ma etico – il soffio di vita, la “verità contaminata”<br />
può riemergere nella protensione inesausta del dipingere. “Le<br />
opere – suona una preziosa dichiarazione – sono il prodotto di<br />
questa emergenza di valori contaminati. Da qui l’ossessione in<br />
cui rientra la necessità di un oggettivarsi continuo”.<br />
In bilico tra impurità e chiarezza, in aggetto per così dire sul presente,<br />
vengono issati gli elementi della pittura, le sagome d’una<br />
costruzione le cui cerniere sono ritmi e numeri, cadenze metriche.<br />
Le correzioni e gli aggiustamenti cui è sottoposta l’orditura<br />
proporzionata dell’insieme, nonché costituirsi quali tratti stilistici<br />
di quell’animazione dell’inanimato che rimette in vita gli archetipi<br />
figurali, sprigionano tensioni di avanzamento: le forze premono,<br />
stringono da presso, si impongono. È in gioco tutto il lavoro<br />
mentale sui minimi spostamenti che, operando sulle virtualità<br />
della linea e del colore, sull’energia della pittura, abbacina<br />
la visione.<br />
Perché la curva dell’arco si abbassa? Da dove viene la ritmica dei<br />
portali e dei timpani, scanditi nella progressione misurata e sacrale<br />
del passo, sulla fisica statura del corpo, se non dalla volontà<br />
di colmare varchi senza tuttavia serrarli, di creare un continuum<br />
vibratile, una ciliazione che non s’arresta? Perfino le<br />
ombre si caricano di trasalimenti e ospitano mareggiate luminose.<br />
Lontano-vicino, interno-esterno: le due polarità stanno insieme<br />
e creano una spazialità che vorrei chiamare dell’avanzante.<br />
Un avanzante di cui v’è precisa coscienza progettuale; e fantastica<br />
urgenza.<br />
“Mi ha animato (…) quel particolare stato che preferisco chiamare<br />
vecchiezza e per vecchiezza intendo qualcosa che assomiglia<br />
alla lucidità della nostra cultura europea, al cinismo della<br />
struttura filosofica del nostro sistema, eccetera “coscienza di vivere<br />
la continua trasformazione, nell’avanzamento di un passato<br />
mai remoto”. Ritorno della forza e del tempo. Si noterà come la<br />
coscienza del più antico, dell’antichissimo, dell’estrema vecchiez-<br />
448<br />
R. Aricò, Scena di Mantova, progetto 1980.<br />
R. Aricò, Scena di Mantova, progetto 1980.
R. Aricò, Timpano, 1979, acrilico su tela, cm 30x30.<br />
za faccia tutt’uno con l’illusione e il desiderio. Anzi proprio la coscienza<br />
di un passato-mai-remoto, la lucidità che viene da lontano,<br />
genera la potenza della metamorfosi. Il da-semprepresente<br />
è anche ciò che da sempre sopraggiunge e irrompe,<br />
sopravvive e torna ad accadere. La pittura, il dipingere è questo<br />
atto: l’evento dell’accadere-cadere: una riarticolazione metaforica<br />
dei gesti primi, una fitta pioggia, una tessitura. Perciò, non a<br />
caso la pittura è invocata come la “nostra Penelope”. Essa disvela<br />
l’essere che ritorna, lo contiene e lo fa apparire. È la sogliacontenitore,<br />
la stanza dell’evento.<br />
Proviene da qui un tremore quasi sacro dentro il mondano, un’atmosfera<br />
di ascolto ininterrotto nell’interrotto accadimento. La<br />
stanza che ha a che fare con un’attesa, con un presagio di miracolo.<br />
I campi, i perimetri, i profili sono una geometria della rivelazione<br />
che appare al tempo stesso vicina e lontana, finita ed infinita.<br />
Per tale motivo (e anche per questo motivo) la finzione teatrale,<br />
il circuito dello spazio scenico esercitano una forte suggestione.<br />
È in ogni caso con una simile attitudine che Aricò ha affrontato<br />
nel ’78 l’allestimento di alcuni atti unici di Tardieu, situando<br />
gli attori in un’area tesa e vibrante, in una sorta di camera mentale,<br />
in grado di accogliere i prorompimenti dell’immaginario.<br />
Funzionava da unico dispositivo una costruzione di praticabili di<br />
449<br />
fronte al pubblico, separato/fuso rispetto all’azione mediante<br />
l’uso di un esilissimo diaframma, “un velo posto obliquamente”,<br />
da una soglia dunque appena accentuata e tuttavia, proprio per<br />
questo, in grado di dischiudere, di alludere ad un al di là, di dare<br />
forma al cosmo del semiaperto. La scena: un laboratorio per<br />
l’evocazione dei deliri onirici… la piattaforma, teatrum<br />
mundi,…sospesa per aiutare, nella sua oggettività anche uno<br />
stato levitazionale, una dimensione lirica, diffusa, in un’ambientazione<br />
di toni sfumati”. Vale perciò l’indicazione dell’entità costruttiva<br />
del teatro e la metafora di quella realtà. La citazione testuale<br />
di Mannoni, dell’anno precedente, autorizza ad allargare<br />
ancor di più la rete dei riferimenti, ad ispessire la trama delle somiglianze.<br />
Se la scena e il luogo in cui “le immagini si pavoneggiano”,<br />
dove si struttura “tutta la nostra riserva di ruoli immaginari”;<br />
se essa è lo scrigno del sogno, ma di un sogno reso comunicante<br />
perché attraversato dall’ordine del linguaggio, calato<br />
nelle geometrie significanti dello sguardo, sarà allora possibile<br />
far coincidere quello spazio con l’oggettivazione non semplicemente<br />
utopica, ma visionaria di quell’altra vita, di quell’invisibile<br />
che l’artista vuol far risalire alla chiarezza. Scena I, del ’78 ed<br />
ora, qui alla Casa del Mantegna, Scena II sono in rapporto col<br />
teatro, ma nel modo in cui la pittura può condividere un progetto<br />
di vita e di idee con una pratica dello spazio che ha modi suoi<br />
propri e diversi di esprimere il tempo e il movimento.<br />
“La puerta, que da frente a espectador, està entrabierta”, semiaperta:<br />
è l’istruzione di Calderon. Così, a suo modo, la pittura:<br />
un universo del dischiuso.<br />
(1) Scritto in occasione della mostra “Mito e architettura”, Casa del<br />
Mantegna, Mantova, 1980.
Arte temporale e arte spaziale.<br />
Pittura (1)<br />
“Nel Laocoonte di Lessing, sul quale perdemmo tante giovanili<br />
meditazioni – scrive Klee nella Confessione creatrice – si<br />
fa un gran parlare di differenza tra arte temporale e arte spaziale:<br />
il che è una dotta illusione, perché anche lo spazio è<br />
una nozione temporale”. Rivendicare il flusso del tempo allo<br />
statuto della figurazione pittorica costituisce, al di là dell’altissima<br />
posizione di un autore teso a sondare, per tutta la vita,<br />
gli oscuri processi della genesi, un tema assiduo di meditazione<br />
per l’artista del Novecento. Le matrici filosofiche stanno<br />
però più lontano, nelle estetiche e poetiche tardosettecentesche<br />
e romantiche, alleate a quelle pratiche della pittura<br />
in cui venne disegnandosi l’eclissi dell’ocularità rinascimentale.<br />
Occorre insomma tornare ai grandi visionari, a Blake<br />
o a Füssli, pittori sensibilissimi, per altro, alle suggestioni<br />
della drammaturgia e vicini a quel teatro che Goethe chiamava<br />
“invisibile” (Kleist, Büchner, eccetera), sia per la temperatura<br />
dell’immagine sia per l’intolleranza verso la convenzionale<br />
boîte d’optique. In Füssli, per esempio, il tempo e lo<br />
spazio, il teatro e la pittura si condensano nello spessore di<br />
un’immagine. Una tensione innomata colma le figure di<br />
energia e i personaggi, fissati in positure impossibili, raccolgono<br />
le memorie dei gesti. L’istante rappresentato non è che<br />
l’estrema culminazione d’una sotterranea geologia emotiva, il<br />
punto d’arrivo d’una traiettoria spaziale e temporale. Pittura<br />
d’azione dunque, nata sotto il cielo dei ‘furori’ e per di più riscrittura,<br />
in certi casi, delle passioni shakespeariane.<br />
Il prospettivismo comincia a mancare proprio nel luogo che<br />
era suo: il cubo illusionistico. Ma non si tratta solo di questo.<br />
Anche lo sguardo (quello Sguardo che è solidale al Concetto)<br />
viene messo in causa e spinto a rovesciarsi nelle regioni altre<br />
del Notturno, a darsi in negativo, a tuffarsi nelle acque dell’Immaginario<br />
e delle Origini, oppure a rintracciare parentele<br />
con la musica (e l’opera lirica), con un sistema di segni che intrattiene,<br />
assai meno degli altri specifici, obblighi mimetici<br />
verso la realtà. Nella elezione di un simile modello linguistico,<br />
autogenerativo per eccellenza, anche la figurazione esperimenta<br />
partiture inedite, fa i conti col divenire, la metamorfo-<br />
450<br />
si, il movimento. L’immagine si mentalizza (“Chiudi l’occhio fisico,<br />
per vedere dapprima il tuo quadro con l’occhio dello spirito”,<br />
annota Friedrich) e obbedisce alle leggi del ritmo.<br />
Più avanti il processo all’illusionismo porta la pittura a estrofletterre<br />
i suoi protocolli, a denudarsi come finzione, maschera,<br />
sistema costruttivo. L’arte per l’arte, ossia (qui) l’arte come<br />
‘convenzione’, stile: è la via intrapresa da un Seurat, contemporanea<br />
ma affatto divergente da quella dell’espressione.<br />
Il confronto fra la pittura e il teatro avviene in entrambi i territori,<br />
per iniziativa frequente delle arti figurative specie nei<br />
primi decenni del secolo. Tuttavia un rapido sguardo d’insieme<br />
sul panorama del Novecento svela macroscopici casi di rigetto<br />
e di cancellazione del codice-pittura, mettendo così a<br />
nudo una incompatibilità di fondo da parte dei riteatralizzatori.<br />
Il sospetto con cui è considerato oggi, da molte parti, il<br />
teatro dell’immagine ne è d’altronde ereditaria dimostrazione.<br />
È infatti vero che la rinascita del teatro, quand’anche comporta<br />
l’assunzione di stilemi visuali desunti dalle arti figurative,<br />
mette in causa la stessa sopravvivenza della pittura sulla<br />
scena, in nome di un teatro che sia integralmente ‘teatrale’.<br />
Tuttavia, nelle teorizzazioni e nelle pratiche più estreme rimbalzano<br />
spesso nomi familiari alla storia delle immagini, sia<br />
pure di una storia antipittoricistica e visionaria, carica di simboli<br />
e di forza: Blake, Paolo Uccello, i bizantini o Rembrandt.<br />
È accaduto però che, nel momento stesso in cui Appia e Craig<br />
negavano la pittura a teatro, la figurazione si prendesse rivincite<br />
clamorose, trasferendosi nel circuito della scenografia<br />
e sostituendosi a essa, tanto da imporsi come protagonista<br />
sul palcoscenico: il teatro come tableau vivant, col quale si<br />
decretava il trionfo della bidimensionalità. Si pensi poi ai successi<br />
della “scuola di Parigi”, a Picasso o a Mirò, le cui pitture<br />
teatrali stanno spesso al di qua della rappresentazione,<br />
così come oggi i manufatti di Dubuffet o di Burri sopravvivono<br />
all’evento scenico.<br />
Altra cosa è invece l’assoluto cinetico e visivo degli sperimentatori<br />
sensibili alle leggi della scena astratta (da Prampolini<br />
a Moholy-Nagy a Schöffer), che nell’area della utopia<br />
craighiana hanno dato vita, per così dire, a un terzo teatro, a<br />
una scena che, situandosi al di là del teatro e della pittura, ne<br />
riassume al tempo stesso le reciproche ragioni col fare dello
spazio visivo l’attore di un dramma.<br />
Infine, se si vorrà dar conto delle relazioni intervenute fra i<br />
due universi di segni, sarà conveniente abbandonare il luogo<br />
comune d’una visualità che procede soltanto dalle arti plastiche<br />
a quella della scena. Il Novecento, se non altro, smentisce<br />
recisamente un simile pregiudizio, avendo spesso invertito<br />
il tragitto dei prestiti e delle trasformazioni, grazie alla<br />
profonda vocazione teatrale delle avanguardie e delle neoavanguardie.<br />
Non solo la pittura si è dissolta negli spazi dell’evento<br />
(happening), ma ha assunto talora gli stilemi compositivi<br />
della finzione scenica, configurandosi, per esempio in<br />
Klee e De Chirico, come teatro mentale.<br />
Araldica, superdecorazione e stile<br />
Un denominatore comune avvicina le esperienze francesi di<br />
Paul Fort, Lugné-Poe e Rouché a quelle tedesche e russe alle<br />
soglie del secolo (Reinhardt, il primo Mejerchol’d, lo stesso<br />
Stanislavskij, Djaghilev, eccetera): la venuta dei pittori a teatro.<br />
Non è qui certo il caso di procedere al resoconto dei fatti,<br />
ma di insistere sulle motivazioni di un orientamento generale<br />
che, in concomitanza con l’espansione travolgente dello Jugendstil,<br />
ma non di rado in opposizione a essa (decise in<br />
questo senso le riserve di Mejerchol’d verso il modernismo di<br />
Reinhardt), ha di mira lo smantellamento della visone naturalista.<br />
Ricorrere alla pittura, alla partizione bidimensionale<br />
della scena, significa imporre i diritti dello stile alla poetica<br />
della tranche de vie. Che poi, nelle realizzazioni effettive, gli<br />
esiti appaiono diversissimi e in numerosi casi perfino opposti,<br />
tutto ciò è dipeso dalla superiore o minore intensità con cui<br />
la presenza del simbolo ha permeato di sé il lavoro dei pittori.<br />
Si potrebbe con cautela affermare che laddove il “Saint des<br />
Saints, mais mental” di Mallarmé ha agito in profondità, l’immagine<br />
ha toccato indici altissimi di spoliazione. Tutto il contrario<br />
è invece avvenuto quando la cecità del simbolo ha dovuto<br />
cedere al bonheur dell’immagine e l’invisibile contrarsi<br />
di fronte al visibile. L’astrazione metafisica di Mallarmé si è<br />
scontrata, a un certo punto, con lo sguardo materiato di cose<br />
di Rimbaud, con la teoria delle correspondances: vogliamo<br />
dire cioè che la visione si spettacolarizza con tanto maggiore<br />
evidenza quanto più si diffonde il progetto di rinvenire degli<br />
451<br />
equivalenti della parola, dei parallelismi concreti e sensibili<br />
della scrittura. Sérusier e Bonnard collaborarono alla messa in<br />
scena di Ubu per Lugné-Poe nel 1896, ma il loro intervento<br />
si limitò alla sola esecuzione delle idee di Jarry. L’ambientazione<br />
temporale e spaziale del dramma venne affidata infatti<br />
a impersonali cartelli indicatori e a un eteroclito deposito di<br />
oggetti senza tempo, in uno spazio vuoto e invisibile (“un<br />
décor qui voudrait représenter Nulle Part...”, aveva ordinato<br />
l’autore), secondo i dettami d’una scenografia araldica che intendeva<br />
valersi delle grafie neutre e dei toni uniformi dei blasoni.<br />
Araldica come ideogramma scarnificato, ben diversa<br />
dall’arabesco cromaticamente abbagliante dei Balletti Russi.<br />
Simile al Libro, anche la pittura si fa scrigno di epifanie. Colori,<br />
linee e superfici velano e svelano, esprimono piuttosto che<br />
rappresentare. Se la pittura è finestra, ora lo è in un senso rovesciato<br />
e antialbertiano: apre verso un dentro pieno d’ombra.<br />
Quando Munch dipinge gli scenari per Gli Spettri, è il fantasmatico<br />
che domina la chiusa prigione dell’io.<br />
In tale temperie prende quota un’idea di ornato, imperativamente<br />
retto dai principi di semplificazione e di sintesi, i cui<br />
rapporti col pensiero mistico sono ormai indubitabili. A ragione<br />
si è parlato di teosofia per il Mejerchol’d del Primo Studio,<br />
così come v’è incidenza massiccia di cabalismo e di alchimia<br />
nelle propensioni araldiche di Jarry. Tranne che per Djaghilev<br />
e alcuni altri, i rimandi si possono moltiplicare all’infinito, ma<br />
quel che importa sottolineare è la congiunzione sacrale in cui<br />
l’ornato viene a situarsi, dischiudendo una semantica del divino<br />
agli esercizi del décor.<br />
Ben lungi dall’attribuire all’ornamentazione una pura funzione<br />
decorativa, anche i pittori Nabis del Théâtre d’Art e de<br />
l’Oeuvre fanno valere l’equazione col sacro, il maestoso, l’Immobile.<br />
Da qui viene anche il cloisonnisme, vale a dire l’uso<br />
di una procedura compositiva estratta da una tradizione religiosa<br />
dell’immagine: stilema tecnico, questo, largamente impiegato<br />
nelle messe in scena di Maeterlinck, sul versante sia<br />
occidentale che russo, e esteso poi alla visualizzazione di altri<br />
drammi, fino all’impiego di questo artificio tecnico, ma in<br />
clima più laico, nelle radianti composizioni di Benois e Bakst.<br />
Appartiene a Maurice Denis una precisa formulazione del<br />
tema ornamentale in senso mistico e divino: “La grande arte
che chiamiamo decorativa degli indiani, degli assiri, degli egiziani,<br />
dei greci, l’arte del medioevo, del rinascimento e le<br />
opere decisamente superiori dell’arte moderna che cosa sono<br />
– egli argomenta – se non il travestimento delle sensazioni<br />
comuni in immagini sacre, ermetiche, maestose?” Tale persuasione<br />
si annoda inoltre (secondo un rapporto che si ripresenta,<br />
ad esempio, in Mondrian) a una rigorosa indagine<br />
compositiva, a una teoria volta a secernere, nella pittura à<br />
plat dei quadri e di conseguenza anche dei fondali di scena,<br />
le forze stilistiche in gioco, l’energetismo delle linee e del colore.<br />
Lo studio della fictio è in tal modo solidale con la teleologia<br />
essenzialista, lo stile – in una parola il jeu della peinture<br />
– alla tensione evocativa della forma. Sempre in tema di<br />
style orné le dichiarazioni dei Nabis vanno in parallelo con i<br />
pensieri di Van der Velde, grande ammiratore anch’egli dell’arte<br />
orientale e studioso della linea. L’ornato si collega perciò<br />
alle filosofie della forza vitale e del soffio divino, così diffuse<br />
anche in ambito rosacrociano.<br />
Stilbühne e ornamentation pongono entrambe l’accento sulla<br />
‘codificazione’, sulle necessità dello stile. La prima si adegua<br />
alla seconda proprio per riceverne le massime garanzie di<br />
concentrazione. Si imitano, nell’uso del colore e della linea, i<br />
pittori vascolari greci e i pompeiani, i primitivi, gli artisti delle<br />
icone, Perugino, Borgognone, Puvis de Chavanne; ma al di là<br />
dei modelli iconografici, la strategia compositiva dei pittori a<br />
teatro è indirizzata al gioco degli incastri fra figura e sfondo,<br />
a legare i costumi e gli atteggiamenti degli attori con le strutture<br />
compositive del fondale. In una simile ‘bidimensionalità’<br />
l’evento spettacolare ha il compito di assecondare l’opera del<br />
pittore, poiché il quadro si anima quando gli attori prendono<br />
posto nelle caselle in attesa della composizione. Il demiurgismo<br />
degli artisti è evidente. Altissima anche la consapevolezza<br />
critica, nelle differenti pronunce teoriche e stilistiche,<br />
ora inclinanti verso le tonalità basse e indeterminate, ora<br />
volte ad accelerare il dinamismo delle superfici, mediante<br />
iperboli prospettiche e ingigantimenti. Oltre a Bakst, Benois o<br />
Variot, un altro pittore, Dethomas, braccio destro di Rouché al<br />
Théâtre des Arts, si segnala per la chiarezza teorica dell’operazione.<br />
Facendo del teatro finalmente un’arte liberata dalle ipoteche<br />
452<br />
illusionistiche, la figurazione scenica bidimensionale mise a<br />
fuoco il problema della ‘convenzione’. Si trattò però, come<br />
osservò Craig, di un flirt ‘pericoloso’ e a lungo andare conservativo.<br />
Quando De Chirico, anni più tardi, trasferirà in teatro<br />
l’impianto metafisico degli schizzi per I puritani, sconterà<br />
forse inconsapevolmente l’eccesso di fiducia nella superficie<br />
e voterà all’inerzia la straordinaria invenzione dei bozzetti.<br />
Ma se fu errore, servì certo a indicare un punto di rottura e a<br />
orientare De Chirico verso nuove soluzioni.<br />
Profezie della pittura e spazio organico<br />
Di radicale impossibilità di trasposizione (dalla superficie alla<br />
scena) conviene invece parlare a proposito dell’espressionismo.<br />
E ciò non accade tanto perché l’arte figurativa perda<br />
quota nei confronti del teatro, quanto perché proprio la pittura<br />
di espressione insegna a puntare sui ritmi vitali del colore,<br />
a passare cioè dall’immagine piatta (Bild) allo spazio (Raum)<br />
vivente, dal simulacro al corpo dell’attore. Spazialità plastica,<br />
quella dell’espressionismo, incompatibile con le nozioni di<br />
piano retinico e di perimetro, con la scansione ottica di ascendenza<br />
cartesiana.<br />
Il rapporto con la pittura segue le vie del contagio, dell’affatturamento,<br />
della traslazione di forze, del transfert. La pittura<br />
è profezia della nuova scena, luogo di seduzione e di ispirazione<br />
magica: una certa pittura naturalmente, quella solcata<br />
dal conflitto primigenio delle energie.<br />
Tintoretto, Grünewald, Leonardo, Rembrandt; poi Van Gogh,<br />
Munch, Ensor: ecco i nomi tutelari presenti nelle pagine di<br />
Sievert, Emmel, Hasenclever, Bahr o Schreyer. Scrive ad<br />
esempio Emmel: “Noi vogliamo muovere le linee e le forme<br />
corporee dall’interno, dal dramma, e non concedere loro<br />
alcun ruolo particolare al di fuori dello spartito drammatico<br />
[…]. Che esistano linee drammatiche lo vediamo in un quadro<br />
di Rembrandt, I discepoli di Emmaus, eccetera. L’archetipo<br />
è probabilmente Strindberg, con le sue letture dei pittori<br />
visionari, non solo di Munch, ma anche di Böcklin. In ogni<br />
caso, quel che Van Gogh e Munch sottolineano è la convulsione<br />
dello sguardo.<br />
La visione si acceca, cementandosi con le presenze animate<br />
che attorniano il pittore. L’atto del guardare si tramuta in flus-
so ardente di energia: energia fisica e al tempo stesso psichica.<br />
Scaturigine della luce, anzi dramma cosmogonico dell’ombra<br />
e della luce, esplosione genesica.<br />
Se tra pittura e figurazione teatrale è senz’altro possibile rintracciare<br />
tutta una serie di sintonie teoriche e stilistiche (i<br />
temi della rinascita e dell’Uno; le teorie della dissonanza cromatica<br />
e del contrasto lineare; la grafia acutangola, lo scheggiamento<br />
delle forme, la fluenzialità delle cadenze colorate,<br />
la deformazione e così via), sempre nella differenza segnata<br />
dal transfert, ciò che lega in profondità il pensiero pittorico a<br />
quello drammatico è il tema della luce, autentico centro mitico<br />
dell’espressionismo, essendo appunto il dramma un calvario<br />
dal buio alla rinascita. Qui si spiega il richiamo a Rembrandt<br />
e a Van Gogh, quali detentori dei ‘segreti’ della creazione,<br />
e perciò fatti interagire con la mistica della luce, da<br />
Ruysbroeck a Eckart a Boehme. Qui anche l’appello alle forme<br />
‘ardenti’ dei primitivi (per esempio Nolde), alle colture del<br />
fuoco e della danza. La luce, in quanto articolazione prima<br />
dell’energia, anteriore alle parole e alle immagini, scandisce<br />
il processo della creazione, non dipendendo da nessun altro<br />
principio che da se stessa. Se Rembrandt interessa, ciò avviene<br />
perché la sua luce proviene dall’interno del quadro, ne<br />
costituisce la sorgente, anziché un oggetto di rappresentazione.<br />
E ancora: la luce-forza frantuma le forme, le dissocia in un<br />
paesaggio di macerie, ma proprio per questo le riempie di<br />
vita: è il motivo della morte come crogiuolo che purifica.<br />
Mentre nella scena astratta, dove pure è centralissimo il principio<br />
luminoso, gli oggetti scompaiono, nello spazio organico<br />
la loro presenza ha il compito di testimoniare il ritorno sconvolgente-risanatore<br />
del mythos. Le combustioni e le deformazioni<br />
oggettuali costituiscono appunto la prova della iniziazione.<br />
L’assassinamento delle immagini opache a favore dei corpi di<br />
luce è in rapporto con l’animazione totale dello spazio: un’animazione<br />
affidata in primo luogo alla recitazione e al gesto<br />
dell’attore. Ed è importante osservare, a questo punto, come il<br />
contributo forse più alto dato dai pittori alla nascita della scena<br />
espressionista non avvenga nel campo della scenografia, ma<br />
in quello della parola, del dramma, vale a dire in una direzione<br />
diversa rispetto al fronte futurista, dove si registra, insieme<br />
453<br />
al lavoro della ‘sintesi’, un interesse acuto e sistematico per la<br />
visualizzazione spettacolare e per la scenotecnica; anzi la pittura<br />
stessa finisce per spezzare le coordinate della superficie,<br />
diventando polimaterica, oggettuale, cinetica.<br />
Kokoschka non scrive, come Depero o Trampolini, né una<br />
storia né una teoria della scena. Sceglie altre maniere di intervento,<br />
oltre alla pittura e all’incisione: compone drammi.<br />
Così anche Barlach. Tranne alcune mirabili sequenze di bozzetti,<br />
l’uno e l’altro scavano nella drammaturgia e redigono<br />
testi di straordinaria portata innovatrice. Segno quanto mai<br />
eloquente dell’impossibilità, per loro, di trasferire a teatro il<br />
codice del quadro. Solo più tardi, ma ormai si affacciano gli<br />
anni Venti, la scenografia tedesca vedrà una più marcata frequentazione<br />
degli artisti. Con gli allestimenti brechtiani di<br />
Grosz e le esperienze di Piscator si avvia la fase della politicizzazione:<br />
la scena come spazio del mito cede il passo alla<br />
Nuova Oggettività.<br />
In Germania, ma non in Francia. Il tragitto segnato dall’espressionismo<br />
trova in Artaud un rilancio ad alta tensione.<br />
È difatti col Teatro della crudeltà, in posizione eretica rispetto<br />
al surrealismo bretoniano, che la scena come circuito della<br />
rigenerazione e guerra dei principi torna ad ardere e, correlativamente,<br />
la pittura assume quel compito oracolare e profetico<br />
che il Teatro estatico di Emmel aveva prefigurato.<br />
Paolo Uccello, Bosch, Luca di Leyda vengono additati come gli<br />
autentici detentori dei segreti vitali e definiti registi implacabili<br />
della ‘necessità’. Il loro è “teatro muto”, carico di forza<br />
proiettiva, ermeticamente intessuto di geroglifici mortali, di<br />
un’araldica che non lascia scampo. Così anche, fra i contemporanei,<br />
Masson, Balthus, Klee, Derain. Contro la parata delle<br />
false effigi e la menzogna del teatro-spettacolo, Artaud fa valere<br />
l’urto d’una pittura magica che scava nel soffio e se ne<br />
lascia scavare.<br />
Anche per lui è impensabile trasporre la pittura sulla scena<br />
come se si trattasse di citare dei reperti figurativi, di tradurre<br />
delle iconografie, poiché i quadri, quei quadri “sono a doppio<br />
senso, e accanto a un aspetto puramente pittorico comportano<br />
un messaggio e rivelano aspetti misteriosi o terribili della<br />
natura e dello spirito”: ed è il secondo aspetto evidentemente<br />
che importa. Essendo la superficie, al pari della pagina, do-
tata di poteri paralizzanti, il quadro non può essere che talismano<br />
e annuncio; come tale, portatore muto del soffio, fatalmente<br />
diminuito rispetto al teatro e tuttavia capace di innescare<br />
il linguaggio inaudito della ”vera scena”.<br />
Nella visione metafisica e gnostica del Teatro e il suo doppio<br />
la spazializzazione del registro, nell’atto stesso di frantumare<br />
le immagini, si manifesta come esplosione luminosa, abbagliamento,<br />
bruciatura. “La luce […] assume l’aspetto di autentico<br />
linguaggio e le cose sulla scena, gravide di significati,<br />
si ordinano, rivelano figure”. Identità del gesto, del suono e<br />
della luce nella ritrovata pienezza della Creazione: quest’identità<br />
genesica e organica, proiettata verso la conquista<br />
dell’Uno perduto, la cui menzogna Artaud denuncerà nella<br />
successiva fase rodeziana, segna durante gli anni ‘metafisici’<br />
una tappa decisiva per quel pensiero dell’Origine che arriva<br />
fino ai nostri giorni.<br />
Genesi pittorica della grammatica scenica dalla “composizione”<br />
al “sistema”<br />
Riconquistare il Tutto, abbattere la barriera della civilizzazione,<br />
è anche la nota di fondo delle prime sperimentazioni<br />
astratte della scena.<br />
Da Scrjabin a Kandinskij si annuncia l’avvento dello Spirito<br />
dopo l’Apocalissi del presente. L’età nuova è vicina, un’età<br />
portatrice di linguaggio totale, fondato sul principio interiore<br />
e su una rigorosa cifra transmentale, L’Opera d’Arte Monumentale,<br />
erede del Gesamtkunstwerk wagneriano, ne costituisce<br />
il luogo di rivelazione.<br />
Fortemente connotata in senso simbolista, la ricerca di Kandinskij<br />
si avvicina in più di un punto, ma con piena indipendenza,<br />
all’utopia di Craig, non solo per gli accenti metafisici e<br />
lo slancio empatetico delle forme, ma specialmente per<br />
l’energica sottolineatura dell’a priori grammaticale della<br />
scena , di cui i due autori intendono rintracciare i fondamentali<br />
dati costitutivi, gli elementi nucleari a livello linguistico.<br />
Kandinskij riformula il problema della sintesi teatrale nel saggio<br />
Sulla composizione scenica. Dopo aver criticato Wagner<br />
per l’uso del ‘parallelismo’ fra le arti e per gli eccessi descrittivi,<br />
sottolinea come centrale la nozione di movimento: dinamizzazione<br />
multipla e intersecata di scritture diverse (gesto,<br />
454<br />
colore, suono), in cui dissonanza e consonanza coabitano a<br />
pari diritto: “Tutti e tre gli elementi – egli scrive – sostengono<br />
una parte ugualmente importante, rimangono eternamente<br />
autonomi e vengono trattati allo stesso modo, ossia subordinati<br />
al fine interiore. […] Tra i due poli, cooperazione e reazione,<br />
si colloca tutta una serie di combinazioni intermedie”.<br />
Comporre gli elementi in un’unità superiore è il compito dell’Arte:<br />
comporre nel senso di conciliare anche gli opposti, non<br />
di mettere in simmetria, in equilibrio statico; comporre vuol<br />
dire conquistare un’armonia più alta, far sì che l’Opera materializzi<br />
il Movimento cosmico, essendo la risonanza interiore<br />
l’asse attorno al quale ruota il flusso continuo delle forze in<br />
disfacimento/rinascita. Per mettere in vita una simile ‘composizione’<br />
occorrono nuovi mezzi artistici, capaci di risuonare<br />
col Tutto, di natura dunque transrazionale piuttosto che irrazionale<br />
(poiché il Tutto è ineffabile, ma non è Caos), sull’esempio<br />
del linguaggio mistico e simbolico, di cui vengono<br />
ristudiate le leggi mediante la tradizione teosofica. In seguito<br />
l’opera teorica di Kandinskij, Punto, linea, superficie, lungi<br />
dal presentarsi come una svolta razionalistica dopo gli anni<br />
del Cavaliere azzurro, costituisce un approfondimento metodologico<br />
delle premesse contenute nello Spirituale, e dunque<br />
di una ontologia linguistica di radice romantica. Se ci fu scarto<br />
dal futurismo russo, il dissenso si incentrò proprio sul divario<br />
fra psichiatricità kandinskiana e formalizzazione costruttivista,<br />
fra ‘composizione’ simbolica e sistema.<br />
Alla linea dello Spirituale, ma sulle primarie matrici della Parola,<br />
si riporta poi la proposta di Achille Ricciardi, tendente a<br />
fare del colore “la seconda anima” del dramma e l’oscura<br />
forza rivelatrice: forza per altro inconoscibile, daimon ed<br />
enigma che la grammatica non può afferrare. Forse per un difetto<br />
di teorizzazione, come è stato ipotizzato, il fossato fra<br />
composizione e sistema è qui ulteriormente approfondito.<br />
Siamo in ogni caso lontanissimi dal presenzialismo futurista,<br />
cui per tanti anni il Teatro del colore ricciardiano è stato forzatamente<br />
ricondotto.<br />
Per il tramite di Schreyer e di Klee, vale a dire attraverso un<br />
canale centrale e uno laterale dell’espressionismo, il tema<br />
dell’Opus entra nella fucina del Bauhaus. Schlemmer rilancia<br />
con tensione assoluta il progetto del Teatro totale, annodan-
do persuasioni metafisiche a una strenua ricerca linguistica.<br />
Nel suo Figurales Kabinett un’inesausta esplorazione di movimenti<br />
rifà l’immagine dell’uomo sulla scena, salda l’ombra<br />
alla luce, le due metà disperse dell’Essere, nel tentativo di risalire<br />
alle sorgenti dell’Armonia universale, secondo una pitagorica<br />
sapienza delle trasformazioni che convoca insieme il<br />
numero e il gesto. “ L’uomo cerca il Senso. Sia questo un problema<br />
faustiano, che pone a proprio fine la creazione<br />
dell’Homunkulus; sia un’istanza di personificazione, per la<br />
quale egli si è creato dèi e idoli, l’uomo cerca senza tregua il<br />
proprio simile, o la propria immagine, oppure quanto c’è di<br />
incomparabile rispetto a lui stesso. L’uomo cerca il suo riflesso,<br />
il superuomo o la forma fantastica”.<br />
Nello spazio “caleidoscopico” del teatro, Schlemmer aduna figure,<br />
posizioni, gesti d’una primigenia vita delle forme, come<br />
quell’otto rovesciato (“il segno delle braccia conserte”) che lo<br />
stesso Klee assumeva nei corsi al Bauhaus quale emblema<br />
della “fluidità allo stato puro”, del ciclo Degenerazione-Rigenerazione.<br />
In Germania, come in Russia, la grammatica della scena<br />
astratta si trova presto di fronte a un bivio: se si debbano conservare<br />
le premesse essenzialiste delle prime avanguardie o<br />
se l’astrazione radicale abbia altrove, nel funzionamento del<br />
segno piuttosto che nel rinvio allo Spirituale, i propri fondamenti.<br />
Nel 1913 erano nate intanto le lettere di un alfabeto<br />
non-figurativo, decisivo tanto per il teatro quanto per la pittura.<br />
Realizzando alcune parti dello spettacolo La vittoria sul<br />
sole, Malevič aveva posto le basi del linguaggio suprematista.<br />
“Il sipario – scriverà più tardi – rappresenta un quadrato<br />
nero, embrione di tutte le possibilità. Nel corso della sua evoluzione<br />
il quadrato acquista una forza incredibile: diventa il<br />
capostipite del cubo e del globo, le sue decomposizioni apportano<br />
una sorprendente cultura in campo pittorico”.<br />
Da quel momento in poi, nella convergenza incandescente di<br />
istanze cubiste, raggiste e futuriste, vengono dispiegandosi le<br />
invenzioni dei “planiti”, i modelli volumetrici dipinti da Malevič,<br />
che sono il tramite più interno fra la pittura da cavalletto<br />
e lo spazio dello spettacolo. Tutto un susseguirsi di ricerche,<br />
impossibili da riassumere se non a rischio di sfigurarle, prepara<br />
lo spazio ‘nudo’ senza oggetti, fino alla precipitazione<br />
455<br />
della pittura in un universo architettonico. In più v’è la fecondazione<br />
della poesia fonetica e del formalismo letterario, con<br />
Šklovskij in posizione emergente, da cui viene il concetto di<br />
meccanica formale e di struttura del testo artistico. Da questo<br />
punto di vista, la biomeccanica mejercholdiana non è che la<br />
prodigiosa fioritura in campo registico di simili premesse.<br />
Risulta decisiva la nozione di unità delle parti nel funzionamento<br />
del testo scenico, nella formulazione, ad esempio, di<br />
Efros nel suo Il teatro e la pittura durante la rivoluzione: “Il<br />
principio del teatro russo non è l’insieme ma l’unità. Come il<br />
cambiamento di attitudine di una creatura vivente produce<br />
un cambiamento coordinato di tutte le parti del corpo, un<br />
cambiamento di una qualsiasi parte dello spettacolo russo<br />
deve produrre uno spostamento di tutte le altre parti per ottenere<br />
un nuovo equilibrio vitale”.<br />
È la vittoria del ‘sistema’ sulla ‘composizione’. Introducendo<br />
una semantica della funzione, del corpo testuale, al posto del<br />
simbolo, la teoria della non-intercambiabilità determina<br />
anche uno spostamento di valore nel campo degli oggetti.<br />
Il mito negativo della macchina, con la connessa paura dell’inorganico,<br />
che nell’immaginazione apocalittica di Majakovskij<br />
aveva ispirato il tema degli oggetti in rivolta, viene ora<br />
assorbito ed espunto nel lucido funzionamento macchinico<br />
della rappresentazione. Domina la pantomima astratta, cui<br />
obbedisce non solo l’attore ma l’intero meccanismo scenico.<br />
Le analogie col futurismo italiano sono evidenti. Se in Marinetti,<br />
ad esempio, il geometrico-inorganico assume valenza<br />
duplice (energetica o orrifica, nel caso dei “fantocci”), con<br />
Balla, Depero e Prampolini l’accento cade prevalentemente<br />
sulle polarità positive, pur nella varietà delle pronunce stilistiche:<br />
ludico-combinatorie, funamboliche (i “complessi plastici”),<br />
grottesche e infine astratte. Prampolini soprattutto approda<br />
a una limpida dottrina delle funzionalità, all’idea di sistema,<br />
sulla spinta delle intuizioni giovanili dell’attore-gas e<br />
nella ripresa craighiana d’uno spettacolo integralmente luminoso.<br />
Con la scenodinamica “accanto al problema dello spazio<br />
viene posto e risolto il problema del tempo mediante il ricorso<br />
a una successione ritmica di elementi in gioco, alla loro<br />
continua trasformazione”; infatti, scrive F. Menna, “il nuovo<br />
sistema scenico, come l’oggetto tecnico moderno, si fonda
[…] su una stretta e inestricabile convergenza di funzioni separate<br />
in virtù del dinamismo della simultaneità e dell’unità<br />
dei singoli elementi costitutivi”.<br />
Press’a poco alla stessa epoca lo scontro espressione/funzione<br />
impegna Schreyer e Moholy-Nagy; poi, con la sconfitta di<br />
Schreyer, scompare l’ala più radicale dell’espressionismo al<br />
Bauhaus. Di conseguenza vengono ripudiate le componenti<br />
mitiche e la ‘zavorra letteraria’ del Teatro da camera. Se non<br />
ci fosse stata l’influenza determinante di Schlemmer, l’annientamento<br />
dell’uomo sulla scena sarebbe stato forse totale;<br />
l’attore vi rientra infatti, ma con dignità pari a quella degli<br />
oggetti, materiale fra i materiali di una cristallina spettacolarizzazione<br />
visiva. Di nuovo agisce l’aspirazione all’ordine (il<br />
Cosmo contro il Caos), non significando però quest’ordine una<br />
restaurazione della categoria cartesiana e neppure il ritorno<br />
pitagorico-craighiano dell’Armonia: il cosmo di Moholy-Nagy<br />
ha natura funzionale-combinatoria, è un meccanismo di figure,<br />
una con-figurazione appunto, com’egli lo chiama. Certo la<br />
parola ‘organismo’ riaffiora, ma nel senso di corpo retorico<br />
della scena e vita d’un testo figurale: “il Teatro della totalità<br />
– si legge nel saggio programmatico del ’25 – dovrà essere,<br />
con i suoi svariati fasci di rapporti di luce, spazio, superficie,<br />
forma, movimento, suono, uomo – con tutte le possibilità di<br />
variazione e di combinazione di tali elementi vicendevolmente<br />
– configurazione artistica: Organismo”.<br />
Il pittore-regista, “demiurgo dai mille occhi”, non solo determina<br />
la vita dell’intera struttura, ma predispone le condizioni<br />
idonee alla partecipazione del pubblico, chiamato a qualificare<br />
in senso attivo la propria presenza. Tanto demiurgismo fa<br />
ricordare Lisickij che avrebbe voluto manovrare, in una progettata<br />
edizione della Vittoria sul sole, la “machine à spectacle”<br />
da una tastiera di suoni-movimenti. Né da meno era<br />
stata la messa in scena di Balla per Feu d’artifice.<br />
È certo significativo che in anni di rinnovato furore strutturalista<br />
questi archetipi siano stati citati e persino ‘rifatti’ nell’area<br />
delle ricerche cinetico-visuali, mentre tornava tumultuosamente<br />
la febbre giacobina dell’Ottobre o l’ideologia di Gropius.<br />
Icone e fantasmi<br />
Proseguendo nell’excursus veniamo a imbatterci in una diffi-<br />
456<br />
coltà. Appena si ha a che fare con la teatralità dada-surrealista<br />
(ma anche, in parte, futurista), viene il sospetto che la nozione<br />
di codice scenico sia ben poco praticabile, se non fuorviante.<br />
Già nel primo futurismo, e non solo italiano, così pieno<br />
di germi anarcoidi e di tensioni destrutturanti, certe manifestazioni<br />
dell’avanguardia storica stentano a rientrare nella normatività<br />
d’una categoria: intendiamo riferirci alle ‘serate’, alle<br />
‘recitazioni’ di poesia, alle irruzioni degli artisti fra il pubblico. O,<br />
per dir meglio, servono allo scopo altri metri di misura, per<br />
altro caratterizzati da una terminologia in piena fluttuazione<br />
teorica, come happening, performance, body art, eccetera.<br />
Tutto ciò è in parte spiegabile col fatto che i ‘processi’ tendono<br />
a porsi al di là dell’idea stessa di codice, oltre il Simbolico, a<br />
meno che non fingano di farlo, per appoggiarsi segretamente<br />
a una rete tanto rigorosa quanto coperta di relazioni linguistiche,<br />
di cui è esemplare paradigma l’opus duchampiano.<br />
Ciò premesso, sembra eccessivo da un lato ricondurre, come<br />
è stato fatto da taluni critici anglosassoni, tutto il teatro e la<br />
scena futuristi all’idea di performance, così come non persuade<br />
d’altro canto l’intento di trovare nel teatro dada-surrealista<br />
una dottrina, in senso stretto, della scena. È ben nota<br />
del resto l’allergia bretoniana per il luogo teatrale (al quale è<br />
senz’altro preferito il testo immaginario della città), ed è sintomatico<br />
d’altronde che di “scena” si possa parlare quando le<br />
poetiche pittorico-teatrali ricorrono al concetto di astrazione.<br />
Negli altri casi converrà forzatamente parlare di teatro come<br />
drammaturgia o di cooperazione visiva alla scena. La prima<br />
grande eccezione è costituita da Schwitters. A essa farà seguito<br />
un secondo esempio, ma di opposta polarità (Picabia).<br />
Si è frequentemente affermato che Schwitters è un portatore<br />
di antiforma, un assassino di immagini, latore di un gioco<br />
nichilista e insensato. Ed è certamente vero, se si tiene conto<br />
dell’eteroclito campionario di materiali che egli comprime e<br />
affoga in strati sempre più densi; tanto più vero quando gli<br />
acidi corrosivi dell’ironia, dello humour, della beffa disperdono<br />
i significati e i valori concettuali affidati ai brandelli di parole<br />
o ai frammenti di materie. Meno credibile invece quando<br />
si osservi la sua strategia compositiva volta a erigere un<br />
edificio calibratissimo nei rapporti interni di funzione; funzioni<br />
che non sono certo più concettuali, ma materiche e plasti-
che, perfino narrative. Tutto accade come se ci si trovasse in<br />
un universo polverizzato, in un flusso informe di materie dissolte,<br />
e si provasse a far coagulare dei corpi energetici in<br />
piena trasmutazione. Corpi e non fantasmi, come per Tzara.<br />
La partenza è senz’altro costituita da un mondo di macerie e<br />
rifiuti, ma non è questo il momento della decostruzione: ché<br />
anzi, raccogliendo i frammenti dimenticati, l’artista li vuole in<br />
certo modo salvare dalla miseria, con attitudine simile a<br />
quella dell’archivista. Senonché, a differenza d’un restauratore,<br />
Schwitters ha di mira un’opera d’arte vivente, un’agglomerazione<br />
metaforica in crescita. L’atto decostruttivo interviene<br />
quando il frammento, già sfigurato nella collocazione<br />
imprevista dell’assemblage, può essere mutato di posto e<br />
addirittura strappato. L’opera può disfarsi e rinascere dalle<br />
proprie ceneri. Più che la funzione in senso meccanico, è in<br />
gioco l’idea di funzione corporea, nel rapporto binario assimilazione/taglio,<br />
suzione/rigetto. La procedura dominante è<br />
tuttavia quella di adunamento, raccolta, conglomerato: di assemblage<br />
appunto. Schwitters ha parlato di intercambiabilità<br />
dei pezzi e di astrazione, nel manifesto della Scena Merz:<br />
“L’opera scenica è un’opera d’arte astratta. […] Finora nelle<br />
rappresentazioni teatrali si distingueva tra scenografia, testo<br />
e partitura. Ogni valore veniva elaborato singolarmente e lo<br />
si poteva anche gustare singolarmente. La Scena Merz conosce<br />
solo la fusione di tutti i fattori nell’opera complessiva”.<br />
Non meno significativa, poi, la simbolica sottesa al Merzbau,<br />
col suo processo di elevazione e di discesa dal laboratorio ai<br />
piani superiori e nella cantina; e con tutta una serie di anfratti<br />
e di stazioni faustiane.<br />
Picabia ha di mira invece la confusione diretta allo spreco,<br />
alla perdita, all’abbagliamento. I legami con i futuristi o con<br />
Léger non vanno al di là di certe coincidenze tematiche e dell’uso,<br />
tutto negativo però e ironizzato, di congegni meccanici.<br />
Ossimorico fin nel titolo, l’’istantaneismo’ del balletto Relâche<br />
è una dilapidazione di energia, con quel gusto del rovesciamento<br />
del falso nel vero che si trova nella piéce dialogata Festival-Manifeste-Presbyte<br />
e nel monologo Cannibale nell’oscurità,<br />
dove un oratore della Morte, reincarnazione forse<br />
di Stirner, affronta l’io dello spettatore tentando di scavarne<br />
la compattezza e di precipitarlo in un puro flusso di traspa-<br />
457<br />
renze, di desideri senza gravità. Lo spazio per Picabia perde<br />
spessore, è esso stesso fantasma e corrente abbagliante di<br />
luce, della quale non si intravede la sorgente, perché l’origine<br />
acceca, distrugge lo sguardo. Il nesso fra bocca da fuoco e<br />
fondale di scena (i riflettori puntati), l’uso delle proiezioni, la<br />
regia stessa della danza, benché richiamino il mito della Ville<br />
lumière, sono molto di più e di diverso dalla modernistica<br />
gioia di vivere: rappresentano una visualizzazione del nomadismo,<br />
di una erranza affatto aerea e fantasmatica nelle regioni<br />
nietzscheano-stirneriane del Nulla creatore. Nonostante<br />
alcuni punti di contatto (cinetismo visivo, la “sorpresa” marinettiana,<br />
il clownismo, l’antipsicologismo, eccetera), Léger<br />
resta ben altrimenti fedele al ‘pieno’ e all’iconicità oggettuale:<br />
“la scène – egli dichiara – ne sera pas vide, car nous allons<br />
faire agir les objets”. Loda il picabiano Entr’acte, ma per ragioni<br />
simili a quelle, forse, di un Depero, in nome cioè dell’astrazione<br />
volumetrica e della scena mobile. Se esalta la policromia<br />
e il dinamismo, cardini dell’orfismo di Delaunay e di<br />
Kandinskij, lo fa partendo da una ideologia completamente<br />
diversa, tesa a reinventare la tecnologia dell’oggetto piuttosto<br />
che a svuotarne sottilmente i significati, come Duchamp,<br />
o a idealizzare le forme-colore. La messinscena Création du<br />
monde, appartiene in fondo al giro dei progetti futuristi di<br />
“nuova costruzione della vita”.<br />
Come il cubismo, anche il surrealismo a teatro va per lo più<br />
nella direzione dei costumi e del décor, sicché gli interventi<br />
sono da ritagliarsi nell’ambito della storia della scenografia,<br />
alla quale di proposito in questa sede non abbiamo fatto<br />
cenno se non per talune implicazioni interne del discorso. Da<br />
Dalì a Masson, da Ernst all’eterodosso Savinio, quasi tutti i pittori<br />
hanno allestito scenari. Non Magritte: eccezione davvero<br />
curiosa, questa, poiché l’opera sua è diventata materia di citazione<br />
a teatro fin dagli anni Trenta. E ancor più lo è oggi,<br />
assieme a quella di Duchamp e di Delvaux, nelle figurazioni<br />
del Teatro dell’immagine, sul doppio registro del concettuale<br />
e dell’onirico. Basti pensare a Bob Wilson o al Carrozzone.<br />
Sulla scia delle persuasioni di Djaghilev, di Massine o di Rolf<br />
de Maré, la pittura diventa un ingrediente centrale dello spettacolo,<br />
anzi spettacolo essa stessa, come nelle fantasie spaziali<br />
di Mirò per Jeux d’enfants; o ingenera esercizi di scrittu-
a parallela, fra movimento e immagine, fra recitazione e partitura<br />
visiva, come nella Traumbühne di Masson o di Dalì.<br />
Singolarmente densa, ancora una volta, la presenza di Picasso.<br />
Già in Parade era venuta fuori un’attitudine speciale a rivoluzionare<br />
lo spazio lasciando intatta la cubatura del palcoscenico,<br />
anzi giocandola con la ripetizione ‘dipinta’ dei media<br />
della rappresentazione: quinte, fondali, sipari. Come in pittura,<br />
così sulla scena Picasso lavora all’interno della convenzione,<br />
la cornice, ma impedendole di essere trasparente al<br />
senso, ai valori referenziali. Non ci sono ‘finzioni’, poiché ciò<br />
che la pittura produce è ‘più vero del vero’, istanza assoluta:<br />
e il pittore lavora sulla storia delle immagini come se si trattasse<br />
di alimenti con i quali nutrire la vita dello sguardo.<br />
Che il teatro, per Picasso, sia essenzialmente ‘visione’, e visione<br />
in qualche modo onnivora, lo si desume anche dalla ripetuta<br />
associazione di sguardo e boccascena. Nei suoi disegni<br />
compare spesso un occhio spalancato accanto alla parola<br />
théâtre (nel senso primo e etimologico dunque di theaomai,<br />
guardare). Dentro la cornice l’occhio gioca le sue partite, con<br />
elementi multipli e interattivi. I tempi dell’azione sono anche<br />
‘epoche’ diverse dell’immagine: così, in Parade, la scansione<br />
cubista del retroscena convive accanto all’area mitologica<br />
‘neoromantica’ del sipario, e le architetture mobili di alcuni<br />
personaggi, graniticamente complessi, si coniugano con le<br />
acrobazie e le ‘sorprese’ dei funamboli. L’età primitiva gioca<br />
con quella urbana.<br />
Dopo l’allestimento di Mercuri (1924), non abbiamo che ingrandimenti<br />
sistematici dei quadri per gli scenari. Senonché,<br />
proprio nella più avanzata stagione del Surrealismo, anzi ben<br />
oltre la diaspora del movimento, Picasso torna di colpo al teatro<br />
tramite la scrittura. Compone nel ’41 una commedia, Il<br />
desiderio preso per la coda, in cui l’iconismo pittorico viene<br />
assorbito nelle regioni della parola. Il protagonista, Gros Pied,<br />
veste i panni dello scrittore, di un narratore-cuoco intento a<br />
sfornare agli ospiti del Sordid’s Hotel i frammenti di un interminabile<br />
romanzo-salsiccia, condito di metafore culinarie,<br />
erotiche e visive. Anche i personaggi convocati provengono<br />
da una fantastica cucina dei desideri: una maya di cui tutti i<br />
maschi si innamorano, denominata la Torta, Cipolla, le Angosce<br />
Magra e Grassa, gli oggetti animati. Gros Pied-Picasso im-<br />
458<br />
bandisce, si direbbe, i materiali accumulati nell’arsenale del<br />
lavoro e della memoria, compresi quelli della pittura, ma li<br />
manipola con la tecnica della scrittura automatica, sicché la<br />
pittura è questa volta oggetto di traslazione piuttosto che<br />
procedura compositiva, un tema fra gli altri e nemmeno il più<br />
esplicito. Ciò non toglie tuttavia che la pittura viva in profondità<br />
e ritorni allusivamente sulla pagina, non solo nello sventagliamento<br />
dell’archivio tematico (i déjeuners sur l’herbe,<br />
les demoiselles d’Avignon, i topoi di Parade, eccetera), ma<br />
nell’impasto pittorico di certi passaggi verbali. Soprattutto<br />
opera a supporto dell’esercizio traspositivo, l’impeto dell’immaginazione<br />
gastronomica. La cucina, ha suggerito R. Queneau,<br />
è arte “corpuscolare”, come la pittura, una “chimica”<br />
anch’essa degli odori e dei colori.<br />
Seduzioni e ambivalenze<br />
Chiudendo qui la nota sulle avanguardie storiche, resta appena<br />
lo spazio per un cenno ad altre ambivalenze.<br />
È ben noto che il gesto, la danza e la recitazione, vale a dire<br />
alcuni dati primari del mestiere teatrale, hanno fornito, fin dal<br />
secolo scorso, spunti essenziali all’analisi dei processi attivi<br />
della visione. Grazie a essi è stato possibile dilatare l’universo<br />
dell’immagine oltre i confini dell’estetica classica e indagare<br />
le connessioni fra la vita dello sguardo e i fenomeni cinesici,<br />
psichici e comportamentali, anche in rapporto alla comunicazione;<br />
scoprire cioè la materialità dello sguardo, sottraendolo<br />
agli obblighi della contemplazione distaccata, alla<br />
presa della Bellezza e dell’Identico.<br />
Il teatro poi, configurandosi come il luogo palmare della ‘dissimulazione’,<br />
rappresentò nell’epoca stessa della tranche de<br />
vie uno stimolo alla conoscenza del principio pittorico, delle<br />
sue convenzioni e del suo diritto all’opacità rispetto all’esistente.<br />
Quando Degas abbandona la natura en plein air per trasferirsi<br />
negli interni (e gli interni sono significativamente quelli del<br />
lavoro teatrale), obbedisce alla convinzione che la pittura<br />
coincida con l’artificiale. E artificiale significa tecnica di dominio<br />
e di potenziamento, poiché l’arte è, per lui, al tempo stesso<br />
maîtrise e sovrabbondanza, eccesso: organizzazione del<br />
dispendio, convenzione e vita, inestricabilmente congiunte.
Esiste – scrive Valéry – una forma singolare di dépense: la<br />
danza, che consiste “nell’ordinare e nell’organizzare i nostri<br />
movimenti di dissipazione”.<br />
Studiare la danza vuol dire rituffare la pittura nelle tensioni<br />
più alte e restituirle un compito produttivo, anziché mortificarla<br />
nelle pratiche della ri-produzione. Dalla danza l’interesse<br />
si allarga fino a comprendere la festa popolare, il circo e<br />
le sue mitologie (mitologie della sospensione, del manque,<br />
di un mondo perduto), la vita del teatro al di qua del palcoscenico,<br />
i riti pubblici della platea, dei ridotti, della piazza. Il<br />
circo in modo speciale esercita una seduzione profonda. Non<br />
v’è infatti manifesto, o quasi, delle avanguardie che non<br />
abbia per esso un riferimento centrale. Ma qui probabilmente,<br />
come suggerisce J. Starobinskij, il teatro è mediato dal<br />
pensiero letterario, da Gautier e Baudelaire.<br />
Lo sguardo abbandona la stazione consueta anche grazie all’identificazione<br />
col clown, l’acrobata, il danzatore. Quasi tutti<br />
i riformatori della pittura si sono rifatti al topos del funambolo,<br />
o l’hanno, in qualche momento, intensamente frequentato,<br />
da Seurat a Picasso a Malevič. Se nelle opere di Matisse<br />
la linea dell’orizzonte si incurva assumendo un andamento<br />
sferico e cosmico, è certo perché vi agisce, insieme alla forza<br />
del colore, lo ‘spirito’ della danza. La consonanza è decisiva:<br />
dal primo Novecento rimbalza sui movimenti di oggi, connotando<br />
gli sviluppi ‘processuali’ della pittura e accelerando l’assimilazione<br />
del tempo allo statuto della figurazione. Le immagini<br />
fluttuanti di Rauschenberg, le forme ‘a processione’ di<br />
Pollock o le recitazioni di Oldenburg, Warhol, Klein, Beuys,<br />
sono debitrici di non poco, benché in misura diversa, nei confronti<br />
del teatro e più specificamente dell’attore.<br />
Il futurismo aveva risolutamente individuato i nodi centrali<br />
del problema nei temi della sintesi e della simultaneità: motivi<br />
non radicalmente nuovi nella storia dei rapporti fra teatro<br />
e pittura, ma rilanciati con veemenza nel crogiuolo dell’opera<br />
dell’arte totale, divenuta un punto di intreccio obbligato per<br />
tutte le ricerche sulla simultaneità. Anche gli sviluppi<br />
dell’happening e dell’environment cominciano da lì la loro<br />
avventura. La pittura ha dovuto spesso attraversare materialmente<br />
questo crocicchio, confrontarsi con altri specifici e perfino<br />
annientarsi nel loro dominio. Altre volte s’è invece tenu-<br />
459<br />
ta in disparte, rifiutando il telos della totalizzazione. Ma<br />
anche nelle zone più appartate e ascetiche s’è fatta valere, a<br />
un certo momento, la suggestione d’una sintonia improvvisa<br />
e illuminante. È il caso, ad esempio, dei bozzetti di Mondrian<br />
per L’éphémère est eternelle di Seuphor, opera nata da suggestioni<br />
futur-dadaiste, in cui l’autore olandese vide l’opportunità<br />
di esprimere la profezia della sua pittura facendola interagire<br />
dialetticamente con “l’effimero” del drammaturgo.<br />
C’è dunque tutto un versante pittorico che ha introiettato e<br />
tenuto segrete certe inclinazioni recitative e gestuali, risolvendole<br />
nel giro delle grafie e nelle impaginazioni della<br />
forma, nel riecheggiamento di un mito. Le androgine Amalassunte<br />
di Licini che altro sono se non un malizioso travestimento<br />
del lunare Pierrot?<br />
Come dimenticare i “teatrini” di Melotti e Fontana? O di Martini?<br />
Le finzioni di Clerici o le macchine teatrali di Ceroli? Le<br />
“impronte” di Scialoja e le colonne-avvenimenti di Perilli?<br />
Quinte, fondali, costumi, silhouettes compaiono enigmaticamente<br />
nelle tele di Klee, De Chirico, Savinio, accaniti lettori di<br />
Goethe e di Kleist. L’Immaginario ricorre all’arsenale del teatro,<br />
invoca il silenzio, nell’attesa forse di una esplosione più<br />
grande.<br />
(1) Il saggio è stato pubblicato in Enciclopedia del teatro del ‘900, a<br />
cura di A. Attisani, Feltrinelli, Milano 1980, pp. 468-73.
1981<br />
Da Domenico Gentile<br />
a Renzo Schirolli<br />
Modi del comporre<br />
Domenico Gentile<br />
La scena come cantiere del possibile<br />
Leonardo Mosso<br />
Chi recita?<br />
Elio Marchegiani<br />
“Campionario”<br />
Mostra di alternative<br />
Filo annodato<br />
Gianni Del Bue<br />
La forma dell’invisibile<br />
Carlo Cioni<br />
Materie e cerniere<br />
Renzo Schirolli
Modi del comporre<br />
Domenico Gentile (1)<br />
Terzo respiro pittorico, questo del salernitano Gentile: un tempo<br />
segnato come i precedenti dalle cose e dalle immagini concrete,<br />
ma con una differente accensione rispetto all’esordio (anche<br />
impressionistico) e alla successiva ripresa lombarda negli anni<br />
Sessanta: ora meno cupa e materica. Di mezzo, oltre agli effetti<br />
del silenzio, v’è la lettura della contemporaneità; l’esercizio privato<br />
dello sguardo intorno ai fatti della visione, anche di quelli<br />
lontani e assunti per ragioni di contraggenio nel lavoro riflessivo.<br />
Contrario si rivela infatti (per l’emozione) il puramente mentale,<br />
la smaterializzazione dell’oggettivo, giacché dipingere qui vuol<br />
462<br />
dire mettere insieme, confrontare e accumulare elementi sensibili:<br />
dar luogo ad una rappresentazione perfino murata, ispessita<br />
di corpi cromatici, di presenze ed esistenze. Con in più il ribadimento<br />
della procedura d’origine: la finzione della finestra, della<br />
tela e del cavalletto.<br />
L’ossessione della radice fornisce i modi del comporre. Si badi<br />
alla massiccia emergenza dei primi piani, veri e propri parapetti<br />
visivi sui quali si innesta l’ordito del quadro. Le forme colorate, ritagliate<br />
e addossate come le tessere di una scacchiera, materializzano<br />
pesi plastici e si annodano lungo cerniere figurali. Prendono<br />
corpo dentro i perimetri delle cose, ritmandosi nella ricerca<br />
delle consonanze e nei passaggi armonici di tono. Si centripeta<br />
l’aereo a vantaggio del terrestre, dell’architettonico.<br />
D. Gentile, Metà/fisico, 1980, olio su tela, cm 50x40.
Ne deriva un cuirioso rapporto con l’oggetto, che è rispettato<br />
come schema e configurazione, ma poi alterato nell’interpretazione<br />
emotiva, quasi sognata. Come dire che l’immaginazione<br />
si prende la rivincita dall’interno, ingigantendo, raddoppiando o<br />
comunque trasformando l’immagine, dopo averla estratta dall’universo<br />
visibile.<br />
Così un cono di gelato può diventare un edificio, un vaso di fiori<br />
dar luogo ad una scenografia; o un paesaggio metamorfosarsi<br />
nella articolazione di piani astratti, in una costruzione di quinte e<br />
fondali. Ed è qui che Gentile, con la mente un poco rivolta ai fantasmi<br />
dei pittori urbani (dei pop, ad esempio), può ironizzare su<br />
se stesso e citare per simpatia anche le “magie” di Carotenuto,<br />
pur dichiarandosene irrimediabilmente diverso: a lui vicino nel-<br />
D. Gentile, Notturno in quadricromia, 1981<br />
olio su tela, cm 45x35.<br />
463<br />
l’assunzione di un simulacro quotidiano, ma estraneo per la gravirà<br />
comunque data alla carne dell’esistente: metà/fisico appunto,<br />
con la barratura, e cioè soprattutto fisico.<br />
Lo scarto della penultima stagione è, come s’è detto, di accenti.<br />
Non incidendo sulla fedeltà delle figure, sui consueti luoghi<br />
del paesaggio, vi insinua piuttosto l’interrogazione della memoria<br />
e un contemplare più sospeso: l’interpellanza del sentimento<br />
intorno all’invincibile evidenza del reale.<br />
(1) Tratto dal cartoncino d’invito alla mostra tenutasi alla Galleria Rossi<br />
di Parma, maggio 1981.
La scena come cantiere del possibile<br />
Leonardo Mosso (1)<br />
Nello spazio nudo del teatro nascono e muoiono figure. È la<br />
struttura, questa fluida architettura inventata da Mosso, a sprigionarle<br />
e riassorbirle dentro di sé. Nel vuoto sta invece la chiave,<br />
la grammatica produttiva del modulo, un algoritmo di forme<br />
possibili. In se stessa è un’astrazione, benché sia uno schema attivo,<br />
una misura che scandisce ed articola. In quanto puro pensiero<br />
progettante richiama l’universo del non-ancora ed è la memoria<br />
del futuro.<br />
“Io progetto - scrive l’autore - dei sistemi strutturali semiotici che<br />
in sé non sono la forma, ma dei sistemi di generazione, di produzione<br />
e trasformazione della forma”.<br />
Concepita come lo stampo in cavo del vivente, la struttura ancora<br />
immobile, appena eretta, sta all’azione come una cifra dell’esorcismo<br />
che risana. Docile e trasparente. La sofficità le è infatti<br />
indispensabile per lasciarsi attraversare dal movimento<br />
reale e dai gesti, dal tragitto dei corpi. È un arcobaleno virtuale<br />
di forme. Contiene il presagio della nuvola e della fiamma, i<br />
grandi mitemi della spettacolarità urbana. Si direbbe una macchina,<br />
se la parola non suonasse compromessa con la fissità e<br />
con il sistema, tanto più in area costruttiva e neoplastica. Meglio<br />
considerarla un crogiuolo, un ordigno di trasformazione, incentivatore<br />
di processi: un’entità mobile, con i suoi giunti elastici e virtuali,<br />
in cui si esprime la tensione di una tèchne che vuol essere<br />
poiesis. Analisi e ricomposizione.<br />
La prima specificazione scenica, la più evidente, nasce dalla cifra<br />
evocativa, dalla disponibilità della struttura a confrontarsi col<br />
corpo. Venendo in scena si metamorfosa subito in attrezzo fisico.<br />
Sprigiona motilità e richiama, in sé e fuori di sé, l’immaginazione<br />
corporea.<br />
La vocazione al teatro è recente. Solo nel 1972, nel corso dei seminari<br />
berlinesi, le costellazioni modulari si trasmutano in machines<br />
à jouer. Ed è, il loro, un jouer a doppio senso, del gioco e<br />
della recitazione. Grazie alla complicità della pantomina ed al<br />
magistero dell’attore prendono vita dei quadri, frammenti di<br />
dramma.<br />
Il mimo è l’interrogante. Ma la configurazione modulare non è da<br />
meno: se il danzatore vi scopre la promessa di inedite partiture<br />
464<br />
coreografiche, lo può fare unicamente accettando la disciplina interna<br />
della struttura, cioè scomponendo e ritessendo il proprio repertorio<br />
espressivo secondo le misure e i ritmi della forma plastica.<br />
A sua volta anche questa si sacrifica e, azzerandosi, diventa<br />
effigie scenica e spielkorper: organismo spettacolare.<br />
Altre volte si esibisce, come in alcuni pensieri grafici o nella concretezza<br />
della volta di Palazzo Carignano, nell’autonomia della<br />
performance cinetica, ricorrendo alle attrezzerie e al sapere del<br />
teatro: alle luci e alle prospettive, ai percorsi gestuali e alle sequenze<br />
dei piani rappresentativi. Mai però si fa oggetto, elemento<br />
del décor, scenografia. Istituisce invece rapporti di integrazione<br />
con la scrittura poetica o con la musica, suggerendo<br />
partiture di relazione nel tempo e nello spazio.<br />
È sintomatico, da questo punto di vista, che Mosso prediliga le<br />
cavità di grande respiro e ancor più gli spazi aperti, i profili dei<br />
paesaggi sociali, senza quinte, fondali e macchinismi illusivi. Lavora<br />
sullo sviluppo delle forme anziché circoscrivere e bloccare<br />
dei luoghi. Fa leva sui trapassi e sulle continuità. Procedendo dal<br />
nucleare al complesso, attiva traiettorie di crescita: una crescita<br />
che lavora all’interno delle forme (così che si danno delle avventure<br />
sceniche dentro ciascuna struttura) ed al tempo stesso<br />
produce scambi con altri sistemi di segni, con la conseguenza di<br />
avviare delle peripezie di contatto, delle azioni di reciprocità.<br />
Nella speciale attitudine della “comunicazione universale”, l’accento<br />
dominante cade sulla formatività delle scritture. Non v’è<br />
altro modo, infatti, data la pronuncia del problema, per sondare<br />
i confini disciplinari e far vibrare insieme i piani multipli della testualità.<br />
Soltanto filtrando la materia dell’espressione nella cifra<br />
cristallina del numero, della regola e del caso, e discendendo all’arché,<br />
verso la matrice comune delle lingue, ridiventando,<br />
come scrive Mosso, analfabeti, è possibile scuotere l’immaginario<br />
collettivo, le sue strutture linguistiche, e farlo risalire verso la<br />
costruzione.<br />
Da qui il privilegio accordato al teatro, depositario di plurime dimensioni<br />
ritmiche e scritturali. Differenti testualità vi si incontrano,<br />
anatomizzandosi, ed esplorano, nella singolarità delle loro<br />
specifiche articolazioni, la radice comune, quel fonema che legittima<br />
poi gli isomorfismi.<br />
È allora evidente l’eco del tòpos romantico della ‘sintesi’, benchè<br />
il tema assuma qui una fisionomia del tutto nuova, in forte po-
L. Mosso, Grande struttura cinetica autogestibile e complessizzabile<br />
a giunto universale elastico, come applicazione<br />
degli studi delle strutture semiotiche,<br />
per la Technische Universität di Berlino, con la collaborazione<br />
del gruppo di lavoro del Seminario di Metodologia<br />
della Progettazione Strutturale, Berlino 1972.<br />
lemica con le tentazioni di specie essenzialistica o meccanica. È infatti sempre energicamente<br />
presente una sorta di contromovimento che garantisce la necessaria ambiguità<br />
alle configurazioni. Quando una di esse sembra sul punto di assestarsi su un<br />
ordito definitivo, ecco intervenire uno scarto d’annichilimento e di autocancellazione.<br />
Nel teatro, si intende. L’immagine, scandendosi nella temporalità scenica, si inabissa<br />
ad un tratto nello stampo vertiginoso della struttura. Si defigura. E ciò facendo<br />
evidenzia la precarietà di un’icona o di una lettera, prima di rianimarsi nel segno<br />
successivo. Piomba dentro se stessa e ne emerge diversa, attraverso un ciclo di<br />
reinvestimenti circolari.<br />
Si tratta di un’inclinazione documentabile a vari livelli retorici, sia nei tropi che nelle<br />
figure di senso. Nel balletto Egalité, ad esempio, le lettere fluiscono conflittualmente<br />
nel giro della propria organizzazione, scompaginandosi e riordinandosi lungo<br />
il passo d’una scrittura che è tesa a contraddire la ricezione linearizzata del significato.<br />
Il messaggio non è mai totalmente pronunciato. È anch’esso una virtualità da<br />
interpretare. Allo stesso modo, nel primo quadro dello stesso spettacolo, Mattmarkmortmark,<br />
il tema dell’agitazione si incrocia con quello della morte, mentre sul versante<br />
plastico, si spazializza un’entità simbolicamente multipla: un emblema del<br />
movimento e della tortura, della vita e della violenza, nel chiasmo degli opposti.<br />
465
L. Mosso, Nuvola rossa, 1975.<br />
L. Mosso, Struttura mobile a giunto elastico (1970), realizzata nell’aula del Primo<br />
Parlamento Italiano al Museo del Risorgimento di Torino, sale della Resistenza in<br />
Palazzo Carignano. Legno rosso, m 20x20x0,40.<br />
466<br />
Neppure l’architettura recitativa totale, l’insieme cioè della scena<br />
e della sala (e perfino ciò che sta fuori dall’involucro), rimangono<br />
esclusi dalla motilità innescata dalla struttura. Anzi il perimetro<br />
rappresenta per definizione, in questo genere di teatralità,<br />
una zona di scorrimento, una cerniera - diaframma sulla quale è<br />
possibile, in certe circostanze, dislocare un intervento di trasformazione.<br />
Non solo ne deriva il recupero delle parti marginali<br />
(con tutta una riqualificazione dei dati periferici, per lo più assegnati<br />
al voyeurismo, come balconate e parapetti), ma quel che<br />
più conta si mette in moto una catena di investimenti, di reazioni<br />
e di contagi. L’autore decentra, nel senso che stabilisce una pluralità<br />
di centri. Agisce sui bordi e sulle tensioni diagonali, piazzando<br />
lateralmente una configurazione o proiettando una sequenza<br />
di processi sulla volta del palcoscenico, sicchè una scrittura<br />
può germinare dove meno ci aspetteremmo di trovarla.<br />
Nulla resta estraneo all’idea del continuum. Oltre a ciò l’innesto<br />
provoca una metamorfosi, un passaggio dal chiuso all’aperto, dal<br />
contratto al fluido. Dando respiro ad un luogo, lo si trascina verso<br />
nuovi spazi semantici, che sono qui spazi della forma: soprattutto<br />
luminosità diffusa, senza bruschi e segmentati trapassi dallo<br />
scuro al chiaro.<br />
Che cosa ha rappresentato infatti, qualche anno fa, la sospensione<br />
di una struttura aerea all’esterno e poi all’interno di un teatro<br />
popolare di Milano? Se una forma è stata issata fra la fronsscenae<br />
e la platea, non è stato forse per porre in comunicazione<br />
due spazialità separate? Ed indicare, con la discrezione d’una<br />
presenza silenziosa, delle modalità linguistiche di illuminazione<br />
e di scambio? Così può capitare che una procedura compositiva<br />
si traduca in metafora, dia carne all’idea, pur restando rigorosamente<br />
nella sfera delle ‘figure’ stilistiche.<br />
Anche Schlemmer, quand’era più vicino a Moholy-Nagy che a<br />
Schreyer, operava nell’atmosfera dell’officina, reperendo gli strumenti<br />
elementari dell’azione nella prospettiva analitica. La sua<br />
era però una visione fortemente attoriale, mentre Mosso guarda<br />
alle zone di incrocio, all’integrazione e alla reciprocità con l’attore.<br />
Quell’orientamento riaffiora semmai nel lavoro collettivo, in<br />
cui ciascuno sacrifica qualcosa e mette in gioco la lingua dell’altro.<br />
Se alla fine ci si proietta nell’organico, nell’estensività del fare<br />
e nella sapienza del corpo, si tocca a ben guardare l’ultimo bersaglio<br />
di Mosso, il possibile estremo della sua tecnologia.
Consideriamo per un momento le operazioni combinatorie con<br />
cui vennero scanditi i rapporti fra la struttura, la musica e la poesia,<br />
nelle regie coreutiche o più semplicemente scenico-visive<br />
del ’78. Si va dal programmato all’aleatorio, infittendo i punti di<br />
cerniera. In più vengono ruotate le gerarchie testuali, variando la<br />
collocazione dell’icona sui nastri della voce, del suono (quello<br />
della musica elettronica, sintetizzata) e del gesto, ora al centro<br />
ora ai lati, in modo da farla rientrare o uscire alternativamente<br />
dalle soglie del proprio alfabeto. Ne risulta una tessitura totale,<br />
con una serie di passaggi qualitativi dal più al meno.<br />
È nel circuito pantomimico, soprattutto, che la struttura può vantare<br />
una compiuta astanza scenica. Il contatto col mimo crea il<br />
dramma, indipendentemente dal suo contenuto ideologico.<br />
"Dans le théatre moderne - scriveva Vera Idelson in "Cercle e<br />
Carré" - nous pouvons exploiter simultanéament les deux dynamismes…La<br />
marionette n’est pas necéssairement une poupée<br />
humaine. Dans la conception moderne la marionette n’est<br />
qu’une plastique-mécanique rytmée et harmonieuse". Il nuovo<br />
dramma, il dramma dell’incontro dell’umano col meccanico, "est<br />
à naitre". Anche qui, l’immagine, stando ai limiti quasi del-<br />
L. Mosso, Nuvola rossa ed esposizione. “Un’altra Italia nelle bandiere dei lavoratori”,<br />
al Palazzo Carignano di Torino, 1980.<br />
467<br />
l’astrazione, svolge una molteplicità di compiti, fra i quali il ruolo<br />
del personaggio antagonista o del doppio. Diventa l’ ‘idolo’<br />
aereo, la quintessenza della fluidità che sfida la danza. Ma, in<br />
altre situazioni, è poi un segnale, una cifra ritmica o un costume<br />
scenico.<br />
Nel paesaggio sociale e architettonico di Martina Franca queste<br />
qualità emergono lungo un itinerario articolato in luoghi deputati<br />
e segnalato dalle strutture. Ne vien fuori così un tracciato ludico-conoscitivo:<br />
ludico perchè la struttura fa da esca alla danza,<br />
offrendo dei pretesti di gioco e invitando la ballerina a tessere<br />
una trama narrativa, la fabula; conoscitivo perché il racconto interpella<br />
altri segni, quelli del contesto ambientale, e suggerisce<br />
la ricombinazione. Quando poi una struttura si porge come costume,<br />
non slitta affatto verso l’inessenziale. C’è sì l’arabesco, ma<br />
un arabesco dinamico. Piana o tridimensionale, “a mantello” o<br />
avvolgente, la struttura esige una serrata interpretazione da<br />
parte del corpo, il suo mobile addossamento strutturale, e nel<br />
contempo rappresenta l’ostacolo, il nodo da sciogliere in una dialettica<br />
di leggerezze.<br />
La riprova viene dalle minime configurazioni modulari dei “gio-<br />
L. Mosso, Nuvola rossa ed esposizione. “Struttura”, Palazzo Carignano di Torino,<br />
1980.
ielli”. Manovrandole si può dar vita ad un teatro microscopico, ad<br />
una scena gulliverizzata di gesti e metamorfosi; anche ad un<br />
teatro di ombre. In tal caso il gioiello funziona come magnete,<br />
una pietra magica, un talismano: custodisce delle figure che la<br />
mano rivela.<br />
Evocare: questo verbo ricorre, non a caso, nelle dichiarazioni dell’architetto<br />
e della ballerina. Ma che significa esattamente? Non<br />
è certo ad una magmatica ed oscura energia psichica che si fa<br />
riferimento. Evocare vuol dire piuttosto far appello all’ordo della<br />
forma e della luce, all’inespresso della Gestalt.<br />
Il battito ritmico della struttura convoca, se così si può dire, il respiro<br />
della lingua originaria. Compie un lavoro di rimozione, specie<br />
nei confronti dei sistemi formali costretti al silenzio o disarticolati<br />
dalla arroganza dell’Identico, del sempre-uguale. Poiché in<br />
definitiva, ciò che importa è l’elemento pneumatico, la vibrazione<br />
continua, nella gamma infinita delle sue manifestazioni, dalle<br />
‘radici’ del comunicare alle articolazioni imprevedibili delle parole,<br />
degli atti espressivi. Quel battito li riporta alla superficie, nella<br />
pienezza del tempo assembleare.<br />
Da qui il valore proiettivo degli esercizi sintetici compiuti nel laboratorio<br />
teatrale. La sua esemplarità è la metafora dell’architet-<br />
L. Mosso, “Progetto per Torino”, struttura in piazza, strutture in cielo, struttura e<br />
danza sulla città, 1979-’80.<br />
468<br />
tura vivente, della progettazione a grande scala urbana.<br />
Le profezie apocalittiche della fine sono in tal modo rintuzzate<br />
con la forza dell’utopia positiva. Il sogno serve per corrodere<br />
l’inerte e creare zone di resistenza, momenti di propulsione.<br />
Apriamo i fogli del teatro immaginario e troviamo una folla di<br />
progetti per Torino: Struttura e danza sulla città. Sono investimenti<br />
fantastici dei luoghi pubblici, di piazze, giardini e cieli piemontesi:<br />
pensieri che hanno trovato posto nelle strade e sui cornicioni,<br />
sia pure in abbozzo. Dunque non attraversiamo le regioni<br />
della rinuncia, quanto quelle dell’attesa e della prefigurazione.<br />
Questi progetti sono infatti i possibili vaticinati nella febbre disegnativa.<br />
Qualcuno di essi ha cominciato ad abitare i teatri e le sale, come<br />
la grande fiamma sospesa sul percorso multiplo del Museo della<br />
Resistenza, sopra le bandiere dell’Altra Italia. Un sogno? Lo è<br />
senza dubbio, purchè si riconosca a questo sogno uno spessore<br />
concreto, il suo farsi qui ed ora forma manifestata di un immaginario<br />
volto alla leggerezza.<br />
Questa animazione totalizzante e tuttavia sempre aperta è<br />
l’esatto contrario della messa in scena archeologica, giacché il<br />
passato ritorna, non come spoglia o documento congelato, ma<br />
L. Mosso, Inserimento di una struttura a giunto elastico in ambiente storico, Martina<br />
Franca, 1981.
L. Mosso, Struttura di scena per lo spettacolo “Struttura e danza”,<br />
esperimento di teatro urbano al ‘Teatro d’artista’ di Martina Franca, danzatrice Tiziana Tosco, 1980.<br />
469
come un’espressione viva: un materiale d’uso. Lo si constata ulteriormente<br />
nei progetti di risanamento e ristrutturazione dei<br />
centri storici, dove la "regia totale" dell’architetto riesce a far convivere,<br />
in un organismo flessibile, i segni del passato (o della subalternità)<br />
con quelli del presente.<br />
La interpretiamo come la fatica più arrischiata di Mosso. Un<br />
frammento di esistenza (un complesso di spazi) si trasforma in<br />
officina sperimentale, sia esso il museo o un isolato, il “quartiere-borgo”<br />
della città. Il Gesamtkunstwerk si rovescia così nella<br />
470<br />
L. Mosso, Sistema alfabetico<br />
seriale monografematico a<br />
modulazione verticale, 1980,<br />
tecnica mista, cm 22x22.<br />
prassi della trasformazione urbana. La scena continua ad agire<br />
sullo sfondo, con potenza divinatoria. È il “piccolo mondo” in cui<br />
si forgiano le istanze della città trasparente.<br />
(1) Scritto in occasione della mostra “Architettura e pensiero logico”, tenutasi<br />
presso la Casa del Mantegna, a Mantova, nel maggio 1981.
Chi recita?<br />
Elio Marchegiani (1)<br />
Il tempo è oggettivo, dice Marchegiani: oggettivo a differenza<br />
dello spazio, che è invece marcato dalla soggettività, dal limite,<br />
dalla prospetticità dello sguardo. Ed è figurazione del tempo senz’altro,<br />
la sua, così insistentemente cadenzata sullo scorrere degli<br />
istanti e sul rifluire del già-stato nei punti del ricominciamento,<br />
dei ritorni e dei rilanci.<br />
La messa in scena, sia dell’oggetto in sé sia dell’intero visibile<br />
della mostra, spazializza gli accadimenti, disloca forme ed immagini<br />
lungo stazioni duali, in cui giocano i doppi, le false somiglianze,<br />
il soggetto di ieri e quello di oggi, infine le identità e i<br />
loro simulacri. Niente panottico dunque, ma talora peste, conta-<br />
E. Marchegiani, Grammature di colore - supporto intonaco, 1978.<br />
471
gio e fulmini, come nelle "Veneri", nelle "Mosche" del 1969 o nel "Fiore e farfalla artificiale" di<br />
due anni dopo.<br />
Fra gli stazionamenti polari degli oggetti, fra il polo per così dire negativo e quello positivo delle<br />
immagini, preme inoltre tutto lo spessore mentale del tempo, quell’entità invisibile ed illuminante<br />
che fa appello alla visione intuitiva del dentro, la sola in grado di istituire un rapporto di<br />
solidarietà fra le differenze e di innescare perfino dei misteriosi coaguli d’amore.<br />
Ecco scandito, ad esempio, nell’ultima stanza, il dialogo muto di un oggetto naturale e di un manufatto,<br />
entrambi bianchi, ambedue salvati dalla dimenticanza e situati ai bordi opposti del tavolo:<br />
una conchiglia ed il frammento di uno stucco. Diversi e tuttavia uguali. Li accomuna il segno<br />
della spirale, il glifo della crescita. Nella misura evolutiva della forma, l’una fusionale e l’altra impressa<br />
dalla mano, avviene la condensazione immaginaria: l’artificiale precipita nell’inconsapevolezza<br />
della natura e lì trova il suo stampo, la vitale ‘corrispondenza’. Mentre lo sguardo segmenta<br />
le cose, il geroglifico del tempo li riunisce nella gessata uguaglianza di un medesimo destino.<br />
Due bianche presenze naufraghe: così si adunano le tracce, ma per farlo, occorre lo stato<br />
di "grazia", come diceva Kleist; solo la superiore leggerezza riesce ad avvicinare l’antichissimo<br />
ed il nuovo, ponendoli l’uno al di qua e l’altro al di là di uno stesso punto nel cerchio della conoscenza.<br />
Allora, come qui avviene, i relitti e le testimonianze parlano nonostante il silenzio,<br />
dentro il vuoto, oltre il loro guscio ed essere mortale, poiché appartengono alla circolarità degli<br />
E. Marchegiani, Rapito da infinito amore,<br />
più care d’ogni bene mi accolgano le Muse<br />
(Georgiche, II)<br />
472
E. Marchegiani, Sinopia XVII (<strong>Francesco</strong> <strong>Bartoli</strong>), 1981, cm 50x50. E. Marchegiani, Sinopia XVI (Gino Baratta), 1981, cm 50x50.<br />
eventi ed insieme la misurano. La continuità li riassorbe dentro<br />
di sé riconoscendovi il proprio volto.<br />
Lavorare sulle diversità e produrre somiglianze, ben sapendo che<br />
l’immagine ultima è imprendibile; anzi correre insistentemente<br />
da un luogo all’altro per catturare il filo nascosto delle ‘figure’,<br />
costituisce l’ossessiva tensione di questa morfologia: una morfologia<br />
genesica (e non genetica), una pratica del rifacimento e<br />
della maçonnerie, divaricata fra il gesto spaesante del trascrivere<br />
e la riattivazione dell’energia, fra il disseppellimento dell’interrato<br />
(che altro è la sinopia se non una scintilla nascosta,<br />
un’anima delle cose?) e la nuova nascita, La forma evidentemente<br />
non è l’energia ma solo il luogo nel quale scorre: è la finzione<br />
che rende percepibile lo scatto dell’accadimento; il suo involucro<br />
fittizio e la sua maschera. Di qui la necessità di rendere<br />
ubiquitarie le manifestazioni sensibili, facendole poi tornare su<br />
sé stesse lungo itinerari anomali, mediante l’esercizio della distorsione<br />
e del ribaltamento, del dritto anche e del rovescio insieme<br />
(Il Cristo morto). Perciò Marchegiani ricorre alla recitazione<br />
dello spazio. Lo spettacolarizza fisicamente e mentalmente,<br />
dis-centrando le attese e provocando parallelismi, suggerendo<br />
analogie nella trama discontinua degli eventi.<br />
473<br />
Percorsi laterali e rovesciati, si è detto. Ma anche verticali. In comune,<br />
gli uni e gli altri possiedono la strategia dell’aereo, promuovono<br />
cioè l’incunearsi di spazi liberi fra i termini contrari di<br />
una configurazione: spazi aperti ma fortemente centripeti, attrattivi.<br />
Quando i principi opposti (l’uovo e il punto di luce, la durezza<br />
e la sofficità, eccetera), spesso pregnanti come emblemi,<br />
fanno respirare la visione sulle cerniere dell’alto e del basso,<br />
della destra e della sinistra, lo spazio subisce una sorta di accelerazione,<br />
diventa ‘ordine cosmico’, saldando in unico blocco gli<br />
elementi lontani. Né si tratta di un pieno cristallizzato, quanto di<br />
una concentrata attesa contemplativa, in cui il dato fisico fa da<br />
supporto all’evento ideale, alla ‘mente’.<br />
Questo detentore di materie cifrate, ouvrier del silenzio, fa conto<br />
delle mappe, organizza i luoghi nella collana armonica delle<br />
stanze, ponendo al centro del perimetro, sotto il metafisico cielo<br />
mantegnesco, la più rapinosa delle installazioni. Adotta la sintassi<br />
della febbre fissata, la pura ed assoluta verticalità, vale a<br />
dire una stilistica e una topica della ascesa. Dall’alto, sul cuore<br />
della casa-atelier, pende l’uovo calcinato di Piero, il lapis della divina<br />
proporzione, col tatuaggio sferico di una scritta vaticinata<br />
nel mondo dell’Ade da Anchise-Pitagora: voce, quest’ultima,
E. Marchegiani, Sinopia II (Il Cristo morto), 1981.<br />
delle ombre intorno alla ‘mole’ del mondo in gestazione, per segnalarne<br />
la peripezia di metamorfosi e rinascita. Ma il cuore sottostante<br />
è ancora più vivo; è la luce incandescente del pensiero:<br />
lampeggia dal fondo, distillata dalla superficie della terra.<br />
Tutta una serie di simboli intesse dunque la rete del senso. Eppure<br />
questi significati non si lasciano perimetrare dalla discorsività.<br />
Più che simboli conclusi, le forme sprigionano delle traiettorie<br />
di idee, delle virtualità significative. Fanno apparire e disparire,<br />
dischiudono e mostrano il vuoto, sicché quel che parrebbe<br />
essere una trasparente pronuncia teorica, un offrirsi quasi<br />
della poetica nell’opera, alla fine non si fa più catturare. Incentiva<br />
anzi l’ambiguità.<br />
Ecco perché le immagini, simili ai crocicchi di un paesaggio accidentato,<br />
invitano a viaggiare. Né si è certi che i loro sentieri assicurino<br />
tragitti sereni, con regolari ritorni. Ogni volta, all’atto dell’attraversamento,<br />
può aggiungersi un’asperità, un caso inedito,<br />
così come può capitare una perdita, un incidente sottrattivo. Il simile<br />
sfocia nel diverso.<br />
Nella galleria dei ritratti la somiglianza conosce avventure di trasformazione.<br />
Quel volto, per esempio, non è più lui. Oppure: è<br />
lui, ma in una differente stratificazione psichica, ha tratto fuori la<br />
“sinopia” e l’ha ribaltata, l’ha fatta giocare a scacchi col ‘sottosuolo’<br />
di un altro io.<br />
Osservando tecnicamente le cose, è chiaro che il pittore mano-<br />
474<br />
vra le entrate e le uscite. Esibisce e fa esibire, è il clown agile<br />
che traghetta le anime. Guarda e si fa guardare. Ma forse neppure<br />
lui è il primo attore. Anch’egli è un portatore di energia, il<br />
sostegno di qualcos’altro. Chi agisce in realtà? Chi recita, dietro le<br />
apparenze?<br />
Lo spazio della finzione e la topografia teatrale sono chiaramente<br />
fissati secondo i principi, ancora una volta ‘trascritti’ e perciò<br />
metamorfici, del rituale cortese. C’è una corte d’anime, non servile,<br />
Servo è semmai, qualche volta, il ritrattista per sue segrete<br />
disposizioni spirituali, in certi luoghi deputati al cerimoniale d’affezione,<br />
come nella stanza della “grande chiave”, del pensiero<br />
dominante e del potere. Altrove l’autore è solo con se stesso, allestisce<br />
una ironica triangolazione con la sua presenza vivente,<br />
l’io solo spettatore, e con le funzioni attoriali attribuite alle effigi,<br />
ai propri duplici riflessi: dialoga con l’Artifex e con Hermes,<br />
con l’io tutto in luce e quello sfuggente, col grande e col piccolo,<br />
col severo e col folle. Ma anche qui vale il processo della<br />
identificazione con un altro, sia pure parziale, e del travestimento.<br />
Quasi una trasmigrazione. Trasferisce l’io e lo fa abitare in una<br />
figura immaginaria, nell’universo della cultura (la ‘seconda’<br />
corte) e dell’autoriflessione. Lo sdoppia per potenziarlo. L’analisi<br />
diventa così una procedura dell’energia.<br />
Se la morte non è morte ma un evento di traslazione, tanto più<br />
un simile movimento opera nella pittura. Sottraendosi alle metafore,<br />
anche le superfici dipinte trasmigrano: passano dalla totalità,<br />
dall’istante compiuto dell’opus, al proprio riflesso; dalla<br />
Vecchia storia del 1964 alla nuova storia, potrei dire, in figura di<br />
sinopia. Disimpietrano l’Identico osservandosi. Allo stesso modo,<br />
l’ultimo segno guarda la sua radice, quella datità che è per lui<br />
natura.<br />
Chi recita non è perciò l’effigie, ma il tempo, quel tempo della<br />
pittura che in altra ed essenziale occasione, proprio in termini di<br />
spettacolo, Marchegiani aveva restituito/ sottratto a Balla, "trascrivendo"<br />
materialmente Jeu d’artefice, cioè una scena di luce.<br />
Non a caso.<br />
(1) Scritto in occasione della mostra “Mens agitat molem”, tenutasi<br />
presso la Casa del Mantegna, Mantova, giugno-agosto 1981.
“Campionario”<br />
Mostra di alternative (1)<br />
Furono anni effervescenti, pieni di promesse di eccitazioni per<br />
l’arte italiana quelli che vanno dal declino dell’informale al Sessantotto:<br />
splendidi allora, per chi li visse alle soglie delle grandi<br />
utopie di liberazione, ma carichi in seguito di rimorsi e perfino di<br />
sensi di colpa: tanto carichi da introdurre poi lo sguardo retrospettivo<br />
a dare giudizi discriminanti, oltre che a disamorarsi o rimuovere.<br />
Se pochi finora si sono cimentati in un esame complessivo<br />
del periodo, quasi nessuno lo ha fatto ricorrendo ad uno<br />
strumento diretto di conoscenza come la mostra, con la sua concreta<br />
partitura di materiale. Ed il silenzio, più che apparire misterioso,<br />
sembra venire dal disagio o da calcolata dimenticanza.<br />
Tra le rare eccezioni sta la recente rassegna veronese di “Campionario<br />
60-68 – alternative italiane alla Pop Art e al Nouveau<br />
Réalisme”, aperta fin dall’agosto al palazzo della Gran Guardia.<br />
Curatori dell’ordinamento sono gli stessi saggisti in catalogo: un<br />
poeta e critico come Alessandro Mozzambani, che vanta una sua<br />
attiva presenza nel Sessanta (dunque un ‘testimone’) e un giovane<br />
Luigi Meneghelli, cui, per ragioni di anagrafe, è affidata la<br />
responsabilità dell’inventariamento e della lettura a distanza. Col<br />
che viene offerta in apertura, la necessaria garanzia di un’operazione<br />
dialettica giocata fra parzialità e acribìa documentaria.<br />
L’esito è non solo persuasivo ma provocatorio abbastanza per<br />
rompere i silenzi e suscitare il dibattito. Innanzitutto “campionario”<br />
svolge una sua tesi polemica, un’ipotesi che - venendo a<br />
concludere altri regesti - ribadisce l’autonomia di una ‘factura’<br />
italiana dell’immagine rispetto ad altri contesti, europei e statunitensi,<br />
con i quali viene spesso fatta collidere. Insomma un’attiva<br />
differenza, neppure riducibile al moto uniforme di una corrente.<br />
L’inchiesta, tutta condotta sulle immagini artificiali e sulla pelle<br />
dei simulacri urbani, torna a riannodare il dialogo, ora cinico, ora<br />
sottilmente ironico e crudele, ora patetico fra l’artista-mimo e le<br />
vuote superfici della falsità delle maschere e delle icone nella<br />
sfera dell’immaginario: del mito, del gioco, delle scritture. Quasi<br />
mai l’occhio si arrende all’oggetto, alla dovizia del tutto-uguale,<br />
e gli errori quando ci sono, vengono commessi per eccesso di<br />
slancio, senza le cadute che altrove si ebbero nelle cieche eufo-<br />
475<br />
rie di realismo. L’artista coglie segnali ma al tempo stesso rammemora<br />
e rifà, demolisce e rinnova, magari tuffandosi nell’oscurità<br />
dell’inconscio o nel segreto degli enigmi. Lo spaccato<br />
degli anni e delle opere si anima così di molteplici avventure individuali.<br />
In particolare vien fuori limpidamente la continuità col<br />
passato, il coagulo fra le neoavanguardie e il futurismo, dada, la<br />
metafisica. Di fronte ai reperti più prestigiosi, la temperatura si<br />
fa incandescente, sprigionando scintille di anticipazione; ed allora<br />
si pensa all’arte povera e ai fatti successivi del Sessanta. Dal<br />
canto suo il ‘testimone’ scommette sull’eredità, con ricchezza di<br />
prove dirette: inoppugnabili anche per noi, quando si tratta per<br />
esempio dei cifrari di Kounellis o di Baruchello, dei fantasmi mortali<br />
di Mauri; oppure di Pascali (splendido il suo monolito di<br />
“negra al bagno”), di Pozzati, di Schifano o della Fioroni.<br />
(1) Articolo comparso sulla Gazzetta di Mantova del 3 ottobre 1981, in<br />
occasione della mostra tenutasi presso il Palazzo della Gran Guardia a<br />
Verona.
Filo annodato<br />
Gianni Del Bue (1)<br />
Librata sulla superficie una figura si sposta, alita, ondeggia. Tante<br />
altre cercano di sfuggire alla tela lacerando i legami col quadro.<br />
Ma vi riescono solo in parte: eccole infatti affiorare altrove, più in<br />
basso o di fianco, intere, a pezzi o semivelate. Qualcosa continua<br />
a trattenerle e questo qualcosa non è soltanto la forza dello stile,<br />
il passo della ripetizione (figura dominante in Del Bue), bensì un<br />
elemento materiale, il filo stesso della tela, un filo che talvolta si<br />
strappa e più spesso aggancia, afferra e ricuce l’immagine al corpo<br />
della rappresentazione. Va a finire che la figura aggalla incerta a<br />
mezz’aria, insieme vicina e lontana, come un’esca che infinitamente<br />
rilanci il piacere dell’inseguimento.<br />
Va - vieni, scompari-ritorna, Fort! Da! Non è questo il gesto onnipotente<br />
del bambino, quel gioco del «rocchetto» che, stando allacciato<br />
alla mano, salva dalla perdita? Anche il pittore tiene un<br />
cappio e, allentandolo, inscena l’atto della scomparsa. Colma il<br />
vuoto mediante una cerimonia, con la differenza che gli oggetti<br />
non appartengono più alla camera dell’infanzia ma provengono<br />
dai campi della pittura.<br />
Egli rovescia, annoda, torce. Associa e dissocia, ricombina. Dalla<br />
storia dell’arte, viene fuori un’altra storia, un racconto. Un romanzo<br />
finito? O non si tratta piuttosto di tessere e ritessere l’impossibilità<br />
di dargli compimento? di rincorrere, senza mai raggiungerla,<br />
quella medesima figura, e di affaticarsi per tenerla velata?<br />
Se nulla si linearizza e tutto, anzi, sfugge e ritorna a potenze diverse,<br />
per ellissi e spirali, se non v’è progresso ma spostamento<br />
laterale e arretramento, dove sta veramente lo sguardo? Sul dritto<br />
o sul rovescio? Probabilmente sull’angolazione dell’uno e dell’altro,<br />
sul calcolato spigolo che separa le cose dai loro riflessi, a<br />
100 gradi, come vuole una celebre ipotesi della metafora. Che sia<br />
in questione una partita di caccia pare intanto sicuro. L’iconografia<br />
sta lì a confermarlo. Basta osservare fra gli intrichi e i cespugli di<br />
fili, anche nei minimi scomparti dell’opera, i cani lanciati su animali<br />
selvatici, gli ami, le frecce e i graffi confitti nella pasta del colore:<br />
poi le reti, gli anelli e le fionde, tanto per citare alcuni dei<br />
molteplici arnesi d’urto e di taglio.<br />
La caccia si direbbe selvatica, ma fa presto a tramutarsi in un appostamento<br />
d’altro genere e più precisamente in una battaglia<br />
476<br />
d’amore, se è vero che la lepre lascia il posto ad una dama, il cane<br />
ad un cavaliere. Intorno alle principesse di Paolo Uccello, alle Veneri,<br />
ed alle Lede, ruotano ghirlande di segni illudenti, battiti d’ala,<br />
astri e pianeti in rivoluzione. Su uno sfondo di costellazioni si convoca<br />
il tòpos del torneo, che è segnale inequivoco dei riti di affascinamento.<br />
La festa è galante, altre volte romanzesca e talora maliziosamente<br />
crudele. In ogni caso, sempre, marcata dalla finzione, da un eccesso<br />
ornamentale; troppo affollata di smalti per essere un travestimento<br />
del quotidiano. Viene il sospetto che la partita vera non<br />
sia neppure quella d’amore, pur restando centrale la tensione erotizzante<br />
degli ostacoli. Intanto osserviamo che anche la tela opera<br />
sulla strategia del rovesciamento, rientrando nella prospettiva del<br />
riflesso cui soggiace il repertorio delle apparenze. Del Bue l’ha ritagliata<br />
e di nuovo composta sul verso, per meglio lavorarne la<br />
trama. E sul rovescio risalgono anche i protagonisti, catturati per<br />
così dire allo specchio, come se di loro importasse il frangersi sul<br />
vetro della rappresentazione e non la vera, primitiva sembianza.<br />
Rispetto ai luoghi d’origine (che sono regioni dipinte e scolpite: un<br />
quadro di Carpaccio o un marmo di Canova), i draghi, i cavalieri e<br />
i corpi femminili percorrono tragitti di retrocessione. Guardano all’indietro<br />
e inviano lontano la fragilità dei profili, i tratti dimidiati<br />
fin dal principio come compete alla loro natura di effigi.<br />
Un’ulteriore caratteristica di una simile battaglia di miraggi è che<br />
la tecnica del ribaltamento colpisce infine chi dovrebbe imprigionarli.<br />
Il cacciatore appare a sua volta preso ed il legamento legato.<br />
Uno scolo di colore ingomma, per esempio, il gancio del disegno<br />
e lo incolla alla tela. Il molle inchioda l’acuminato.<br />
Le grafie di Garanza e dei Finimenti rossi al pari dei serpentinati<br />
addobbi ispirati ai turchesi e alle maschere, escono dal guardaroba<br />
dei trucchi avvolgenti. I copricapo, che molto debbono al mazzocchio,<br />
finiscono per tramutarsi in anelli e cinture. Stringono<br />
mentre arabescano e colorano un corpo. Così un nastro girato sulla<br />
caviglia svolge doppiamente, come le giarrettiere, una funzione di<br />
cattura e una di seduzione.<br />
E più la prima che la seconda. È chiaro allora che lo scontro si consuma<br />
dentro la pittura, teso a coniugare, meglio ad intersecare il<br />
momento mentale con quello fisico del dipingere. Che cosa sono<br />
ami e finimenti, cuciture e fili se non manifestazione della pratica<br />
intellettuale della figura, concettualizzazioni dello sguardo?
G. Del Bue, Senza titolo, olio su tela, cm 60x50.<br />
In breve gli artifici del disegno. E d’altra parte non si incarica il colore,<br />
da sempre, di convogliare il vibrare dell’ ‘anima’, l’impulsività<br />
dell’espressione? Senonché l’autore confonde i ruoli, precipita il<br />
puro nel greve spessore delle materie, rendendo prodigo l’ordine<br />
avaro del segno. Né alto né basso: sopravvivono unicamente<br />
brandelli di superficie e volano arpioni, simulacri disseccati, cortecce<br />
e fili. Reciprocamente in urto.<br />
Che cosa resta?<br />
Nient’altro, ci sembra, che una battaglia sospesa, potenziata dalla<br />
moltiplica degli scorci. Non il colore in sé e neppure, da solo, il progetto<br />
mentale della figura. Opera invece la doppia macchinazione<br />
degli elementi polari che si evocano a catena sul limite della sparizione.<br />
Nel tentativo di scongiurarla.<br />
Sorpresa nello spazio della nascita, l’immagine è mantenuta allo<br />
stato aurorale, in una sorta di ripetuta simbolizzazione primaria<br />
della pittura: lingua fluttuante, beninteso, cigliata ed elastica. Scopriamo<br />
la sua metafora nella Grande allegoria: una gabbia da cui<br />
477<br />
fluttuano ritagli e sagome. Frammenti come lingue tagliate.<br />
Se poi arcangeli e corpi divini impugnano spade lampeggianti alla<br />
periferia di Nuova disseminazione. non lo fanno per appiccare<br />
fuochi del giudizio. Per niente.<br />
L’apocalissi è intransitiva e endolinguistica: serve a riformulare i<br />
segni della pittura in una folla danzante di cigliazioni. Di nuovo un<br />
fulmine esplode alle spalle di Vermeer, facitore di allegorie, e subito<br />
frantuma la mappa che gli sta di fronte, sì che l’ordinato interno<br />
olandese si sfonda in curvature celesti, tiepolesche. Trauma<br />
del distacco ma esorcizzato dai festoni, questo di Del Bue. Anche<br />
San Giorgio, al quale si dedica il recente ciclo dei dipinti, dilapida<br />
una pittura che si alimenta dei propri resti. Colpisce e viene trafìtto.<br />
È il filo annodato all’anello di Olimpia. Scompari! Ritorna!<br />
(1) Scritto in occasione della mostra “Gianni Del Bue, opere 1979-1981”,<br />
tenutasi presso la Galleria d’Arte “Giancarlo Salzano”, piazza Carignano 2,<br />
Torino, dicembre 1981.
La forma dell’invisibile<br />
Carlo Cioni (1)<br />
Due termini vengono a contatto perentoriamente, da anni, nell’opera<br />
di Cioni: termini che parrebbero non solo opposti ma<br />
anche incompatibili. Da un lato sta l’ossessione della forma, con<br />
i suoi connotati ad un tempo esaltanti e mortali, ma anche griglia,<br />
carcere, simulacro e impietramento. Dall’altro v’è l’energia,<br />
il fluire della forza, il Movimento, anch’esso scandito nella duplice<br />
pronuncia dell’accrescimento e della perdita, del vivente e del<br />
riflesso.<br />
Oscillando rischiosamente tra significazioni contrarie e comunque<br />
divergenti, il segno assume sulle tavole uno statuto enigmatico.<br />
Per via di agglutinamenti e rilanci (tutta la poetica del<br />
comunicare mediante la ritmica dell’anima lo prova), si spinge a<br />
condensare una molteplicità di tensioni, l’invisibile e concreto<br />
scorrere dell’energia che il Senso non può perimetrare e che, tuttavia,<br />
ne rappresenta la sorgente, l’imprendibile arché. Accade<br />
così che, nella ricerca del legame, un’immagine non sia più immagine,<br />
ma vibrante figura mentale, e che l’Immobile, tutta la<br />
congerie degli oggetti d’una visione senza zolfo, si sciolgano<br />
riannodandosi al fluido; accade che il geometrizzato precipiti nel<br />
radiante o che un atto sovrano come lo scrivere divenga, nella<br />
strategia figurale del ‘viaggio’, una pratica della sospensione significativa:<br />
una forma dell’itinerare, piuttosto che un congegno<br />
per fissare ed esaurire. È singolare l’amore di Cioni per le scritture<br />
gerarchiche, geroglifiche, ieratiche; significativa la sua partenza<br />
dall’impietrato. Mai lo vediamo mettere tra parentesi le<br />
tecniche del dominio. Per lui il “compimento”, il ritorno della /<br />
alla forza va promosso nel presente, anticipato. L’originario, il suo<br />
‘totemico’, riguarda il futuro. Così come c’è una redenzione della<br />
storia (e della "scienza"), allo stesso modo i protocolli della potenza<br />
sono oggetto di scontro e ri-facimento. L’uomo nuovo (un<br />
leitmotiv dell’artista negli anni della poesia tecnologica) è colui<br />
che interroga con pazienza la funzione del concetto e dell’analisi;<br />
che cerca sostanze e radici nelle regioni della freddezza.<br />
Questo lavorare sulle materie dure, dalle scritture agli atlanti allegorici,<br />
su tutto ciò che ha perduto la plasticità dell’organico,<br />
viene a delineare un’avventura di traslazione: un camminare ad<br />
occhi aperti che nulla concede alla dimenticanza. Il rimembran-<br />
478<br />
te osserva il presente e staziona nei luoghi della modernità.<br />
Adotta lingue gelate per accoglierne meglio la sfida. Lo fa conoscendo<br />
bene la fatalità della maschera, la finzione dei sostituti e<br />
i rischi di spossessamento connessi alle forme della rappresentazione,<br />
rischi dai quali neppure le tradizioni misteriche più agguerrite<br />
possono considerarsi immuni. Se ricorre alle mitografie<br />
segrete, ne coglie il nostos profondo verso lo Heimat, la patria<br />
dimenticata, ma ne denuncia contemporaneamente i pericoli:<br />
l’alienazione che è perdita di coscienza. Come a dire che la loro<br />
funzione dev’essere profetica, non regressiva.<br />
Anziché separare radicalmente l’un versante dall’altro, i due<br />
‘sogni’ della scienza e della mistica, del mondano e del sacro, ne<br />
considera invece i punti di frizione, quella fascia indistinta e conflittuale<br />
dove l’interno e l’esterno misurano le proprie intermittenze:<br />
lo spazio-cerniera tra l’indicibile e la mediazione oggettivata.<br />
È una questione di ‘soglie’ e di ‘porte’, di echi e di segnali<br />
colti sul limite, come avviene ad esempio nella serie dei ritratti<br />
senza volto della Dalle cose fuori, dove l’abisso della contemplazione<br />
si apre dentro la muratura delle effigi e quella muratura<br />
viene cifrata, ‘rifatta’ nella lingua sospesa del geroglifico. La<br />
rappresentazione martellata nella fucina dell’ideogramma; e il<br />
mondano, per così dire, divinizzato.<br />
Mi sembra inoltre che lo sguardo di Cioni oltrepassi i segni e le<br />
cose nell’atto stesso di attraversarli. Ed è questa simultaneità del<br />
qui e dell’oltre, questo continuo fiorire dell’ápeiron dentro le maglie<br />
dell’apparenza che ne anima il tragitto. Sicché, con coerenza,<br />
il processo germinativo dell’opera, il suo costruirsi sull’asse<br />
della compenetrazione e degli incastri, si manifesta poi in una<br />
sequenza di enunciati discorsivi, che traducono lo scontro delle<br />
forme in una dialettica senza fine (non decapitata) della storia e<br />
del tempo. Tutta una collana di dicotomie viene convocata (magico/razionale,<br />
alogico/quantitativo, analitico/sintetico, eccetera),<br />
con effetti produttivi di chiasmo, di discesa e di risalita. Forse<br />
un concetto pregnante come quello di rinascita potrebbe essergli<br />
attribuito.<br />
Che significa l’insistenza, acutissima nell’artista toscano, sulle ragioni<br />
della modernità, quel suo pronunciarsi dalla finestra dell’esistenza?<br />
Perché tenersi dentro i margini dell’analitico e del costruttivo,<br />
rovesciandoli di segno? Come spiegare il nesso fra l’elemento<br />
progettuale dell’ipotesi e la tensione verso l’innominabi-
le e l’occulto? Tra logico e totemico?<br />
Benché tecnicizzate fino alla aridità, le grammatiche formative<br />
del moderno non vengono eluse. È vero che esse, obbedendo al<br />
demone della scomposizione, designano una caduta di valori.<br />
Ma in quanto macerie ed eclissi, venendo a testimoniare al<br />
C. Cioni, Dai semi della mente, 1980, acrilico su tela, cm 100x100.<br />
479<br />
grado più alto un’assenza, suscitano in negativo il desiderio di un<br />
altro tempo e diventano le forme in cavo dell’attesa. Se il silenzio<br />
è una delle costanti dell’opera di Cioni, soprattutto il silenzio<br />
della concentrazione, l’attimo senza misura che sta al vertice<br />
della comunicazione, occorre osservare che accanto a questo
stato ‘finale’, se ne colloca uno d’esordio: ed è il silenzio dell’inautentico<br />
ormai devitalizzato; il respiro affannoso delle lingue<br />
totalmente amministrative.<br />
Eppure, per Cioni, la caduta innesca potenzialità inedite. Le materie<br />
tecnologiche, di per sé afflitte dalla cecità, vengono assunte<br />
per modellare la luce e far da sostegno alle cifre pitagoriche.<br />
C’è una dialettica dell’opacità che si rovescia in splendore. Come<br />
ha osservato Ernst Bloch, “quando il mondo visibile sembra crollare<br />
e svuotarsi", proprio allora "le risonanze del mondo invisibile<br />
cercano di diventare immagini in esso e per esso: superfici<br />
evanescenti, crescendo di pienezza, flusso e riflusso delle cose<br />
nella selva di cristallo dell’Io”.<br />
Il che significa servirsi della dis-continuità per mettervi fine, inaugurando<br />
la condizione dell’intensivo. È quel che leggiamo in Un<br />
uomo nuovo: “Il superamento di questa fase può avvenire unicamente<br />
con la generazione di un super-linguaggio che ne rappre-<br />
C. Cioni, Scripta volant, 1963, tempera su tela, cm 120x85.<br />
480<br />
senti la sintesi”. Un super-linguaggio, aggiungiamo, che non è la<br />
summa né la biblioteca di figure separate, ma un’unica figura che<br />
tutte le oltrepassa, convocandole insieme e bruciandole. C’è infatti<br />
un moto di sfiguramento e di cancellazione che non va dimenticato.<br />
Cioni aduna i nomi delle cose, va in traccia di morfologie<br />
visive e di archetipi, ritma numeri e misure, ma è sempre<br />
lontanissimo dal produrre un archivio, poiché i numeri e i nomi,<br />
una volta issati nel campo della tela, hanno perduto il contrassegno<br />
della somiglianza. Azzerano la presunzione del simulacro.<br />
A cominciare dalle superfici, programmaticamente monocrome<br />
in certi anni, viene interpellata la potenza dell’oscuro, del buio,<br />
vale a dire il generarsi delle forme dal vuoto lasciato dai sostituti.<br />
In questo senso il quadro è una metafora genesica, qualcosa<br />
che ‘lavora’ in parallelo con le correnti della vita e le richiama. Tipica<br />
tensione del sapere intuitivo: la pittura, che pure è apparenza,<br />
è fatta rientrare nel circuito kleeiano (e goethiano) del linguaggio<br />
simbolico, dell’indagine essa stessa metamorfica che<br />
esplora la physis: pittura come immersione nella ‘natura delle<br />
cose’, isomorfismo, velo e nube del vivente; con lo scarto necessario<br />
tra fisico e mentale. Ecco perché il dipingere è una forma<br />
dell’ermeneutica, un decifrare per cifrare di nuovo, un evento filtrato<br />
in ogni caso dai protocolli geometrici della conoscenza; e, in<br />
quanto tale, delinea un itinerario, un cammino di avvicinamento<br />
(talora di lontananza) e una sequenza di stazioni.<br />
L’antiromanticismo di Cioni sta proprio qui, nella scelta del limite e<br />
anzi nel fare di esso (la forma) il luogo della ‘seconda’ creazione.<br />
Lo zero, il vuoto, il non ancora semantizzato (l’ ‘asettico’) rappresentano<br />
la condizione perché una forma ancora ardente si manifesti<br />
nella sua estrema purezza. Niente dissoluzione estatica, uscita<br />
da sé, spargimento di energia, ma addensamento e coagulo.<br />
Da qui viene la serrata configurazione della tela, che appare simile<br />
ad uno schermo o ad un oscuro boccascena percorso da<br />
lampi. Gli accadimenti sono fulmini e traiettorie, epifanie luminose,<br />
germinazioni di strutture ritmiche. Certo vi si delinea un<br />
universo di analogie, ma la densità dell’analogico finisce col far<br />
crollare la meccanica dei distinti e sprigiona qualcosa che non è<br />
il reale e neppure il suo rovescio, ma un terzo dato: una energetica<br />
della creazione.<br />
“Nella parte inferiore della scala - racconta un personaggio di<br />
Borges - vidi una sfera cangiante, di quasi intollerabile fulgore.
(...) Vidi l’Aleph. In quell’istante gigantesco, ho visto milioni di<br />
atti gradevoli o atroci; nessuno di essi mi stupì quanto il fatto che<br />
tutti occupassero lo stesso punto, senza sovrapposizione e senza<br />
trasparenza”.<br />
Questa immaginazione cabalistica ricompare sugli schermi di<br />
Cioni. Anche lì il tempo lineare svanisce, annientato dal sopravvenire<br />
di un attimo totalizzante. Ma si badi: è in gioco una azione<br />
della mente, non la natura. Come per l’autore dell’Aleph, il<br />
demiurgismo della nascita appartiene al pensiero, che con una<br />
prodigiosa abbreviazione si impadronisce di tutti i luoghi e li concentra<br />
in un punto senza estensione.<br />
Dallo zero ad un altro zero: zero attivo, s’intende; un nulla genesico.<br />
“Dal diario di un artista vissuto sul finire della seconda<br />
era dell’uomo conosciuta come periodo della corruzione (dissoluzione)<br />
iniziale o Nigredo”: questo l’incipit di un foglio. E altrove:<br />
“In fondo il tentativo consiste nello svincolare il ritmo individuale<br />
da quello cosmico per ritrovarsi presenti col nostro punto<br />
zero nello zero del mondo”. Il legame tra il grande ed il piccolo,<br />
l’unione fra i piani dell’esperienza, si pone così nei termini dell’Einfühlung,<br />
della simpatia cosmica, in un salto energetico e ritmico<br />
che mentre fa appello all’unica forza, conserva l’identità del<br />
corpo proprio. Micro e macro risuonano insieme: la grammatica<br />
è quella del contagio, dell’oscillazione simultanea, del potenziamento<br />
del soffio tramite il raddoppiamento intensivo. A ben vedere,<br />
si tratta della medesima relazione che l’opus alchemico instaura<br />
con l’universo naturale, concepito come un crogiuolo di<br />
forze. Non che l’alchimista voglia rifare il mondo. Intende costruire<br />
sé come mondo, rinnovata creazione. Perciò si chiude con<br />
la propria opera in una ferrea meccanica costruttiva, affidandosi<br />
ai suoi indici di contatto, alla dynamis vibratoria che da essa<br />
emana. In altre parole l’opera è una finzione ma una finzione efficace.<br />
Dal principio alla fine, proseguendo nella scala della purificazione,<br />
rimane perfettamente consapevole del carattere illusorio<br />
del processo. Ed è la coscienza dell’illusione, insieme alla<br />
‘densità’ del sogno, a garantirgli la riuscita. La presenza a sé, trasferita<br />
nel fare pittorico, fa sì che l’immagine acquisti spessori<br />
fortemente psichici, operazionali; che non sia solo una metafora,<br />
ma anche un processo di trasformazione, produca sigilli mentali:<br />
un mutus liber.<br />
Se la luce costituisce un tòpos dominante, è tuttavia come de-<br />
481<br />
tentore delle partiture temporali che il tema diventa significativo.<br />
Quale tempo? Intanto, come s’è visto, l’oltre del fenomeno<br />
(il lampo cairologico, l’Aleph) è un evento congiuntivo. Moltiplica<br />
i rapporti. L’altrove, l’istante che tutto contrae, non trascende<br />
il deposito delle forme, ma le invera. Opera nel qui del visibile,<br />
agganciandolo, grazie ai colpi di sonda del pittore, al “regno nascosto”.<br />
Prende vita piuttosto un diverso prodigio: l’insediarsi<br />
dell’universale nel particolare, dell’assoluto nel tempo. La violenza<br />
divorante e quantitativa di Chronos è sconfitta dall’amoroso<br />
coagulo di Mnemosine, la custode degli itinerari, colei che tesse<br />
la tela dei ricominciamenti e dei ritorni.<br />
Nella mitografia dell’artista il tempo creaturale, marcato com’è<br />
dalla scissione, è latore di malinconie saturnine. “Le porte - egli<br />
scrive - rimangono chiuse e una grande tristezza / incombe su<br />
tutta la scena”. Forse la creazione stessa è sbagliata: la beffa di<br />
un Arconte malvagio o un gioco di specchi del pensiero: “la porta<br />
C. Cioni, Dalle cose fuori, 1981, tecnica mista, cm 48x33.
C. Cioni, Dalle cose fuori, 1980, tecnica mista, cm 45x32.<br />
482
sempre chiusa / senza cardini e senza serrature. / Sigillata: essa<br />
è una / porta finta”. Come può la limpida forma, la teatrale e<br />
specchiante rappresentazione, sopportare la crudeltà di un dio<br />
insensato? Lo specchio non fa che rimandare, moltiplicandoli, i<br />
frammenti, accrescendo lo strazio della perdita. Anche le opere<br />
sembrano impotenti di fronte all’assalto del tempo; inutile l’itinerario<br />
testimoniato dai “fogli, con i tuoi / poveri segni”.<br />
Per invertire il tragitto del tempo, la pittura dovrà percorrere sentieri<br />
laterali, praticare a sua volta la menzogna, battere l’Altro<br />
con la potenza del “vero sogno”. E ci riuscirà facendo irrompere<br />
l’enigma, la tensione dell’ambiguità nelle strutture della contraddizione:<br />
il tutto pieno del simbolo nei frammentati paesaggi<br />
dell’analitico.<br />
Cioni è talvolta approdato al récit, al racconto visivo del “suo”<br />
viaggio. Ci ha dato delle fabulae e delle scene, anche una dram-<br />
C. Cioni, Albero, 1975, acrilico su tela, cm 150x100.<br />
483<br />
matica dell’ombra e della luce, montando un teatro essenziale,<br />
fatto di emergenze smaterializzate e di scale ritmiche. Un dato,<br />
questo, che testimonia fra tanti altri la continua riflessione intorno<br />
al tema della generatività: dalle avventure del linguaggio dei<br />
primi anni Sessanta alle rifrazioni temporali, fino alle ironie di<br />
certe trame ultime dei semi e modelli cosmici; voglio dire che lo<br />
documenta l’intera successione dei cicli plastici e disegnativi. Va<br />
però aggiunto che la temporalità, quella ossimorica e circolare<br />
che gli è propria, agisce fin nel sottosuolo dell’immagine, nei<br />
punti più riposti del meccanismo formativo delle grafie e delle<br />
icone, di cui rappresenta il traliccio portante. Ne sorprendiamo la<br />
presenza già nelle cellule pittoriche. Poi da nocciolo si dilata a<br />
macrosegno, a mitologema perfino frontale, e al campo intero<br />
della superficie.<br />
Questa struttura profonda è dotata di prospetticità: ambigua<br />
però e ubiquitaria. Due immagini in una, o l’uno con i suoi doppi.<br />
Il più e il meno nello stesso percorso. Anche nelle configurazioni<br />
più racchiuse e centripete, le tracce luminose disegnano flussi<br />
di andata e ritorno, con-fondono l’identico. Il loro dèmone formale<br />
è il labirinto. Lavora sui rovesci, separa ed unisce. E tanto<br />
più attivo è il suo dinamismo quanto maggiormente impatta<br />
nella centralità dei luoghi, come mostra il frangersi e rinascere<br />
dei corpi lineari nelle tempere ed acrilici del ’75-’76; o l’affrontarsi<br />
di una parte col proprio volto rovesciato nelle zone opposte<br />
di un quadro: sugli spartiti laterali, sul sopra e sul sotto di un orizzonte<br />
arbitrario, all’interno e all’esterno di un perimetro.<br />
Se la spirale abita in una sfera, è certo per incentivare il principio<br />
dedalico che un cerchio viene spezzato, un poligono contraddetto<br />
o una immagine spartita da una energica cesura luminosa.<br />
Il coefficiente di smarrimento che un segno in trasformazione<br />
convoglia dentro lo spazio, con l’andare e tornare dal centro<br />
all’esterno, tocca l’intimità stessa del simbolo. Ogni punto, ogni<br />
pulsazione è difatti un labirinto in miniatura. E poiché un<br />
tema cresce dentro l’altro, tutti i germi nati da questo elemento<br />
nucleare, una larga costellazione di motivi finisce per ruotarvi attorno:<br />
la voluta, la chiocciola, la caverna ed infine il mandala, per<br />
citarne solo alcuni cardinali. È evidente allora che la ‘simultaneità’<br />
dello sguardo di Cioni si riferisce alle proprietà agglutinanti<br />
della forma, che determina anche qui una ‘storia infinita’ di analogie,<br />
per aggiunte, accrescimenti e incontri di doppi.
Quel che importa sottolineare, in ogni caso, è il tremore dell’ubiquità<br />
nel cuore dell’uno.<br />
Nelle ultime tele, al posto dei neri e dei blu senza fondo, iniziano<br />
a scandirsi sottili grammature di colore, alternanze scalari di<br />
azzurri, di grigi e di chiari, trasparenze e velature quasi fantasmatiche.<br />
Si ha l’impressione che dei corpi provengano dall’indistinto,<br />
come se l’occhio li percepisse dal di fuori, da un mondo<br />
non ancora nato e cercasse una scorza visibile con cui rivestirli.<br />
Forse il dialogo con l’altrove si è fatto più intenso; e più struggente<br />
il rapporto col tempo. Vi leggiamo delle storie cosmogoniche<br />
di incontri. Attrazioni regali di soli e di lune. Nozze mistiche.<br />
Ma la fantasia grafematica, questa ‘vera’ alchimia, è l’autentica<br />
protagonista. Che cosa articolano i miti, i corpi astrali del<br />
Maschile e del Femminile, se non i meandri del pensiero, il suo<br />
pulsare per grandi volute? Non per nulla tornano a ribadire le vie<br />
della scrittura, i sistemi vertiginosi, come li ha chiamati una volta<br />
Sergio Salvi, delle lettere e degli alfabeti. Nascono, non a caso,<br />
dai “semi” della mente. E seme letteralmente vuol dire indizio,<br />
traccia, cifra e prodigio. Dunque sono i sigilli della conoscenza, la<br />
sua incontenibile produzione simbolica e formale.<br />
484<br />
C. Cioni, Dalle cose fuori, 1979, tecnica mista, cm 48x33<br />
(particolare).<br />
Una strategia del compimento? Stando nella zona dell’intermittenza,<br />
la forma che puntualmente svolge il ruolo della mediazione,<br />
si carica di desideri androgini. “Sono figlio di terra / e di<br />
cielo stellante”. Ma il mito nasconde un itinerario negativo, la ripresa<br />
del processo, l’umbratile consistenza di una pittura ormai<br />
sospesa fra il reale e i possibili. Anticipa un’altra tappa del viaggio<br />
e un traguardo irraggiungibile, se non come tensione estrema<br />
e contagio.<br />
Un corpo puro anche la tela, un tutto perimetrato. Nuova lingua<br />
che arresta il tempo, ai confini della fluidità.<br />
(1) Articolo comparso su “Arte Centro”, Milano, luglio 1981.
Materie e cerniere<br />
Renzo Schirolli (1)<br />
Nel giro di quattro anni, dal ’56 al ’59 (e in parte nel ’60), si<br />
avvia e conclude il primo tempo di questa pittura: primo tempo<br />
e non semplicemente esordio (tantomeno preistoria). I preliminari,<br />
se mai, vanno cercati altrove, nel triennio precedente, all’epoca<br />
degli esercizi inaugurali intorno al neonaturalismo lombardo<br />
ed emiliano.<br />
Ora, proprio nel ’56, il pittore si trova ad operare su un limite. È<br />
l’idea stessa di natura ad essere posta in questione: un’idea che<br />
egli interroga ancora come dato emozionale e sensitivo, per<br />
spingerla, poi, a tradursi in qualcosa d’altro, in un evento che la<br />
fa precipitare dentro se stessa, più a fondo, mentre va trasformandola.<br />
Lo sguardo viene allenato a discendere e quasi accecarsi<br />
dentro le cose. Lì scopre relazioni e ritmi, soprattutto scansioni,<br />
senza-nome, che dissolvono definitivamente la naturalità<br />
come dimensione riconoscibile.<br />
L’attenzione per le grafie, con certe attitudini alle congestioni lineari,<br />
ritmate e pulsanti, talora incise nella pasta dei quadri, va<br />
in parallelo con la volontà di defigurare; di trovare cioè grumosità<br />
sotterranee, dei noccioli oscuri di natura gestante, anonima,<br />
anche cosmica, che solo il sentimento ritmico può aiutare a cogliere.<br />
Il che spiega, in taluni momenti, il riecheggiamento di tonalità<br />
ed accenti di area veneta, da Afro ad esempio. Ma è breve<br />
citazione, più che altro un orientarsi nei primi passi dell’indagine.<br />
Il riferimento essenziale resta sempre, come identità da oltrepassare<br />
e bruciare attraverso gli scarti, la carne lombarda di<br />
Morlotti, alla quale l’autore discendeva per tragitti diagonali, spiralici<br />
e vegetali.<br />
Ed è allora che Schirolli mette a punto un suo impatto frontale,<br />
meno febbrilmente organico e più minerale. Non conta più la<br />
curva molle, fibrillare, della terra, bensì la polvere, il terriccio, il<br />
muro, la crosta, il suolo, la crepa. Da lì, seguendo la catena delle<br />
analogie e delle somiglianze, viene lo sfogliarsi di evidenze<br />
aride e porose, come carte, intonaci, carboni, ruggini, concrezioni<br />
per così dire fossili nelle fibre degli oggetti. Calando nel basso<br />
la visione si dilata, potenzia la minima apparizione, ingrandisce<br />
un intrico o una cellula. Eleva il particolare ad universo.<br />
Così la natura si metamorfosa in materia e, a sua volta, quest’ul-<br />
485<br />
tima (con un rovesciamento davvero decisivo) in natura più vera,<br />
essenziale. Materia è natura, suona il titolo di una tela, volendo<br />
significare che è vita, energia ed origine; e che lo è proprio nel<br />
suo nucleo più indifferenziato, non nominabile, cieco.<br />
Un simile sentimento dell’ ‘inizio’, questo presagio di vita nascosta<br />
ed aurorale che preme dal fondo, che indistintamente alita e<br />
resta imprendibile; che si fa sentire ma non esplode, rappresenta<br />
una potenza del buio che il dipingere tenta di penetrare per<br />
mettervi luce e di portare in superficie. Si direbbe un cercare rivelazioni<br />
per manifestarle, un premere dall’interno all’esterno.<br />
Quanto abbia pesato in quel frangente l’esempio di Bendini, frequentato<br />
allora a Bologna, appare tanto più risolutivo se considerato<br />
da questa angolazione. Diversa è fuor di dubbio la temperatura<br />
morale del ‘maestro’. Singolare ed irripetibile l’inquietudine<br />
conoscitiva dell’artista più anziano, quel suo cercare echi<br />
di un fantasma indecifrato nel mondo della dispersione ed arrestarsi<br />
sulle “porte” e “lapidi” del sensibile; e sospendere l’inchiesta<br />
nella turbata coscienza degli incompimenti. Ma in comune<br />
v’è l’itinerario che parte dall’oscuro, l’interpellanza sulla ‘figura’<br />
custodita in uno scrigno lontano.<br />
La strategia di Bendini, “l’accanita estroversione” di un’effigie, dal<br />
dentro al fuori, passa in Schirolli, lo contagia, assumendo calibri<br />
percettivi, in certo modo tattili, nel fiottare concreto di forme ed<br />
elementi. Se Burri, altra presenza capitale nel ’57 - ’58, specie<br />
R. Schirolli, Per favore, l’uscita?, 1964, olio su tela, cm 170x200.
per i “legni”, insegna l’arte del coagulo, strappa, addossa e condensa,<br />
Bendini dal canto suo assottiglia e sfrangia, apre le cuciture.<br />
Insinua soffi nella geologia delle croste.<br />
L’umido in Schirolli presto s’inaridisce, lascia posto al secco e in<br />
seguito all’aereo: potrei riassumere così schematicamente la trasmutazione<br />
delle forme nelle regioni dell’immaginario, aggiungendo<br />
però che il trapasso di regime convoglia una diramata avventura<br />
cromatica, uno sviluppo lenticolare verso l’ombra, mediante<br />
minime, impercettibili differenze. Le terre ancor molli e<br />
vegetanti, i verdi e i bruni si incarboniscono e perdono intumescenza<br />
fino a trasferirsi in pellicole. Tramate, quasi fossero scisti<br />
e filtri, le superfici tradiscono alla lunga un desiderio di traspa-<br />
R. Schirolli, Paesaggio n. 1, 1974, olio su tela, cm 190x250.<br />
486<br />
renza e di velature.<br />
Si osservino gli impasti e si vedrà che i colori più fervidi, i gialli<br />
e i rossi, anziché perdersi e scomparire, vengono invece precipitati<br />
nell’oscuro, fatti lavorare dentro e sotto gli accumuli. Segno<br />
che il nero non è nero assoluto, ma innerimento e calcinazione.<br />
Un temporaneo annientamento: gestazione profonda ed interrata<br />
perfino dei bianchi.<br />
Quando si aprono crateri e ferite, non è un lago di rosso a sedimentare<br />
(il vivo fuoco e sangue di Burri), quanto una faglia accidentata<br />
e una riverberazione di riflessi. Uno sfrangiarsi di spigoli<br />
abbrunati, di tessere lucide ed opache, di spugne e garze.<br />
I riflessi delineano cadenze, sprigionano ordini e misure. La ma-
R. Schirolli, Atmosferico, 1975, olio su tela, cm 100x100.<br />
487
teria è soggetto e oggetto insieme, presenza a sé e forma. Stando<br />
nel cuore del ‘motivo’ il pittore alterna i registri d’ascolto: allenta<br />
e tira, si abbandona all’improvvisazione e la riprende, ordina<br />
il caso. Si mantiene docile all’imprevedibile: ed è la sua<br />
sperimentalità. Accumula accidenti, vi si aggancia e li riassesta.<br />
Come?<br />
Non direi soltanto in virtù dello sguardo. C’è in Schirolli un vedere<br />
quasi tattile che lo porta a sfiorare, ad accarezzare le materie.<br />
L’occhio si allea alla mano, non solo per ragioni di prossimità,<br />
ma per esigenza di vibrazione. Quel che appare immediatamente<br />
(ed è anche) “piacere della pittura” deriva da una speciale<br />
modalità di orientamento, da un guardare per toccamenti<br />
e passi leggeri, facendo conto delle pressioni, delle direzioni di<br />
stesura e degli spogliamenti. Tuttavia resta pur sempre un vedere,<br />
poiché il tatto riposa infine nello sguardo e cerca prove<br />
nella figura.<br />
Ecco perché assume valore esemplare la pratica del disegno e<br />
R. Schirolli, Gotic Phought, 1972, olio su legno telato, cm 202x90x110.<br />
488<br />
dell’acquaforte, accanto all’esercizio sulla tela, in stringente relazione<br />
di scambio con gli oli e le tempere. Già la tecnica è di per<br />
sé rivelatrice. Più che incidere, Schirolli preme, valuta assorbenze,<br />
cerca impronte, verifica contatti. Si serve di carte dure e le<br />
piega, usa stracci, garze, legni, colle; fa correre acidi, acque ed<br />
inchiostri. Tratteggia, sfuma, lievita.<br />
In un quadro del ’57 (Sul fondo oscuro) grume terrose e croste,<br />
rossi, marroni e bruni, s’incarcerano e fermentano cagliandosi gli<br />
uni dentro gli altri, in un focolaio di germi polverizzati, al pari di<br />
altre condensazioni nelle acqueforti. Si configurano campi, simili<br />
talvolta a schermi e fosse, che se richiamano per analogia ‘territori’<br />
bendiniani (come nella struttura a cornice mandalica di un<br />
Senza titolo dello stesso anno) prefigurano anche certi fondali<br />
oscurissimi del ’58.<br />
Sempre più l’attenzione si concentra verso le zone di confine, gli<br />
orli, i crinali di smarginamento e sovrimpressione. Poiché in questi<br />
luoghi, nei punti di scorrimento e d’urto, Schirolli misura i presagi<br />
della forma. Dove una pelle s’accartoccia e freme contro un’altra,<br />
s’insinua fertile l’ambiguità, scocca una promessa iconica.<br />
Inoltre, per quanto rugoso ed opaco, un confine non blocca mai<br />
la mobilità dei percorsi. La cerniera designa un attraversamento<br />
e fa balenare dei corpi sottostanti. È viluppo di pieghe e velo accartocciato.<br />
Di più: segnala stazioni e rilanci. Collega ed avvicina<br />
anziché separare. È insomma uno stilema congiuntivo. Lega nonostante<br />
le strozzature.<br />
Lo si vede, ad esempio, in Immagine e rosa o nello splendido<br />
collage Polimaterico, tutto cadenzato in orizzontale, del ’58. E<br />
non solo lì. Quand’anche le carte, l’amalgama coi supporti, le<br />
paste ed i veli siano addossati, perfino bruciati e fusi dalla fiamma,<br />
ne viene sempre una spazialità traforata e vibratile, una topografia<br />
a gruviera.<br />
Ci si muove nel buio, eppure la tenebra non è mai totalmente<br />
ostile. Benché minimi, sussistono indizi di abitabilità. Tant’è vero<br />
che rinascono gli orizzonti; meglio: si dà una messa in scena del<br />
‘fondo’, scandito nella partitura delle quinte e nel montaggio di<br />
cortine, appoggi e fondali. Screens del buio ripartiscono Immagine<br />
(’58) e tutta la serie dei quadri del medesimo ciclo.<br />
Inutile dire l’eredità guidiana in queste scritture sotterrate di<br />
“marine” e cieli; così appare anche evidente dove s’è rivolta<br />
l’opzione dell’artista nel contrastato panorama dell’informale.
R. Schirolli, Pittura, 1974, olio su tela, cm 170x170.<br />
Certo lontano dagli scheggiamenti e gorghi espressionistici. Vale<br />
invece la ricerca contraria, tesa a cavare misure dalle derive del<br />
vitale; e a confrontare, anche, cifre auree e neoplastiche con la<br />
perdita del centro.<br />
Per due anni almeno Schirolli resta agli inferi, distillando grafie,<br />
contorni, flussi. Vede con le mani, ma presagisce geometrie aeree.<br />
Se stampa (in alcune delle Trentatré acqueforti, le ultime) l’impronta<br />
velata d’una carta cannetée dentro l’orbita di un cratere<br />
di polvere, la tenebra si fa crepuscolo, luce incerta e spiraglio. In<br />
altri fogli, da tempo, fluttua una struttura bivalve, astata verticalmente.<br />
Oppure si incrociano orli e tralicci in risalita che danno<br />
vita ad un morfema generativo: la piegatura radiante. Pare una<br />
linea, un solco, ma è molto di più: un doppio margine, una ci-<br />
489<br />
gliata emergenza figurale: si schioda ed apre dapprima al centro,<br />
poi ai lati del foglio.<br />
Troppo presto ancora per parlare di luce, quest’immagine è piuttosto<br />
materia leggibile al chiaro, pellicola decantata e pura. Costola<br />
e spigolo.<br />
La cerniera: un tema chiave della pittura a venire.<br />
(1) Scritto in occasione della mostra “Renzo Schirolli 1956-1981”, tenutasi<br />
presso la Galleria d’Arte Contemporanea di Suzzara (Mantova), dicembre<br />
1981-gennaio 1982.
1982<br />
Da Ferruccio Bolognesi<br />
a Giuseppe Botturi<br />
Un sistema magico<br />
Ferruccio Bolognesi<br />
Di piombo e di cera<br />
Paolo Cotani<br />
Ai confini dell’astratto<br />
Giordano Di Capi<br />
Il codice del nulla<br />
Giuseppe Botturi
Un sistema magico<br />
Ferruccio Bolognesi (1)<br />
La scena del melodramma, di un melodramma sorpreso nei momenti<br />
di slancio e di rinnovata sperimentalità anziché nelle codificazioni<br />
monumentali dell’opera chiusa, costituisce il luogo dominante<br />
dell’invenzione di Bolognesi; ed insieme ai lavori di Gagliano<br />
o Paisiello, anche il genere misto, a cerniera fra l’oratorio,<br />
il ballo di corte, la cantata. Il suo sguardo trova alimento in un<br />
teatro per musica già di per sé votato all’esplorazione di grammatiche<br />
metamorfiche ed innovative, capace di sondare partiture<br />
multiple, incastri, compenetrazioni con i registri verbali e figurativi.<br />
Pensiamo, in campo visivo, al gusto composito di Diaghilev,<br />
a certi "scherzi" e trucchi di Taìrov. Non si guarda comunque alla<br />
F. Bolognesi, Villanello, 1973, acrilico su carta, mm 200x155. F. Bolognesi, Nina, 1973, acrilico su carta, mm 200x155.<br />
492
costruzione di un edificio totalizzante (il mito di Gesamtkunstwerk,<br />
pur così vitale nel nostro secolo), quanto alla cooperazione<br />
tra le arti, per incrociarle in un tessuto effervescente di scritture.<br />
Le si fa agire per contatto, consonanza o divergenza espressiva,<br />
mai asservendo l’una all’altra e tenendo viva piuttosto, di<br />
ciascuna, l’esigenza di autonoma formalizzazione.<br />
Quanto all’unità dello spettacolo, è la figura demiurgica del regista,<br />
questa funzione ossessiva della teatralità contemporanea, a<br />
subire uno scarto. Non regge più da sola il fatto rappresentativo.<br />
La congruenza fra le parti è affidata al laboratorio, dove lo specifico<br />
della messa in scena gioca sempre un ruolo inventivo, ma<br />
alla pari con la musica, la pittura e la coreografia. Coordina intenzioni<br />
ed analogie; non prevarica. Può anche accadere, in certi<br />
casi, che l’architettura spettacolare venga suggerita da un versante<br />
speciale, quello del suono. In ogni caso si tiene lontano il<br />
supercodice delle regie totali, dove l’evento musicale appare fatalmente<br />
ri-scritto dalla messa in scena.<br />
Un attivo sguardo filologico innesca il metodo rappresentativo,<br />
nella condivisione di un criterio appreso dalla direzione musicale.<br />
L’archetipo è un corpo semisommerso, rilevato dalle tracce di<br />
una testualità di cui molti spessori sono andati perduti: lo spartito<br />
sei-settecentesco. In più, per sua natura, lo spettacolo non<br />
ammette ripetizioni. Il che legittima, quando il restauro non sarebbe<br />
che un falso con la presunzione dell’autentico, l’intervento<br />
creativo, l’addossamento a ciò che il pittore chiama, con locuzione<br />
significativa, lo spirito del dramma.<br />
La nozione di spirito ha qui un valore propulsivo ed allontana<br />
ogni tentazione ricostruttrice, naturalistica, storico-archeologica.<br />
Non solo: mentre implica una fedeltà più profonda, libera un’attitudine<br />
interpretativa incline al simbolico e all’intensività. Questo<br />
tema, ben noto all’epoca dei ri-teatralizzatori primo-novecenteschi<br />
ed avvertito in modo particolarmente acuto ogni volta<br />
che occorra costruire una ritmica dello spazio a partire dalla metrica<br />
musicale, porta ora ad intendere l’immagine scenica come<br />
emblema cromatico e geroglifico visivo: inclinazione stilistica<br />
senz’altro costante nella attrezzeria e nei costumi di Bolognesi.<br />
Ritmo non vuol dire però movimentazione materiale del palcoscenico<br />
in senso ingegneresco e meccanico. Significa eccitazione<br />
psichica, forza allusiva del colore e della linea.<br />
Secondo quale itinerario?<br />
493<br />
È il testo, empaticamente assunto mediante una pratica severa<br />
di ascolto, ad innescare il tragitto creativo. Dallo scrigno dei suoni<br />
provengono i possibili, l’inesauribile effimero delle figure. Non<br />
arbitrariamente poiché di quel ‘campo’ strutturale vengono indagati<br />
i nessi compositivi, i tempi e le loro relazioni, fino a ricostituirlo<br />
come misura di ritorno. "Il senso dello spettacolo - dichiara<br />
l’artista - mi viene dall’opera, da ciò che mi arriva attraverso<br />
il tempo. Ecco perché mi documento e studio: non voglio<br />
che il mio esercizio sia gratuito". Si configura così una poetica<br />
della risonanza, da cui discende quel tipo di formatività grazie al<br />
quale la lettera del testo trapassa continuamente in memoria e<br />
da lì in emozione pittorica. La voce ed il suono suggeriscono<br />
degli equivalenti nati per vibrazione, con l’esigenza di un confronto<br />
ripetuto con la matrice del senso (la parola, il canto, eccetera,<br />
o meglio le loro tensioni).<br />
Diceva Matisse: "Ci sono due modi per esprimere le cose: uno é<br />
mostrarle brutalmente, l’altro evocarle con arte". Ed è il secondo<br />
che importa. Qualcosa di analogo avviene in questa gestazione<br />
di immagini. Si trasgredisce la somiglianza a vantaggio dell’espressione,<br />
del trar-fuori. E si deforma magari la ‘cosa’ per coglierne<br />
la cifra nascosta. Deformare e rifare, ma non tradire è<br />
chiaro, giacché la presa sull’oggetto (un artificio musicale) resta<br />
sempre fortissima, come d’altronde nella pittura di Bolognesi,<br />
dove non hai una rappresentazione semplicemente fantasticata,<br />
ma una realtà risarcita, generata per la seconda volta. I mitologemi<br />
della vita. Risarcire la musica vale, da una simile prospettiva,<br />
quanto artificializzare il teatro, spingere in avanti il gioco<br />
delle finzioni e delle maschere. Così la superficie viene posta in<br />
stato di allucinazione, talora fissata tanto a lungo da tramutarla<br />
manieristicamente in impresa ed allegoria.<br />
Si consideri, a tale proposito, a quali avventure sottoponga il pittore<br />
il codice della scena all’italiana, vale a dire l’assialità prospettica<br />
con la sua gerarchia di fughe e addizioni. Mantiene in<br />
vita il sistema, lasciandosene fasciare come da un corpo periferico,<br />
un guscio entro il quale mettere in campo un’altra scena.<br />
Alla scansione armonica contrappone, per lo più in avanti, la<br />
forza dell’eccentrico o la frontalità tutta topologica di un percorso<br />
in piano: i due ‘occhi’ della Nina, tradotti in piazza e giardino<br />
sulla pianta dipinta del palcoscenico, ne sono un esempio. E dal<br />
momento che l’ordine chiuso della boite post-rinascimentale
F. Bolognesi, Lindoro, 1973, acrilico su cartoncino bianco, mm 400x300.<br />
494<br />
riassume il mondo, egli fa dialogare quell’universo in controcanto<br />
con una scenografia ‘aperta’, montata sulle catene paratattiche<br />
degli arredi e delle immagini, in cui il frammento, la parte<br />
per il tutto, la sineddoche contano più dell’intero.<br />
Se il contenitore rimane intatto, la logica della molecolarità finisce<br />
col determinare nuovi centri di tensione. Un inquietamento,<br />
si direbbe, dell’esistente, in coincidenza con le stazioni barocche<br />
e settecentesche del dramma.<br />
Perché mai verrebbero innalzate altrimenti sagome inorganiche<br />
e rigide proprio nel cuore del retroscena, all’Olimpico o al Bibiena,<br />
se non per iscrivere delle emergenze araldiche, controprospettiche<br />
ed avanzanti, nei punti di fuga? E segnare così dei<br />
‘metri’ su cui misurare la fisicità degli attori? Di simili interventi<br />
è intriso il montaggio figurale di Bolognesi: dalla emblematizzazione<br />
dell’acqua e del cielo negli speroni aggiunti al proscenio<br />
per Paisiello, agli arredi mobili, alle gabbie della ‘prima’ Dafne,<br />
alla galleria dei costumi. Inclinandosi a contrappuntare l’incombenza<br />
plastica dell’architettura, lo sguardo rilegge il pieno servendosi<br />
di grafismi e irradiazioni coloristiche. Fa leva sull’energetismo<br />
lineare per indurre moti, pulsazioni e pirotecnie nel<br />
quadro iconografico.<br />
Entriamo per un momento nell’officina del costumista. Lo troviamo<br />
immerso nel ritmo, mentre alterna momenti di sintesi a sviluppi<br />
analitici. All’origine c’è un gesto, una sorta di grafema animato,<br />
quasi un’essenza mentale che rivela la natura scenica di un<br />
personaggio. Nel disegno trovi già impressa una attitudine spaziale.<br />
Poi quel ‘soffio’ si ispessisce di paste cromatiche ed è qui<br />
che un protagonista assume forma definitiva. D’ora in poi nulla<br />
potrà più cambiare. Dai semi sigillati dal colore verranno delle<br />
conseguenze strutturali per lo spettacolo, che dovrà rispettare<br />
certe positure, collocazioni e movimenti, perfino registici. Un cavallo,<br />
per citare un caso, anziché sorreggere, dovrà essere sostenuto<br />
e richiederà dei cambiamenti a vista, di sapore tra ludico e<br />
metateatrale, che ricordano i cartigli di Jarry o Mejerchol’d. Naturalmente,<br />
quando nasce, una figura trascina con sé una famiglia<br />
omogenea di segni, accomunati da una nota interna che agisce<br />
da riconoscimento collettivo; e il contrassegno, insieme psichico<br />
e visivo, trova modo di esprimersi in uno specialissimo accenno<br />
di curva, in una inedita forma di diagonalità, in una atmosfera. A<br />
parte alcuni macrosegni clamorosi, quali il labirinto dell’Aeneis
F. Bolognesi, Maschera per il “ballo delle ingrate”, 1979.<br />
495<br />
(venuto per altro da una illuminazione d’equipe) o la siepe dei<br />
doppi metallici del ’78, a Sabbioneta, un’intera suite di personaggi<br />
appare connotata da un tropo centrale: può essere l’ovale,<br />
l’immagine con due fuochi e anime multiple per la Dafne (non a<br />
caso il tema della metamorfosi), o lo spegnimento cinereo del<br />
tono, elegiaco e lunare nelle storie di Eolo ed Eurialo e Niso.<br />
Un elemento curioso che non sempre traspare alla fine del processo<br />
esecutivo (ma un nesso sostanziale deve pur esserci, se riflettiamo<br />
sul carattere totemico ed antipsicologico delle icone: la<br />
cancellazione dei tratti individuali, la cosmesi assoluta del corpo<br />
di cui parla C. Gallico), è ravvisabile nella oggettualità, ossia nella<br />
tendenza a dare l’umano attraverso la cosa. È ben noto che tanta<br />
parte delle grammatiche ‘meravigliose’ traggono ispirazione dalla<br />
fantasia combinatoria, confondendo i territori dell’evidenza sensibile.<br />
Il ‘mostro’ è un figlio puro dell’inventio, per nulla malato di<br />
prospetticità (e forse per questo i mostri sono simpatici a Bolognesi,<br />
compreso l’’’orribil angue" trafitto da Apollo). Fatto sta che<br />
la cosa, non importa a quale regione essa appartenga, infera, terrestre<br />
o cosmica, minerale od organica, determina una metaforizzazione<br />
tale per cui il fisiognomico diventa tipico.<br />
Un personaggio sarà fiore, fiamma, albero, pavone, pipistrello, libellula,<br />
oppure guardinfante, voluta, ricamo. Anche poltrona, bacile,<br />
sacra effigie, santino: ma nei casi proprio estremi dell’opera<br />
buffa (e per ora soltanto progettati), perché l’artista, più disposto<br />
all’ironia che alla disfrenata comicità, suggerisce delle<br />
linee di fuga dentro l’umano. Non demolisce né pietrifica, ma<br />
fonde. È la sua strada verso l’universale. Da qui all’animazione<br />
degli oggetti il passo è breve. Bolognesi lo ha compiuto quando<br />
ha retto un intero spettacolo o potuto dirigere piccoli quadri dentro<br />
la rappresentazione.<br />
Tuttavia, che lo possa o no, dal costume egli procede verso lo<br />
spazio scenografico più ampio, facendo proprie alcune competenze<br />
coreutiche o direttive.<br />
Muove i personaggi in un suo ‘teatrino grafico’, sul foglio da disegno.<br />
Ne anticipa movenze, passi, rotazioni e distanze rispetto<br />
all’osservatore. In breve: fa agire il costume nello spazio. O se si<br />
vuole: inventa lo spazio deducendolo dalla figura. Tanti fogli ancora<br />
lasciati nel cassetto sono zeppi di appunti sul tempo e sulla<br />
illuminazione: tutte regie immaginarie che Bolognesi non impone.<br />
Li usa semmai come zibaldoni di lavoro e credo gli servano
F. Bolognesi, Ermafrodita, 1980, pastello su carta da parati, mm 350x230.<br />
contemporaneamente da alternativa e verifica, per provare se<br />
un’immagine regge alla prova del palcoscenico; e vedere quale<br />
sia la forma più congrua di gestualità: lenta, inceppata, marionettistica,<br />
oppure concitata, fluida e così via. Per lui è una questione<br />
di "tempi affettivi".<br />
Quando venne rappresentato Per passatempo di veglia nel ’79,<br />
con la regia di Caterina Mattea, aveva predisposto, fin dall’anno<br />
precedente, un brogliaccio d’azione per il Combattimento di Tancredi<br />
e Clorinda, che, se pure rimase lettera morta, la dice lunga<br />
sugli sviluppi della scena nell’immaginazione del pittore. Lo<br />
spettacolo è concepito infatti nei termini d’una rivelazione, come<br />
se il teatro fosse il luogo in cui l’oscuro viene improvvisamente,<br />
folgorantemente, in luce. E questo oscuro è la precarietà dell’esistente,<br />
il non senso delle cose. Gli eventi appaiono dal niente<br />
(dal buio e dal deserto) per ritornare nel niente; anche l’or-<br />
496<br />
chestra è cancellata, posta "in modo - dice l’appunto - che non<br />
si veda". I due cantanti, quasi alle radici dell’arco scenico, in costume<br />
cortigiano, disegnano la cerniera tra pubblico e scena. Così<br />
vien data la nota storica ed araldica del recitar monteverdiano.<br />
Poi, alle spalle dell’auctor (la figura del Testo), viene inscenata<br />
una sorprendente azione pantomimica. Gli eroi tasseschi compaiono<br />
letteralmente dal nulla, emergendo dentro il visibile su<br />
due trapezi volanti con progressione lentissima. Il congelamento<br />
del tempo è anzi la nota dominante di tutta la sequenza successiva,<br />
ribadita dall’imprigionamento fisico, cui alludono due<br />
gabbie metalliche, "di ferro forgiato col fuoco", a significazione<br />
plurima: sono armature e luoghi, costumi e fondali, a seconda<br />
dei casi. Una materializzazione del destino che diventa paesaggio,<br />
geografia fatale. Anche la luce partecipa, frantumata com’è,<br />
dopo la tenebra iniziale, in un pulviscolo lampeggiante. Tutto è<br />
concreto, materico, pregno di corposità ed al tempo stesso sognato,<br />
magico. Lo si vede anche nei gesti, nel modo di portare i<br />
colpi: "molto realistico e con grande lentezza". Straniata a sé,<br />
l’esistenza si rivela irrealizzandosi.<br />
Che la luce svolga un ruolo drammatico, ora di energica conflittualità<br />
ora di patetico illanguidimento, appare ulteriormente chiaro<br />
sfogliando il grande spartito registico per la Dafne del 1981,<br />
che porta una minuziosa registrazione di fatti scenici. È una luce<br />
che commenta ma anche una luce che agisce e significa. Talora<br />
un medesimo quadro ospita più di una luminosità, tenue e intensa,<br />
azzurrata e solare, così da esporre nel concertato luministico<br />
un incontro di antagonistiche temperature emotive.<br />
Altrettanto incisiva la recitazione dell’ombra e forse di più, almeno<br />
in certe sequenze. I personaggi stessi sono miraggi e<br />
larve, apparenze talora destinate a svanire (Aeneis), a perdersi<br />
o a perdere gli altri, come il Plutone del Ballo delle Ingrate, vera<br />
creatura abissale; o a celebrare riti di trasformazione, momenti<br />
del lutto. Con più di una soluzione: o l’ombra viene concretata in<br />
una forma circoscritta (costume, maschera, sagoma, attrezzo), o<br />
risolta attraverso una dominante cromatica, oppure manovrata<br />
come l’altro dal corpo, il suo fluido ed enigmatico prolungamento.<br />
Il protendersi del fantasma. Dal brevissimo esercizio del Sanitruch<br />
(’74), dove una battaglia veniva stilizzata nelle proiezioni<br />
d’ombra su uno schermo, fino ai percorsi tortuosi della peripezia<br />
mazzocchiana, si scava dentro questa possibilità. Il vertice
è però raggiunto nell’episodio della metamorfosi di Dafne nell’edizione<br />
del ’78, con lo scompigliamento di un simulacro metallico,<br />
gli echi d’ombre e penombre, i vuoti duramente ritagliati<br />
nei manichini di lamiera.<br />
Una vitalizzazione dell’inerte sarebbe dovuta avvenire già nel<br />
’76 (un’altra delle scenografie mancate) per l’Arcadia in Brenta,<br />
con un’intuizione felice della vita degli oggetti nella drammaturgia<br />
dell’autore veneziano. Protagonisti, nella XII scena, una porta<br />
girevole e dei siparietti, un arioso carosello di forme. Giudicati<br />
"troppo espressionistici" non passarono, per evidente miopia<br />
anche nei confronti dell’opera goldoniana, come se il realismo<br />
della copia fosse davvero la chiave del Settecento.<br />
In definitiva il pittore occupa spazi esigui per produrre effetti risonanti.<br />
Gli bastano alcuni punti di appoggio, attrezzi e gesti minimi:<br />
dei modi aggreganti. Coagula il molto nel poco, per stratificazione.<br />
Ecco perché un gesto appena accennato contiene una<br />
tensione esplosiva e una mano leggermente schiusa può riassumere<br />
una geometria sentimentale, seguendo il criterio pantomimico<br />
dell’essenziale. Niente ridondanze nei costumi di Bolognesi,<br />
ma pressioni e rigonfiamenti per eccesso di contrazione.<br />
Non sono decorativi ma tesi, e proprio per questo intrattengono<br />
un difficile rapporto con l’attore ed il ballerino, chiedendo a quest’ultimo<br />
d’essere altra cosa che due gambe danzanti. Al posto di<br />
un portatore d’abiti hai un corposcenario rifatto dalla pittura.<br />
Muovendosi, il costume traccia figure e mappe nella scatola teatrale.<br />
In certo modo incide degli itinerari simbolici. Enfatizza gravità<br />
e leggerezze. Ed è anche un congegno trasformabile, come<br />
per Depero. Teatro nel teatro, trucco e incernieramento di opposti,<br />
un ermafrodito. L’arcaismo della figurazione ci riporta spesso<br />
alle origini del passo di danza, dissentendo o consentendo alle<br />
istruzioni del ballo di corte, che è, per suo conto, un nuovo principio<br />
nella storia del movimento (la disposizione "a mezzaluna",<br />
per esempio, raccomandata da Marco da Gagliano, riaffiora nella<br />
pioggia di segni sul foglio XXI di regia). Maschere ed arredi,<br />
nei loro artifici, nascondono coups à surprise.<br />
Anche la simmetria rovesciata dei décors induce ribaltamenti. E la<br />
procedura vale per i colori come per la linea. Il dietro del costume,<br />
invece di proseguire e concludere lo sviluppo della composizione<br />
frontale, quasi sempre la ribadisce per inversione, o la tronca di<br />
netto, evitando i panneggiamenti decorativi. Ragion per cui le sa-<br />
497<br />
gome, con la loro piattezza radicale, appartengono alla medesima<br />
costellazione formale dei costumi-corazza, antiplastici e lontanissimi<br />
dall’effettismo a tutto tondo dei quadri viventi.<br />
Il colore è cercato nel suo oltrepassarsi, un oltre raggiunto mediante<br />
picchiettamenti, dislocazioni di fibre, grumosità, velature,<br />
pieghe, trasparenze, brillii, mélanges, compenetrazioni. Pelle su<br />
pelle: scatta il meccanismo dell’accumulo eterogeneo.<br />
Nel creare una situazione l’artista mobilita il sistema delle rifrazioni,<br />
esibendone la flessibilità costruttiva. Addensa/dirada. Sovrappone/toglie.<br />
Concentra o allarga una selva dipinta.<br />
Il cerimoniale della simulazione rientra perfettamente in questo<br />
gioco. Vedi le maschere. Nel "capriccio" madrigalesco sulla Bellezza,<br />
sono delle lamine appena sagomate, facce impugnabili,<br />
danzanti col corpo e specchi dell’irrealtà. Talismani dell’iniziazione<br />
amorosa. Ma riflettono anche il doppio negativo e finalmente<br />
si lasciano annientare nel culmine del trionfo. Altre volte connotano<br />
la profondità, qualcosa di definitivo. Rappresentano il<br />
compimento del personaggio in cifra metafisica. In quanto tali<br />
serrano il capo dentro una grata ieratica (i visi catafratti delle Ingrate).<br />
Con analoga evidenza riassuntiva operano le minuzie<br />
della bottega teatrale, incentivando la catena dei rimandi.<br />
Non servono al corpo ma all’occhio. Guai a sedersi su un cavallo<br />
o su una sedia di Bolognesi! Crollerebbe l’incanto.<br />
Dunque, per concludere, una scenografia mobile, in apertura. C’è<br />
da chiedersi che cosa produrrebbe dialogando con parole e musiche<br />
del Novecento. Ma la domanda è oziosa. La rielaborazione<br />
dei suoni appartiene all’oggi.<br />
.<br />
(1) Scritto per il catalogo della mostra “Vestire i sogni. Rassegna di bozzetti<br />
e di costumi teatrali ideati da Ferruccio Bolognesi e realizzati dalla<br />
sartoria teatrale Umberto Tirelli”, edito dal Centro di Documentazione<br />
Arti Contemporanee, quaderno 1, nell’aprile 1982 a Carpi (Modena).<br />
Rieditato in occasione della mostra “Simulazione d’ombre”, tenutasi<br />
presso la Casa del Mantegna a Mantova nel 1985
Di piombo e di cera<br />
Paolo Cotani (1)<br />
Che vuol dir cercare uno “spazio totalizzante” e poi fare di questo spazio una regione soffice, pulviscolare,<br />
cigliata in cui la percezione si disorienta? Nelle superfici di Cotani (ma sono poi superfici?)<br />
mi trovo e mi perdo. Posso dire piuttosto che vi galleggio, vado alla ricerca di margini ed approdi<br />
e che, una volta trovatili, devo subito attaccarmi a nuovi confini per non sprofondare. Scopro<br />
isole e continenti, anche l’Africa, le piramidi e palazzi incantati, muraglie, archi, colonne. Luoghi<br />
della memoria e paesaggi segnati sulle carte: sono territori ideali e plaghe viste dall’alto, non<br />
corpi solidi. Soprattutto ho a che fare con fessure, crepe e frammenti, giacché il segno di confine<br />
è in realtà un avvallamento, una riva scoscesa: e l’Africa, quando la incontro, mi è data anche al<br />
rovescio ed in maniera che là dove credevo di salire mi tocca invece discendere e camminare su<br />
degli orli.<br />
L’andare è precario e la precarietà vien ribadita dal rovesciamento sistematico dei piani d’appoggio<br />
e degli orizzonti mentali. Isole e penisole sono nubi e i cieli delle porzioni di terra. E via di seguito,<br />
per moltiplicazioni, agglutinamenti, intersezioni; o affiorare di doppi.<br />
Una immagine forse mi aiuta a capire dove e in che modo debba posare lo sguardo, come dargli<br />
consistenza e spostarlo. Si tratta di un segnale di controllo, di una lastra di piombo fatta per<br />
misurare nei muri l’espandersi di una fenditura: una biffa. Qui l’occhio trova delle ragioni per ope-<br />
P. Cotani, Sulla piramide, cm 58x77.<br />
498
are e si riconosce. Il vedere, metaforizzato nella lastra, è tutta<br />
questione di assestamenti e di pesi, sicché, mentre guardo, non<br />
sono che una misura posata nell’intervallo, una sosta di piombo<br />
fra due rive e una presenza nella marginatura. O anche una cucitura<br />
nel (e dell’) intervallo.<br />
E di nuovo: al di fuori del mio stare non ho sostegni plausibili. I<br />
sostegni li trovo grazie ai contrappesi che riesco a provocare<br />
sulle sponde e alla sola forza di penetrazione nei margini. Direi<br />
quasi che la gravità lotta con se stessa e che questo consistere<br />
di metalli, lamine e carte ha alcunché di medianico. Un puro atto<br />
di sospensione in luoghi immateriali e svuotati. Il che equivale a<br />
dire che il principio cui mi appiglio non sta al di fuori di me, ma<br />
nel mio occhio, nella fatica, sia pure labile ed intermittente, di<br />
viaggiare lungo linee di confine che il cammino stesso vien tracciando<br />
nel corso dell’esperienza.<br />
Che cos’è allora l’atto di dipingere se non un lavoro che inventa<br />
il proprio itinerario, produce mappe e figure, copre i deserti di<br />
solchi e passaggi? Magari li reincide e stratifica?<br />
Comunque ha fame di costruzioni. E le eleva perché innalzarle è<br />
il solo modo che ha di vivere agitando la fucina della visione.<br />
Se nel passato recente qualcuno, anche un maestro di Cotani,<br />
praticava l’arte di viaggiare nei paesi dell’Origine, ora quest’illusione<br />
è tramontata. Alle spalle non restano in attesa degli universi<br />
pieni, ma soltanto belle finzioni e vecchie favole, territori<br />
vuoti e antiche violenze.<br />
Così per via di racconti e nuove finzioni vien fuori un mondo immaginario<br />
teso fra le soglie del tempo, fluido ed espansivo come<br />
lo scorrere degli istanti ai quali aderisce. La tela registra il vorticare<br />
delle luci e delle ombre che gli atti visivi producono senza<br />
soluzione. La mente resta dentro l’ingegno della pittura e vive di<br />
ciò che finge e modella. In questo senso totalizza spazi di crescita<br />
e li dilata instancabilmente per minime differenze.<br />
Quando poi la pittura è una pratica consapevole dell’incantesimo,<br />
l’efficacia dell’ordito fa trasparire nelle pieghe il repertorio<br />
delle astuzie. E la mano le esibisce col porre in frizione ed infine<br />
confondere la duplicità dei miraggi, certi modi d’apparire e i<br />
loro contrari. Cotani non dipinge per esempio una colonna intera<br />
né separa il vuoto dal pieno, o la massa dall’esterno di una ‘piramide’.<br />
Agisce al contrario per sovrimpressioni e rimandi. Ad un<br />
vertice accosta una base, allo schiacciamento fa seguire l’eleva-<br />
499<br />
zione, allo scuro il chiaro. Al nero l’oro, il suo altro. I dittici di cui<br />
è costellata la sua ricerca negli ultimi anni vengono a dirci che il<br />
sogno di totalità, una volta che sia slittato verso linee d’ombra,<br />
diventa una inquietata sorgente di segni; e che è tensione anziché<br />
dominio, un pencolare tra l’esistente e il possibile. Non comprenderei<br />
altrimenti l’assiduo riprendere e soppesare dal ’76 ad<br />
oggi (e forse anche prima) le categorie dell’uguale e del simmetrico,<br />
spinte a rivelare delle zone di crepuscolo, sfuocate ed<br />
instabili; a fare i conti col dissimile. Cotani tira nelle sue “fabbriche”<br />
dei fili acuminati che sono corde vibranti e tagli. Imprime<br />
P. Cotani, Il continente analogo, cm 150x73.
colpi di rasoio contro la presunzione dell’Identico e mobilita gli<br />
spazi sul ritmo delle ferite e delle cerniere.<br />
Ora la fabbrica, quel tema struttivo che abitava il cuore delle<br />
configurazioni nei cicli delle vele a volta, dei doppi archi e dei<br />
cerchi in un campo rettangolare, va assumendo sempre più il<br />
senso delle architetture periferiche e delle soglie. Ha finito per<br />
coincidere con lo spigolo della tela producendo una orlatura continua<br />
e divenendo in certo modo il themenos della fattura. Il suo<br />
recinto: una angolatura oltretutto aurea e tanto più eminente in<br />
quanto ricorre all’artificio della massima sottigliezza. Sta lì senz’essere<br />
dipinta e regge, quasi invisibile, il farsi dell’opera sui<br />
principi cardinali dell’ordo, quali il cerchio e il quadrato.<br />
Ma se il tondo è aspirazione all’immobile, il segno di durata vien<br />
però fatto reagire sul filo degli eventi. Nell’Idea, tradotta in contorno,<br />
i contraccolpi di infiniti accidenti non fanno che alimentare<br />
la motilità del contenuto, il loro essere da un lato già vissuti e<br />
il loro prefigurarsi, da un altro, in una sorta di memoria futura,<br />
500<br />
P. Cotani, dal ciclo “Spazi virtuali e mondani”, cm 140 Ø.<br />
provocata dal presente. Il ‘mondano’ e il ‘virtuale’. Le differenze<br />
sono i fatti del colore e del disegno, i biancori e le nerezze delle<br />
grafiti e delle cere. Gli alti e i bassi, gli andirivieni, le grommature<br />
e gli sfrangiamenti delle carte ripropongono infatti le ragioni<br />
della materia e dei corpi. Sono loro a far sì che sulla pianura<br />
perfetta, dentro l’immobile architettura, si apra un abisso, che un<br />
sole sia nero per virtù cromatica e che una figura in gestazione<br />
ecciti un battito di analogie.<br />
D’altra parte l’opaco tende alla trasparenza e cerca la leggerezza<br />
del pensiero. Corpi di cera e contemporaneamente idee plananti<br />
dentro il mondo visibile. Nulla è certo se non l’inventio che li<br />
spinge a manifestarsi. Dietro intravedo l’ossessione di Cotani, la<br />
figura raggelata del vuoto che l’à plomb dello sguardo tenta di<br />
risanare, cucendo e colmando.<br />
(1) Scritto in occasione della mostra antologica “Paolo Cotani”, Casa del<br />
Mantegna, Mantova, 5 giugno 1982.
Ai confini dell’astratto<br />
Giordano Di Capi (1)<br />
Parafrasando un passo di Braque ispirato a Pascal, Non la cosa<br />
ma la ricerca della cosa, potremmo dire che per mantenere vivo<br />
il fuoco della visione occorre alimentarlo appassionatamente e<br />
desiderare quel fuoco più che l’oggetto stesso del dipingere, più<br />
che l’immagine ultima. Ogni conclusione è mortificante per la<br />
pittura poiché "concludere significa escludere l’imponderabile’’.<br />
Se ora consideriamo lo sguardo del pittore, così com’egli lo dipinse<br />
nell’autoritratto del 1934 e come poi si deposita e lavora sulla<br />
superficie dei quadri, ci troviamo davanti a qualcosa di simile: ad<br />
una speculazione (nella pregnanza etimologica del termine) ad<br />
infinitum. Un osservare le cose in modo fermo, penetrante, teso;<br />
un fissare e circoscrivere gli oggetti e non solo quelli pittorici; un<br />
abbandonarsi ad essi ed impregnarsene prima ancora di domi-<br />
G. Di Capi, Composizione astratta, 1952, tempera su carta, cm 32x46.<br />
501<br />
narli con la severità del metodo rappresentativo; e, fatto decisivo,<br />
un anticipare l’azione dello sguardo col suo patimento, un<br />
mettere a confronto l’emozione con la regola e cercare di annodarle<br />
in un equilibrato sistema di rapporti visivi, mai per altro definitivo:<br />
queste le attitudini mentali che l’artista trasferisce nell’atto<br />
creativo e che, oltrepassando la stessa pratica figurale, rivelano<br />
un pensiero in movimento attraverso i visibili, un orientamento<br />
e un progetto riconducibile ad uno stile di vita.<br />
Osserviamo l’autoritratto: niente frontalità, nonostante l’energica<br />
e calibrata strutturazione del corpo, ma - com’è stato detto - "eccezionale<br />
intensità drammatica", emozionato dialogo fra l’occhio<br />
dell’artista e le cose circostanti, tra la diagonalità di un vedere<br />
che ci sfiora, pur apparendo acutissimo, ed un’altra inquieta lateralità,<br />
quella della piccola tela appesa a destra, alla medesima<br />
quota del volto. L’esiguo riquadro è anch’esso inondato di luminosità<br />
fluttuanti, quasi un generatore di echi colorati, di aloni e
iverberi dal bianco all’azzurro, dal vicino al lontano. Le relazioni<br />
formali e simboliche insistono sulle ‘fughe’ e delineano sconfinamenti,<br />
ma lo fanno senza tumulto ed avviano contemporaneamente<br />
dei moti circolari, in certo modo delle controcurve che<br />
suggeriscono il ritorno al centro del quadro, così da ricomporre<br />
l’esterno con l’interno, la lontananza degli spazi con lo sguardo<br />
che vi si immerge e li scruta. E l’oscurità sta, pittoricamente, più<br />
fuori che dentro.<br />
Il vedere è dunque un evento intensivo; di meditato abbandono.<br />
Di Capi - molte testimonianze lo ribadiscono - ne faceva una<br />
questione di docilità alla ricchezza del mondo visibile. Essere<br />
umili, nella maniera aristocratica, segreta ed ironica che gli era<br />
propria, voleva dire consegnarsi senza riserve al dettato muto<br />
delle cose e, seguendo i suggerimenti di altri pittori introspettivi,<br />
Chardin o Morandi, tentare di decifrare l’anima nascosta delle<br />
forme. Il suo mentalismo, che batte anche i sentieri dell’analisi<br />
ed arriva alla scomposizione di corpi ed oggetti, non ha nulla di<br />
precostituito e di gelidamente concettuale. Si ricordino i suoi sospetti<br />
sul far critica dei letterati e dei filosofi in fatto di immagine.<br />
Cerca invece nessi, spazi connettivi, associazioni. Intende<br />
leggere in profondità e trovare legami sotto le manifestazioni di<br />
natura, restandovi però dentro e non operando contro di esse. Il<br />
pittore vuole interpretare l’oggetto, farvi aderire l’occhio, ma<br />
teme l’inganno e la cieca irruenza della percezione immediata.<br />
Perciò ne disciplina lo slancio. L’educazione all’attesa costituisce<br />
una premessa al dipingere. Tracciare segni e colori significa pensare<br />
in figure. Registrare e riscrivere. Senza questo sostegno che<br />
un Braque chiamava "teorico" e che qui potremmo definire autoeducativo<br />
e speculativo, non si spiega - crediamo - lo sperimentalismo<br />
di Di Capi, il suo desiderio di "esperienza".<br />
A proposito poi di quest’atteggiamento sperimentale non si vede,<br />
alla prova dei fatti, nessuno scarto immotivato o troppo brusco,<br />
neppure quando, arrivato alla soglia del Cinquanta, egli imbocca<br />
decisamente una via che finirà col portarlo nel breve giro<br />
di tre-quattro anni ai confini dell’astrazione. Non si tratta neanche,<br />
in questo come in altri casi, di trascrivere degli aggiornamenti<br />
linguistici sulla spinta dei modelli affacciatisi nel secondo<br />
dopoguerra. Avvengono invece degli approfondimenti, anche<br />
con l’aiuto di quei modelli, all’interno di un itinerario che continua<br />
a restare fedele a se stesso. Che poi la decisione a favore di<br />
502<br />
una grammatica essenziale scatti improvvisamente, ad una certa<br />
data, ciò va fatto corrispondere ad una consapevole volontà<br />
espressiva che si era preparata con circospezione. Per nulla insolita.<br />
Basti pensare alle svolte molto più dirompenti di Capogrossi,<br />
Birolli, Vedova ed in generale agli autori provenienti dalla<br />
Scuola Romana o da Corrente, allora militanti nel Fronte Nuovo<br />
delle Arti. Quando Di Capi riprende a dipingere dopo la parentesi<br />
della guerra, compie tutta una serie di verifiche sulla propria<br />
pittura, sui grandi esempi che lo avevano guidato nel decennio<br />
precedente e sulle conseguenze che ne erano derivate ai più<br />
giovani. Le fa in silenzio frequentando le mostre e misurandosi<br />
direttamente sulle opere che venivano esposte, spesso per la<br />
prima volta, a Venezia, Milano, Firenze. È un periodo di letture e<br />
di ripensamenti, lasciati fermentare in segreto e affioranti solo<br />
per tracce esilissime negli esercizi personali, se si eccettuano alcune<br />
tavole e cartoni del ’47. Nel complesso egli appare volto a<br />
scandagliare le radici abituali delle sue immagini (anche marginalmente<br />
chiariste), andandosi a cercare gli elementi di modernità<br />
fuori dell’avanguardia più stretta, nei precorritori e negli isolati<br />
del Novecento: gli stessi dell’anteguerra, lungo l’asse Chardin-Cézanne-Morandi<br />
e in parte Carrà, con digressioni intorno<br />
agli svolgimenti tonali di Semeghini e ai disfatti tessuti pittorici<br />
di De Pisis. Il problema centrale riguarda sempre la struttura colorata:<br />
una costruzione tesa ad assorbire il campo pittorico in una<br />
solidale rete cromatica, ottenuta ora per larghe stesure ed ora<br />
per fibrillare motilità di tocchi. Tutto avanza in primo piano,<br />
preme in avanti. Lo spazio si fa fluido e le immagini appoggiano<br />
sulle pure consistenze di forma e colore. Le irradiazioni partono<br />
dall’immagine, l’attraversano per contagiare la periferia. Nelle<br />
nature morte le conseguenze di rilievo toccano lo sfondo e l’oggetto.<br />
Se quest’ultimo tende a disincarnarsi fino ad assumere un<br />
aspetto pellicolare, quello addirittura si dissolve in uno schermo<br />
impalpabile e talvolta si annulla lasciando emergere il supporto,<br />
non solo e non tanto per restituirlo matericamente all’ordito<br />
della composizione, quanto per spalancare proprio dei vuoti,<br />
delle zone di risonanza estenuata e delle pause nella successione<br />
dei pieni; di modo che, non facendosi grumo, le stesure veleggiano<br />
nello spazio aperto, simili a bave di vento e a superfici<br />
sfogliate. Tuttavia non sempre. Soprattutto quando Di Capi ricorre<br />
all’à plat o rassoda il nucleo dell’immagine, chiude i varchi al-
l’irruzione del vuoto. Per un verso concentra i pesi cromatici su<br />
un motivo dominante, quasi sempre alloggiato nel cuore della<br />
superficie (per esempio le "sviluppatrici fotografiche" e le brocche<br />
azzurre, un colore ben suo, del ’47-’49), per un altro cerca<br />
digradate e continue sequenze di piani, sia in verticale che in<br />
orizzontale. Un caso è l’olio acquerellato del ’47 circa (la natura<br />
morta della Coll. Morari), dove già viene impostandosi il reticolo<br />
a fasce ortogonali, a maglia larga (lo schema a croce), che genererà<br />
in seguito gli ordini a scacchiera di molte tempere. Da notare<br />
che la forma centrale non è mai sola, ma dialoga con uno<br />
o più oggetti, per lo più secondo scale tripartite, così che ad una<br />
figura forte rispondono due battute costruttive più deboli, ma<br />
nell’insieme equivalenti alla prima. In questo genere di montaggi<br />
il fuoco può anche frangersi per onde concentriche, come<br />
un sasso gettato nell’acqua. Esempi ulteriori di scala continua,<br />
forse del medesimo anno, sono una "natura morta con brocca"<br />
G. Di Capi, Natura morta, 1950, tempera su carta, cm 36x50.<br />
503<br />
(Coll. Masè Dari), che insegue in cifra araldica lo slittamento verticale<br />
di tre rotondità, e la tavola ‘astratta’ della collezione Paiola,<br />
in cui tessere variamente ritagliate di frutti ed oggetti si assiepano<br />
sul piano, e vorremmo dire su un proscenio rigorosamente<br />
bidimensionale.<br />
È come se l’occhio sperimentasse un doppio respiro, in uscita ed<br />
in entrata; da un lato decomponendo l’immagine e diradandola,<br />
dall’altro riassestandola come una riserva di energie. Cosa che<br />
porta ad investigare delle coppie antinomiche: movimento-stabilità,<br />
periferia-centro, asimmetria-equilibrio. Le figure si ripetono<br />
instancabilmente nell’inventariamento di molteplici possibilità<br />
compositive, favorendo il sedimentarsi della memoria e di<br />
fantasmi più pensati che percepiti.<br />
Insieme ad esse, si fa largo in qualche caso un colore improbabile,<br />
assente in natura. Anche acido, come in Villon. Lo spettro<br />
tonale nasce infatti da accordi strettamente pittorici fra una tinta
e le sue derivazioni, pensabili soltanto sulla tavola, oppure da un<br />
clima immaginario che assimila l’ombra alla luce, le coniuga insieme<br />
come parti di un universo che non è più notturno o solare,<br />
ma annegato in una regione intermedia, tendenzialmente<br />
monocromatica. Ed assieme a Braque, anche Matisse deve aver<br />
richiamato il pittore, specie sul versante della purezza.<br />
Il Cinquanta fa registrare il compiuto esaurimento di simili motivi<br />
(si veda l’olio della Coll. Lanfredi, che dispiega una finissima<br />
padronanza di grigi, rosati e bruni), ma segnala anche un rilancio,<br />
quello definitivo, che mentre determina un insieme di rinunce<br />
ai risultati, prolunga però le tensioni che vi erano sottese.<br />
Vanno inoltre tenuti nel conto, per respingere l’ipotesi della immotivazione,<br />
i brevi assaggi di arabescatura e profilamento dell’oggetto,<br />
che cooperano a tradurre gli elementi del quotidiano<br />
in emblemi fuori del tempo; ed assieme a questi accenni, gli altri<br />
esercizi minimi o appena abbozzati intorno alla intersezione dei<br />
piani, come si vede nell’incompleta "natura morta con Budda"<br />
del ’47 e nel ben più maturo olio dell’anno dopo (raccolta Paiola),<br />
col suo campionario di figure semplificate e di sfibramenti<br />
della superficie semiscollata dal fondo: in vista, si direbbe, di un<br />
repertorio spirituale di immagini.<br />
Dunque le ragioni di inchiesta, per Di Capi, agiscono nel territorio<br />
delle figure riconoscibili e per ora tenute lontane dalle maniere<br />
neocubiste o astratto-concrete. L’arroccamento è per altro<br />
confermato dal dipinto presente al "Premio Mantova" del ’49-<br />
’50: una natura morta calibrata su inequivocabili evidenze naturali,<br />
sui verdi e le terre. Lì avviene il confronto con il Totem di<br />
Morlotti e gli sviluppi postpicassiani di Birolli (Il Picasso della<br />
Pesca notturna di Antibes), vincitori del premio insieme a Mandelli<br />
e Perina. Ma alla rassegna partecipavano anche Vedova, Alberto<br />
Viani, Soldati, Spazzapan, cioè alcuni protagonisti, nella diversità<br />
dei temperamenti, di una rinnovata astrazione.<br />
Con la pressoché totale mancanza di documenti, oggi è arduo dire<br />
quali fossero con esattezza gli stimoli che contribuirono ad affrettare<br />
il bisogno di strutture essenziali. Non crediamo comunque<br />
che le occasioni vadano iscritte in un generico eclettismo. Di<br />
Capi era curioso fino all’ossessione, non dispersivo. Aveva visto<br />
Kokoschka e Braque nella memorabile Biennale del ’48 e si sa<br />
che andava dibattendone le ragioni, condividendo in questo l’atteggiamento<br />
di <strong>Francesco</strong> Arcangeli. Rifiutava l’alternativa radi-<br />
504<br />
cale fra realtà ed astrazione promossa dal "Fronte" e riteneva legittimo<br />
più di un approccio all’astratto. Niente aut-aut. Tra i tanti<br />
appartati, stimava Zigaina e Breddo, del quale segnalava l’autonomia<br />
al giovane Carlo Bondioli, specie per certe modulate stesure<br />
di colore puro. E pur facendo riferimento ad Arcangeli, era<br />
ben lontano dal condividere i miti lombardo-emiliani di una natura<br />
sanguigna, di forze vitali, oscure ed interrate. Nella sua pittura<br />
si interpone infatti tutta una serie di filtri tra la rappresentazione<br />
e il naturale: in primo luogo un pensiero che non possiamo<br />
chiamare altrimenti che essenzialista (differenza capitale<br />
con Facciotto), grazie al quale le cose esistono, ma vivono come<br />
ombre e scrigni di immagini mentali. In secondo luogo v’è una<br />
memoria collettiva, consegnata alla sapienza della pittura e ad<br />
alcune visioni dell’arte in ispecie.<br />
Cézanne, per esempio, non è un approdo ‘cosmico’ dal quale bisogna<br />
deviare (lo diceva ancora Facciotto), ma un inizio gravido<br />
di conseguenze analitiche. E dopo di lui il cubismo. Non stupisce<br />
perciò che egli interpelli contemporaneamente la natura e la cultura<br />
(la prima come pre-testo), andando avanti "senza fretta" nei<br />
magazzini delle forme per catturare, nel particolare e non nel<br />
generale, negli interstizi e negli episodi, quel che comunemente<br />
è considerato invisibile ma che è invece (anche) cultura depositata<br />
nella vita, spontaneità apparente e rigore dimenticato.<br />
Lo chiama "mestiere" in pittura ed è paziente illuminazione.<br />
Dopo gli oli del ’48-’49, ecco lo scarnificare di slancio ordito ed<br />
immagine; e lasciar sopravvivere pochi elementi di natura morta.<br />
Sottrae spazio tutt’attorno, concentrandosi sull’armatura portante<br />
della composizione. Toglie atmosfera agli oggetti e li ravvicina in<br />
un primissimo piano frontale. Fa scomparire i panneggiamenti, le<br />
bianche vaporosità delle tovaglie, gli sfumati. Mineralizza la luce.<br />
L’aria si dissolve per troppa vicinanza così che non v’è modo di<br />
sfuggire all’aggetto di un piatto o di una mela. Il colore viene<br />
scandito ed arrestato, vetrificato in scaglie mediante sciabolate<br />
decise, mentre l’impasto crudo toglie di mezzo i passaggi di profondità.<br />
Si ha l’impressione che lo sguardo precipiti nel motivo,<br />
levando e semplificando, mettendo a nudo delle strutture, in un<br />
mondo pittorico del dettaglio che era già avaro di concessioni descrittive.<br />
Restano delle sagome campite rapidamente, con contorni<br />
alonati di traiettorie secche, gesti riduttivi. Dentro il profilo,<br />
l’ombra diventa tessera di un mosaico. Costituisce cifre serrate al
pari della luce, depositandole in aree omogenee e separate:<br />
facce di un prisma tutto svolto in superficie. Può essere questo il<br />
motivo di fondo per cui la tempera magra sostituisce progressivamente<br />
l’olio, a cominciare da "Piatto con pere" della raccolta di<br />
famiglia1 . Ora che la ricerca verte sulle cromìe nette, distinte, non<br />
c’è più bisogno di illuminare per trasparenza, di velare e sovrapporre.<br />
E difatti nelle nature morte ad olio di quell’anno, se trascuriamo<br />
la tavola più sopra citata della Coll. Lanfredi (che era un<br />
compimento) e simili risoluzioni, la materia viene stesa con forza,<br />
quasi fosse uno smalto. In ogni caso gli effetti aerei sono inibiti,<br />
raggelati nei settori mediani e nei contorni. Con le polveri trattate<br />
ad acqua l’esito coprente è assicurato. Ed è allora che Di Capi<br />
inventa delle nature morte, per così dire, sotto vetro, in cui la<br />
linea colorata, ampia e spessa, campisce mentre disegna. Tira<br />
fuori nervi e carni, talora vividi e smaglianti di energie pure. Basterà<br />
vedere le due carte, come dire?, araldiche, dagli oggetti che<br />
paiono sigilli e fanno pensare allo splendore di un ornato matissiano,<br />
cioè ad un’idea decorativa in grado di fondere il colore alla<br />
linea. In una (Coll. Di Capi), la brocca e le tre mele diventano<br />
sigle, pittogrammi, emblemi. Non solo: vengono tramutate in<br />
qualcosa che non è più brocca o frutto, ma risoluzione geroglifica<br />
dell’immagine, oggetto di grazia. Che cos’è il tema sintetico dipinto<br />
accanto alla brocca, quel condensato di memorie ottiche, se<br />
non un motivo proiettato nel tempo assoluto del piacere, una lettera<br />
trilobata e stemma del visibile? Una cifra dello sguardo?<br />
Nella seconda carta (Coll. Baratta) è un oggetto in partenza bloccato,<br />
una gabbia o scatola, ad eccitare l’immaginazione. Da solo<br />
fa tutto: da campo e da motivo. È supporto e figura di se stesso,<br />
una struttura astratta autonoma2 .<br />
Vien da chiedersi quale sia la natura del fantasma pittorico, poiché<br />
non sono in questione soltanto elementi disegnativi, logici,<br />
‘cubistici’ (anche se il disegno resta una premessa irrinunciabile,<br />
un disegno però espressivo, in talune circostanze, toccato fin<br />
dagli esordi dalle magie scipioniane, come nella puntasecca Primavera<br />
e in quella del sole a picco su un nudo) 3 , ma svolge un<br />
ruolo primario il colore allusivo, indagato nei costituenti armonici,<br />
per pesi e contrappesi, lievi dissimmetrie. "La regola corregge<br />
l’emozione", ma l’emozione vien prima. Il fantasma sembra<br />
insediarsi in una zona mediana, a cerniera fra l’evidente e l’edificio<br />
interno dello spazio, in una struttura primaria sottesa al-<br />
505<br />
l’evento percepito: nel tipico e nel permanente, in ciò che resiste<br />
alla variabilità del fenomeno.<br />
Che una sostanza antidiurna si accompagni di frequente ad un<br />
simile scavo, può servire da indizio psicologico, sia pure marginale,<br />
intorno allo stato sorgente delle immagini. Nei pochi ritratti<br />
la mano insiste su itinerari intermedi, tangenti al cerchio e al<br />
quadrato, come ovali, spicchi, archi, mezzelune, crescenti, trapezi,<br />
angolarità differenti e frante, prese in un giro di movimenti<br />
che fanno pensare ai tracciati di Spazzapan o di Zigaina (Filatrice,<br />
Nudo seduto). Il volto di un contadino vien colto in controluce<br />
e composto su un ventaglio di semicerchi centrati lateralmente.<br />
Una vendemmiatrice segue una analoga legge generativa,<br />
complicata questa volta dal rapporto con i percorsi curvilinei,<br />
a fascio e matassa, dei tralci che la sovrastano.<br />
La stessa cosa, afferrata al suo inizio, si trova in qualche natura<br />
morta (Piatto con pera, ’51, ad esempio: in cui il piano è sventagliato<br />
a destra per tre volte sui colori primari. Coll. Di Capi).<br />
Ma stiamo anticipando. Il primo tempo (che si inoltra fino alla<br />
metà circa del 1951) è rappresentato, nella sua maniera più tipica,<br />
da energiche abbreviature. È vero che si configurano parallelamente<br />
diverse soluzioni, più riposate e magari più ricche, ma<br />
senza la scarna essenzialità di quel momento di slancio (e il suo<br />
vuoto d’aria) non ne comprenderemmo il principio orientativo.<br />
Abbreviare, poi, vuol dire sforbiciare, indurre tagli e dissezioni.<br />
Fatto sta che, recuperando a suo modo la tecnica delle carte incollate<br />
all’esercizio della tempera, Di Capi dipinge strisce di colore,<br />
ricavate alternativamente dal positivo e dal negativo degli<br />
oggetti, dall’ombra e dalla luce, una accanto all’altra. Le accosta<br />
e ne tiene impercettibilmente separati i margini. Non so se pensasse<br />
a regole auree, a rapporti calcolati di corrispondenza, ma<br />
l’idea poetica della scala armonica è senz’altro attiva di nuovo:<br />
in genere riferita a rime pari, sia nei valori ortogonali che negli<br />
incroci a chiasmo, o per entrambi contemporaneamente. Doppia<br />
la silhouette di una bottiglia, duplice o quadruplice l’invaso di un<br />
bicchiere, iterate le bande laterali, ultimo resto di un luogo stilistico<br />
tanto a lungo esercitato: la piattaforma della natura morta.<br />
Riaffiorano i bianchi in un clima d’acque ferme. Le altre colorazioni<br />
ovattate mediano gli scuri per registri graduati, disponendosi<br />
sui punti di orientamento della pianta a croce, vertici e centro.<br />
Talvolta un doppio centro. Ed è un modo per ribadire gli anel-
G. Di Capi, Natura morta, s.d., tempera su cartoncino, cm 50x35.<br />
506
li col passato. A voler schematizzare il percorso successivo, si rintracciano<br />
almeno due costanti, dialetticamente intrecciate: la<br />
tendenza a costruire l’omogeneo, un tout-se-tient sul piatto, e un<br />
complementare scioglimento dei legami, un introdurre vuoti, disarticolazioni<br />
e dinamismi di superficie4 : ciò che non vorremmo<br />
chiamare analisi, per la freddezza implicita in un simile termine,<br />
ma fluttuazione e formatività del segno. L’una punta sull’effetto<br />
"vetrata", come ha ben letto Schirolli, l’altra rimette in moto la<br />
linea, i profili. Libera effervescenze. Campiture vaporose e nebbie<br />
palpitano dentro griglie sottili, appena scalfite; vi aleggiano,<br />
mettendo fuori causa pesi e profondità5 .<br />
Che si tratti di persone o di cose, poco importa, tanto l’occhio rimette<br />
in posa, assesta e riquadra. Tranne esigue eccezioni (carte<br />
e tavole per il Suzzara), la vibrazione viene dal pensiero pittorico,<br />
quando è necessario, mai da un’attitudine fisica. Le figure riposano,<br />
i volti chini e quasi abbandonati stanno in attesa, segnali<br />
in certo modo anch’essi di uno stato riflessivo. Davvero si percepisce<br />
il silenzio guardandoli. Il vuoto determina la condizione del<br />
sentire le forme, è l’intervallo fra una cosa e l’altra. E vincere il<br />
vuoto, o meglio costringerlo ad accogliere misure, a farsi ‘contenere’<br />
dai mezzi del dipingere, è un compito della costruzione.<br />
L’artista è preso da questo pensiero inesauribile né intende, mi<br />
sembra, concluderlo con una cancellazione, facendo stravincere<br />
la forma. Che sarebbe forzato. L’autoironia, lo scetticismo, il male<br />
della perfezione nascevano forse anche da questo: dal dubbio,<br />
dal sentire che è raro trovare un assoluto e che i mezzi per imprigionarlo<br />
sono fatalmente insufficienti, se si eccettua qualche<br />
episodio irripetibile nella storia della pittura.<br />
A che valeva la presunzione? Era meglio commentare quegli episodi<br />
e inseguire, con acuta avvertenza di lettore, un tracciato toccato<br />
dalla perfezione, giottesco o morandiano6 .<br />
Eppure la reticenza è produttiva. Il senso dell’impossibilità finisce<br />
col segnare intensamente fogli e carte di lavoro. Se le superfici<br />
non sono preparate, lo si deve a questa interpellanza dell’informe,<br />
non ad approssimazione o a fretta. Semmai ad una avarizia<br />
che spinge ad essere essenziali, perché, in definitiva, i conti tornano,<br />
almeno in pittura.<br />
Quel che Di Capi lascia non è solo un insieme di tracce; è la pronuncia<br />
limpida di un problema, su quell’intervallo tra vuoto e<br />
forma che egli tenta di colmare andando da un polo all’altro, dal<br />
507<br />
G. Di Capi, Natura morta, 1952, tempera su carta, cm 61x47.<br />
configurare delle nebulose di segni alle sequenze continue. Problema,<br />
quest’ultimo, che tecnicamente apre una alternativa fra<br />
i poteri della linea e della campitura; ed ancora richiede di saper<br />
estrarre dei segni puri dalle somiglianze con le cose.<br />
Sulle carte i tratti dipinti denunciano da principio la loro provenienza<br />
dall’imitazione. Nascono da qui, per un lettore, desideri<br />
di riconoscibilità utili a decifrare la genesi di un tema stilistico7 .<br />
È ben chiaro, però, che l’autore avverte modernamente il fondo<br />
come entità priva di significato, senza-forma. Le superfici, le<br />
barre di colore vi si accampano ma non fanno presa. Nessun<br />
fondo le può garantire. Navigano cercandosi, poiché solo i rapporti<br />
danno senso ad una configurazione.<br />
Dominano i grigi, i bianchi, gli azzurri, i bruni e le terre, inframezzati<br />
da insorgenze di neri, rossi cupi e blu in controcanto, rapidi<br />
tasti sul registro generale dei colori smorzati. Dilaga l’acquario.<br />
Eccezionalmente una natura morta s’accende d’un acuto, di
un tagliente brivido cromatico, che è il segno di un istante che<br />
irrompe e scherza con le forme: per un attimo, come nella Fruttiera<br />
con uccellino del ’52.<br />
Motivi grigliati, liste curviformi e serpentine, trapezi fermi di colore<br />
appena stemperato portano ritmi verticali alle ultime carte.<br />
Ma il tono rimane quello delle elegie del ’51-’52.<br />
L’esercizio sulla curva che aveva dato gli ovali nei ritratti memori<br />
di Modigliani, si fissa su una geometria più severa, a ricorrenze<br />
binarie di archi e semicerchi. Il pittore crede nella forza risolutiva<br />
della simmetria e cerca i bilanciamenti sia nel fluido che nell’arrestato<br />
(ora prevalente). Se usa le asimmetrie, ne dispone più di<br />
una in parallelo a breve o a lunga distanza, con la coscienza che<br />
gli errori d’equilibrio servono a richiamarlo con più forza.<br />
Qual è il Di Capi più nuovo: quello teso a ricomporre l’unità o al<br />
contrario, il pittore che lascia correre il movimento? che concatena<br />
o scioglie? L’autore, per ricordare un esempio, della mirabile<br />
natura morta madreperla, degli ordini doppi o trinari, delle stilizzazioni<br />
sul piatto, o colui che disloca le somiglianze ed incentiva<br />
gli slittamenti?<br />
Da una parte sta l’esigenza della grazia, dall’altra l’interrogativo<br />
sulla sua fragilità. Sappiamo che sono complementari.<br />
Anche le composizioni decisamente astratte del ’52 lasciano<br />
aperto l’indecidibile incontro del vuoto con la forma, lavorando<br />
ora sulla stabilità ed ora sulla oscillazione, per morbide scacchiere<br />
o per pendolarismo e diagonalità.<br />
Quando l’alternativa sembra risolta, nelle tempere estreme, leggere<br />
distonie inquietano dall’interno il comporre. Il vuoto scivola<br />
sui bordi, li disfa e se ne lascia disfare impercettibilmente.<br />
No alla solidificazione8 .<br />
1. Ciò non toglie che qualche volta la tempera preceda un olio e ne sia la forma<br />
prefigurante, la stesura che lo anticipa, o anche l’assaggio analitico compiuto di<br />
una struttura, poi risolta con modi propri. Lo si può misurare confrontando le tessitrici<br />
n. 1 e n. 2, nudo e figura definitiva, 1950. Gli esiti sono ugualmente pregnanti.<br />
Nella mietitrice del ’51 l’olio è, poi, sostanzialmente trattato come nelle carte a<br />
tempera: stessi gesti dell’Aratura.<br />
2. A guardar bene, la composizione sembra derivare dal motivo della gabbia con<br />
uccellino, svolto nel ’52, ma stilisticamente l’opera é vicinissima alla “natura<br />
morta araldica” del ’50. Poiché Di Capi non era insolito a riprese, potrebbe essere<br />
giustificato uno spostamento della data in avanti. Le ragioni sono però più<br />
contenutistiche che formali.<br />
3. Si tratta di una lastra recentemente ritrovata (ora di proprietà Nenci, Mantova),<br />
che assieme ad altre otto, dovrebbe essere tirata in pochi esemplari, a cura<br />
508<br />
della vedova del pittore e del Museo Civico, forse in occasione della mostra. Sono<br />
visibili presso il proprietario alcune prove di stampa in attesa di autentica. La<br />
punta secca cui alludiamo presenta una veduta in verticale, con un nudo sdraiato<br />
sull’erba, affiancato da un treppiede per dipingere provvisto di tela e sormontato,<br />
oltre il profilo di una fabbrica, dal sole. Il segno è fortemente allusivo. La interpretiamo<br />
come uno svolgimento lirico dei luoghi della pittura (mm. 200 x 92).<br />
4 È la relazione tra le cose che interessa all’artista, il legame (non di natura né<br />
prospettico) che la mente intravede fra un oggetto e l’altro. Per questo ho scelto<br />
di impiegare un termine (e un concetto) come quello di ‘vuoto’ che mi sembra<br />
dar conto del confronto dell’artista con l’informe: lo ‘spazio tra’ da colmare,<br />
da rendere significante.<br />
5. Un ritorno di atmosfericità? Lo si può ammettere, purché si dia ad essa un significato<br />
antinaturalistico, di luce impalpabile, proveniente dall’interno dei luoghi<br />
dipinti. Quest’atmosfera richiede tempo di lettura e dunque ha carattere contemplativo.<br />
6. Tra i gesti più tipici di Di Capi vi è il cerchio, con le sue varianti. Le figure disegnate<br />
ne sono piene. È una memoria classica? Sembra in certi casi trasferirsi<br />
dai volti alle cose.<br />
7. Questo desiderio aiuta, per altro, il processo di dissociazione del ‘motivo’. Cfr.<br />
Composizioni astratte (cat. nn. 88, 88 b), 1952, Coll. G. Venturini, tra le più belle<br />
per la impaginazione a sequenza libera verticale.<br />
8. Il testo di G. Braque cui si è fatto riferimento all’inizio, comparve sui “Cahiers<br />
d’Art”, 1935, p. 21 ed è accessibile in trad. it. nella antologia delle poetiche figurative<br />
di A. Pozzi e P. Vandelli, Da Cézanne ai surrealisti, Paravia, Torino 1977,<br />
pp. 122-4. L’altra citazione, tratta da Le jour et la nuit 1917-52, Parigi 1952, segnala<br />
nell’originale un rapporto di reciprocità: “Amo la regola che corregge<br />
l’emozione e l’emozione che corregge la regola”, cui segue: “L’Arte vola in alto,<br />
la Scienza procura dei puntelli” (trad. di L. Vinca Masini).<br />
È di Chiara Perina l’espressione fra virgolette sul tono drammatico dell’autoritratto<br />
del ’34 (v. E. Marani-C. Perina, Mantova - Le Arti, III, cap. “Fra Otto e Novecento”,<br />
Istituto Carlo d’Arco, Mantova 1965, p. 663. Nel dare una testimonianza<br />
orale, molto preziosa, E. Marani mi ha segnalato lo stretto rapporto fra Di Capi e<br />
De Luigi intorno al “costruire col colore”, specie alla fine degli anni Trenta, insistendo<br />
inoltre sul carattere antiletterario, rigorosamente visivo, del loro modo di<br />
intendere la pittura. Sue anche le numerose precisazioni sui legami con la cultura<br />
fiorentina (ma di questo si è occupato Margonari nel saggio che precede).<br />
Altre notizie sono state rilasciate da F. Ruberti, A. Seguri, G. Perina C. Bondioli. A<br />
quest’ultimo, in particolare, sono debitore di stimoli sullo “spirituale”, ricchi di<br />
spunti interpretativi, tra i più pertinenti dei lavori astratti. Ecco un passaggio della<br />
sua conversazione: “perché meno Picasso? Il fatto è che Di Capi non teneva alla<br />
resa evidente dell’oggetto. Non che lo rifiutasse, questo no. L’oggetto restava ma<br />
veniva trasfigurato (...). In molti quadri di Picasso è fortissima la volontà filosofica,<br />
l’intenzione, l’idea di dar corpo alla dimensione dello spazio e del tempo. In<br />
Braque invece (e in Di Capi) l’immagine si fa più spirituale. È non a caso che Braque<br />
precede Mondrian. Tutti pittori dell’atemporalità. Metterei nell’elenco anche<br />
Klee, benché Giordano avesse visto poco o quasi niente dal vivo. Conosceva Klee<br />
quasi esclusivamente attraverso le quadricromie. È una linea della bellezza in cui<br />
la dimostrazione è totalmente bandita e conta all’opposto il puro fatto estetico.<br />
Anche Di Capi pensava a strumenti proiettivi nuovi che gli permettessero di dar<br />
vita ad un’eloquenza non divulgativa”. Per la datazione delle opere mi sono attenuto<br />
principalmente ai ricordi della Sig.ra Aldina Menegollo vedova del pittore,<br />
che è stata larga di notizie, consentendomi di fissare alcuni nodi cronologici<br />
precisi, nonché di ampliare la documentazione bio-bibliografica sull’artista.<br />
(1) Scritto in occasione della mostra “Giordano Di Capi. Opere 1930-<br />
1953”, tenutasi a Palazzo Te, Mantova, settembre-ottobre 1982.
Il codice del nulla<br />
Giuseppe Botturi (1)<br />
C’è in Botturi una rinnovata scommessa a favore della combinatoria:<br />
una combinatoria beninteso arbitraria, che mentre insegue<br />
particolari cadenze numeriche, cerca fonti e figure nei paesaggi<br />
semicancellati del passato e trae spunti dovunque l’archeologia<br />
fantastica suggerisca larghi margini di congetturalità. La sua ossessione<br />
è la griglia, il rettangolo e il quadrato magico, l’acrostico,<br />
grazie ai quali balena il miraggio di una lingua universale non<br />
ancora nata, che sappia coniugare gli elementi dispersi del visibile,<br />
stabilire connessioni ed incastri.<br />
Raramente il singolo foglio disegnato può vantare una propria autonomia<br />
compositiva. Più spesso fa parte di una sequenza, così<br />
come gli altri oggetti (le scatole o i cilindri a spirale, i codici e le<br />
mappe) costituiscono i paragrafi di un racconto e vivono, nonostante<br />
l’estensione, più nel tempo che nello spazio. Si sottraggono<br />
anzi, per quanto è possibile, alla presa fisica dello sguardo, fanno<br />
in certo modo della prosa visiva rinunciando alla corposità del<br />
segno e all’allettamento materico delle paste colorate.<br />
Già qualche anno fa (e non a caso) quando Botturi dipingeva<br />
quadri nell’accezione consueta del termine, il fondo della tela restava<br />
in parte scoperto o appena velato da una colorazione fluida,<br />
quasi impalpabile e senza peso; ed insieme al piano d’appoggio<br />
anche le immagini esibivano una presenza umbratile,<br />
come se veleggiassero lungo correnti d’aria e potessero cambiare<br />
di posto, scorrere sullo schermo del dipinto. Quest’attitudine a<br />
spogliare lo spazio si è ora approfondita fino ad accecare quasi<br />
del tutto il colore, con la conseguenza di spostare il disegno<br />
verso la pratica della scrittura e della ideografia. Nient’altro che<br />
scritture sono infatti gli elementi di questa affabulazione disossata,<br />
ridotta ad una trama di fili, sia nel caso dei motivi inchiostrati<br />
sulla carta che delle materie naturali, quali fibre, sabbia, oli<br />
o pietre, deposti nel letto delle “scatole” o in luoghi pittoricamente<br />
neutri e poverissimi. Mediante la sequenza viene ordinato<br />
un campo temporale in cui i segni acquistano valori di lettera<br />
e di cifra, scandendo la nascita di un alfabeto elementare ed allusivo.<br />
Che cosa indicano? Quale azione promuovono?<br />
Di primo acchito vien da pensare ad una archiviazione topogra-<br />
509<br />
fica di emblemi e di simboli, ad una sorta di collezionismo figurale.<br />
Senonché questo archivio non lascia intatti i segni che accoglie,<br />
li spreme secondo una chiave cerimoniale e li trasforma.<br />
Per di più contamina una mitografia oggettiva, quella del paesaggio<br />
supposto archeologico, con una storia personale, cioè con<br />
scavi soggettivi e diaristici. La configurazione dei reticoli in forma<br />
di nota, l’andare per appunti, il camminare per mappe provvisorie<br />
e talora impraticabili introducono qualcosa che richiama la<br />
casualità della réverie e la rarefazione del sogno. In tal modo realtà<br />
ed immaginazione si confondono incentivando gli sdrucciolamenti<br />
nell’uno e nell’altro senso. Quel che resta è una figura<br />
fantasma, il desiderio di una lingua, spesso una increspatura di<br />
segni che vengono dal niente per andare verso un altro niente.<br />
Il Codice del nulla è probabilmente fra tante congetture, il meno<br />
azzardato.<br />
La griglia serve allora a far cagliare il poco, il quasi niente, quel<br />
possibile che corre da una stazione all’altra per attirarlo e dargli<br />
un senso. Ostinatamente ancorato al simbolismo del cinque, la<br />
progressione denuncia una forte presunzione sintetica, coagulante.<br />
Vuol far riposare l’annuncio di un segno e dargli tempo di<br />
nascere.<br />
Ecco i riti del sonno. Le pietre e le fibre riposano nei tumoli. Botturi<br />
li chiama sepolture, ma dentro non troviamo dei morti. Tant’è<br />
vero che, dopo averli interrati, torna ad aprirli. Li mura e li riapre.<br />
Li dissemina anche, seguendo certi tempi e durate, nei luoghi<br />
di passaggio di una superficie urbana, lungo i camminamenti,<br />
vicino alle porte e agli ingressi, così che la città diventi davvero<br />
madre del codice immaginario: metro-poli.<br />
Ne viene fuori una geometria del riposo, incolore, senza timbro<br />
avvertibile poiché anche il bianco, che qui dà il tono dominante,<br />
non è ravvivato da pigmenti ed è semplicemente un lenzuolo sul<br />
quale giacciono polveri di segni. Il foglio è un arredo accogliente,<br />
un letto misurato sul numero delle dita, simbolo forse dell’uomo<br />
e della totalità del sensibile. Temi e grafie, per ora, di un<br />
inizio.<br />
(1) Scritto in occasione della mostra “Giuseppe Botturi”, Galleria d’Arte<br />
“Ferrari”, Verona, 1982.
1983<br />
Da Valentino Vago<br />
a Yasmin Brandolini d’Adda<br />
Ritmiche dell’ascesa<br />
Valentino Vago<br />
Dopo il tutto<br />
Concetto Pozzati<br />
Ad occhi chiusi<br />
Sculture di Nenci al Te<br />
Svolte e ritorni<br />
Giovanni Bernardelli<br />
L’occhio del cielo. Miraggi<br />
Carrozzone Magazzini Criminali<br />
Sulla soglia delle figure<br />
Sonia Costantini<br />
Fotografare come un gotico<br />
Christian Schad<br />
Risanare l’ombra<br />
Renzo Schirolli<br />
Cere come stanze mentali<br />
Giovanni d’Agostino<br />
Cartomagie<br />
Yasmin Brandolini d’Adda
Ritmiche dell’ascesa<br />
Valentino Vago (1)<br />
C’è un avvertimento della Gaia scienza che può servire da preludio<br />
per accostare la pronunciatissima astrazione lirica di Valentino<br />
Vago. Scriveva Nietzsche: tutto quanto viene costruito e plasmato<br />
in una forma “o appartiene all’arte monologica, o all’arte<br />
in presenza di testimoni”. E proseguiva precisando che la sospensione<br />
del mondo costituisce l’elemento essenziale di un’arte<br />
della solitudine. “Essa ha la sua base nell’oblio, è la musica<br />
dell’oblio”.<br />
Quel che provo davanti alle tele è un transfert, la spinta a portarmi<br />
altrove; un’esperienza della cancellazione. Non che manchino<br />
i suoni o che sia assente una lingua, poiché è vero piuttosto<br />
il contrario. La lingua c’è, perfino sfolgorante, irradiata e assoluta.<br />
L’insufficienza che avverto riguarda il linguaggio del<br />
mondo, voglio dire un’insufficienza conseguente alla “musica<br />
dell’oblio”.<br />
Che cosa è dunque all’opera? Chi sospende lo sguardo ed insieme<br />
parla? Intanto registro un trascorrere di fuochi e una metamorfosi<br />
di emergenze. Delle vere e proprie nascite. Le chiamerei<br />
volti e presenze, se con ‘volto’ conveniamo di intendere qualcosa<br />
di originario, un affacciarsi e venire incontro di sostanze e<br />
corpi, qui diafani, vibranti, smaterializzati, in trasformazione. C’è<br />
un desiderio di riconoscimento, una domanda di voci prime e di<br />
nomi nel pulsare dei colori e nelle forme sottratte alla prigionia<br />
delle cose.<br />
Potrei dire, impiegando una formula romantica, di avere a che<br />
fare con una espressione geroglifica, ossia con una lingua che si<br />
fa universo e non parla più del mondo, ma è essa stessa un<br />
mondo nell’atto di esprimersi. Se cosmico è attributo ricorrente<br />
nelle letture di Vago, esso viene ad indicare, certamente non a<br />
caso, il senso di una cosmicità e di una genesi divenuti immanenti<br />
al costituirsi stesso delle forme nell’ordine del dipingere.<br />
Ragion per cui le analogie e le metafore, di cui indubbiamente<br />
è dotata la pittura, non si riferiscono a ciò che sta fuori dalla tela,<br />
giacché questa non è lo specchio, una trasfigurazione magari sublimata<br />
del reale, ma fanno capo ad una catena interna di rapporti.<br />
Vivono insomma dietro una rete autonoma di somiglianze.<br />
Vedo anche che una simile cosmicità punta sulla consonanza dei<br />
512<br />
segni, come se il conflitto fosse un antefatto dimenticato e tutto<br />
cooperasse ormai all’unità dell’organismo compositivo. L’affiorare,<br />
il venire in primo piano di una forma appartengono inoltre ad<br />
una ritmica dell’inizio, costituendo contemporaneamente una invariante<br />
tematica di tono positivo. Niente cadute e vuoti. Una<br />
volta avviato il processo del comporre, la forma grida l’eccomi!<br />
d’una creatura, l’”io sono” di un insieme cromatico. Come chiamarli<br />
questi corpi privi affatto di gravità materiche, ma alla cui<br />
costituzione coopera nondimeno una memoria lontana della<br />
concretezza? Talora una atmosfera diffusa di fumi perlacei e di<br />
nebbie? Il fatto è che l’aereo e l’astrale disincarnano la natura,<br />
trasferendola nelle regioni di un’esistenza espansiva, fatta di alonature,<br />
echi, riverberi. Tutta la prima stagione di Vago è percorsa<br />
ed in certo modo ossessionata dal fantasma della nascita.<br />
Anche le intitolazioni contengono dei segnali e aiutano quelle<br />
didascalie, pur minime, che in seguito scompariranno del tutto.<br />
Che altro vengono a mostrare parole come apparizione, immagine,<br />
distensione, o termini estratti da una sorta di archetipologia<br />
geometrica, quali linea, quadrato, forma, orizzonte, se non<br />
un animato risalire di corpi eterei dall’ombra delle materie? se<br />
non un vocabolario luminoso? Le lettere, o meglio le figure sono<br />
infatti entità vive dell’immaginazione, poiché i nomi sono esseri<br />
e gli esseri nomi di un puro universo di cifre. Volti ed aspetti<br />
della genesi; e della pittura come genesi.<br />
Per comprendere questa curvatura fantastica, bisogna afferrarne<br />
l’ipostasi che la sorregge e che deriva, come si diceva, da<br />
un’epoché armonizzante. Obliato l’invivibile diurno, l’insieme fissato<br />
e petroso dei fenomeni, il paesaggio viene rifatto nel pensiero,<br />
ricominciando dai suoi elementi essenziali: il colore, la<br />
linea, lo spazio. Così la materia è anch’essa risospinta al suo principio<br />
generatore, a quel mitologema ben noto alla fantasia visionaria<br />
che è la luce. Non però la luce accecante, “nera”, della<br />
mistica negativa, dei soli scuri e mortali di Rembrandt e Kokoschka,<br />
ma quella neoplatonica, bianca, drammatica certo, ma<br />
salvifica, dell’orfismo. L’andirivieni segmentato dal mondo al sovramondo,<br />
dall’oscuro al chiaro e nuovamente al buio, lascia<br />
posto ad un tragitto unico ed assetato nella luce, alla risalita. Peripezia,<br />
questa, sempre più inquietata, dilagante e senz’altro corale<br />
nelle opere degli ultimi anni, dove un’azione, quando vi ha<br />
posto, disegna dei gradi della incandescenza ed è un morire e
nascere della luminosità a se stessa.<br />
Le icone del ’60-’62 mostrano ormai in atto la produzione di una<br />
chiarezza per via di effrazione. Le immagini si aprono, disserrando<br />
dei nuclei positivi; si distendono e bilanciano, coagulano dei<br />
rapporti d’unione. Le loro ferite non sono tagli, ma sorgenti di<br />
fuochi in espansione. Una metrica dell’irraggiante. Si consideri,<br />
per esempio, il rosso. Non ha nulla di sanguigno e di corposo;<br />
non fa grumi. È piuttosto un timbro sonoro, una vibrazione, un<br />
evento acustico e spesso un incendio.<br />
Decantati a forza di levitazione i detriti e le scorie, pencola sul<br />
più e sul meno, modellando dei battiti. Divide e riunisce. Cerca<br />
delle cromìe solidali con le quali mettere in circuito delle gravitazioni.<br />
Vien fuori quel che il pittore chiama una presenza, o anche<br />
un’anima o un soffio: il primo attante della sua scena mentale.<br />
Non si creda però ad un facile equilibrio degli opposti, tant’è<br />
vero che appena lo spazio si dilata e quella presenza cerca un riferimento<br />
amplificato verso altri valori luminosi, può incrinarsi e<br />
cadere. Quando si è trattato di passare dal piccolo al molteplice,<br />
da una a più alitazioni, la rottura è difatti avvenuta in modo flagrante,<br />
tanto da mettere in dubbio il telos stesso dell’accordo. La<br />
tempesta dello sfondo, rivelatosi un’energia straripante (e un’insorgenza<br />
del caos), disarticolava le configurazioni minori. Impadroneggiata<br />
com’era, spezzava e frantumava, sprigionando quell’antiforza,<br />
quel niente, che più di ogni altra cosa l’artista teme<br />
V. Vago, E 291, 1973, olio su tela, cm 180x240. V. Vago, M.R., 1974, olio su tela, cm 150x200.<br />
513<br />
perché impedisce il generarsi armonico della lingua per partiture<br />
continue.<br />
Ne sanno qualcosa gli Orizzonti sconvolti del ’63 che hanno richiesto<br />
tutta una serie di assestamenti, di calibrature e di messe<br />
a punto analitiche del campo visivo e quindi un confronto col sapere<br />
‘astratto’ del Novecento, una ripresa che ora diventa non<br />
soltanto limpidamente consapevole, ma necessaria per risolvere<br />
un problema generale di struttura. Se fino a questo momento,<br />
nell’invenzione di un solo nome, lo sguardo ha saputo cavare da<br />
sé l’immagine nascosta, tenendosi in certo modo ancorato agli<br />
accertamenti intuitivi della forma, stando cioè in consonanza indiretta<br />
con le figure dei grandi visionari, d’ora in poi - almeno per<br />
un certo periodo - la riconquista della luce passa attraverso le<br />
verifiche esplicite del “basso continuo”, della teoria e di una situazione.<br />
Influisce, per esempio, il Licini ultimo, o quella sua<br />
parte più celeste e meno demoniaca, direi quasi senza coda e<br />
angelica, dalla quale viene il magistero cristallino degli spazi.<br />
Cosa che apre un curioso paragrafo dentro il capitolo finalmente<br />
attivo dell’errante nelle stratosfere del Settentrione, mentre<br />
l’eretico/erotico sarà da vedere altrove nel ritorno alle Madri.<br />
Oppure viene ad incidere una microstruttura kleeiana di bande e<br />
tastiere, fatta trasvolare insieme all’arricciatura di un filo di luce,<br />
ad un segmento o al bordo incipiente di un “planiti”. Fatto sta<br />
che a poco a poco si configurano delle pluralità di tempi e luoghi.<br />
La linea d’appoggio si ricompone e questa pur sottilissima
linea costituisce la chiave di volta dell’intero piano orbitale.<br />
Quanto allo schema segreto da cui un simile cardine deriva, non<br />
pare azzardato pensare ad un punto di vista vagante, ad una<br />
sorta di croce, di germe reticolare o di embrione a scacchiera in<br />
continuo slittamento. Se una forma si estende e dilata, è bensì<br />
vero che il movimento batte dei sentieri privilegiati in verticale<br />
o in piano, per via di ripetizioni intensive e fasce parallele. Segno<br />
che la mobile griglia d’origine, quell’incrociamento di fratture e<br />
riprese che è l’icona della presenza, sta producendo una scansione<br />
di cerniere: l’orizzonte di uno spettacolo immaginario.<br />
Perché un orizzonte? Dal momento che tutto viene giocato sul-<br />
V. Vago, Presenza, 1962, olio su tela, cm 130x163.<br />
514<br />
l’irradianza e manca il sussidio laterale delle quinte, lo scenario<br />
esige dei confini per disegnare una topologia degli spazi recitativi<br />
che sia funzionale all’ingresso o all’uscita dei segni. Detto in<br />
altri termini, è la temporalità del quadro, la sua ripartizione in<br />
tappe a richiederlo. Il bisogno della sequenza e dell’assembramento<br />
di istanti. L’orizzonte è poi il limite, la zona di passaggio<br />
e il bordo entro il quale l’informe, vale a dire la percussività anarchica<br />
del colore viene costretta a modellarsi. Manifesta dunque<br />
l’esigenza di serrare nell’articolazione un flusso altrimenti imperimetrabile.<br />
L’essere ancora attraversabile, resta comunque nella<br />
natura di questo confine, sicché un segno quando viene ad in-
V. Vago, P.C. 78, 1982, olio su tela, cm 200x150.<br />
515
crociarlo prosegue nel suo percorso, non muta traiettoria, ma ne<br />
esce come rifratto continuando la corsa in un riverbero di echi. A<br />
metà tra forma e non-forma, non ancora del tutto segno parlabile<br />
ma nemmeno più corrente irreggimentata, l’immagine vive<br />
nella dimensione fluida dell’edenico.<br />
Non ha significato; tuttavia, proprio perché si grammatizza in un<br />
ordito nascente, tende ad averlo.<br />
È volontà di senso appoggiata al puro fianco del colore.<br />
Se aduniamo il corteo delle somiglianze interne, l’intermittente<br />
suite dell’aereo e del luminoso, una figura forse potrebbe riassumerle.<br />
È quella del lampo, di un abbagliamento del pensiero anteriore<br />
ai fulmini e ai fuochi reali: la forma-lampo di uno spirito<br />
meditativo. In certe occasioni la vediamo rimbalzare da un capo<br />
all’altro della superficie, mettendo in chiaro un’altra tendenza di<br />
fondo, che è l’aspirazione al grande e all’avvolgente. Dilatare il<br />
quadro, oltrepassare l’ordine percettivo della cornice, assorbire<br />
psichicamente lo spazio dell’osservatore in un’unica mareggiata<br />
cromatica ed infine fondare su un simile incontro la solidarietà<br />
col riguardante, rendendolo co-autore di un evento contemplativo,<br />
rappresenta, per altro, una delle più appassionanti ragioni di<br />
confronto fra la pittura italiana e quella statunitense, per suo<br />
contro nutrita di molteplici spinte storiche europee. Vi si raffrontano<br />
due soglie della visione, oggi tutt’altro che esaurite. Già all’origine<br />
il ‘grande’ è implicato, in Vago, dall’idea di stendere velari<br />
e trasparenze. Il quadro viene dipinto come se fosse un affresco,<br />
la tela un muro o una parete, un ‘murale’ in potenza,<br />
come osservava vent’anni fa Ballo con felice intuizione. Non solo<br />
il quadro da allora si allarga fino ad assumere sintomaticamente<br />
le misure di uno schermo eccedente le proporzioni fisiche di<br />
chi lo osserva, obbligandolo ad uscire da se stesso, ma il supporto<br />
svolge un ruolo attivo, è già pittura virtuale. Non perché<br />
assuma una funzione cromatica speciale restando grezzo o scoperto<br />
da qualche parte, ma perché vive nel ricambio dei toni,<br />
come può vivere uno strato sottostante che respira insieme alle<br />
stesure successive. Non si comprenderebbe altrimenti il passaggio<br />
naturalissimo, quasi senza sforzo, ai due recenti cicli parietali<br />
di Barlassina, entrambi realizzati nell’invaso di spazi comunitari:<br />
una banca artigiana e una chiesa. Di modo che oggi tela e pittura<br />
murale convivono fianco a fianco, o sono addirittura la stessa<br />
cosa.<br />
516<br />
Diceva Kandinsky, a proposito di “nuovo futuro romanticismo”,<br />
che la parte nuda è l’inedito sì contro il rumore, la distrazione,<br />
l’accidentalità caotica e parassitaria del quotidiano: “Chi sa veramente<br />
sentire, con l’intensità dell’esperienza vissuta, la parete<br />
nuda, è preparato nel modo migliore per vivere l’esperienza di<br />
un’opera pittorica: la parete bidimensionale, perfettamente liscia,<br />
verticale, proporzionata, “muta”, sublime, che dice di sì a<br />
se stessa, rivolta in sé, limitata all’esterno e irraggiantesi verso<br />
l’esterno, è un elemento quasi primario”.<br />
La congiunzione dell’intimità con la grandezza, della solitudine<br />
con lo spazio aperto parrebbe un paradosso. E senza dubbio lo<br />
è, ma contraddittorio, se questo ‘dentro’ deriva da una storia privata<br />
e rifluisce nell’intimismo del diario soggettivo. Ma qui non<br />
v’è soggettivismo. Tanto più intima, nel senso alto del termine,<br />
è la grandezza quando sprigiona immagini ignote, dense come<br />
archetipi, dalle quali l’ocularità del fuori è posta fuori gioco; che<br />
assorbono lo sguardo della mente e vi si fondono. Allora si dà<br />
come unità interiore del pensiero; ed è anche un segno del<br />
maestoso. L’implicita religiosità delle figure è proprio ciò che, nel<br />
nostro caso, occorre in definitiva ribadire. Lo sviluppo dimensionale,<br />
con i suoi precisi corollari stilistici e tematici, lo richiede.<br />
Il protagonismo della luce ha prodotto una coralità di presenze:<br />
una scena e un’azione. Osservo dei segni e contemporaneamente<br />
ne sono guardato. I parapetti del vedere, gli orizzonti, i<br />
piani d’appoggio e i tralicci sono duplici. I miei si spostano mano<br />
a mano che passo davanti alle tele, mi avvicino e allontano. Ma<br />
sono poi soltanto miei? Non sto seguendo degli altri sguardi? Ed<br />
in fondo agendo empaticamente in sintonia con la luce? Ci sono<br />
degli ideogrammi che fanno da catalizzatori, quasi delle “finestre”<br />
aperte dall’alto, delle triangolarità appena accennate, delle<br />
barre e delle cerniere.<br />
Punti, croci e tasti. A Barlassina, nella cupola ottagonale e nel<br />
presbiterio (una fabbrica per altro duramente estranea ed aggiunta<br />
all’edificio barocco di S. Giulio), trovo delle chiavi di raffronto.<br />
Lì Vago ha dovuto delineare degli equivalenti, decidere e<br />
predisporre un glossario ‘umile’ della sua mitografia. Sotto la<br />
grande spirale bianca, giallo-azzurra (ancora un lampo! e un abbagliamento)<br />
in discesa/ascesa, ha lavorato di citazioni, lui pur<br />
così restio all’esercizio del tradurre. Una concessione “popolare”<br />
(nonostante i referenti raffinati), ma anche generosa e difficile,
che il torrente luminoso produttivamente riassorbe. La vera azione infatti sovrasta le<br />
stazioni letterali e riconoscibili. Le autentiche icone sono il fiume cromatico, gli ideogrammi<br />
e le barre, tutto il vortice delle trasparenze. Proprio il medesimo dramma<br />
delle tele. Anche il bilanciamento della luminosità proveniente dalle aperture murarie<br />
serve all’unico macrosegno, all’environment prodotto nel cavo mediante spinte<br />
e controspinte, di modo che il citazionismo viene nella sostanza negato per ciò<br />
che di eteroclito (e combinatorio) questa procedura di solito comporta. D’après e<br />
plurilinguismo stanno davvero agli antipodi della grammatica dello scintillamento.<br />
Là dove una forma tira l’altra non sussiste pittura a programma. Eppure una confi-<br />
V. Vago, P.E. 96, 1972, olio su tela, cm 240x180.<br />
517<br />
gurazione triadica è lentamente emersa<br />
col tempo nei quadri. E s’impone. Con insistenza<br />
via via maggiore una, due, tre sottili<br />
architetture aeree incidono lo sfondo,<br />
dialogando con la tessitura delle effervescenze<br />
e col paesaggio, ora tumultuante<br />
ora rasserenato, in retroscena. È una crocifissione<br />
del colore, una passione della luce,<br />
iconologicamente attiva come via crucis<br />
mentale di specie radiosa. I punti sono<br />
‘occhi’ e pupille. Ed i fili arricciature di<br />
nembi ed ali. Per questo si invoca il silenzio.<br />
Quale silenzio? Se Vago dichiara di essere<br />
colto da afasia di fronte alle sue tele;<br />
se, com’egli dice, “ogni crescita dell’immagine<br />
è sottrazione di parola”, non è certo<br />
l’azzerante arsura dell’aorgico cui vuole alludere.<br />
Questo nulla radicale gli è in realtà<br />
estraneo. La parola tace perché abbia<br />
luogo una lingua piena, totale: quella rigeneratrice<br />
della manifestazione.<br />
(1) Scritto in occasione della mostra “Valentino<br />
Vago”, Padiglione d’Arte Contemporanea, Milano,<br />
11 marzo-11 aprile 1983.
Dopo il tutto<br />
Concetto Pozzati (1)<br />
…Pozzati aveva abbastanza da spartire, era stato in quell’occasione<br />
che avevamo avuto la possibilità di intessere un confronto<br />
con autori con i quali Pozzati da tempo intrattiene per lo meno<br />
una relazione, non dico un rapporto strettissimo, ma certamente<br />
una relazione di dibattito, di discussione. Si trattava di Bonfiglioli,<br />
Boarini e Boatto, che credo abbiano contato qualcosa nella<br />
storia critica di Pozzati, della letteratura critica intorno a Pozzati.<br />
Poi c’è stata la mostra di Suzzara, nel corso della quale Umberto<br />
Artioli ha potuto intervenire direttamente sul lavoro di Pozzati<br />
del ’79, su quella tematica del bacio e della spada, che credo<br />
prosegua nei lavori che questa sera noi presentiamo. Si tratta infatti<br />
di un ciclo di dipinti, leggo dal frontespizio del libro che questa<br />
sera vi proponiamo, a tecnica mista: 301, cioè una introduzione,<br />
un incipit, più 300 dipinti, che cadono sotto il titolo di<br />
"Dopo il tutto". Come dicevo mi pare che ci sia una forte continuità<br />
tra le cose viste nella mostra di Suzzara e queste riprodotte<br />
nel libro. Avremmo voluto certamente intervenire, almeno per<br />
quanto mi riguarda, in maniera più incisiva su quanto Pozzati va<br />
componendo proprio perchè riteniamo che il suo lavoro sia<br />
estremamente articolato e importante, quindi cercheremo di<br />
dire qualcosa su questo lavoro sapendo bene che probabilmente<br />
si tratterà di un attraversamento dell’opera abbastanza occasionale;<br />
ci riserviamo di intervenire in modo più incisivo in seguito,<br />
intanto questa è una ragione per cui le nostre (mie e di Baratta)<br />
non saranno delle presentazioni, come suona l’indicazione dell’invito,<br />
ma piuttosto delle letture a ridosso e successive al discorso<br />
che Pozzati farà sul suo lavoro, sia parlandone, sia presentando<br />
l’immagine di questo "Dopo il tutto".<br />
Comincerò ad azzardare qualcosa sapendo bene di non poter<br />
fare una lettura esauriente; mi sono notato alcuni temi che Pozzati<br />
ha enunciato; ha parlato di un bianco lattiginoso, di isole. La<br />
prima constatazione è naturalmente evidentissima: le immagini<br />
i segni le cose che ci dà Pozzati stesso, il bambolotto appeso,<br />
galleggiano su un universo di elementi ‘indifferenti’, disegni che<br />
sono tra di loro commutabili, intercambiabili, svuotati, cioè collocati<br />
in un universo di simulazione. È scattato un corto circuito<br />
518<br />
nei meccanismi dialettici del regime duale, della opposizione,<br />
non è possibile distingure tra un vero e un falso, tra la vita e la<br />
finzione, tutto è sovrapponibile. Ci dice anche che egli ha raccolto<br />
una biblioteca, un catalogo, ha fatto un inventario, che di fronte<br />
ci troviamo degli scaffali con delle coste di libri più all’inizio<br />
che libri aperti. Ha evocato il diluvio, la fine della storia; quale<br />
storia? Quella sorretta da un télos, quella che aveva un futuro.<br />
Ma mi sembra che dopo quella storia una nuova cominci, una<br />
svuotata dalle presunzioni della storia precedente. La domanda<br />
a questo punto è: anche il pittore è indifferente di fronte a questo<br />
universo di segni in cui non agisce più la differenza? Egli mi<br />
pare abbia reclamato più volte il diritto della sua soggettività, sia<br />
pure sottolineandone l’aspetto precario, e una soggettività che<br />
ha i caratteri del desiderio; in certi momenti ha parlato di un piacere<br />
del disegnare, del ripercorrere certi segni; ci ha detto che il<br />
disegno è un elemento di uniformazione, di resa del tutto ad un<br />
tutto uguale, e tuttavia però non può privarsi del diritto di segnare<br />
dei percorsi molto precisi in cui una soggettività comunque<br />
vien fuori e allora di fronte a questa grande tavola, a questo<br />
insieme di loculi, come lo ha chiamato, a questo apparente<br />
cimitero fluttuante, si genera una catena di incontri. E mi pare<br />
che attraverso la sovrapposizione alcuni luoghi, almeno dieci,<br />
stando all’opera definitiva, quella esposta e fotografata in catalogo,<br />
almeno dieci di questi luoghi emergano sopra agli altri,<br />
quelli che Pozzati ha chiamato “le mie isole”, o le isole che in<br />
qualche modo si sono configurate. Dunque se il pittore non è del<br />
tutto indifferente, se c’è in qualche modo la precarietà del soggetto<br />
a riproporsi di nuovo ed a installarsi nel segno, il suo è in<br />
qualche modo anche un addossamento, è uno stare ‘da vicino’,<br />
è un incollarsi alle cose; c’è una vecchia polemica che Pozzati ha<br />
riportato qui e ha gia discusso qualche anno fa, della serie che<br />
ho ricordato prima, la polemica contro il d’aprés, cioè contro una<br />
lettura della ripetizione, della ripresa delle figure in termini di<br />
prospettivismo, in termini di storicismo: quello ha rifiutato da allora<br />
e continua a rifiutarlo. Quello che mi interessa dire è che c’è<br />
un attaccamento alle figure, alle immagini che diventano da lontano;<br />
Pozzati parla di amori “da lontano” ad un certo momento,<br />
però questi amori da lontano si individualizzano all’avvicinamento,<br />
hanno qualcosa anche di plastico, di tattile, questo mare<br />
lattiginoso ad un certo momento si individua, si arricchisce di fi-
gure, questi resti cominciano a parlare, e allora per citare alcune<br />
delle note "anonime", apparentemente impersonali, o per lo<br />
meno di una impersonalità nuova, tutta da ridiscutere, questo<br />
nominare le cose, che si costruisce nei termini di un ascolto delle<br />
tracce, ha qualcosa che ha a che fare con delle materie collose,<br />
ha qualcosa che restituisce di nuovo un rapporto fisico. Non a<br />
caso poi, tra i materiali che egli usa ci sono tecniche del tagliare,<br />
dello sforbiciare, del rendere tagliente, ma anche del raggrumare,<br />
del far coagulare. Comunque c’è una catena di amori da<br />
lontano e dieci luoghi privilegiati si evidenziano in questo senso.<br />
Non mi sembra neppure un caso, o almeno non lo voglio considerare<br />
tale, non voglio scartarlo subito arrendendomi a quella<br />
che è una dichiarazione dell’analiticità di cui ci ha parlato Pozzati;<br />
è molto curioso che alcune di queste figure, alcune delle dieci<br />
figure che coagulano di più, provengano da territori per così dire<br />
magici, che da sempre hanno saputo coagulare; è già stato nominato<br />
più volte Licini, ma non a caso anche il tocco di Klee, poi<br />
c’è un’altra animalità, che è quella di Dürer, poi ci sono delle figure<br />
animali, fisicamente pregnanti legate a Grosz, in particolare<br />
delle figure del femminile legate ad un assassinamento, a<br />
tutta una storia che si lega ad una mitografia molto precisa del<br />
primo ’900, per esempio.<br />
Abile dell’assassinamento. Mi interessa riprendere per un momento,<br />
so di non essere estremamente coerente, quella sottolineatura<br />
del termine: disegno. Allora io me la leggo subito a livello<br />
etimologico, e so che disegno deriva da de-signum, cioè riprendere,<br />
un partire da un segno dato; io vengo da un segno,<br />
dice P., e intanto risegno, ricalco quel segno e cancello, ma questo<br />
cancellare, guarda caso, poi riproduce delle riconoscibilità, e<br />
queste riconoscibilità sono dei coaguli, delle isole in qualche<br />
modo amorose, sia pur precarie. Questo procedimento che va<br />
per rovesciamenti è visibile, secondo me, sia a livello di figure<br />
che anche di procedimenti, di lavoro proprio artistico in senso<br />
stretto, di pratiche, di manualità, di fattualità; cioè da una parte<br />
trovo un muoversi sia sulle figure che sul segno, in termini di ossimoro,<br />
in termini di chiasmo. Da una parte trovo elementi estremamente<br />
puntuti, estremamente taglienti, dall’altro trovo invece<br />
elementi assorbenti, trovo delle ceralacche, quasi delle spugne,<br />
la carta stessa mi pare di aver notato, direttamente dalla<br />
conoscenza delle opere precedenti al ciclo che lui ci ha presen-<br />
519<br />
tato, ma molto legate a quello; mi sembra l’uso di una carta in<br />
grado di assorbire il segno che vuole in qualche maniera cancellare,<br />
cioè c’è un impregnarsi di quel ridisegnare, di quel battere<br />
il passo su certi elementi, di questo reinterrogare le cose e<br />
prendere da parte del supporto in qualche modo questo segnale<br />
di evocazione.<br />
Un argomento che mi interessa in modo particolare, al quale per<br />
ora accenno soltanto, è questa dominante del bianco, del biancore,<br />
del lattiginoso che c’è nelle opere degli ultimi tre anni; di<br />
un bianco che non è abbacinante, e tuttavia abbacina, di un<br />
bianco che si sporca e che tuttavia sembra invecchiato, sembra<br />
estremamente antico; in realtà è in qualche maniera fermentante,<br />
in qualche maniera di nuovo riemergente; anche qui, in<br />
questo biancore della carta, del supporto, trovo doppiamente<br />
presente sia l’elemento del vecchio, sia l’elemento del giovane,<br />
sia dell’antico che del nuovo, senza potermi decidere però su<br />
una direzione, mi sembra che siano compresenti entrambi. Sappiamo<br />
da sempre - gli interpreti più acuti di Pozzati, ed è questa<br />
la domanda che egli in ultimo si è rivolto -, sappiamo da sempre<br />
che egli è un maestro del nascondimento, che in lui è fortissimo<br />
l’esercizio della rimozione, che sempre, là dove egli ci<br />
mostra un’immagine, certamente sotto di essa o di fianco o lateralmente<br />
o addirittura in un punto molto evidente, ma quasi<br />
non visibile, vi è l’oggetto rimosso, vi è qualcosa di cui non ci<br />
parla esplicitamente; questo abilissimo camuffatore ci propone<br />
dei tranelli, sta a noi, e questa è la sfida che lui ci ha lanciato,<br />
trovare qual è il segnale nascosto, ciò che egli ha allontanato. Se<br />
dovessi seguire il percorso delle rimozioni, degli inganni, delle<br />
trappole e degli allontanamenti che Pozzati ha esercitato nel<br />
corso degli anni, certamente non avrei dubbi sul rispondere che<br />
ciò che egli nasconde, ciò che nasconde perché non vuol darlo<br />
in pasto ad un universo del tutto uguale, è un elemento di vita<br />
profonda, è un qualcosa come una organicità che è sotto le cose,<br />
è qualcosa che potrei chiamare provvisoriamente una scintilla di<br />
vita, è qualcosa che ha a che fare con la materia, con la plasticità<br />
della materia, e che in altri anni si è manifestata con la ripresa<br />
di un simbolo, di un elemento o di un segno fortemente<br />
organico.<br />
A questo proposito, aprendo una rapidissima digressione, credo<br />
che non sia affatto secondario che ci sia una figura ossessiva in
questi 301 pannelli/quadri e cioè quella dell’incontro pittoremodella:<br />
mi pare che quell’incontro che egli rivive attraverso la<br />
catena delle invenzioni della modernità, attraverso Picasso in<br />
particolare, un incontro che ha qualcosa a che fare con la carne,<br />
con la fisicità, sia un incontro che significa anche attraversare il<br />
modello, un rifarlo e un violentarlo, per trarne attraverso l’opera<br />
un qualcosa che è anche la morte dell’altro. Mi ha interessato<br />
dire come all’inizio, o a un certo momento del suo discorso, la<br />
matrice, la prima lastra che egli ha posto per prima nella numerazione,<br />
come incipit a fianco delle 300 tavole, sia qualcosa che<br />
non riproduce, e tuttavia questo qualcosa che non riproduce è<br />
una madre, è una materia che egli non fa riprodurre proprio perché<br />
tiene gelosamente per sé. Tra tutte le immagini una in particolare<br />
credo che debba essere interrogata, perché mi sembra<br />
che costituisca un poco la chiave del discorso pozzatiano, è una<br />
immagine ben evidente a tutti quanti, è quella del bambolotto,<br />
del puer, dell’appeso, di quel soggetto mutilato in cui Pozzati si<br />
riconosce. Mi ero segnato su un foglio una serie di corrispondenze,<br />
di associazioni, di ricorrenze di questa immagine, di familiarità<br />
con questa immagine, nel ciclo dei 360 quadri: se dovessi<br />
seguire tutte le associazioni mi troverei di fronte certamente<br />
ad una molteplicità di sensi, questa molteplicità di sensi<br />
mi confonde, ma anche mi spinge a creare delle solidarietà, ad<br />
individuare dei significati sotterranei, quel forse rimosso, quel taciuto<br />
di cui Pozzati parla, su cui ci interroga, intorno al quale probabilmente<br />
ha disposto una sottilissima trappola. Intanto credo<br />
che a nessuno sia sfuggito come in un caso il bambolotto sia<br />
stato presentato come un giocattolo, quasi smontato, una sorta<br />
di personaggio appeso di cui si è perduto il filo, si è perduta la<br />
corda - e cioè assomigli molto in certi casi ad una marionetta -,<br />
poi come sia diventato ad un certo momento un puer; lo dico<br />
sottolineandolo, perché qui mi conforta il fatto che sia associato<br />
alla figura di Dürer e Dürer sappiamo bene che è legato ad una<br />
tematica molto precisa del saturnino, della nigredo, della macinazione:<br />
ed allora questo puer che è cieco: gli sono stati rubati<br />
gli occhi, ma al tempo stesso guarda, con che cosa guarda se<br />
non - ha detto Pozzati - con il sapere che gli è rimasto e cioè con<br />
uno sguardo del dentro che è in grado di fermentare? Questo pupazzo<br />
è mutilato, ma al tempo stesso appeso, sospeso, è diventato<br />
aereo, può aggirarsi e guardare questo catalogo di cose e<br />
520<br />
può stabilire lui dei luoghi di stazione, dei momenti di coagulazione,<br />
quei dieci momenti che mi pare in modo evidente risaltino<br />
dal complesso dell’opera.<br />
La mia ipotesi allora è questa, che all’interno di questo deserto<br />
di segmentazione, questo deserto di elementi tutti uguali, questo<br />
universo appunto delle simulazioni, in realtà si celino delle<br />
scintille di rinascita: non una, altrimenti ricadremmo forse in una<br />
teologia storicistica, ma molteplici possibilità di viaggio, molteplici<br />
stazioni e momenti di cammino; rinascita che proprio per<br />
non avere un centro, ma una serie di centri polverizzati, può lì<br />
trovare le sue ragioni in qualche maniera di svolgimento.<br />
(1) Conversazione pubblica su Pozzati, tenutasi in occasione della presentazione<br />
“Dopo il tutto” presso la Casa del Mantegna, Mantova, 5<br />
aprile 1983. Relatori: F. <strong>Bartoli</strong>, G. Baratta. La conversazione è stata trascritta<br />
da una registrazione.
Ad occhi chiusi<br />
Sculture di Nenci al Te (1)<br />
Che la cultura artistica mantovana del Novecento riservi ancora delle<br />
zone, sia pure esigue, d’ombra e che talune valutazioni vadano riviste<br />
o comunque controllate nel confronto diretto con le opere, lo<br />
suggerisce – tra altri episodi espositivi – la mostra postuma di E.<br />
Nenci (1903-1972), attualmente ordinata presso il Museo Civico di<br />
Palazzo Te. La rassegna consente di gettare uno sguardo d’insieme<br />
sull’attività di circa un cinquantennio, illuminandone le stazioni<br />
principali e puntando in modo particolare sulla lettura delle plastiche<br />
di piccola e media fattura che costituiscono, a fianco di qualche<br />
impresa monumentale, l’asse portante di una ricerca pienamente<br />
innestata nel gusto del suo tempo.<br />
Gli esordi si esplicano soprattutto nel clima ferrarese del Venti, connotato<br />
per un verso dall’eclissi di Valori Plastici (la Metafisica è ormai<br />
memoria e per di più memoria di pochi aristocratici) e per un<br />
altro dall’affiorare di elementi tardo-liberty e neopuristi che vengono<br />
progressivamente annodandosi alle proposizioni del realismo<br />
521<br />
magico e di quel Novecento, ‘nazionale’ e non milanese, che sta<br />
affermandosi un po’ dappertutto come orientamento vincente.<br />
Una situazione per molti aspetti elastica quanto ai riferimenti stilistici,<br />
oscillante tra suggestioni regionali, fantasmi del visibile in<br />
chiave simbolista e rinnovata volontà di espressione, ma tesa<br />
tutto sommato verso una essenziale misura compositiva. Né mancano<br />
le accordature da melodramma. Ed è proprio questa idea d’ordine,<br />
di stile e di forma, di cifra interna dell’opera, a ottenere l’esuberanza<br />
immaginativa del giovane scultore, poiché appare evidente<br />
fin dai primi esercizi un’insistita disposizione a calcare sulle metafore<br />
e a suggerire prolungamenti patetici dell’emozione. Di modo<br />
che il fare disciplinato (Wildt con la sua Arte del marmo è un referente<br />
lampante di quel decennio), la riduzione al minimo, il dare<br />
l’immagine per via di scorciature e rinunce hanno quasi sempre effetti<br />
positivi sull’articolazione formale. Specie il volgersi allo stiacciato,<br />
l’aderire anche nelle opere di proporzioni maggiori ad una<br />
sorta di superficie continua, quasi di percorso prolungato, incentivano<br />
senza appesantirle le qualità allusive della scultura.<br />
Ciò non toglie tuttavia che agisca anche un’altra componente. In-<br />
E. Nenci, Stalagmiti-stalattiti - La caduta, 1962, alluminio patinato, cm 52x18x18. E. Nenci, Argonauta, 1950, bronzo, cm 23x25x32.
sorgono infatti in più di un lavoro delle tensioni fisicamente corpose,<br />
come delle inarcature, nodi e grumi pregni di materia, alcunché<br />
di impulsivo e originario, fremente sotto la superficie. È l’altra<br />
faccia di Nenci, quella che fa discorrere di oscure ossessioni,<br />
di genesi (La creazione dell’uomo, 1949), di slanci che l’artista tendeva<br />
a purificare in nitida scrittura. L’organico spinge però senza<br />
esplodere. Produce accenni di moto e non sequenze agitate o racconti<br />
d’azione. Il che promuove uno speciale capitolo di quella gestualità<br />
contenuta che, mentre privilegia la quiete intensiva, libera<br />
alcune figure ricorrenti del comporre, quelle per esempio dell’arco<br />
o del “ponte”, intese a connettere e compenetrare, a far slittare<br />
l’una nell’altra, le direttrici plastiche dell’immaginazione. In fondo<br />
certe fasi stilistiche si definiscono in rapporto alla duplice pronuncia<br />
cui soggiace la forza, alla maggiore o minore nudità con la quale<br />
viene espressa l’energia sotterranea. Ed a ragione lo sottolinea Licisco<br />
Magagnato quando in catalogo parla di volontà di occultamento<br />
del "terrestre”, di decantazione del “materico e sensuale”,<br />
E. Nenci, Ritratto di Mimmi, 1952, terracotta, cm 35 h.<br />
522<br />
negli ultimi lavori contrapponendo dialetticamente una simile<br />
pratica all’impulsività di taluni momenti precedenti.<br />
Vien da dire, osservando la severa campionatura della mostra, che<br />
la finezza del modellato, insieme ai valori pellicolari ed alle articolazioni<br />
minute dei bronzi e dei marmi, alle scabrosità e patinature<br />
delle crete, costituisce una invariante sia del periodo ferrarese<br />
che di quello mantovano, pur offrendo il primo inclinazioni di ricerca<br />
maggiormente divaricate, che è merito degli ordinatori<br />
aver segnalato nonostante l’esiguità della documentazione reperibile.<br />
Costante è l’addossamento della mano, il tastare, premere<br />
ed incidere delle dita sul corpo plastico. Lo sguardo ravvicinato prevale<br />
sulla visione della distanza, così come il plasmare ha la meglio<br />
sullo scolpire, la modulazione sull’asperità e contrapposizione<br />
di blocchi: cosa che poi si traduce in una solida iconografia<br />
di figure e volti, intensamente contenuti quand’anche abbreviati<br />
ed icasticamente penetranti, tuffati nel giro d’una ritmica che ritorna<br />
su se stessa e ribadisce l’assetto inziale dei volumi.<br />
Si capiscono allora certe affinità elettive, il perché dell’amicizia con<br />
Casorati o De Pisis: e il magistero di Rambelli, Drei, Wildt; il classicismo<br />
o meglio l’atticismo decadente del Lamento di un cieco,<br />
dell’Argonauta, la cerea consistenza della Testa dell’aviatore o<br />
della Donna dagli occhi chiusi, la sua levigata trasparenza. Splendido<br />
di proporzioni il modellato intorno al ’26.<br />
Quando Nenci si sposta a Mantova, nel secondo dopoguerra,<br />
l’immagine quotidiana deve certo attrarlo, ma si tratta di una quotidianità<br />
considerata ancora una volta sotto il profilo delle volumetrie<br />
essenziali. E sono allora leggibili diverse riflessioni in comune<br />
con gli scultori locali, con Bergonzoni e con Seguri; per<br />
analogie (ad esempio la Deposizione del ’50 o la Donnina dell’anno<br />
successivo) o per contrasto. Se la compagine dei Bonzi in<br />
Preghiera non può non richiamare per affinità di struttura certi conglomerati<br />
coevi e quasi fungaie di personaggi seguriani, l’esito<br />
espressivo è poi diametralmente opposto, giacché nel primo caso<br />
si sfocia nel silenzio mentre dall’altro vengon fuori dissacrazione<br />
e grottesco. Sempre più vengono poi accentuandosi morbide cifre<br />
simboliche, quasi a chiudere il cerchio e a far tornare i conti<br />
con le esperienze giovanili, nella ripresa fin troppo estenuata, in<br />
qualche caso, dell’allegoria.<br />
(1) Articolo comparso sulla Gazzetta di Mantova del 21 maggio 1983.
Svolte e ritorni<br />
Giovanni Bernardelli (1)<br />
Non credo che la categoria dello stile, da sola, possa tornare utile<br />
alla lettura di quest’opera. La pittura c’è, fuor di dubbio, ma manca<br />
la risoluzione costringente d’una lingua, voglio dire il premere<br />
d’una forma unica che proceda conseguentemente da determinate<br />
premesse per approdare a precise conclusioni compositive. Ci<br />
G. Bernardelli, L’annegato, 1969, olio su tavola, cm 30x40.<br />
523<br />
sono blocchi di quadri, ognuno con proprie articolazioni e pronunce<br />
che, però, non inducono acquisti e neppure rifiuti definitivi. Accade<br />
infatti che nel corso di un medesimo periodo ci si imbatta in<br />
famiglie diverse di immagini o si subisca il contraccolpo, perentorio<br />
quanto inatteso, di un fantasma che credevamo consumato.<br />
D’altra parte non si può neanche sostenere che questa maniera<br />
di dipingere sia eclettica, dispersiva o accidentale, tanto resta<br />
addossata a se stessa e in certo modo acquattata nelle ragioni
G. Bernardelli, Aratura, 1977, olio su tela, cm 40x50.<br />
che la determinano. Si tratta piuttosto di constatare che lo svolgimento<br />
normale del tempo, se pur presente, non è imperativo,<br />
come se fosse consentito retroflettere le esperienze, farle zigzagare<br />
fino a confondere cause ed effetti.<br />
Tutto è o può essere sinuosamente richiamato, senza dar luogo al<br />
dramma delle contraddizioni. Detto in altre parole, l’esito testuale<br />
non decide sullo scorrere del pensiero figurativo. Può ben capitare<br />
che un approdo stilistico porti alla luce una certa figura, ma è<br />
altrettanto vero che quasi mai ne esaurisce l’antefatto, se quest’ultimo<br />
torna poi a riemergere con una fisionomia, per dir così,<br />
anteriore a quel risultato. Ne viene che il dar forma a qualcosa,<br />
mentre corrisponde ad intermittenti spinte psicologiche, disubbidisce<br />
con discreta frequenza alla pratica selettiva del dipingere.<br />
Se talora compaiono delle relazioni con la pittura contemporanea,<br />
metti coi lombardi o gli emiliani del Trenta, Rosai o altri, le<br />
analogie sono a tal punto mediate da non dovervi insistere eccessivamente.<br />
Fanno parte del tempo e sono, a volerle considerare,<br />
troppo generali per definire una militanza. E il chiarismo?<br />
Quando pare di avvertirlo, resta spesso un sospetto, un’eco vaga,<br />
un’assonanza spirituale ed anche postuma che non ha molto da<br />
spartire con le impressioni in presa diretta ed il plein air. Tant’è<br />
vero che l’atmosferico tende a comprimersi anziché ad irraggiare,<br />
sboccando in conclusione sul piatto, ed eguagliando tonalmente<br />
il vicino al lontano.<br />
524<br />
Bernardelli torna a guardare alle ‘sue’ sorgenti e se, per lui, quel<br />
che conta è la fedeltà alle radici delle immagini, non mi sorprende<br />
che il percorso assuma un andamento irregolare, con<br />
tutta una serie di volute interne, di arresti e diramazioni all’indietro:<br />
un itinerario che, visto nell’insieme, appare scandito<br />
lungo tre stazioni principali. Per circa trent’anni (ed è la prima<br />
lunghissima tappa) vengono fuori le ‘mitologie’ personali e di<br />
Gorgo, i sogni e i desideri, anche gli angelismi del pittore, la sua<br />
educata dialettalità. Più tardi, pressapoco intorno al ’65, comincia<br />
una svolta di natura purista e geometrizzante: si riducono le<br />
immagini ma in compenso le tele diventano più numerose, calibrate,<br />
riflessive. Infine, quasi riassumendo l’una e l’altra stagione,<br />
prende corpo l’epoca dei ‘ritorni’, l’ultima e tuttora in corso.<br />
Due quadri, tanto per esemplificare la logica della ripetizione,<br />
servono da riscontro. Uno è addirittura la prima opera dipinta, Alberi.<br />
Il piano avanzato costituisce anche lo sfondo, come una barriera<br />
blu-azzurra di vegetazione e di tronchi assiepata davanti<br />
agli occhi. L’altro, ancora un bosco (del 1982), impaginato quasi<br />
fosse un muro, anzi una superficie frontale, ha il medesimo andamento<br />
di linee e forme. E tuttavia è rovesciato in quanto a sostanza,<br />
poiché la barriera ha la consistenza d’una parete di cenere,<br />
in cui gli alberi sono scalfitture e solchi, crepe, angoli, grafie.<br />
È da lì che l’osservazione cava le sue intuizioni: da boscosità imparentate<br />
con acque e golene, argini, prati e altre presenze selvatiche.<br />
Selvatiche tuttavia in origine, nella materia prima dell’immaginare<br />
e nel suo derivare da un luogo che è l’unico orizzonte<br />
percepibile. Poiché in seguito interviene a modificarle la<br />
fantasticheria di assottigliamento, la spinta a depurare ed irrealizzare,<br />
che è tutto il contrario (penso dialettico e compensatorio)<br />
di chi ha pronunciato Tempo di bufera ed altri versi di imprecazione;<br />
di uno che sta lì vicino a guardare e giudicare, per<br />
amicizia, anche.<br />
La siepe. Questo elemento d’origine costituisce anche la metafora<br />
di una cornice, oltre che di un mondo. Nella pastorale del<br />
’38 (Figure sulla riva) o nei tanti interni del Settanta, che sono<br />
poi scrigni e cassetti dove si rifugia la memoria, vediamo gli oggetti<br />
disporsi al di qua o dentro i margini.<br />
Il pittore non afferra subito il piano concreto delle figure. Lo vive<br />
e rivive, poiché tra lui e le cose interviene il rimuginìo, la distanza<br />
del ripensamento, sicché, prima di affacciarsi sulla pittu-
a, luoghi e persone germogliano nella mente, han bisogno di farsi sogno e ricordo. Ed è questo intervallo che li<br />
trasforma in sostanza diversa, sottraendoli all’ordine corposo del quotidiano.<br />
L’ingorgo selvoso inaugura il primo mito: è la muraglia d’alberi e l’accerchiamento della natura. Otturazione, intoppo,<br />
sbarramento, griglia. La linea dell’orizzonte o scompare o viene a formare una cintura. Chi guarda ne resta<br />
imprigionato e può, al massimo, assestarvi sopra delle cose, magari un nudo o una natura morta, mai sfondarla.<br />
Procedimento già riscontrabile agli esordi, per esempio tanto nel Mio paese del ’47 quanto nei Fiori del ’42, vale<br />
a dire in due prove apparentemente molto diverse tra loro per luminosità e stesura cromatica, ma più solidali di<br />
quel che sembra a prima vista, poiché entrambe danno fiato ad una spazialità protesa in avanti, concava, sbarrata<br />
sul fondo.<br />
Le limpide conferme verranno tanti anni dopo. Che cosa sono la Sfoglia o le arature se non superfici a piombo?<br />
tavole verticali?<br />
È la griglia il nodo generatore. Proprio nell’imporsi come luogo abituale della fantasia, nell’essere semenza delle<br />
immagini e tema introduttivo, risulta disponibile e subisce tutto un ventaglio di metamorfosi. È l’argine e lo ster-<br />
G. Bernardelli, Tramonto, 1982, olio su tela, cm 50x60.<br />
525
peto, ma assorbe anche l’intero ambiente, fino a confondersi col<br />
cielo, il vento, le nubi. E non mi riferisco soltanto alle innumerevoli<br />
porte, muraglie e pareti assestate contro il fondo, alle quinte<br />
e ai sipari laterali del Sessanta e del Settanta, ma al divenir<br />
siepe del cielo stesso, al tumefarsi e stendersi dell’aria in padiglioni<br />
di scaglie e barre. Sì che ad un certo punto un bosco equivale<br />
pittoricamente ad una ventata di nuvole, l’aereo precipita<br />
nell’umido, in un fuoco liquido o in una danza di scorie (Tramonto,<br />
1971). Una nebbia agitata, lenticolare. Ecco perché allineerei<br />
insieme, lungo una catena ideale, le prime ‘barriere’ alle<br />
molto più tarde orchestrazioni di segni celesti e vegetali, alle<br />
tempeste e ai notturni recenti, compreso il fondale scuro, da caverna,<br />
di una luna del 1982.<br />
È davvero qui, dentro e non dietro la muraglia, che il pittore<br />
spinge lo sguardo, aspettando che una figura riveli quel che ha<br />
da dirgli; che lo scuota, minacci, affascini, come le pietre e i legni<br />
che raccoglie sul greto. L’occhio non trova risposte sensate, uniformi:<br />
solo emozioni, accadimenti, mute ambivalenze, maniere<br />
alterne dell’esistere.<br />
Allora è sintomatico che una riva suggerisca insieme idee<br />
d’amore e di soffocamento; e che le linee d’appoggio siano biforcazioni<br />
e crocicchi.<br />
Prendiamo il più fluido e vicino degli orizzonti del paese, quello<br />
dell’acqua che scorre. Il filo del fiume, un canale. L’esito è duplice.<br />
Incorniciata da un reticolo di tronchi e di sponde, un’ambivalenza<br />
elementare non tarda a manifestarsi; e lo fa in controluce,<br />
cioè ancora attraverso uno sbarramento ed una tenaglia. Nelle<br />
tele del ’38 hai l’idillio e il suo opposto, con le mitologie primitive<br />
del corpo, dell’uomo, della donna, delle bagnanti. Su una riva<br />
la dormiente, su un’altra l’annegato. Spavento e piacere, proiettati<br />
nel silenzio o nel suono d’uno zufolo, si danno il cambio. Avviene<br />
la stessa cosa per il sogno sereno e l’incubo, ma mentre il secondo<br />
ha breve sviluppo il primo motivo conoscerà un largo numero<br />
di varianti pur continuando ad insistere sull’immobilità del<br />
corpo femminile, sul suo essere fermo come un fossile o un idolo,<br />
a parte qualche accenno di moto in un paio di danzanti.<br />
Lavorato nell’essenziale, il nudo si fa enigmatico, petroso, squadrato<br />
man mano che passa il tempo. Dal tenero pastello al sasso,<br />
dal verosimile al deformato ed all’imprendibile. Si mineralizza.<br />
Non si tratta comunque di un processo violento. Bensì di preserva-<br />
526<br />
zione. Una forma chiara, luminosa, ridotta all’osso, quasi un talismano.<br />
Del resto questa pittura opera sul secco da sempre. Si serve<br />
di colori smagriti, lascia scoperte delle parti o vela appena la superficie.<br />
Colorisce - si direbbe - un disegno e dissecca paste e materie,<br />
sia che s’arruffi oppure proceda in modo uniforme e continuo.<br />
Anche altre storie vi si adeguano, intendo quelle sociali e naturali<br />
di Gorgo, gli episodi dei cavallanti e del varo, le domeniche<br />
e i giorni di festa al santuario, i campi, le case; soprattutto quest’ultime,<br />
che da un certo anno in poi fanno da protagoniste uniche,<br />
o pressappoco, dei dipinti. Proprio da esse (il quadro-chiave,<br />
per me, cade nel ’65) viene il segnale d’un cambiamento. Lasciando<br />
da parte la corsività del bozzetto ed il tenero degli sfumati,<br />
l’occhio prende a selezionare le forme. Riduce la composizione,<br />
poche linee, semplifica ed abbrevia i piani. Il risultato è<br />
una immagine compatta (non dico astratta, benché questa intenzione<br />
sia sicuramente presente), in cui l’idea della realtà ha<br />
subìto un ulteriore giro di vite in direzione contemplativa.<br />
Solo ora, probabilmente, Bernardelli si pone il problema del linguaggio<br />
in termini drastici e forza le cose a vantaggio della forma.<br />
Tenta il partito purista a costo di cadere nel geometrismo. Pialla,<br />
cancella l’oggetto. Conserva pochi argomenti: la natura morta, la<br />
stanza, le pareti di casa ed il paese. E dappertutto fa circolare<br />
un’aria intima, gelosa, domestica, come se dovesse tirare le fila<br />
d’un pensiero disperso puntando sulla nettezza dell’esecuzione.<br />
Mi pare un bagno di ascetismo in cui sfoga la neccessità della<br />
misura espressiva e dell’equilibrio. Potrebbe costargli molto,<br />
anche la perdita delle fonti di eccitazione fantastica, la monotonia<br />
dell’armonico. Ma per fortuna inizia a profilarsi, dentro le impaginazioni<br />
centralizzate, a volte fin troppo assiali, una vera urgenza.<br />
Qualcosa che va oltre l’ordine, che non fa questione di<br />
questo o quell’oggetto, ma della loro sopravvivenza in generale.<br />
Alludo agli effetti dissolventi del contemplare: un’energia corrosiva<br />
che disfa il mondo circostante. Ne dimostra la precarietà.<br />
Meglio: il suo carattere sognato e fantasmatico. Che è quel che<br />
serve realmente al pittore.<br />
Là dove compare l’immagine-fantasma, l’ustione, il buco, il quadro<br />
infatti riesce. Penso in particolare ad un paesaggio e a una<br />
natura morta del ’72, in cui un settore dell’immagine sembra<br />
calcinarsi, diventar traccia. Mi spiego allora come, in tanto purismo,<br />
vengano alla luce delle tele in qualche modo marginali,
G. Bernardelli, Case, 1965 ca., olio su tavola, cm 25x35.<br />
non-geometriche, dove uno spaccato vegetale o un cielo agitato<br />
offrono il pretesto per svolgere il tema profondo, che è l’incandescenza<br />
della pittura e il suo svanire. La cenere.<br />
Vedo le conseguenze nell’epoca dei “ritorni”. Certi motivi visivi<br />
rinascono come impronte, delicati ricalchi ed ombre di una materia<br />
divenuta così sottile da tramutarsi in profilo. Grazie alla<br />
linea di confine il mondo riappare per evocazione. Lo si richiama<br />
bordeggiandolo.<br />
Il sentiero (1975), La ragazza sul prato (’78), dei nudi. Accanto<br />
527<br />
a questa c’è l’altra maniera, quella delle scaglie e dei controluce,<br />
alle cui premesse ho già accennato.<br />
Sta al sogno, a questo dialetto del sogno, incernierarle.<br />
(1) Scritto in occasione della mostra “Giovanni Bernardelli. Opere 1935-<br />
1982”, Suzzara (Mantova), 19 giugno-31 luglio 1983; San Benedetto Po<br />
(Mantova), settembre-ottobre 1983; Ferrara, 18 dicembre-5 febbraio<br />
1984.
L’occhio del cielo. Miraggi<br />
Carrozzone Magazzini Criminali (1)<br />
La prossimità del teatro al cinema, la presenza di media elettronici<br />
nonché il ricorso sempre più insistito, in molta spettacolarità<br />
recente, all’immagine pellicolare, gettata sullo schermo, costituiscono<br />
uno stato ormai ‘normalizzato’ dello spazio scenico. Optare<br />
per l’ocularità diffusa, per il neutro e l’indifferenziato dello<br />
sguardo, significa molto spesso dar credito ad un’idea di parete,<br />
sipario, quadro teatrale: uno screen traslucido che moltiplica i<br />
luoghi, funzionante nella duplice valenza della parete divisoria e<br />
della superficie ricettiva. Lo schermo assicura l’impalpabilità e<br />
nello stesso tempo il movimento continuo dell’immagine. Non è<br />
un caso che proprio nello screen il panottico abbia trovato la sua<br />
culminazione. Che cos’era la scena cinetico-visiva del progetto<br />
moderno se non un perfetto congegno di schermi, Schau-Spiel<br />
meccanico, tastiera di immagini in trasformazione?<br />
Ancor prima di McLuhan, Benjamin si era soffermato su due decisive<br />
specificazioni dello sguardo senza distanza, attribuendole<br />
al cinema e all’architettura, due arti destinate alla disattenzione:<br />
il tattico e il tattile. Ed ora cinema ed architettura sono entrati nel<br />
corpo del teatro, ci sono entrati insieme, simultaneamente, costruendo<br />
una sorta di congegno a sequenza, una architettura ci-<br />
528<br />
nematografica programmata elettronicamente. Struttura dell’evanescenza<br />
ma nondimeno avvolgente: là dove il flusso delle<br />
immagini non viene perimetrato dal silenzio delle pause, dove<br />
manca l’intervallo, l’occhio si fa onnivoro, ubiquitario, insinuante.<br />
È lo sguardo benjaminiano del “chirurgo” per il quale il segreto<br />
non ha più ragione di esistere e che penetra all’interno, per operarvi<br />
tatticamente da vicino, estrovertendo in superficie quel che,<br />
in altre visioni è spessore e nascondimento.<br />
Lo screen ha inoltre qualcosa da spartire con la sequenza e lo<br />
scorrimento a scatti dell’immagine, col taglio e la ripresa. Lo<br />
scatto opera una manovra di slittamento nell’indifferenziato. Artificializza<br />
ed accumula riserve di figure. Torna a combinarle. Non<br />
importa dove, purché il gioco del montaggio possa continuare.<br />
Che il mondo si offra come un magazzino di effigi e che il viaggio<br />
attraverso il reale sia puramente illusorio poiché, di fatto, è il<br />
mondo che viaggia, vale a dire il repertorio delle immagini del<br />
mondo, l’iconosfera avvolta su se stessa, e che nulla resti da<br />
esplorare poiché l’esplorazione è già di per sé un effetto di simulazione,<br />
o preda di quell’effetto, è conclusione cui la pittura, su<br />
certi versanti e da tempo, è pervenuta. Rauschenberg, Warhol o<br />
Schifano lo testimoniano e prima di loro la pratica del “trovare”<br />
in sostituzione del cercare, dell’artificiale al posto del naturale.<br />
A questo proposito appare esemplare, in teatro, lo spostamento<br />
Antonin Artaud, Punto di rottura, 1979.
tematico del “Carrozzone” / “Magazzini criminali”. Dalla metafora<br />
del viaggio che lo ha accompagnato al termine (o quasi)<br />
degli anni Settanta, è approdato ad una nuova mitologia, compiendo<br />
quel che è probabilmente un passo strategico nei confronti<br />
dell’esistente: il passo verso (contro) il tutto-pieno delle<br />
immagini, il magazzino, l’arsenale. L’antibiologico quotidiano. Il<br />
che vuol dire anche immmersione nelle tecniche produttive del<br />
deposito, nelle viscere di quel panottico che la modernità ha<br />
ostinatamente inseguito; ed ancora significa confronto con la<br />
geografia assestata alle spalle del teatro tecnologico, la città, il<br />
territorio metropolitano.<br />
Ma, a considerarlo dal di dentro, l’arsenale presenta poi connotazioni<br />
tutt’altro che rassicuranti. Badiamo all’aggettivazione che lo<br />
completa: camaleontico, frantumatorio dissolvente. Il “magazzino<br />
criminale”, a dire il vero, potrebbe esprimere due cose esattamente<br />
opposte, a seconda che l’accento cada piuttosto sull’uno o<br />
sull’altro termine giuntura, sulla criminalità o sulla riserva. Giacché<br />
si pone l’alternativa: o il furto tesaurizza il risultato della propria<br />
azione, oppure al contrario questo magazzino è un falso contenitore,<br />
uno spazio in negativo, dove avvengono dei crimini mortali.<br />
Per trovare una risposta conviene vedere su quale sfondo si collochi<br />
il luogo della recitazione e come la città ne venga implicata.<br />
Dopo le mappe terrestri del primo “Carrozzone”, da quando<br />
si è concluso il cammino attraverso i cicli stagionali e i segreti<br />
degli elementi, ecco sopravvenire al posto dei sentieri un sistema<br />
non meno intricato di itinerari. A diramarsi è questa volta la<br />
selva dell’elettrico, l’antinatura meccanica della metropoli intessuta<br />
di correnti artificiali: una galassia talmente compatta da interdire<br />
ogni movimento vitale. Non è l’officina del corpo, l’infero<br />
sottosuolo, ma il suo limbo, qualcosa di eternamente raffreddato<br />
e neutralizzante. Nell’iper-pieno della città l’occhio non fa<br />
esperienza. Osserva soltanto pellicole fantomatiche che mimano<br />
un falso respiro. È come se annegasse in un oceano di vedute.<br />
Ben altra cosa è la città orientale evocata dai componenti del<br />
gruppo, quella configurazione dell’abitare dove l’esistere fa tutt’uno<br />
con l’esperienza ed il paesaggio si pensa per così dire nello<br />
sguardo che lo osserva, germina con lui, si trasforma. Qui il suo<br />
potere è magico ed ha una forza d’intrattenimento, di intreccio,<br />
che non riguarda più le vedute. Pertiene piuttosto ai miraggi.<br />
Neppure più metropoli, ma “megalopoli”, città dal disegno fem-<br />
529<br />
minile, un nulla e un vuoto in cui le forme vengono dilapidate.<br />
Quanto la prima è caratterizzata dal processo rettilineo di accumulazione,<br />
dal simmetrico riprodursi dei segnali per via di equivalenze,<br />
tanto la seconda viene lacerata dalle pause, dall’intervallarsi<br />
degli istanti. L’una è il territorio della logica, mentre l’altra<br />
ospita costrutti impossibili della retorica: una retorica disaccumulante,<br />
sofisticata, orientale, demonica. “L’inferno della megalopoli<br />
è qui, in Asia, in Africa, città stese come tappeti, bruciate<br />
dal sole, imputridite dalla pioggia (...), nervose come fanciulle,<br />
instabili come adolescenti”.<br />
Tutt’altro che dimenticato è perciò l’asianesimo che costituiva<br />
una delle radici del “Carrozzone”. Meno ieratico, forse meno clamoroso<br />
di un tempo, si iscrive ora nella ritmica dissolvente, nella<br />
operatività ‘nera’ del disgregare e del solvere.<br />
Mario Ceroli, Le tre età, 1982, tecnica mista, cm 260x160.
Quel che importa è tuttavia stabilire delle zone di contatto fra<br />
mitologia ed esistenza, il calare della città-tappeto sulla metropoli.<br />
Non fuori, accanto, in parallelo all’universo tecnologico, ma<br />
dentro, nella geografia epidermica della città europea, per usare<br />
una metafora ricorrente. Quel che il teatro della “criminalità”<br />
sembra cercare è allora la presa, l’addentamento dell’immaginario<br />
sull’inerte e non una fuga, un viaggio lontano dai ghiacci<br />
della tecnica. Nonostante molte dichiarazioni possano indurre a<br />
pensare che il movimento sia di natura nomadica, volta all’accumulo<br />
‘felice’ di spazi biologici, la pratica del teatro nel suo insieme<br />
non prende corpo al di qua, prima, delle barriere del Simbolico.<br />
Invertendo in qualche modo il tragitto positivante del Surrealismo,<br />
teso ad elevare il quotidiano nel meraviglioso ed a<br />
chiudere cerniere di scala ascendente tra il reale e l’immaginario,<br />
qui i ‘vasi comunicanti’, le sovrimpressioni, gli agganci<br />
forti, le morsure non imbiancano per niente la realtà. Il vaso comunicante,<br />
l’interconnessione, fa correre il vuoto, inietta una seconda<br />
morte nel solidificato.<br />
Per quale ragione, altrimenti, i ritmi teatrali assumerebbero una<br />
così forte pronuncia antiorganico-frantumatoria? Che vuol dire in<br />
questi esercizi il delirio di un corpo spinto a guadagnarsi il morire?<br />
Che specie di meraviglioso sprigiona la fatica della marionettizzazione?<br />
Se un concetto come quello di “possibile” compa-<br />
Giuseppe Spagnulo, Tondo, 1982, Ø cm 60x6.<br />
530<br />
re insistentemente nella poetica dei Magazzini Criminali (ed è<br />
concetto invariabilmente associato a meraviglioso e immaginario),<br />
le procedure che poi lo accompagnano spingono verso la rarefazione<br />
e il prosciugamento. Vien da dire allora che i ‘possibili’<br />
siano piuttosto delle rotture, degli scontri indirizzati a liquefare.<br />
Per un certo numero di anni il “Carrozzone” è stato rubricato fra<br />
i teatri della figuratività e dell’immagine, tra i più vicini, ed ancora<br />
lo è in parte, alle arti visive. Architettura, pittura, arte povera<br />
e minimal hanno lasciato tracce consistenti nelle sue tecniche<br />
spettacolari. Questo è vero, con una speciale predilezione per le<br />
configurazioni rituali, esoteriche, mentalizzate dell’immagine.<br />
Quell’emergenza iconica, però, si è data sempre con modalità<br />
essenziali, spesso per via di sottrazione e di stringata allusività.<br />
Anche il procedimento costruttivo a stazioni, per quadri e “studi”<br />
irrelati, aveva compito di serrare dentro le reti degli elementi<br />
scheggiati e dei frantumi; serviva a corrodere l’immobilità delle<br />
figure oltreché a ritagliare, all’interno dell’azione, dei minima figurali:<br />
minimi che lavorano in definitiva contro l’immagine; o<br />
meglio, la liquefano, aprono dei precipizi.<br />
Se, ricorrendo a Deleuze e Guattari, lo scatenamento della visione<br />
viene iscritto in una esperienza che fa “senza l’immmagine”,<br />
cosa che la porterebbe al principio materno, a tutto favore di una<br />
ocularità selvaggia e straripante, di pienezza organica, una conseguenza<br />
potrebbe essere proprio quella, rifiutare il vuoto, l’annientamento<br />
dei liberi flussi immaginifici. Invece lo scheggiamento,<br />
il “punto di rottura”, stanno a testimoniare una volontà<br />
di sperdimento.<br />
Viene perciò da supporre che il nomadismo, al pari dell’asianesimo<br />
in versione “barbara”, non costituisca l’indiscusso e unico<br />
polo di lavoro e sia invece una delle componenti sulle quali<br />
viene giocata un’azione più larga (e sostanzialmente più cifrata),<br />
uno scontro, vogliamo dire, fra immagini che fingono la vita e<br />
immagini (rigorosamente cerimonializzate) che intendono riattivare<br />
la tensione del morire.<br />
È curioso che uno degli spettacoli più recenti, Punto di rottura, sia<br />
stato letto in chiave modernista come un evento di primitivismo<br />
meccanico, di magìa e di trance a vantaggio della produzione costruttiva,<br />
come una “Cerimonia del Movimento e del Rumore”,<br />
quando al contrario - e qualcuno non ha mancato di osservarlo -<br />
ciò che si annuncia è l’agonia del geometrico e l’invivibilità dei
suoni e delle luci. Eppure quel giudizio coglie a suo modo nel<br />
segno poiché indica lo sfondo del conflitto, la vicinanza dei Magazzini<br />
Criminali al mondo della simulazione, e l’installarvisi per<br />
spingerlo alle estreme conseguenze. La cerimonia c’è, ma antagonistica,<br />
ed il teatro indossa per celebrarla le sembianze dell’avversario.<br />
Decide - tatticamente - di assumere la freddezza dell’analitico.<br />
Il teatro deve morire né sa se potrà rinascere. Quel che cerca è<br />
la necessità della fine. In un simile amor fati si sviluppano paradossi<br />
e contraddizioni, quel problematico incastro di mentale e<br />
di vitale di cui parlano le interpretazioni.<br />
Intanto il teatro, “l’arte dell’istante” e della presenza del corpo a<br />
sé, devìa nella parata scenica, diventa scenario, veduta, luogo<br />
‘cinematografico’ e pianoforte di luci. Introietta feticci, macchine<br />
dall’apparenza eterna, moti continui, computer. “Corpo che seduce<br />
se stesso. Patinato lucido immortale, astratto, non logorato,<br />
senza orifizi...”, come la moda. La parodia del corpo glorioso non<br />
potrebbe essere più forte, se non fosse che ciò che si vuole parodiare<br />
in realtà è un finto organismo di gloria, una manifestazione<br />
evanescente di energia, un guscio inerte: il mondo del tuttouguale,<br />
omologato dagli edifici della produzione estetica.<br />
Renzo Schirolli, Componenti per installazione “L’occhio del cielo”, 1983, olio su tela e legno, cm 336x461x223.<br />
531<br />
Artificializzazione poi del corpo. Non che l’attore adotti delle maschere<br />
o si occulti dietro corazze e costumi biomeccanici. Si dà<br />
come immagine piatta, riduce se stesso a figura che scorre, trucco<br />
e pellicola riproducibile. Cosmesi e travestimento, maquillage<br />
che ne doppia altri. Per derubarli, poiché un trucco più forte dà<br />
modo di incidere la normalità del simulacro, lo fissa nella sua più<br />
reale attitudine che è quella di essere una spoglia. Tutto viene in<br />
certo modo inchiodato alla propria superficie e sfidato ad esibire<br />
i sortilegi di cui è capace.<br />
Se il “mondo vero è diventato favola”, non resta che accogliere<br />
la favola, la maschera, il riflesso come il campo dei possibili rapporti<br />
intensivi. Sarà anzi da vedere, fra tante favole, quale o quali<br />
abbiano un più alto grado di trascinamento e sappiano forgiare<br />
la menzogna più forte; quali in definitiva custodiscano la tecnica<br />
del segreto, l’ars della tentazione, capace di affatturare, condurre<br />
a sé e stregare l’avversario, dentro il niente della propria macchinazione<br />
maliosa: in un vuoto che contagia. Segreto come arte<br />
del mettere in abisso, del dissolvere la proprietà (il dominio)<br />
delle figure, sventando il trabocchetto d’una presuntuosa perfezione<br />
nel quale ogni imago, arrestandosi, rischia di inciampare.<br />
Quest’artificiale non fa questione di inautentico o meno, colloca-
to com’è oltre l’insincerità delle storie “che erano vere un<br />
tempo”. Se di questo si trattasse, rispunterebbe fuori un nascosto<br />
che aspetta d’essere conosciuto o sarebbe in causa un suo ritorno<br />
in qualche veste nuova; o anche una speciale verità della finzione<br />
che direbbe l’essenza del falso. Siamo oltre tutto ciò. È il<br />
macchinare del falso assoluto, dell’innaturale dell’arte, la magia<br />
del miraggio, quell’istinto che, leggiamo nel Crepuscolo degli<br />
Idoli, “comprende in sé anche il piacere dell’annientamento”.<br />
Dire che non v’è più posto per l’illusione “perché il reale non è<br />
più possibile”, adottare la diagnosi di Baudrillard almeno su questo<br />
punto, significa cercare scampo nelle forze, dar fiato alla catena<br />
delle sperdizioni, e fare della presenza attoriale un detonatore<br />
di svuotamenti. Anche in lui stesso, poiché la ‘guerra’ è rivolta<br />
fuori e dentro, contro le accumulazioni del corpo proprio, le<br />
crescite del biologico e dell’erotico. L’artificio si iscrive così nell’ordine<br />
sacrificale della Natura, nella messa a nudo e nella of-<br />
532<br />
ferta (dissociativa) di frammenti, come avviene in Punto di rottura,<br />
immagini registrate - scatti e dissolvenze, tics fisionomici -<br />
vengono ridate per videotape; e ancor più in Crollo nervoso, con<br />
l’impaginazione astrattizzante, ocularizzata, bidimensionale,<br />
combinatoria. Un massimo di visualità per assassinarla.<br />
È una poetica che mentre inclina al Schau-spiel, alla festa dell’occhio,<br />
recita anche il funzionamento corrosivo, macerante dell’intrattenimento.<br />
L’attore governa le regole della sparizione e ne<br />
è a sua volta governato: ombra contro ombra, maschera contro<br />
maschera, finzione contro finzione. E nell’esistere come tale, non<br />
dietro ma in una maschera, dimostra la sua attitudine obliqua al<br />
tradimento. Bada, il ladro, soprattutto. Ed ancora: thanatos, quella<br />
pulsione di annientamento che s’annida nel ciclo biologico e<br />
costituisce l’antefatto (e l’antagonista irriducibile) del principio di<br />
verticalità. L’agguato dell’inorganico, secondo quanto suggerisce<br />
l’ultimo Freud.<br />
Luigi Ontani, Davide e Golia, 1980, tempera su carta, cm 190x90. Luigi Ontani, Maschera Galimese, 1982, legno e lacca.
Luciano <strong>Bartoli</strong>ni, Mantegna a Berlino, 1983, tempera e<br />
olio su carta, cm 200x150.<br />
Ci si chiedeva poco fa in quale regione questo teatro avesse scelto di operare.<br />
Una metropoli liquefatta dalla retorica asiana. Più precisamente, per stare ai termini<br />
della sua teoresi, le zone (e i tempi) di passaggio, gli intermondi dove le forme<br />
sono ‘ibridi’, né notte né giorno, né altezze né profondità: lo spazio dove il fare è<br />
contemporaneamente disfare, soprattutto disfare.<br />
Val la pena di soffermarsi sulla mitologia del luogo inter, tra, del mezzo e nel mezzo,<br />
che mette in situazione l’evento teatrale. Per un verso ciò che lo qualifica è la violenza<br />
delle traiettorie, l’incrociarsi disfrenato di rapine, per un altro quest’irruenza che si<br />
dichiara selvaggia è tutta filtrata da una matematica interna, ipertecnicizzata e siderale.<br />
Mentre si dà come deserto e steppa, nel medesimo tempo è come un impianto<br />
elettronico. Un’astronave.<br />
Occupa l’indifferenziato ed il ‘neutro’. Ed ancora: territorio di pestilenze, putrefazioni,<br />
contagi, quasi che l’inizio e la fine della storia vi si trovassero confusi.<br />
Annotiamo la bivalenza messa in campo: pulsione e techne, convulsività ed ars, primitivismo<br />
e regola. Forse nemmeno un fatto di polarità, ma un’endiadi, un’inferenza<br />
di antitesi. Ancora una volta, come dire? una iter-polarità, quale sarebbe una violenza<br />
ritualizzata o un ‘segreto’, una ‘misura’ mortale.<br />
Se interroghiamo ora la tematizzazione più stretta del luogo scenico, l’intermondo si<br />
articola in una zona pneumatica, l’empty room, “la stanza vuota”, che rappresenta<br />
l’esito di una progettazione analitica in piena regola. Ha alle spalle perfino l’ascesi<br />
533
laica (la fredda hybris del costruttivismo) che alimentava l’arte<br />
totale degli anni Venti, compresa l’idea di una grammatica degli<br />
elementi primi e il rinvenimento delle figure fondanti il sistema<br />
scenico. Il concetto di opera come organismo e struttura. “Ogni<br />
singolo ‘spettacolo’ è una parola in cui la lingua è teatro. Ora<br />
siamo più interessati alla lingua che alla parola. Vorremmo procedere<br />
in un lavoro in cui lo spettacolo-parola scompare per lasciar<br />
posto all’analisi della sua lingua-teatro”. La conoscenza<br />
dello spazio, la misurazione dei rapporti d’ambiente, lo studio del<br />
‘campo’ hanno contribuito a dare al teatro la tagliente fisionomia<br />
del nudo congegno, uno scheletro minimal. Eppure la machine<br />
à spectacle non è vuota per questo, anche perché la levigatezza<br />
disossata del minimal, del primario ottico, è rimontata su ritmi<br />
Renzo Schirolli, Quadrombo III, 1983, olio su tela, cm 180x180.<br />
534<br />
sghembi, ipnotici, ossessivi. Né è vuota soltanto perché, a rigore,<br />
almeno ad un certo momento, nelle installazioni e nelle performance,<br />
la scena (nel senso alto del termine) si è allontanata,<br />
sopraffatta dall’esterno, dall’irruzione di immagini urbane. Lo è<br />
specialmente perché l’empty room smaglia la tessitura dell’azione,<br />
precipitando il racconto visivo nella parodia d’una spettacolarità<br />
di cui vengono intaccate perfette giunture modulari, come<br />
stanno a dimostrare, per esempio, gli esercizi di disturbo della<br />
specularità e dei procedimenti binari di crescita, di coppia, di<br />
falsa somiglianza, aggrediti alla sorgente, nella logica combinatoria<br />
del computer: aggressione che si configura come uno svuotamento<br />
della ripetizione accrescitiva, dell’uno-due elettronico,<br />
ricondotto invece all’uno-zero da una controripetizione dissocia-
tiva, di timbro alcoolico, che non produce transitività, ma all’opposto<br />
rende cieche le simmetrie.<br />
“Stanza vuota” fa il paio con “magazzino criminale”, definizioni<br />
entrambe dello spazio in cui l’aggettivo è più importante del sostantivo,<br />
poiché è l’aggettivo che si incarica - nel dibattito teorico<br />
- di esporre la natura dell’intervento.<br />
E se in altre dichiarazioni il perimetro del contenitore viene particolarmente<br />
sottolineato, questo ‘chiuso’ non sta certo ad indicare<br />
dei procedimenti di conservazione quanto il chiudersi, il serrarsi<br />
della volontà operatoria dell’attore, la sua magìa (“Il mistero<br />
della stanza chiusa”), analogamente a quel che avviene nel<br />
chiuso di un ‘esperimento’ delimitato, nello spazio contratto di<br />
un miraggio, sulla tastiera circoscritta - chiusa - di pochi suoni.<br />
Ora, proprio la stanza vuota, con le sue calcolate possibilità d’uso,<br />
con le sequenze esatte affidate ai monitor, questo luogo che ha<br />
un ex-machina ancor più imperioso, accoglie il corpo, anch’esso<br />
spinto a lavorare per figure, a partire da principi elementari, a<br />
patire-reagire al principio costruttivo. L’attore perde il corpo nel<br />
continuum ottico e si rilancia in una bidimensionalità scheggiata,<br />
distruttiva per sé e infine per la stessa immagine. Mentre assiste<br />
in certo modo allo svanire della propria presenza, mentre<br />
interpella e convoca il vuoto, getta tutt’attorno l’incantesimo<br />
dello zero. Monta dei drammi che sono ingloriosi per le effigi.<br />
Quando si afferma che il “risultato è il melodramma quasi liturgico<br />
di una società di massa”, veniamo a sapere che stiamo assistendo<br />
ad un quasi-sacro, ad una parvenza dimidiata di sacralità,<br />
anzi alla melodrammaticità di un quasi-sacro. A nessun’altra<br />
liturgia lo spettacolo fa accedere se non a quella debole di un<br />
dramma fittizio, di un evento simulato.<br />
Un morto che sopravvive per spinta d’inerzia. Un quasi che sta<br />
dalla parte delle sembianze inerti e irrigidite.<br />
Tutt’altra cosa dal melodramma è l’esercizio spettrale della cancellazione,<br />
il restituire una peripezia nelle figure del riso e del<br />
lapsus. L’attore sta nel melodramma per disperderne la finta, risibile<br />
ritualità, ma dalla sua parte c’è qualcosa che al piacere<br />
melodrammatico risulta insopportabile ed è il rischio della morte<br />
reale, il pericolo del black-out definitivo. Deve attraversare il melodramma,<br />
condurlo a sé, sedurlo, rendere improduttiva la sua<br />
circolazione.<br />
Spettacolo dunque arrestato, avente come posta la “morte ne-<br />
535<br />
Eliseo Mattiacci, Predisporsi ad un capolavoro cosmico-astronomico, 1981-’82.<br />
Luigi Mainolfi, Le basi del cielo, 1982, installazione, terracotta.<br />
Mario Nanni, Solidificazione, 1982, gesso e scaiola, cm 100x100x140.
Gianfranco Notargiacomo, 1945, 1982, smalto, acrilico, lamiera su tela, cm 150x200.<br />
gata”, la fine dello spettacolo, il risucchiamento delle superfici. Il<br />
vero ‘intermondo’ dell’attore, costretto a giocare il ruolo della<br />
scimmia nel mondo della simulazione, non starebbe dunque sul<br />
versante dei non-nati.<br />
Deve innanzitutto vivere il morire. La recitazione riguarda l’altra<br />
parte, il dopo la creazione, l’entropia ridotta al punto zero. Il<br />
coma del pieno.<br />
Naufragio energico, accelerato e soprattutto padroneggiato. Arte<br />
del vuoto. Per questo si può parlare di rito del morire e di messa<br />
a morte. Se mancano i simboli della scienza sacra che il melodramma<br />
tiene a distanza, è ben attivo però il funzionamento<br />
della macchina di sparizione, la partitura del liquefare.<br />
536<br />
Congegno di vibrazioni, per di più ubiquitario, atmosferico, ambientale.<br />
Circostanza, questa, non da poco, relativa al teatro “totale”<br />
dell’immagine e non a caso presente in altre teorizzazioni<br />
della spettacolarità astratta, per esempio in Bob Wilson; ed in<br />
genere invocata laddove la componente cinetico-visiva assume<br />
un ruolo centrale. O sia evocata sullo sfondo.<br />
(1) Scritto in occasione della mostra “L’occhio del cielo”, Casa del Mantegna,<br />
Mantova, 19 giugno-17 luglio 1983.
Sulla soglia delle figure<br />
Sonia Costantini (1)<br />
Dapprima c’è il campo, la mappa; un perimetro entro il quale provocare<br />
l’interrogazione. Può essere una zona quadrettata, il foglio<br />
d’un taccuino ed anche una tavola dipinta, ma quel che importa<br />
è soprattutto la morbidità e l’arrendevolezza del supporto, il suo<br />
cedere e saper trasalire ai minimi tocchi ed agli eccitamenti cromatici,<br />
a pieghe e strofinature, come fa il pelo dell’acqua che s’increspa<br />
al passare del vento. Lavorando di punta o di veloci pressioni<br />
il pennello misura la superficie con leggerezza, vi lascia dei<br />
segni e sgomitola dei soffi.<br />
Tra la mano, le carte e i colori si intreccia un dialogo intermittente,<br />
talora si accenna ad un racconto o ad uno smarginamento figurale.<br />
Se la materia è fluida, trasparente, velata, anche l’andirivieni dello<br />
sguardo ha il peso di un alito. Così Sonia Costantini scopre la complementarietà<br />
del liquido e dell’aereo, riuscendo a portare il respiro<br />
nei mondi dell’umido. Una maniera di dipingere, la sua, tutta volta<br />
a cercare miraggi dentro le spume e a strappare fantasmi dallo specchio<br />
solo in apparenza cristallino dell’immaginazione.<br />
Pozzo e stagno, polla d’acqua. Evidentemente anche il pozzo<br />
della memoria. Ogni cosa vi si macera e scioglie poiché l’esperienza<br />
non è altro che il fluire continuo dei pensieri ed il pensiero<br />
interpella le proprie sorgenti, l’archivio delle immagini ed ancora<br />
più le origini che le determinano, il ‘seme’ delle figure. Anzi, proprio<br />
il passaggio dall’immagine già costituita (e preservata) alla<br />
S. Costantini, Senza titolo, 1982, colori in polvere e collage su cartone, cm 24x30.<br />
537<br />
motilità del germinare, l’interesse via via più acuto per la genesi,<br />
costituiscono il dato innovatore degli ultimi lavori. Un tema che già<br />
s’intuiva nelle trame di fili, nelle barre e legamenti dei fogli<br />
dell’82, nelle carte dove affiorava il desiderio di toccare il fondo<br />
e quasi di accecarsi sotto i minimi visibili. Appena qualche mese<br />
fa profili e contorni si incaricavano di assicurare il destino delle figure.<br />
Bastava un frammento d’aquilone, una parete di casa, o un<br />
filo d’argento per segnalare che un’immagine continuava a vivere<br />
intatta e poteva anche salvare lo sguardo. Ed erano presenze quasi<br />
sempre felici, nonostante refoli e brandelli, estratte dal magazzino<br />
del sogno e dei giochi, provenienti dall’infanzia delle cose, come<br />
il cavallo o la marionetta delle fiabe.<br />
Senonché, ad agitarla, la superficie dello stagno s’intorbida ed innesca<br />
un’avventura di cancellazione. Corrode le cose possedute.<br />
Col tragitto di discesa, scompaiono le certezze del disegno e<br />
viene meno il potere di ritagliare l’oggetto, di dargli un volto e un<br />
nome. Restano soltanto degli eventi di gestazione, un pullulare di<br />
sostanze possibili. Non la figura ma la sua virtualità.<br />
Ciò che vive prima dell’immagine ed anticipa il visibile, dunque<br />
il colore con la sua energia espansiva e cangiante, diventa l’universo<br />
da sondare, il non-nato da opporre alla fissità dell’esistente.<br />
È perciò accaduto che lo sguardo, dopo aver percorso gli spartiti<br />
della memoria ed aver attraversato tante stanze e momenti di veglia,<br />
abbia oltrepassato la soglia di casa, per affacciarsi al buio in<br />
cui si preparano i nomi e i segni.<br />
Che si tratti di uno stato aurorale piuttosto che di pura informalità<br />
lo dimostra la storia delle immagini. Tant’è che non è la materia<br />
in sé e per sé, ma la grammatica del fare (la fattura e la pratica<br />
del dipingere) a subire i processi fusionali delle colle e delle<br />
muffe, a bagnarsi, imputridire e rinascere a forza di macerazione.<br />
Da questa matrice e non da altro vengono fuori le nuove presenze.<br />
Sono le carte, i fili, gli strappi, i colori i veri ingranaggi del racconto.<br />
Da lì si sprigionano gli incanti della finzione, magari degli ingorghi<br />
e dei vortici, le pirotecnìe del fluido. Sicché non sorprende che<br />
l’ambivalenza torni a circolare in questo mondo subacqueo dove<br />
esplodono fulmini e si aggirano code di comete. Vale a dire talismani<br />
e geroglifici celesti.<br />
(1) Scritto in occasione della mostra “Sonia Costantini”, Libreria Galleria<br />
“Einaudi”, Mantova, giugno 1983.
Fotografare come un gotico<br />
Christian Schad (1)<br />
Schadografie, ossia disegni e scritture di Schad. Così Tristan Tzara<br />
ebbe a chiamare con efficace neologismo le composizioni fotografiche<br />
che il dadaista Christian Schad aveva realizzato nel 1918<br />
a Zurigo, in pieno Cabaret Voltaire, deponendo sulla carta emulsionata<br />
pezzi di giornale, oggetti e ritagli di vario genere sui<br />
quali faceva cadere la luce. Se il procedimento non era nuovo, fu<br />
nuova però e inconfondibile la qualità dei risultati. Innanzitutto il<br />
pittore tedesco rigettava ogni intento formalizzante e analitico<br />
del fotogramma; ed insieme all’oggettività dell’analisi, qualsiasi<br />
parentela con i media tecnologici e il linguaggio della scienza. Il<br />
sapere della luce gli appariva estraneo a tutti i marchingegni,<br />
diorama e camere ottiche escogitate in epoca moderna, un’età<br />
che il suo sguardo di visionario considerava con orrore. Schad ve-<br />
C. Schad, Senza titolo, 1962, tecnica mista.<br />
538<br />
niva infatti da una generazione di apocalittici e sognava la “redenzione<br />
verso le stelle” dopo il calvario sulla terra. Non per<br />
nulla il tramite che lo portò al Dada zurighese, dentro l’orbita<br />
mistica di Hugo Ball, fu l’utopia astrale della rivista “Sirius” diretta<br />
dall’amico W. Serner.<br />
Per lui, come per gli espressionisti dai quali discendeva, solo la<br />
civiltà gotica e la Rinascenza ermetica avevano conosciuta l’autentica<br />
magia della luce. Lo incantavano Baldung, Grien, Cranach,<br />
Grünewald, gli xilografi medievali, Carpaccio, Leonardo.<br />
Sicché era inevitabile che, date simile premesse, la fotografia più<br />
che dar vita ad un nuovo linguaggio, subisse l’imperativo di un<br />
occhio prepotentemente inattuale che l’assimilava ad una pratica<br />
incisoria aspra, fatta di luci intermittenti e di blocchi d’ombre,<br />
durissima nell’esecuzione. Se lo sperimentalismo risulta innegabile<br />
nell’audace mescolamento del collage con la tecnica del<br />
contatto, ciò nonostante quel che resiste sul fondo ha ben poco<br />
da spartire con l’avanguardismo modernista ed è la temperatura<br />
contrastata della visione, l’urto di luci ed ombre, l’impianto in<br />
certo modo xilografico delle figure. E per quanto pronunciato sia<br />
l’astrazione, sprigiona sempre dei drammi di figure in cui emergono<br />
talora degli annunci narrativi, cenni di quel racconto di miti<br />
e visioni che avrà poi modo di distendersi liberamente negli ultimi<br />
anni.<br />
Il fatto è che astrarre nel caso di Schad, voleva dire purificare,<br />
puntare più all’essenziale, cogliere ‘l’intimo’ delle cose un po’<br />
come facevano Schwitters e Arp riattivando materiali di scarto o<br />
interpellando animisticamente i corpi naturali. Tant’è vero che lo<br />
scavo realistico, di un realismo singolarmente allucinato e tipicamente<br />
tedesco, espressivo e fisiognomico, costituiva il termine<br />
costante di partenza e ritorno per l’artista, secondo una prospettiva<br />
che lo spingeva soprattutto ad indagare la figura dell’uomo,<br />
quella presenza terrestre che la memoria nordica dei misteri<br />
medioevali tornava a proporre all’inizio del secolo; specialmente<br />
il volto dell’esule e del perseguitato, còlto in molteplici autoritratti<br />
ed immagini di ribelli, martirizzati e protetti. Ma soltanto<br />
in loro.<br />
Contemporaneamente agli svolgimenti sublimi del tema, troviamo<br />
infatti il quadro della devastazione quotidiana, dei cabaret,<br />
postriboli e “calvari notturni” in cui si riaffaccia la peripezia della<br />
caduta, accompagnata dalle tentazioni del santo e dagli spetta-
C. Schad, Senza titolo, 1976, tecnica mista.<br />
coli enigmatici del desiderio. Si capisce allora perché Schad aderisse,<br />
a metà del Venti, alle ragioni morali (e non politiche) della<br />
Nuova Oggettività e perché tornasse a incidere su metallo e su<br />
legno per decifrare il demoniaco della metropoli. Quando tornerà<br />
alla fotografia un quarantennio più tardi, lo farà per una sorta<br />
di riconversione nostalgica, ormai molto intenerita, alle mitologie<br />
del Dieci (il suo decennio “selvaggio”), mettendo in scena<br />
come su un piccolo palcoscenico di carta i fantasmi della giovinezza:<br />
trine e dischi magici, coboldi, l’immagine dell’Eletta e gli<br />
Sputi di strega, la grande maschera e l’ombra del nuovo evo, infine<br />
il seme di Dada, Dadanux, con i suoi numi tutelari e i prismi<br />
dell’illusione; una recita a mezza voce, sussurrata e tuttavia sorvegliatissima.<br />
539<br />
Quest’Hommage à Dada è ora al centro di una mostra grafica ordinata<br />
dal Goethe Institut ed ospitata presso la galleria “La Torre”<br />
per iniziativa dell’Istituto Mantovano di Cultura germanica: 29<br />
pezzi in tutto, ma splendidi. Una campionatura suggestiva delle<br />
varie fasi dell’autore, compresi alcuni fogli della collaborazione a<br />
“Sirius”, una schedografia delle origini e quattro lito del 1928-29.<br />
. (1) Scritto in occasione della mostra tenutasi presso la Galleria d’Arte<br />
“La Torre”, Mantova, 15 settembre 1983.
Risanare l’ombra<br />
Renzo Schirolli (1)<br />
Indubbiamente queste carte hanno a che fare con l’ombra. Testimoniano<br />
di un testa-a-testa con lei. Stanno con l’ombra e al<br />
tempo stesso la interrogano, l’inquietano, la mettono in dubbio,<br />
la fanno lavorare e infine la vincono.<br />
Ma che cos’è l’ombra per Schirolli tra ’57 e ’59?<br />
Innanzitutto non è un’idea, un simbolo. E neppure un fantasma,<br />
un oltre, una sostanza eterea. Tutto al contrario: è una presenza<br />
immediata e palpabile, una realtà senza orizzonte che lo sguardo<br />
incontra alla minima distanza, come il frammento di un muro,<br />
una macchia, uno strato di polvere; e dunque un oggetto non<br />
tanto o soltanto osservato, per di più con attenzione microscopi-<br />
R. Schirolli, Notizie sotto le due torri, 1958, tecnica mista, cm 70x50.<br />
540<br />
ca, quanto soppesato, toccato, tastato. Ma a questa determinazione<br />
abbastanza prevedibile dopo un Burri o un Fautrier, se ne<br />
aggiunge un’altra decisiva e meno ovvia: ed è che il mondo diventa<br />
ombra quando la materia precipita al nero. Nero per il pestaggio<br />
delle figure, l’ imputridirsi dei confini, il macerarsi delle<br />
forme concluse. Nero da forgia fino alle ultime fibre del colore.<br />
E poiché è un nero “fulminato”, non mancano bagliori e incandescenze.<br />
Il fuoco ferve quasi silenziosamente. Manda oscuri<br />
cromatismi e folate di cenere: una lucentezza capovolta e intermittente<br />
che si conserva nel buio.<br />
Quando, sulle tele di quegli anni, si osservano paste accartocciate<br />
o colanti mentre intessono una ragnatela di grumi in un misto<br />
di scorie, vien da pensare all’energia occulta del carbone, come<br />
se si trattasse di conservare delle potenze e portarle a concen-<br />
R. Schirolli, Opera n. 2, 1956, tempera su tela, cm 80x65.
trazione. Cosa ben evidente nei polimaterici del ’58, dove la<br />
mano ha depositato tutta una variegata famiglia di frantumi e di<br />
superfici ossificate; dove ha incollato, stirato, schiacciato e sovrapposto<br />
tanto intimamente le materie che queste si compenetrano<br />
l’una nell’altra mettendo in piedi una sorta di buio retroscena<br />
e voragine, qualcosa di simile ad un mondo cavo in cui le cose<br />
addensate mutano natura. Una trasformazione è in atto ed ecco<br />
quel che avviene. Per quanto graffiata e ferita, ogni parte del<br />
quadro acquista leggerezza e sembra alitare. Ed è proprio la ferita,<br />
quel modo particolare di incidere i corpi, che da un lato li sfigura<br />
e dall’altro sottilizza la regione sotterranea. La materiaombra<br />
diventa velario, trina, panneggiamento dell’ottenebrato.<br />
Può ben parlare Schirolli, intitolando qualche opera di allora, di<br />
muri ciechi e di zone opache. Tanto la tenebra non è mai totale.<br />
541<br />
O meglio, ne può parlare perché l’opacità è l’antagonista da inseguire<br />
e pestare: un avversario ambivalente che ha in serbo dei<br />
tesori e, messo alla tortura, sprigiona dei lampi. Più di una volta<br />
la tela mette in mostra la doppiezza dell’ombra giocando sulla<br />
natura contrastante dell’elemento materico, sull’alternanza di un<br />
volto raffinato e di uno sordo e pesante, col risultato che quest’ultimo<br />
viene costretto in certo modo alle corde ed infine coopera<br />
alla costruzione di spazi misurati disegnando simmetrie e<br />
rapporti di equilibrio.<br />
Naturalmente un simile addomesticamento non avviene per<br />
caso. Se la materia è selvatica, la pittura rappresenta proprio<br />
l’esperienza di passaggio attraverso la quale un dato impulsivo<br />
viene filtrato e composto. Come ogni processo di metamorfosi,<br />
si avvale anch’essa di speciali procedure riequilibranti, una delle<br />
R. Schirolli, T.C. 57, 1957, tempera e china su carta, cm 49x36,5. R. Schirolli, Notizie sotto le due torri, 1958, tecnica mista, cm 70x50.
quali consiste, per esempio, nel dare all’ombra una o più linee<br />
d’orizzonte, stirandola frontalmente sugli incrociamenti delle verticali<br />
e delle orizzontali; un’altra nell’addensarla dentro perimetri<br />
circolari, crateri e avvallamenti. In ogni modo la pittura interviene<br />
col sapere che le viene dalla più pura tradizione neoplastica,<br />
facendo leva sull’ordine assiale e sulla costolatura centrale del dipinto.<br />
E lo fa senza mezzi termini, non solo imponendo questa<br />
compostezza per via di sciabolate e incisioni ma ricorrendo<br />
anche all’incinerimento estremo del fuoco.<br />
Se prendiamo ora le carte, dove il disegno interviene in modo<br />
consistente ma raramente da solo, visto che il procedimento si<br />
arricchisce di altre tecniche oltreché di mistioni con le ocre, coi<br />
gialli e i bruni di tempera, incontriamo un’attitudine parallela a<br />
quella degli oli. Salvo che occorre registrare un salto rispetto alle<br />
tele: uno scarto che non è semplicemente dovuto ad un cambiamento<br />
di genere, ma a qualcosa di qualitativamente diverso<br />
che avrà poi effetti risolutivi anche sulla pittura. Si tratta, come<br />
dire?, di un cambio di rito che dall’incenerimento passa alla via<br />
umida, alla purificazione per acqua.<br />
Forse per virtù di un caso (Schirolli ricorda l’accidentale caduta di<br />
un foglio dentro un secchio) o per effetto di una sollecitazione<br />
provocata dai lavori all’acquaforte, con le loro morsure lenticolari<br />
e smorzate, l’erosione cambia statuto. Accoglie il liquido. L’impuro,<br />
il pesante, l’informe vengono iniziati ad altro mediante una<br />
immersione violenta, una vera e propria docciatura.<br />
Progressivamente le superfici avanzano verso il chiaro, senza<br />
che l’imbianchimento comporti di per sé la fine dello scontro,<br />
poiché il bianco può essere tante cose contemporaneamente,<br />
ma mai una chiarezza venuta dal di fuori, una entità priva di legami<br />
e tantomeno una luce dipinta. Non vi sarebbero altrimenti<br />
tanti bordi smagliati, tante ferite e slogamenti. Il fatto è che la<br />
bianchezza assume un andamento tagliente, segmentato. La<br />
corrente umida, scorrendo sulla materia, la sottilizza sottraendola<br />
alla sua stessa bêtise. Un’acqua beninteso bruciante, abrasiva,<br />
agitata, che ora squarcia e mette a nudo ed ora cade come un<br />
velo sui segni d’inchiostro.<br />
Sul foglio (stavo per dire in questa sorgente e pozzo) si vedono<br />
subito gli effetti del combattimento, così da far pensare che nel<br />
cuore d’ogni carta deve esserci stata un’esplosione, come un<br />
moto cieco di sparpagliamento dell’ombra. Tutto insomma sem-<br />
542<br />
bra incominciare da un fondo e da un centro che liberano il materico<br />
per irradiazione e quasi lo polverizzano. Ma contemporaneamente<br />
si fa in modo che l’irruzione dell’oscuro si consumi<br />
dentro un territorio-graticola, già grigliato in precedenza dalla<br />
tempera, preparato a riceverne l’inseminazione e in grado di riqualificarla.<br />
Mentre l’imprimitura funziona normalmente da sostegno<br />
per l’immagine, qui la preparazione del fondo è destinata<br />
a scollarsi nel bagno successivo. Anticipa la sottrazione occupando<br />
alcuni luoghi-chiave che serviranno a cifrare l’avversario<br />
prima che l’intensivo si scateni con conseguenze irreversibili.<br />
Come non parlare allora di una trappola guaritrice? Di una macchinazione<br />
pittorica predisposta, analogamente a quel che avviene<br />
nelle dissociazioni ritualizzate, ad accogliere una forza minacciosa<br />
e a canalizzarla?<br />
Quando l’acqua, per spruzzatura o immersione, inonderà l’interno<br />
del campo e metterà in luce l’esorcismo sotteso allo scuro,<br />
quel tatuaggio potrà agire in senso armonizzante. Affioreranno<br />
costole e spiragli, fessure e trasparenze, vale a dire le tessiture<br />
al bianco dell’ombra, le trame di un disegno che hanno scavato<br />
mappe luminose dentro e sotto l’evidenza fisica del buio.<br />
Una cancellazione? È vero piuttosto che - ancora una volta - si è<br />
preservato il rivale dalla dispersione. Lo si è agganciato per ritmarlo<br />
con finalità costruttive.<br />
Ad un certo momento (quando la cerimonia avrà assunto cadenze<br />
meno aspre e la mano busserà lievemente, più che battere,<br />
alle porte dell’ombra), la durezza del combattimento farà<br />
pronunciare parole d’odio nei confronti dell’antagonista, o meglio<br />
di quella parte che non si è lasciata ridurre: un odio vero e necessario.<br />
Il pittore le pronuncerà in nome dell’immagine mentre<br />
sta percorrendo stazioni di risalita. Eppure l’immagine nasce<br />
dalle riserve generative della materia e compare fra i battenti<br />
dell’ombra finalmente schiusa.<br />
Si guardi il foglio. L’ombra continua a girare e a lasciare impronte.<br />
Non copre più né acceca. Si muove sulle punte, di taglio e per<br />
tracce. È l’ombra lavata, preludio delle figure.<br />
(1) Scritto in occasione della mostra “Renzo Schirolli negli anni Cinquanta”,<br />
tenutasi presso la Libreria Galleria “Einaudi”, Mantova, ottobre<br />
1983.
Cere come stanze mentali<br />
Giovanni d’Agostino (1)<br />
Che per vedere intensamente occorra prima diventare ciechi,<br />
d’Agostino lo avverte fin dall’inizio, già alle soglie del Settanta,<br />
quando comincia a sottoporre lo sguardo ad una lunga serie di<br />
esercizi di cancellazione: esercizi ‘pesanti’ che, mentre producono<br />
(ed anzi proprio nel produrre) immagini dure e lavorate come<br />
oggetti, al tempo stesso sottraggono carne alle figure. Di queste<br />
non rimangono intatti che i bordi, i confini, le zone pellicolari, di<br />
modo che l’occhio finisce con lo sbattere contro superfici impermeabili:<br />
bianche, cieche e fantasmatiche.<br />
È una battaglia, direi, contro il corpo delle cose, combattuta dentro<br />
gli spessori del reale. Par quasi che egli voglia assumere una<br />
presenza col proposito di annientarla introducendovi dei cortocircuiti<br />
di vuoto, contraddicendola e spaesandola.<br />
Per di più lavora su figure elementari, anche idee di figure, che<br />
si riferiscono o appartengono all’universo naturale: paglie, sassi,<br />
erbe e tronchi raccolti e imballati. Ingabbiati e molto spesso verniciati<br />
di bianco.<br />
Dunque i segni, al pari dell’occhio che li osserva, vengono legati<br />
in catene e dislocati. Ma come? In che senso va la costrizione?<br />
G. d’Agostino, Trasparenze e spessori, 1983, legno, panno e cera, cm 177x177.<br />
543<br />
Potrei dire che se da un lato v’è l’accumulo delle cose, un darle<br />
in tutta la loro pesantezza, sottolineandone perfino il radicamento<br />
al suolo mediante blocchi serrati, dall’altro quelle medesime<br />
cose vengono disposte lungo percorsi tendenzialmente<br />
verticalizzanti ed aerei.<br />
Dapprima hai l’impatto con la gravità, con un terrestre imbiancato<br />
e circoscritto, poi quel terrestre lo vedi inerpicarsi per gradi<br />
e costruire muraglie, colonne che si perdono nell’aria; o accenni<br />
di ziggurat.<br />
Il minerale insieme al legno, all’organico. Ma questo organico appare<br />
decapitato e defigurato, un fossile di organico, un totem, un<br />
tronco d’albero. E subito dopo eccolo, mummia o dormiente che<br />
sia, tentare una avventura di leggerezza, spinto com’è a negarsi<br />
nel volatile e nel luminoso.<br />
In questa prima fase, comunque si svolga il tragitto dell’opera,<br />
quel che appare costante è la partitura conflittuale del lavoro,<br />
poiché una energia di contrasto, una minaccia (o promessa) di<br />
incandescenza sovrasta la fissità delle effigi. Nell’allineare, ad<br />
esempio una fila di tronchi, l’artista cala su ciascuno di essi dei<br />
fasci di luce elettrica con l’intento di produrre un urto dentro<br />
l’immobile. E di folgorarlo.<br />
Se poi erige, come fa nel ’72, una stele di ceppi sovrapposti la<br />
forza cui ricorre è ancor più dissolvente, poiché immagina di tuffarne<br />
la cima nella profondità vertiginosa del cielo aperto. La<br />
chiama palafitta per la città nuova, che è titolo già di per sé stracarico<br />
di significati, latore di un’utopia di redenzione quando lo<br />
si pensi riferito a Venezia, città per antonomasia delle acque<br />
morte, del declino e dell’impaludamento.<br />
D’Agostino conosce bene la mitologia del moderno, l’ibris costruttiva<br />
della tecnica, il progetto estetico dell’avanguardia. Lo afferra<br />
e lo irrealizza sospendendolo nell’impossibile: un’utopia si<br />
badi bene, cifrata nella tessitura ermetica di un numero, il tre,<br />
che la sposta sul versante della segretezza e del silenzio.<br />
Anche altrove lo vediamo riattivare il volto interno delle cose,<br />
accedere, chiudendo le palpebre, ad una vita più ‘vera’ che per<br />
lui è plasticità inesausta e trasformazione, pneuma. Mi spiego allora<br />
l’insisistenza sulle procedure dello sciogliere, dello spezzare,<br />
del mettere a fuoco. E capisco l’attrazione esercitata da Rimbaud,<br />
Klein, Rotko, il primo Artaud, quello di "Paolo degli Uccelli", l’accecamento<br />
dello sguardo, il rifiuto dello spettacolare e il disgu-