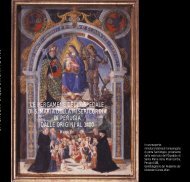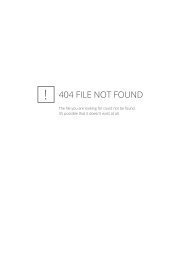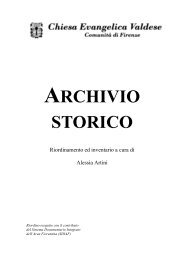esercito e città dall'unità agli anni trenta. tomo i - Sistema ...
esercito e città dall'unità agli anni trenta. tomo i - Sistema ...
esercito e città dall'unità agli anni trenta. tomo i - Sistema ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
522 NICOLA LABANCA<br />
siano un ordine, una subordinazione e una separazione tra forze armate e<br />
società paragonabile a quello che il vecchio sistema francese e lamarmoriano<br />
aveva garantito al Piemonte costituzionale e nei primi <strong>anni</strong> dell'Italia<br />
unita 4?<br />
La forza coercitiva e il variegato sistema repressivo, sociale e 'regolamentare'<br />
5 dell'istituzione militare, risolsero poi di fatto quel 'gravissimo<br />
problema'. I sinistri scenari dei b<strong>agli</strong>ori comunardi parigini non sarebbero<br />
stati rinnovati solo per via di quella specie di 'armamento del popolo' che<br />
la riforma militare di Ricotti pareva a tal uni minacciare 6. Nonostante questa<br />
forza dell'istituzione, nei lunghi <strong>anni</strong> di pace dal l870 al l915 consistenti<br />
settori del mondo militare italiano sentirono il bisogno di controllare la società,<br />
di normalizzare il popolo dentro l'<strong>esercito</strong>, di educare il soldato.<br />
Rivolto ai coscritti, un ufficiale notava: " Ciascuno di voi, per sé, conta<br />
poco o nulla; tutti assieme siete una forza immensa " 7 . Il timore di questa<br />
forza fu in taluni momenti e in taluni ambienti certo eccessivo: l'istituzione<br />
militare italiana - come si è detto - resse, negli <strong>anni</strong> di pace, alla riforma<br />
Ricotti, alla ferma breve, e a ben altro. Cinicamente, ma senza ragioni, ci<br />
fu chi scrisse:<br />
Si acquetino dunque gli allarmati: abbiamo avuto, è vero, nel nostro <strong>esercito</strong><br />
una dozzina di Misdea ma abbiamo avuto un solo Barsanti 8.<br />
Fu comunque per via di quel timore che si dispiegò nei confronti delle<br />
masse dei soldati divenuti coscritti, con le.riforme militari di Cesare Ricotti,<br />
una diversificata serie di iniziative da parte di alcuni settori dell'ufficialità<br />
del tempo. Non si trattava certo del complesso insieme di misure messo in<br />
4 Una canonica interpretazione del 'sistema francese', e delle differenze rispetto al<br />
'sistema prussiano', è in P. PIER!, Storia militare del Risorgimento. Guerre ed insurrezioni,<br />
Torino, Einaudi, 1958, p. 166 sgg. Meno accentuata è l'opposizione dei due sistemi<br />
in ]. GoocH, Militari e borghesi nell'Europa moderna, Bari, Laterza, 1982, p. 56 sgg.<br />
s Per alcuni aspetti della vita di caserma, in sé e quale la videro gli antimilitaristi,<br />
cfr. G. OLIVA, Esercito, paese e movimento operaio. L 'antimilitarismo dal 1861 al! 'età<br />
giolittiana, Milano, Angeli, 1986, pp. 44-55; sull'uso dell'<strong>esercito</strong> in funzione del mantenimento<br />
dell'ordine pubblico cfr. L. VIOLANTE, La repressione del dissenso politico nell'Italia<br />
liberale: stati d'assedio e giustizia militare, in " Rivista di storia contemporanea<br />
"• a. V (1976), pp. 481-524.<br />
6 Sul timore sollevato, in alcuni ambienti conservatori, cfr. V. GALLINARI, Le riforme<br />
militari di Cesare Ricotti, in " Memorie storiche militari 1978 '' Roma USSME 1979<br />
p. 22 e p. 25.<br />
' ' '<br />
'<br />
7 "Il giornale del soldato "• 5 novembre 1899, F. MosELLA, Siamo tutti camerati.<br />
8 "Rivista militare italiana », a. XLI (1896) vol. 2, p. 10, L. NASI, I fenomeni morbosi<br />
nell'<strong>esercito</strong>, p. 896.<br />
I PROGRAMMI DELL'EDUCAZIONE MORALE 523<br />
moto durante la Grande Guerra e in particolare dopo Caporetto 9. Fu con<br />
il primo conflitto mondiale, e in Italia solo nell'ultimo anno di guerra, che<br />
i comandi militari nella loro globalità avvertirono la necessità di una propaganda<br />
e un'assistenza 'morale' alle truppe, le quali nel frattempo avevano<br />
raggiunto dimensioni quantitative sino ad allora inusitate. Nonostante questo,<br />
già negli <strong>anni</strong> dell'Italia liberale, e soprattutto dopo l'introduzione della<br />
coscrizione universale, alcuni settori del mondo militare intuirono l'importanza<br />
di una 'educazione morale del soldato' o, come la chiamarono, di una<br />
'pedagogia militare'.<br />
Gli strumenti di questa educazione, di questo controllo 10, furono vari.<br />
Le scuole reggimentali, gli opuscoli scritti dal singolo ufficiale appositamente<br />
per la truppa della sua compagnia o del suo reggimento, i tentativi<br />
di elaborare un 'libro per il soldato' che comprendesse tutto lo scibile necessario<br />
per il coscritto, le stesse 'conferenze reggimentali' (da declamarsi<br />
da parte degli ufficiali di fronte alla truppa riunita) costituirono altrettanti<br />
strumenti di quella 'pedagogia militare' che avrebbe dovuto 'educare' il soldato.<br />
Ma altri strumenti, ed altre fonti documentarie, potrebbero trovarsi<br />
per questa 'pedagogia militare'. Ad esempio i 'giornali per il soldato', che<br />
se furono diffusi a centinaia di migliaia di copie durante la Grande Guerra,<br />
fecero le loro prime e poco note prove nei decenni dell'Italia liberale 11.<br />
Quali furono in concreto le linee di questa 'pedagogia militare'? Un bilancio<br />
articolato e dett<strong>agli</strong>ato dovrà attendere l'esame di tutti i versanti della<br />
documentazione relativa alla pluralità di strumenti con cui essa si concretizzò.<br />
In generale, intanto, si può notare come questa 'pedagogia militare' aveva<br />
ascendenze e inflessioni fortemente moderate 12 e come non ambiva ad evidenziare<br />
né un particolare sentimento liberale né un anelito 'popolarnazionale'<br />
1 3 degli ufficiali italiani. Né, come vedremo, copriva progetti<br />
9 Per la prima guerra mondiale cfr. M. lsNENGHI, Giornali di trincea (1915-1918),<br />
Torino, Einaudi, 1977.<br />
1° Cfr. L. NARBONE, Strategie e tattiche del disciplinamento nell 'Italia liberale, in<br />
"Aut aut "• a. 1985 n. 205, p. 44.<br />
11 Cfr., come si è detto, N. LABANCA, Una pedagogia militare per l 'Italia liberale.<br />
I primi giornali per il soldato (1866-1915), in " Rivista di storia contemporanea ,, , a. XVII<br />
(1988) n. 4.<br />
12 Cfr. A. VrsiNTIN, Esercito e società nella pubblicistica militare dell 'ultimo Ottocento,<br />
in " Rivista di storia contemporanea "• a. XVI (1987) n. l, p. 36.<br />
13 Antonio Gramsci, tra gli altri, aveva intuito le potenzialità della 'letteratura militare'<br />
e del suo ascendente popolare. Confrontando la produzione dell'Italia liberale con<br />
quella della Grande Guerra aveva anche abbozzato gli elementi di un giudizio su C. Abba,<br />
E. De Amicis ecc. Molti bozzetti o racconti di questi autori servirono da guida per<br />
l'educazione morale del soldato. Cfr. A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, a cura di V. Gerratana,<br />
Torino, Einaudi, 1975, vol. I, p. 143, vol. III, p. 2009 e p. 2196.<br />
36