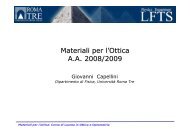Il processo di emmetropizzazione - Università degli Studi Roma Tre
Il processo di emmetropizzazione - Università degli Studi Roma Tre
Il processo di emmetropizzazione - Università degli Studi Roma Tre
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
30<br />
A G G I O R N A M E N T O Contattologia, ottica ed optometria<br />
<strong>Il</strong> <strong>processo</strong> <strong>di</strong> <strong>emmetropizzazione</strong>:<br />
ruolo dei fattori ambientali ed ere<strong>di</strong>tari<br />
Parole chiave<br />
<strong>emmetropizzazione</strong>,<br />
stato <strong>di</strong> refrazione,<br />
deprivazione sensoriale.<br />
Riassunto<br />
I neonati dell’uomo e <strong>di</strong> molte<br />
altre specie tra i vert e b r a t i ,<br />
sono caratterizzati da <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong><br />
refrazione la cui <strong>di</strong>stribuzione è<br />
normale con una me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> circa<br />
2.00 <strong>di</strong>ottrie <strong>di</strong> ipermetropia e<br />
una notevole varianza. Con la<br />
crescita la varianza <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>stri -<br />
buzione <strong>di</strong>minuisce in maniera<br />
netta facendo scorgere la pre -<br />
senza <strong>di</strong> un meccanismo non<br />
casuale <strong>di</strong> eliminazione dei <strong>di</strong>fet -<br />
ti <strong>di</strong> refrazione, conosciuto con il<br />
nome <strong>di</strong> <strong>processo</strong> <strong>di</strong> emmetro -<br />
pizzazione. Anche se i meccani -<br />
smi alla base <strong>di</strong> tale <strong>processo</strong><br />
sono tuttora sconosciuti, si è<br />
proceduto ad una analisi dei fat -<br />
tori potenzialmente implicati, il<br />
tutto alla luce <strong>di</strong> una delle più<br />
accese controversie tra gli stu -<br />
<strong>di</strong>osi dello sviluppo: il <strong>di</strong>battito<br />
natura versus cultura. <strong>Il</strong> quadro<br />
emerso è che i fattori ere<strong>di</strong>tari<br />
sembrerebbero con<strong>di</strong>zionare lo<br />
sviluppo dello stato refrattivo <strong>di</strong><br />
ogni singolo in<strong>di</strong>viduo in una<br />
sorta <strong>di</strong> meccanismo passivo <strong>di</strong><br />
<strong>emmetropizzazione</strong>, ma non<br />
sarebbero in<strong>di</strong>pendenti dalle<br />
influenze ambientali che funzio -<br />
nerebbero da feedback attivo sul<br />
corretto sviluppo oculare.<br />
Introduzione<br />
L’influenza e il ruolo dei fattori<br />
genetici e ambientali nella crescita<br />
<strong>di</strong> un in<strong>di</strong>viduo, è sempre<br />
stata e probabilmente sempre<br />
sarà, fonte <strong>di</strong> acceso <strong>di</strong>battito<br />
tra esperti <strong>di</strong> sviluppo. Questo<br />
perché inevitabilmente ere<strong>di</strong>tà<br />
e ambiente convivono. Se è<br />
vero che due ceppi <strong>di</strong> piante<br />
geneticamente <strong>di</strong>versi, fatte<br />
crescere nel medesimo<br />
ambiente, daranno vite a piante<br />
<strong>di</strong> grandezza <strong>di</strong>verse, è<br />
altrettanto vero che due semi<br />
con genotipo perf e t t a m e n t e<br />
uguale, ma piantati in ambienti<br />
<strong>di</strong>versi, daranno origine a<br />
piante e frutti <strong>di</strong> grandezze<br />
<strong>di</strong>verse (Dawkins, 1992).<br />
La maggior parte delle caratteristiche<br />
fisiche e psicologiche<br />
dell’uomo e <strong>degli</strong> altri<br />
esseri viventi, è quin<strong>di</strong> frutto<br />
dell’interazione <strong>di</strong> molte<br />
influenze genetiche e ambientali.<br />
Questa premessa è particolarmente<br />
vera per lo sviluppo<br />
della percezione del bambino,<br />
il quale, pur <strong>di</strong>sponendo <strong>di</strong><br />
organi sensoriali e reti neurali<br />
<strong>di</strong> processazione in gran parte<br />
determinati alla nascita, ha un<br />
<strong>di</strong>sperato bisogno dall’esperienza<br />
sensoriale (Stassen<br />
Berger, 1996). <strong>Il</strong> primo passo<br />
nella percezione visiva è la<br />
focalizzazione delle immagini<br />
sulla retina che <strong>di</strong>pende dalla<br />
relazione tra il sistema <strong>di</strong><br />
P.O.maggio 2003<br />
<strong>di</strong> Fabrizio Zeri<br />
Optometrista, psicologo<br />
refrazione dell’occhio, composto<br />
da cornea e cristallino, e la<br />
<strong>di</strong>stanza della retina da questo<br />
(lunghezza antero-posteriore<br />
dell’occhio) relazione in<strong>di</strong>cata<br />
come stato <strong>di</strong> refrazione<br />
(Borish, 1970). Quando la<br />
focale delle strutture <strong>di</strong> refrazione<br />
coinciderà con la lunghezza<br />
antero posteriore dell’occhio<br />
ci si troverà in quella<br />
con<strong>di</strong>zione ideale dello stato <strong>di</strong><br />
refrazione, detta emmetropia.<br />
Deviazioni da questa con<strong>di</strong>zione<br />
vengono considerati vizi o<br />
errori <strong>di</strong> refrazione cioè le<br />
ametropie (miopia, ipermetropia,<br />
astigmatismo).<br />
Considerando che il sistema <strong>di</strong><br />
refrazione e la lunghezza antero<br />
posteriore dell’occhio sono<br />
elementi strettamente connessi<br />
alle <strong>di</strong>mensioni della struttura<br />
oculare, deve esser possibile<br />
una crescita armoniosa<br />
<strong>degli</strong> stessi, cruciale per una<br />
adeguata performance visiva.<br />
L’interesse all’argomento dei<br />
molti stu<strong>di</strong>osi della visione<br />
(oftalmologi, optometristi, psicologi,<br />
biologi) che se ne sono<br />
interessati deriva soprattutto<br />
dal fatto che alla nascita lo<br />
stato <strong>di</strong> refrazione del bambino<br />
(questo avviene anche in molte<br />
altre specie <strong>di</strong> animali) è contrad<strong>di</strong>stinto<br />
da una notevole<br />
varianza, cioè dalla frequente<br />
presenza <strong>di</strong> ametropie che<br />
<strong>di</strong>minuisce notevolmente nei<br />
primi mesi <strong>di</strong> vita (Borish,
1970; Calossi e coll 1992;<br />
C u rtin 1988; Rosner e<br />
Rosner, 1990; Zadnik e Mutti,<br />
1998). Questo passaggio dall’ametropia<br />
all’emmetropia<br />
durante la crescita oculare<br />
viene in<strong>di</strong>cato come <strong>processo</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>emmetropizzazione</strong> (Fig. 1).<br />
Tale meccanismo <strong>di</strong> regolazione<br />
evolutiva dello stato refrattivo,<br />
non è esclusivo dell’uomo<br />
infatti è stato rintracciato in<br />
molte specie animali con la<br />
conseguente apertura <strong>di</strong> un<br />
filone comparato <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>.<br />
Nel presente articolo si cercherà<br />
<strong>di</strong> analizzare il ruolo dei<br />
fattori ambientali e genetici<br />
implicati nel <strong>processo</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>emmetropizzazione</strong>, prima<br />
però sarà necessario soffermarsi<br />
sulle caratteristiche dell’occhio<br />
del neonato.<br />
L’occhio del neonato e il suo<br />
sviluppo<br />
Le <strong>di</strong>mensioni dell’occhio del<br />
neonato alla nascita, pur<br />
essendo come quelle del cervello<br />
proporzionalmente più<br />
vicine alle <strong>di</strong>mensioni finali nell’adulto<br />
<strong>di</strong> qualsiasi altra struttura<br />
corporea, non sono ancora<br />
definitive. L’occhio dovrà<br />
crescere ancora, raggiungendo<br />
un peso e un volume tre<br />
volte quelli iniziali, con un<br />
aumento dei <strong>di</strong>ametri oculari <strong>di</strong><br />
circa il 40% (Borish, 1970;<br />
Curtin,1988).<br />
Fig. 1 <strong>Il</strong> fenomeno dell’<strong>emmetropizzazione</strong><br />
(da Zadnik e Mutti, 1998)<br />
A G G I O R N A M E N T O Contattologia, ottica ed optometria<br />
La curva <strong>di</strong> crescita dell’occhio<br />
è molto simile a quella del<br />
sistema nervoso centrale,<br />
piuttosto che a quella della<br />
crescita generale corporea. È<br />
molto rapida nei primi due<br />
anni <strong>di</strong> vita e in pratica si arresta<br />
tra i 10 e i 15 anni.<br />
Le stru t t u re refrattive alla<br />
nascita e il loro successivo<br />
s v i l u p p o<br />
Le principali strutture anatomiche<br />
oculari d’interesse<br />
refrattivo, sono la cornea, il<br />
cristallino, la <strong>di</strong>stanza che li<br />
separa (profon<strong>di</strong>tà camera<br />
anteriore), e la lunghezza<br />
antero posteriore del globo.<br />
Queste strutture infatti, sono<br />
state al centro <strong>di</strong> numerosi<br />
stu<strong>di</strong> sulle <strong>di</strong>mensioni alla<br />
nascita e sulla loro successiva<br />
crescita durante lo sviluppo al<br />
fine <strong>di</strong> determinare il loro<br />
a p p o rto al <strong>processo</strong> <strong>di</strong> <strong>emmetropizzazione</strong><br />
o all’insorgenza<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong> refrazione.<br />
La c o rn e a alla nascita misura<br />
circa 10 mm <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro. Va r i<br />
autori sono concor<strong>di</strong> nel ritenere<br />
che in uno o due anni<br />
raggiunge le sue <strong>di</strong>mensioni<br />
me<strong>di</strong>e massime: 11 mm <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ametro verticale e 12 mm<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro orizzontale<br />
(Borish, 1970; Curtin, 1988;<br />
Rosner e Rosner, 1990).<br />
La curvatura della cornea e<br />
quin<strong>di</strong> il suo potere, tende a<br />
<strong>di</strong>minuire piuttosto vistosamente<br />
nei primi 2/3 anni <strong>di</strong><br />
vita, contribuendo a compensare<br />
la crescita della lunghezza<br />
antero posteriore dell’occhio<br />
(per una rassegna ve<strong>di</strong><br />
Borish, 1970).<br />
La p rofon<strong>di</strong>tà della camera<br />
a n t e r i o re subisce con lo sviluppo<br />
cambiamenti che hanno<br />
uno scarso effetto sulla mo<strong>di</strong>ficazione<br />
dello stato refrattivo,<br />
P.O.maggio 2003<br />
che in questa sede non verranno<br />
presi in considerazione<br />
(per una rassegna ve<strong>di</strong><br />
Borish, 1970).<br />
<strong>Il</strong> c r i s t a l l i n o cresce durante<br />
tutto l’arco della vita, ma<br />
molto più rapidamente nel<br />
primo anno. <strong>Il</strong> potere del cristallino<br />
<strong>di</strong>minuisce con la crescita<br />
(Curtin, 1988; Borish,<br />
1970) infatti il raggio <strong>di</strong> curvatura<br />
delle superfici anteriore<br />
e posteriore si port a<br />
rispettivamente da 5.0 e 4.0<br />
mm alla nascita a 10.0 e 6.0<br />
mm nell’adulto.<br />
La lunghezza antero poster<br />
i o re del bulbo alla nascita si<br />
attesta su valori tra i 17.5 e<br />
i 18.5mm (Sorsby e<br />
Sheridan, 1960). Verso i<br />
13/14 anni l’occhio sarà<br />
completamente sviluppato<br />
arrivando ad un <strong>di</strong>ametro<br />
antero posteriore <strong>di</strong> circa<br />
24.0 mm. La crescita avverrebbe<br />
in due fasi <strong>di</strong>stinte:<br />
- Primaria o infantile: si conclude<br />
a tre anni raggiungendo<br />
i 23.0 mm circa.<br />
- Secondaria: si conclude a<br />
14 anni circa.<br />
Riassumendo, la crescita<br />
oculare porta ad un allungamento<br />
della lunghezza assiale<br />
del bulbo mentre sia la cornea<br />
che il cristallino <strong>di</strong>ventano<br />
più piatti quin<strong>di</strong> meno rifrangenti,<br />
compensando otticamente<br />
l’allungamento.<br />
Un esempio <strong>di</strong> buona e cattiva<br />
coor<strong>di</strong>nazione nella crescita<br />
delle strutture refrattive è<br />
r i p o rtato in figura 2.<br />
Lo stato refrattivo dell’oc -<br />
chio del neonato e il suo<br />
successivo sviluppo<br />
La letteratura scientifica è<br />
veramente ricca <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> che<br />
hanno cercato <strong>di</strong> valutare lo<br />
stato refrattivo del neonato.<br />
Vuoi però per <strong>di</strong>fferenze nel<br />
31
32<br />
metodo <strong>di</strong> valutazione della<br />
refrazione (oftalmoscopia<br />
<strong>di</strong>retta, retinoscopia, uso o<br />
non uso del ciclopegico etc),<br />
nella grandezza del campione<br />
esaminato, nel sesso e nell’età<br />
precisa dei soggetti, i risultati<br />
sono abbastanza eterogenei.<br />
Al fine <strong>di</strong> far or<strong>di</strong>ne e cercare<br />
<strong>di</strong> permettere un colpo d’occhio<br />
generale alla ricerca <strong>di</strong> un<br />
valore me<strong>di</strong>o, i risultati <strong>di</strong> questa<br />
notevole mole <strong>di</strong> stu<strong>di</strong><br />
sono stati raggruppati in tabella<br />
1.<br />
Nel 1980, Banks (citato in<br />
Rosner e Rosner 1990) pubblica<br />
una valutazione trasversale<br />
<strong>di</strong> 11 stu<strong>di</strong> pubblicati tra il<br />
1892 e il 1974, alcuni dei<br />
quali sono riportati nella tabel-<br />
A G G I O R N A M E N T O Contattologia, ottica ed optometria<br />
la sopra, per un totale complessivo<br />
<strong>di</strong> 3057 bambini compresi<br />
tra 1 e 10 giorni dalla<br />
nascita, affermando in conclusione<br />
che:<br />
• La <strong>di</strong>stribuzione dei <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong><br />
refrazione alla nascita è <strong>di</strong> tipo<br />
“ n o r m a l e ” .<br />
• La me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>stribuzione<br />
è <strong>di</strong> +2.00D, la deviazione<br />
standard <strong>di</strong> 2.00.<br />
Soprattutto i due dati numerici<br />
sono ben evidenziabili sia in<br />
figura 1 che in tabella 1, e ci<br />
in<strong>di</strong>cano come alla nascita c’è<br />
una forte tendenza all’ipermetropia<br />
ma anche una notevole<br />
varianza dei dati.<br />
P a rtendo da una <strong>di</strong>stribuzione<br />
pressoché “normale” dello<br />
stato refrattivo nei neonati con<br />
Tabella 1: Tabella riassuntiva dei principali lavori <strong>di</strong> ricerca che<br />
hanno in<strong>di</strong>cato lo stato refrattivo del neonato<br />
Fig. 2 Esempi <strong>di</strong> relazione tra le strtture refrattive oculari. A: la crescita<br />
della lunghezza assiale nei tre casi è coor<strong>di</strong>nata alla variazione del pote -<br />
re <strong>di</strong> cornea e cristallino per cui l’effetto finale è l’emmetropia. B: in quesi<br />
tre casi la variazione della lunghezza assiale non è coor<strong>di</strong>nata con le varia -<br />
zioni <strong>di</strong>ottriche delle lenti, ciò originerà ametropia (Sorsby e coll 1961,<br />
rintracciato da Curtin, 1988)<br />
P.O.maggio 2003<br />
me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> circa +2.00D, il<br />
trend che si riscontra da analisi<br />
successive a 3 anni<br />
(Ingram e Barr, 1979), a 6<br />
anni (Hirsch, 1963; Sorsby,<br />
1957; Goldschmidt, 1968;<br />
citati in Rosner e Rosner<br />
1990) per arrivare all’adolescenza<br />
(Hirsch, 1964) è quello<br />
<strong>di</strong> una <strong>di</strong> una progressiva<br />
l e p t o c u rtosi della <strong>di</strong>stribuzione,<br />
che dopo raggiunta una<br />
simmetria all’età <strong>di</strong> 10/11<br />
anni, <strong>di</strong>viene asimmetrica<br />
verso la miopia (Borish,<br />
1970). In poche parole la<br />
varianza della <strong>di</strong>stribuzione si<br />
riduce drasticamente (<strong>emmetropizzazione</strong>),<br />
e pur rimanendo<br />
prevalente l’emmetropia, la<br />
miopia <strong>di</strong>venta più comune dell<br />
’ i p e r m e t r o p i a .<br />
Saunders e coll (1995), in uno<br />
stu<strong>di</strong>o longitu<strong>di</strong>nale (primi 18<br />
mesi <strong>di</strong> vita) su 22 soggetti<br />
hanno in<strong>di</strong>viduato che la velocità<br />
<strong>di</strong> <strong>emmetropizzazione</strong> è in<br />
relazione al livello del <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong><br />
refrazione presente. Tanto più<br />
questo sarà alto alla nascita,<br />
tanto più velocemente avverrà<br />
la sua neutralizzazione (Fig. 3).<br />
È interessante notare come<br />
popolazioni <strong>di</strong> soggetti han<strong>di</strong>cappati<br />
adulti mostrano una<br />
incidenza maggiore <strong>di</strong> <strong>di</strong>fetti<br />
refrattivi rispetto a popolazioni<br />
normali, il che in<strong>di</strong>cherebbe un<br />
<strong>processo</strong> <strong>di</strong> <strong>emmetropizzazione</strong><br />
non corretto in tali soggetti<br />
(Saunders, 1995).
A G G I O R N A M E N T O Contattologia, ottica ed optometria<br />
Fig. 3 Variazione nella refrazione nei primi mesi <strong>di</strong> vita in 7 bambini: è evidente<br />
come più il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> refrazione alla prima valutazione è alto più la linea tra i due<br />
sta<strong>di</strong> refrattivi è ripida cioè l’<strong>emmetropizzazione</strong> procede rapidamente (Saunders<br />
e coll, 1995)<br />
<strong>Il</strong> <strong>processo</strong> <strong>di</strong> emmetro p i z z azione:<br />
fattori ambientali o<br />
g e n e t i c i ?<br />
La <strong>di</strong>stribuzione leptocurtotica<br />
dello stato refrattivo in soggetti<br />
adulti, e quin<strong>di</strong> la presenza<br />
massiccia <strong>di</strong> soggetti emmetropi<br />
o vicini all’emmetropia<br />
(notevolmente maggiori <strong>di</strong><br />
quanto ci si aspetterebbe se la<br />
<strong>di</strong>stribuzione fosse tipicamente<br />
normale come ad esempio per<br />
l’altezza o il peso), <strong>di</strong>mostrerebbe<br />
come tra gli elementi<br />
che compongono la refrazione,<br />
non c’è libera associazione, ma<br />
il tutto è guidato da un <strong>processo</strong><br />
che ha come preciso scopo<br />
quello <strong>di</strong> eliminare i <strong>di</strong>fetti<br />
refrattivi. Tale <strong>processo</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>emmetropizzazione</strong>, sebbene<br />
maggiormente evidente nell’infanzia,<br />
sembrerebbe assistere<br />
l’uomo per tutto l’arco della<br />
sua esistenza (Ooi e<br />
Grosvenor, 1995). Sul <strong>processo</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>emmetropizzazione</strong> è<br />
stato veramente scritto molto.<br />
Tutto questo interesse alla<br />
comprensione dei meccanismi<br />
sottostanti al fenomeno che<br />
spinge la ricerca, è certamente<br />
la scommessa <strong>di</strong> poter<br />
i n t e rvenire sul meccanismo<br />
stesso quando questo non funziona<br />
originando i <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong><br />
refrazione. Per il momento<br />
siamo ancora lontani da una<br />
tale possibilità, e ciò perché<br />
siamo nella fase delle ipotesi<br />
sul meccanismo che è a tutti gli<br />
e ffetti ancora sconosciuto.<br />
Molti però sono i risultati sugli<br />
e ffetti dei fattori ambientali ed<br />
ere<strong>di</strong>tari sul <strong>processo</strong>. Di seguito<br />
viene effettuata una breve<br />
revisione delle principali conclusioni.<br />
Prima <strong>di</strong> procedere però,<br />
è interessante riportare l’ipotesi<br />
<strong>di</strong> alcuni autori (Glickstein e<br />
Millodot, 1970; Millodot e<br />
O ’ L e a ry, 1978) che si muovono<br />
fuori dal <strong>di</strong>lemma natura vs cultura,<br />
sostenendo che il <strong>processo</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>emmetropizzazione</strong> non<br />
sarebbe altro che un grosso<br />
errore <strong>di</strong> valutazione. Gli esami<br />
refrattivi sul bambino si aff i d ano<br />
prevalentemente alla retinoscopia,<br />
che sfrutta il riflesso<br />
retinico. La luce riflessa sulla<br />
retina avviene però su <strong>di</strong> un<br />
piano <strong>di</strong>verso (più interno) <strong>di</strong><br />
quello dei recettori, questo nel<br />
bambino è maggiormente vero<br />
perché i due piani sono piuttosto<br />
<strong>di</strong>stanti. Risultato <strong>di</strong> quest’errore<br />
<strong>di</strong> misura sarebbe<br />
dunque una sovrastima dell’ipermetropia<br />
nel bambino.<br />
Seppure molto interessante,<br />
questa spiegazione ha <strong>di</strong>versi<br />
limiti, come quello <strong>di</strong> non considerare<br />
che un import a n t e<br />
aspetto del <strong>processo</strong> <strong>di</strong> <strong>emmetropizzazione</strong><br />
è la <strong>di</strong>minuzione<br />
della varianza generale che<br />
implica non solo una <strong>di</strong>minuzione<br />
dell’ipermetropia anche <strong>degli</strong><br />
altri <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong> refrazione cioè<br />
miopia e astigmatismo.<br />
P.O.maggio 2003<br />
Fig. 4 Mo<strong>di</strong>ficazione della struttura ocula -<br />
re indotta dall’uso <strong>di</strong> lenti negative (Shaikh<br />
e coll, 1999)<br />
Fattori genetici<br />
Molti autori ritengono che lo<br />
stato refrattivo “finale” <strong>di</strong> un<br />
in<strong>di</strong>viduo, sia geneticamente<br />
predeterminato. Le argomentazioni<br />
più convincenti a questa<br />
tesi derivano dagli stu<strong>di</strong> sui<br />
gemelli:<br />
• I primi lavori <strong>di</strong> questo tipo<br />
sono da far risalire agli anni<br />
’20 ad autori tedeschi. Sia<br />
Clausen (1924), che Jablonsky<br />
(1926), mostrano un significativo<br />
alto grado <strong>di</strong> concordanza<br />
dello stato <strong>di</strong> refrazione tra<br />
gemelli monozigoti rispetto agli<br />
eterozigoti (citati in Borish,<br />
1970).<br />
• Waardenberg (1950), conferma<br />
tali risultati su <strong>di</strong> un<br />
campione molto grande: 300<br />
coppie <strong>di</strong> monozigoti e 225<br />
eterozigoti.<br />
• Wixon (1958), stima le correlazioni<br />
dello stato refrattivo<br />
tra gemelli omozigoti +0.99;<br />
eterozigoti +0.64; e fratellastri<br />
+0.54 (citato in Rosner e<br />
Rosner 1990).<br />
• Sorsby (1962), in uno stu<strong>di</strong>o<br />
su 78 monozigoti e 40 eterozigoti<br />
non solo trova gli stessi<br />
risultati <strong>degli</strong> altri autori <strong>di</strong> cui<br />
sopra, ma <strong>di</strong>mostra alta correlazione<br />
anche tra le singole<br />
strutture refrattive oculari dei<br />
membri della coppia <strong>di</strong> monozigoti<br />
(citato in Rosner e Rosner<br />
1990).<br />
• Conferme alla tendenza<br />
riportata sopra si ha da molti<br />
33
34<br />
altri autori: Weber (1961),<br />
Otsuka (1956), We e k e r s<br />
(1961) ciatati da Borish<br />
(1970) e Hoste (1950),<br />
Knoblock (1985), Rosner et a<br />
coll (1987) citati in Rosner e<br />
Rosner (1990).<br />
• Molto importanti ai fini <strong>di</strong> una<br />
spiegazione unicamente genetica<br />
nella formazione dello stato<br />
refrattivo sono gli stu<strong>di</strong> dei<br />
tedeschi Lisch (1941) e Janke<br />
e Holste (1942), citati in<br />
Borish (1970), e <strong>di</strong> Bays<br />
(1966) che in<strong>di</strong>cano come il<br />
livello <strong>di</strong> concordanza dello<br />
stato refrattivo, tra gemelli<br />
monozigoti sia alto anche se i<br />
membri della coppia hanno vissuto<br />
in ambienti <strong>di</strong>versi <strong>di</strong> vita.<br />
• Come per ogni regola, sono<br />
state in<strong>di</strong>viduate delle eccezioni:<br />
Skeffington (1941), Gedda<br />
(1951) e Orth (1954) citati in<br />
Borish. <strong>Il</strong> caso più emblematico<br />
è quello <strong>di</strong> Orth che riporta il<br />
caso <strong>di</strong> due gemelli monozigoti<br />
uno dei quali emmetrope e l’atro<br />
miope <strong>di</strong> circa 25D.<br />
Fattori ambientali<br />
Abbiamo appena visto come<br />
l’analisi dei lavori <strong>di</strong> ricerca sull’influenza<br />
dei fattori genetici<br />
nella determinazione dello<br />
stato rifrattivo, ha chiaramente<br />
in<strong>di</strong>cato un loro forte coinvolgimento.<br />
Potrebbe sembrare<br />
strano ma anche i risultati<br />
sull’influenza dei fattori ambientali<br />
sono altrettanto inequivocabili<br />
nella <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> una loro<br />
chiara influenza nel <strong>processo</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>emmetropizzazione</strong>.<br />
Volutamente nel paragrafo vengono<br />
trascurati i fattori<br />
A G G I O R N A M E N T O Contattologia, ottica ed optometria<br />
ambientali prenatali, perinatali,<br />
e quelli post natali legati alla<br />
<strong>di</strong>eta o a stati patologici generali<br />
e/o oculari, soffermandoci<br />
esclusivamente su fattori funzionali<br />
legati all’input visivo.<br />
Esistono tre filoni <strong>di</strong> ricerca,<br />
sia nell’uomo che nell’animale,<br />
con cui si <strong>di</strong>mostrerebbe l’importanza<br />
del feedback visivo<br />
ambientale per il corretto sviluppo<br />
verso l’emmetropia, dello<br />
stato refrattivo.<br />
1) Stu<strong>di</strong> sulla deprivazione<br />
visiva<br />
Se si impe<strong>di</strong>sce ad un occhio in<br />
crescita <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un input<br />
visivo normale (buio totale,<br />
chiusura palpebre, lenti traslucide,<br />
luce continua etc), lo si<br />
espone ad un grosso rischio <strong>di</strong><br />
“smarrire la strada” verso l’emmetropia.<br />
Gli stu<strong>di</strong> sulla deprivazione visiva<br />
hanno avuto una notevole<br />
<strong>di</strong>ffusione sugli animali, dove si<br />
sono utilizzate svariate forme e<br />
modalità <strong>di</strong> deprivazione, con<br />
risultati piuttosto evidenti:<br />
• Inducendo una deprivazione<br />
visiva (lenti traslucide, chiusura<br />
palpebre etc) si genera un<br />
allungamento del globo e quin<strong>di</strong><br />
una miopia su molte specie<br />
<strong>di</strong> animali:<br />
- Pollo (Papastergiou e coll,<br />
1988)<br />
- Toporagno (Siegwart e<br />
Norton, 1998)<br />
- Scoiattolo (McBrien e coll,<br />
1993)<br />
- Macaco (Wiesel e Raviola,<br />
1977).<br />
- Falco (An<strong>di</strong>son, 1992)<br />
- Maiale (Shih e coll, 1998)<br />
P.O.maggio 2003<br />
- Coniglio (Tokoro, 1970)<br />
- Gatto (Gollender e coll, 1979)<br />
• <strong>Il</strong> tasso <strong>di</strong> progressione miopica<br />
è tanto maggiore quanto<br />
più precoce è la deprivazione,<br />
tanto minore quanto più l’animale<br />
ha la possibilità <strong>di</strong> avere<br />
esperienze visive normali<br />
(Napper e coll, 1995;<br />
S i e g w a rt e Norton, 1998).<br />
Inoltre il fenomeno sembrerebbe<br />
essere graduale, cioè il<br />
grado <strong>di</strong> miopia assiale varia<br />
<strong>di</strong>rettamente con il grado <strong>di</strong><br />
degradazione dell’immagine<br />
retinica (Smith e Hung, 2000).<br />
• Troilo e coll (1995), in un<br />
esperimento sull’effetto della<br />
deprivazione visiva (occlusore<br />
<strong>di</strong> plastica traslucida) su varie<br />
specie <strong>di</strong> polli, hanno in<strong>di</strong>viduato<br />
che la deprivazione visiva ha<br />
sempre un effetto sul normale<br />
sviluppo oculare ma la natura<br />
<strong>di</strong> tale effetto è legata alla specie<br />
<strong>di</strong> polli deprivati, evidenziando<br />
quin<strong>di</strong> un rapporto tra fattori<br />
genetici e ambientali.<br />
• Due forme particolari <strong>di</strong><br />
deprivazione visiva; il buio completo<br />
e la luce costante sembrano<br />
dare origine a ipermetropia.<br />
(Troilo e Wa l m a n n ,<br />
1991; Li e coll, 1995).<br />
• Nei pesci è stato anche<br />
<strong>di</strong>mostrato che la qualità dell’input<br />
visivo è in grado <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare<br />
anche il potere e la qualità<br />
ottica del cristallino (Kroger<br />
e coll, 2001).<br />
• Nel caso in cui si interrompe<br />
la deprivazione visiva che ha<br />
indotto miopia (lenti traslucide)<br />
o ipermetropia (buio totale e<br />
continuo) il meccanismo <strong>di</strong><br />
<strong>emmetropizzazione</strong> entra <strong>di</strong>
nuovo in azione riportando i<br />
<strong>di</strong>fetti indotti dalla deprivazione<br />
verso l’emmetropia (Troilo e<br />
Walmann, 1991).<br />
Nell’uomo non è possibile valutare<br />
l’effetto della deprivazione<br />
visiva inducendola sperimentalmente.<br />
Quello che si effettua è<br />
allora, l’osservazione dei casi<br />
<strong>di</strong> deprivazione, indotta da<br />
patologie monoculari. Anche in<br />
questi casi è stata <strong>di</strong>mostrata<br />
una chiara influenza (allungamento<br />
assiale e miopia) legata<br />
alle varie deprivazioni:<br />
• Opacità corneali (Gee, 1988)<br />
• Emorragie vitreali (Miller-<br />
Meeks, 1990)<br />
• Opacità corneali (Calossi,<br />
1994)<br />
• Ptosi palpebrale (Robb, 1977;<br />
O’Leary e Millodot, 1979)<br />
2) Stu<strong>di</strong> sull’eccessiva foca -<br />
lizzazione da vicino<br />
La seconda fonte <strong>di</strong> evidenza<br />
sull’effetto dei fattori ambientali<br />
nello sviluppo dello stato <strong>di</strong><br />
refrazione, fa capo al fattore<br />
della prolungata visione da vicino<br />
come effetto inducente<br />
miopia. Nell’uomo occupazioni<br />
associate ad un impegno prolungato<br />
da vicino mostrerebbero<br />
un aumento dell’incidenza<br />
della miopia (Angle e<br />
Wismann, 1978; Duke-Elder,<br />
1930; Young, 1977; Zadnik e<br />
Mutti, 1995).<br />
Young (1962) riesce ad indurre<br />
sperimentalmente miopia in<br />
scimmie a cui si limitava il loro<br />
sguardo ad una piccola zona<br />
da vicino.<br />
Nella visione da vicino, viene<br />
A G G I O R N A M E N T O Contattologia, ottica ed optometria<br />
continuamente utilizzata l’accomodazione,<br />
cioè quella<br />
capacità <strong>di</strong> aumentare il potere<br />
refrattivo oculare. Se quin<strong>di</strong><br />
il continuo lavoro da vicino è<br />
causa <strong>di</strong> uno spostamento<br />
refrattivo permanente (miopia)<br />
allora ci sono buone possibilità<br />
che l’accomodazione sia un<br />
fattore importante.<br />
Considerando quanto detto,<br />
sul fronte inter<strong>di</strong>sciplinare psicologia-optometria,<br />
è stata<br />
fatta un’interessante ipotesi<br />
(Rosner e Rosner, 1990): considerando<br />
che l’accomodazione<br />
è una funzione controllata<br />
dal Sistema Nerv o s o<br />
Autonomo, anche l’<strong>emmetropizzazione</strong><br />
potrebbe essere<br />
influenzata da fattori psicologici,<br />
come per esempio una<br />
forma <strong>di</strong> stress emotivo.<br />
Considerando però, la complessità<br />
dei fattori tirati in ballo<br />
da una tale possibilità, nessuno<br />
finora è riuscito a <strong>di</strong>mostrarla<br />
sperimentalmente (per<br />
una parziale rassegna ve<strong>di</strong><br />
Chung, 1993). Viceversa il<br />
livello <strong>di</strong> impegno cognitivo che<br />
si accompagna all’attività <strong>di</strong> lettura<br />
durante la visione da vicino,<br />
è stato scartato come<br />
possibile causa <strong>di</strong> induzione<br />
miopica (Rosenfield e<br />
Ciuffreda, 1994).<br />
3) Stu<strong>di</strong> sui <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong> refrazione<br />
indotti<br />
È stato sperimentalmente<br />
<strong>di</strong>mostrato che se si pone <strong>di</strong><br />
fronte ad un occhio <strong>di</strong> vari animali<br />
appena nati, facciamo<br />
conto emmetropi, una lente<br />
positiva che induce miopia,<br />
P.O.maggio 2003<br />
sorprendentemente questo<br />
stato refrattivo comincerà ad<br />
essere compensato dalle<br />
strutture oculari, che tenderanno<br />
a far si che la retina<br />
coincida con il nuovo fuoco (nel<br />
caso appena visto l’occhio si<br />
accorcerà). La stessa cosa<br />
ma in <strong>di</strong>rezione opposta, succederà<br />
nel caso <strong>di</strong> lenti negative<br />
(Fig.4). Questi risultati sono<br />
stati ottenuti in vari animali:<br />
gatto (Smith e coll, 1980),<br />
pollo (Schaeffel e coll, 1988;<br />
Schmid e Wildsoet, 1996;<br />
Wildsoet e Wallman, 1995),<br />
apale (Graham e Judge,<br />
1999), macaco (Smith e coll,<br />
1994), toporagno (Shaikh e<br />
coll, 1999). Irving e coll<br />
(1995), hanno ottenuto risultati<br />
<strong>di</strong> compensazione refrattiva<br />
anche se il <strong>di</strong>fetto che veniva<br />
indotto era un astigmatismo.<br />
Le variazioni strutturali<br />
che sembrerebbero coinvolte<br />
nelle rapide compensazioni<br />
<strong>di</strong>ottriche stimolate dall’uso <strong>di</strong><br />
lenti sembrerebbero essere<br />
principalmente due (Wildsoet<br />
e Wallman, 1995):<br />
-la lunghezza oculare, il cui<br />
allungamento è responsabile<br />
della risposta a lenti negative.<br />
-lo spessore della coroide che<br />
crescendo permetterebbe una<br />
riduzione della lunghezza assiale<br />
per la compensazione al<br />
defocus inflitto da lenti positive.<br />
La compensazione del <strong>di</strong>fetto<br />
<strong>di</strong> refrazione indotto sperimentalmente<br />
durante la crescita<br />
oculare è una delle prove più<br />
evidenti <strong>di</strong> come il <strong>processo</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>emmetropizzazione</strong> sia guidato<br />
da input ambientali.<br />
35
36<br />
Conclusione<br />
Passo successivo al percorso<br />
fin qui compiuto, sarebbe quello<br />
<strong>di</strong> entrare nel merito dei<br />
meccanismi <strong>di</strong> <strong>emmetropizzazione</strong><br />
(per una rassegna ve<strong>di</strong><br />
Troilo, 1992) su cui molto,<br />
anche se controverso, è stato<br />
s c r i t t o .<br />
Ma l’aspetto principale che si<br />
è voluto sottolineare in questa<br />
sede è solo quello <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare<br />
che non si può prescindere<br />
nello stu<strong>di</strong>o dello sviluppo dell’uomo<br />
da nessuno dei due fattori<br />
genetici e ambientali.<br />
Tale conclusione si è rivelata<br />
p a rticolarmente vera anche<br />
per il <strong>processo</strong> <strong>di</strong> <strong>emmetropizzazione</strong><br />
in cui i due fattori, probabilmente<br />
con meccanismi<br />
<strong>di</strong>versi, predeterminato, sequenziale<br />
e passivo quello<br />
genetico, e attivamente guidato<br />
da input visivi quello ambientale,<br />
concorrono sinergicamente<br />
a in<strong>di</strong>rizzare le strutture<br />
oculari in crescita, verso un<br />
r a p p o rto coor<strong>di</strong>nato e sincrono<br />
che consentirà al mondo<br />
circostante <strong>di</strong> focalizzarsi con<br />
una certa precisione sulla retina<br />
del bambino e del futuro<br />
a d u l t o .<br />
BIBLIOGRAFIA:<br />
An<strong>di</strong>son e coll (1992) The refractive<br />
developmentof the eye of the American<br />
kestrel (Falcus sparviero): a new avian<br />
model. J Comp Phisiol, 170: 565-74.<br />
Angle J, Wissmann DA (1978) Age,<br />
rea<strong>di</strong>ng, and myopia. Am J Optom<br />
Phisiol Optics, 55: 302-308.<br />
Bays JA (1966) Here<strong>di</strong>ty and myopia. J<br />
Am Optom Ass, 37: 46.<br />
Borish IM. (1970) Clincal Refraction.<br />
A G G I O R N A M E N T O Contattologia, ottica ed optometria<br />
Third E<strong>di</strong>tion. Professional Press Books,<br />
New York.<br />
Calossi A, Madesani A, Zanella S.<br />
(1992) Nuove prospettive per il control-<br />
lo della miopia? Riv It Optom, 4: 105-<br />
109.<br />
Calossi A. (1994) Increase of ocular<br />
axial length in infantile traumatic cata-<br />
ract. Optom Vis Sci Jun, 71: 386-91.<br />
Chung KM. (1993) Critical review:<br />
effects of optical defocus on refractive<br />
development and ocular growth and<br />
relation to accommodation. Optom Vis<br />
Sci, 70: 228-33.<br />
C u rtin J (1988) La miopia. USES,<br />
Firenze.<br />
Dawkins MS. (1992) I meccanismi del<br />
c o m p o rtamento animale. Piccola<br />
Biblioteca Einau<strong>di</strong>, Torino.<br />
Duke-Elder WS (1930) An investigation<br />
of the effect on the eye of occupations<br />
involvong close work. Br J Ophthal, 14:<br />
609-620.<br />
Gee SS, Tabbara KF (1988) Increase in<br />
ocular axial lenght in patients with cor-<br />
neal opacifications. Ophtalmology, 95:<br />
1276-8.<br />
Glickstein M, Millodot M. (1970)<br />
Retinoscopy and eye size. Science,<br />
168: 605-6.<br />
Gollender M e coll (1979) Development<br />
of axial ocular <strong>di</strong>mension following eyelid<br />
suture in cat. Vis Res, 19: 221-223.<br />
Graham B, Judge S (1999) The effects<br />
of spectacle wear in infancy on eye<br />
growth and refractive error in the mar-<br />
moset (Callithrix jacchus). Vis Res, 39:<br />
189-206.<br />
Hirsch MJ (1964) Pre<strong>di</strong>ctability of<br />
refractionat age 14 on the basis of<br />
testing at age6: interim report on the<br />
P.O.maggio 2003<br />
Ojai longitu<strong>di</strong>nal study of refraction. Am<br />
J Optom, 41: 567-73.<br />
Ingram RM, Barr A (1979) Changes in<br />
refraction between the ages of 1 and 3<br />
? years. Br J Ophthal, 63: 339.<br />
I rving EL, Callender MG, Sivak JG<br />
(1995) Inducing Ametropias in hatch-<br />
ling chicks by defocus- apertur effects<br />
and cylindrical lenses. Vis Res, 35:<br />
1165-1174.<br />
Li T, Troilo D, Glasser A, Howland HC<br />
(1995) Costant light produces severe<br />
corneal flattening and hyperopia in chic-<br />
kens. Vis Res, 35: 1203-1209.<br />
Kroger RHH, Campbell MCW, Fernald<br />
RD (2001) The development of the<br />
crystalline lens is sensitive to visual<br />
input in the African cichlid fish,<br />
Haplochromis burtoni. Vis Res, 41:<br />
549-559.<br />
McBrien NA e coll (1993) Experimental<br />
myopia in a <strong>di</strong>urnal mammal (Sciurus<br />
carolinensis) with no accommodative<br />
ability. J Physiol (Lond), 469: 427-41.<br />
Miller-Meeeks MJ e coll (1990) Myopia<br />
induced by vitreus emorrage. Am J<br />
Ophtalmol, 109: 119-23.<br />
Millodot M, O’Leary D (1978) The <strong>di</strong>s-<br />
crepancy between retinoscopic and<br />
subjective measurements: effect of<br />
age. Am J Optom Phisiol Optics, 55:<br />
553-6.<br />
Napper GA e coll (1995) The duration<br />
of normal visual exposure necessary to<br />
prevent form deprivation myopia in<br />
chicks. Vis Res, 35:1337-44.<br />
O’Leary DJ, Millodot M (1979) Eyelid<br />
closure causes myopia in human.<br />
Experientia, 35: 1478-9.<br />
Ooi CS, Grosvenor T (1995)<br />
Mechanisms of emmetropization in the<br />
aging eye. Optom Vis Sci, 72: 60-6.
38<br />
Papastergiou GI e coll (1998) Induction<br />
of axial eye elongation and myopic<br />
refractive shift in one-year-old chickens.<br />
Vis Res, 38: 1883-8.<br />
Robb RM (1977) refractive errors<br />
associated with hemangiomas of the<br />
eyelids and orbit in infancy. Am J<br />
Ophtalmol, 83: 52-8.<br />
Rosenfield M, Ciuffreda KJ. (1994)<br />
Cognitive demand and transient near-<br />
work-induced myopia. Optom Vis Sci,<br />
71: 381-385.<br />
Rosner J, Rosner J. (1990) Pe<strong>di</strong>atric<br />
O p t o m e t ry. Butterw o rths, Stoneham<br />
USA.<br />
Saunders KJ, Woodhouse JM, Westall<br />
CA (1995) Emmetropization in human<br />
infancy: rate of chages is related to ini-<br />
tial error. Vis Res, 9: 1325-1328.<br />
Schaeffel F, Glasser A, Howland HC<br />
(1988) Accomodation, refractive error<br />
and eye growth in chickens. Vis Res 28:<br />
639-57.<br />
Schmid KL, Wildsoet CF (1996) Effects<br />
on the compensatory responses to<br />
positive and negative lenses of intermit-<br />
tent lens wear and ciliary nerve section<br />
in chicks. Vis Res, 36: 1023-36.<br />
Shaikh AW, Siegwart JT, Norton TT<br />
(1999) Effect of interrupted lens wear<br />
on compensation for minus lens in tree<br />
shrews. Optom Vis Sci, 76: 308-15.<br />
Shih YF e coll (1998) Effects of lid sutu-<br />
A G G I O R N A M E N T O Contattologia, ottica ed optometria<br />
ring and trans-scleral cryotherapy on<br />
ocular growth ina piglet model. Optom<br />
Vis Sci, 75: 758-762.<br />
Siegwart JT Jr, Norton TT (1998) The<br />
susceptible period for deprivation-indu-<br />
ced myopia in tree shrew. Vis Res, 38:<br />
3505-15.<br />
Smith EL 3rd, Maguire GV, Watson JT<br />
(1980) Axial length and refractive<br />
errors in kittens reared with optically<br />
induced anisometropia. Inv Ophthalmol<br />
Vis Sci, 19: 1250-1255.<br />
Smith EL 3rd, Hung LF, Harwerth RS<br />
(1994) Effects of optically induced blur<br />
on the refractive status of young mon-<br />
keys. Vision Res, 34: 293-301.<br />
Smith EL 3rd, Hung LF (2000) Form-<br />
deprivation myopia in monkeys is a gra-<br />
ded phenomenon. Vis Res, 40: 371-<br />
381.<br />
Sorsby A, Sheridan M (1960) The Eye<br />
at birth: mesurement of the principal<br />
<strong>di</strong>ameter in forthyeight cadavers. J<br />
Anat, 94: 192.<br />
Stassen Berger K. (1996) Lo sviluppo<br />
della persona. Zanichelli, Bologna.<br />
Tokoro T. (1970) Experimental myopia<br />
in Rabbits. Inv Ophthalmol Vis Sci, 28<br />
(suppl): 217.<br />
Troilo D, Wallman J (1991) The regula-<br />
tion of eye growth and refractive state:<br />
an experimental study of emmetropiza-<br />
tion. Vis Res, 31: 1237-1250.<br />
P.O.maggio 2003<br />
Troilo D (1992) Neonatal eye growth<br />
and emmetropization – a literature<br />
review. Eye, 6: 154-160.<br />
Troilo D, Li T, Glasser A, Howland HC<br />
(1995) Differences in eye growth and<br />
the response to visual deprivation in <strong>di</strong>f-<br />
ferent strains of chicken. Vis Res,<br />
35:1211-6.<br />
Waardenberg PJ. (1961) Tw i n<br />
research in ophthalmology. Doc<br />
Ophthal, 84: 593.<br />
Wiesel TN, Raviola E. (1977) Myopia<br />
and eye enlargment after neonatal lid<br />
fusion in monkeys. Nature, 266: 66-8.<br />
Wildsoet C, Wallman J. (1995)<br />
Choroidal and scleral mechanisms of<br />
compensation for spectacle lenses in<br />
chicks. Vis Res, 35:1175-94.<br />
Young FA (1961) The effect of restric-<br />
ted space on the primate eye. Am J<br />
Ophthal, 52: 799-806.<br />
Young FA (1977) The nature and con-<br />
trol of myopia. Am J Optom Phisiol<br />
Optics, 48: 451.<br />
Zadnik K, Mutti DO (1995) How appli-<br />
cable are animal myopia models to<br />
human juvenile onset myopia? Vis Res,<br />
35:1283-8.<br />
Zadnik K, Mutti DO (1998) Incidence<br />
and <strong>di</strong>stribution of refractive anomalies.<br />
In Ed. Benjamin WJ. Borish’s Clinical<br />
Refraction. WB Saunders Company,<br />
Philadelphia.








![Materiali_2012_dispense [modalità compatibilità]](https://img.yumpu.com/15881378/1/184x260/materiali-2012-dispense-modalita-compatibilita.jpg?quality=85)