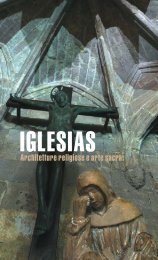You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Gavino Ledda<br />
<strong>Padre</strong> <strong>padrone</strong><br />
Il Maestrale
Tascabili . Narrativa
Cura editoriale<br />
Giancarlo Porcu<br />
Grafica e impaginazione<br />
Nino Mele<br />
Imago multimedia<br />
In copertina:<br />
Simonetta Secci, Senza titolo, 2002<br />
ceramica smaltata, fil di ferro e filo kantal<br />
Per gentile concessione del<br />
MAN _ Museo Arte Provincia Nuoro<br />
Foto di copertina<br />
Donato Tore<br />
© 2003, Edizioni Il Maestrale<br />
Redazione: via Monsignor Melas 15 - 08100 Nuoro<br />
Telefono e Fax 0784.31830<br />
E-mail: redazione@edizionimaestrale.com<br />
Internet: www.edizionimaestrale.com<br />
ISBN 88-86109-71-7<br />
Gavino Ledda<br />
<strong>Padre</strong> <strong>padrone</strong><br />
Il Maestrale
Il 7 gennaio 1944 mi trovai per la prima volta sui<br />
banchi di scuola, con tre mesi di ritardo rispetto ai<br />
miei compagni. Entravo nei sei anni legali mentre<br />
compivo solo i cinque anni biologici. Gli anni, però, li<br />
compivo entro il ’44 e la maestra mi dovette accettare.<br />
I primi giorni i compagni mi prendevano in giro e sghignazzavano<br />
sulla mia ignoranza. Tutti, maschi e femmine,<br />
erano più grandi di me. Molti erano ripetenti. E<br />
nei miei confronti erano spavaldi: sapevano già far bene<br />
le aste, scrivere e leggere le vocali e le consonanti.<br />
Per fortuna come compagno di banco mi toccò Pizzènte,<br />
che avendo la mia stessa età si era presentato in<br />
classe nello stesso giorno. Per noi la maestra fu costretta<br />
a ritornare alle aste. E almeno con lui per un po’ potei<br />
condividere la mia soggezione e timidezza, cui lui<br />
ben presto reagì con aria quasi di sfida: da alunno scapestrato<br />
che avrebbe voluto apprendere tutto fuorché<br />
a leggere e scrivere.<br />
Del mio compagno di banco ricordo che era sempre<br />
in disordine: non portava mai né cartella né quaderni<br />
e non stava mai attento alle lezioni. Spesso, anzi, con<br />
caute contorsioni mentre la maestra scandiva agli altri<br />
il suono delle lettere accompagnandolo con i movi-<br />
7
menti della bocca, e io in silenzio facevo le aste, si<br />
sbraghettava e esibiva ai compagni più vicini il suo uccellino<br />
(sa mariòla). Per lui era un gesto di coraggio<br />
col quale voleva dimostrare di non aver soggezione di<br />
nessuno. Tutta la classe ne veniva sconvolta. E la maestra<br />
quando non ne poteva fare a meno lo picchiava,<br />
lo rimproverava e lo metteva in castigo. Preferiva invece<br />
ignorarlo quando lo notavano soltanto alcuni e<br />
l’attenzione della classe non ne veniva compromessa.<br />
Era allora che Pizzènte si sentiva veramente il più forte.<br />
Se accadeva che la maestra si assentasse, saliva sul<br />
banco e stimolava apertamente la nostra curiosità commentando<br />
l’esibizione con risate più spavalde di quelli<br />
che facevano già bene le lettere. Allora alcuni compagni<br />
reagivano imitandolo. Le ragazze pur dimostrandosi<br />
pudicamente scandalizzate non riuscivano a nascondere<br />
il loro interesse. La maggior parte dei compagni,<br />
fra i quali io, si vergognavano e si scandalizzavano<br />
di ciò che accadeva. Io addirittura me ne sentivo colpevole<br />
come se fossi stato l’autore di quelle bravate. Succedeva<br />
che la spavalderia di questo mio compagno non<br />
solo scuoteva la mia timidezza, ma la ingigantiva paurosamente.<br />
Inoltre io dovevo recuperare il tempo perduto,<br />
colmare le lacune che, senza colpa mia, mi separavano<br />
dai compagni e non potevo farmi distrarre da<br />
Pizzènte. Durante gli intervalli pregavo le compagne e i<br />
compagni di classe di aiutarmi a compitare le vocali e le<br />
consonanti che loro incominciavano a scrivere con una<br />
certa speditezza.<br />
La mia esperienza scolastica, contrariamente alla vo-<br />
8<br />
lontà mia e della maestra, durò poco più di un mese e<br />
cessò molto prima che io divenissi propriamente un<br />
alunno. La maestra mi si era molto affezionata e già<br />
molti compagni e compagne che mi avevano preso in<br />
giro nei primi giorni, li avevo conquistati a furia di rubare<br />
loro aste, consonanti e vocali. La storia, però, stava<br />
tramando ai miei danni inesorabilmente come lo<br />
scorrere del tempo. E una mattina di febbraio, mentre<br />
la maestra si sforzava di farmi scrivere alla lavagna, mio<br />
padre, sorretto dalla convinzione morale di essere il<br />
mio proprietario, con lo sguardo terrificante di un falco<br />
affamato (de unu astòre famìdu) dalla strada fulminò<br />
la scuola. La raggiunse con impeto fragoroso piombando<br />
in classe. Avanzò fino alla cattedra senza far parola e<br />
salutò la maestra con un secco buongiorno. – Buongiorno,<br />
– gli rispose la maestra mentre lui le s’impalò<br />
davanti irrigidito e seccato dalla situazione.<br />
Alla sua vista gli scolari zittirono tutti sui banchi. Mio<br />
padre venne subito al sodo.<br />
La sua fierezza e la sua imponenza dominavano nell’abbigliamento<br />
pastorale: pantaloni di fustagno, giacca<br />
di velluto liscio, scarponi e berretto rigido (craccas e<br />
zizìa).<br />
Inizialmente, però, non riuscì a nascondere una forte<br />
impazienza. I suoi occhi lampeggiarono.<br />
– Sono venuto a riprendermi il ragazzo. Mi serve a<br />
governare le pecore e a custodirle... È mio. E io sono<br />
solo. Non posso continuare a lasciare il gregge incustodito<br />
quando vengo qui a Sìligo a portare il latte in caseificio<br />
o a portarmi via le provviste. Io non faccio solo il<br />
pastore. Per tirare avanti onestamente e senza deruba-<br />
9
e il vicino, mi tocca coltivare una parte della tanca a<br />
grano per il fabbisogno di casa (pro su fittu de domo).<br />
Gavino, anche se è piccolo, custodirà le pecore mentre<br />
io marrerò il grano o poterò la vigna o lavorerò all’oliveto<br />
che ho già cominciato a piantare... Come vede da<br />
solo non posso fare tutte queste cose stando dietro alle<br />
pecore. Incustodite, potrebbero assalirmi la vigna o il<br />
grano, e non possiamo stare un anno senza pane... Insomma,<br />
lui mi custodirà le pecore mentre io farò tutte<br />
le altre cose per procacciare il sostentamento ai suoi<br />
fratelli più piccoli... Io non ne ho di soldi per comprare<br />
loro i mezzi di sussistenza. I liquidi che ricavo dal latte<br />
delle pecore bastano a stento per comprare i vestiti e altre<br />
cose che noi pastori non possiamo produrre. Le patate,<br />
il grano, le cipolle, le fave le debbo produrre io<br />
stesso... Mi spiace riprenderglielo, ma senza di lui non<br />
potrei più andare avanti. Questa è stata sempre la storia<br />
di noi pastori. Ci sono banditi dappertutto e lei lo sa<br />
benissimo, signora maestra.<br />
– Gavino è ancora troppo piccolo! Come potrà custodire<br />
le pecore e far paura ai banditi? La sua presenza<br />
sarà inutile... Qui imparerà a vivere prima di esporsi<br />
alla vita. Gli mancano ancora le penne per prendere il<br />
volo.<br />
– Cosa ne sa lei della pastorizia? I pastori volano tutti<br />
senza ali. – Il tono si fece risoluto.<br />
– Non è necessario che il ragazzo sia grande per custodire<br />
le pecore. Quanto ai banditi, poi, basta un respiro<br />
umano. Avrà fiato sufficiente per chiamarmi da<br />
una vallata all’altra, se sarà il caso. La mia tanca non è<br />
molto grande. Le pecore, però, si spostano rapidamen-<br />
10<br />
te litigandosi i pochi steli d’erba e le ghiande migliori<br />
(sos pagos runcos de erba e sa mezzus landhe). Spesso<br />
s’inforrano per le vallate per ripararsi dal vento e improvvisamente<br />
scompaiono. Così quando io sto da una<br />
parte della tanca a lavorare ed esse scompaiono verso<br />
l’altra, i banditi e la volpe allora fanno man bassa... La<br />
volpe! Sì! La volpe! Anche questa è una minaccia terribile<br />
e continua. Soprattutto nel periodo in cui le pecore<br />
figliano... Azzanna gli agnelli. E un agnello per un pastore<br />
povero come me non è poca cosa. Pensi che noi<br />
pastori contrariamente a quanto si dice, siamo condannati<br />
dalla povertà a non mangiare carne d’agnello...<br />
Quelli che ne mangiano molta la rubano. Con un agnello<br />
trasformato in denaro posso sfamare la famiglia dieci<br />
giorni con pane e pasta... È necessario che me li tenga<br />
cari quelli che figlia il mio gregge... Non sarà né il primo<br />
né l’ultimo... Anch’io ho trascorso la mia infanzia in<br />
questo modo. Infanzia! Puh! Sono dovuto diventare<br />
adulto prima del tempo e gli anziani mi hanno usato come<br />
guardiano contro gli assalti della volpe in pieno inverno...<br />
E le pecore le ho custodite lo stesso anche se<br />
avevo bisogno più del capezzolo della mamma che di<br />
quello della pecora.<br />
A questo punto seguì un momento di silenzio come<br />
se in aula non vi fosse nessuno al di fuori della sua volontà.<br />
La maestra e gli alunni, anzi, sembravano volerselo<br />
ascoltare, quel silenzio terribile.<br />
– Saprò fare di lui un ottimo pastore capace di produrre<br />
latte, formaggio e carne. Lui non deve studiare.<br />
Ora deve pensare a crescere. Quando sarà grande la<br />
quinta elementare la farà come fanno molti prima di ar-<br />
11
uolarsi. Lo studio è roba da ricchi: quello è per i leoni e<br />
noi non siamo che agnelli.<br />
I miei compagni ascoltavano questo irruente e focoso<br />
discorso, quasi fosse il primo fulmine ed il primo tuono<br />
del ciclone che tra breve si sarebbe scatenato sulla loro<br />
futura esistenza vegetale.<br />
Io me ne stavo lì, paralizzato, davanti alla lavagna come<br />
se quel discorso mi avesse inchiodato i piedi alla<br />
predella. Di colpo però di fronte al terribile “discorso<br />
della realtà”, non ho potuto far altro che piangere e aggrapparmi<br />
alla maestra quasi per lasciar smorzare nell’orizzonte<br />
della nuova realtà la terribile luce del fulmine<br />
ed il boato del tuono esplosi sugli occhi e sulla bocca<br />
di mio padre, dilagando per l’aula e tempestando la<br />
mente degli scolari come un oscuro presentimento.<br />
Così appoggiato alla maestra con la faccia affossata<br />
sul mio braccio destro, quella luce terribile scomparve<br />
subito ed il tuono che nella mia mente sembrava annunciare<br />
cose tremende, si ammutolì scorrendo sul cielo<br />
e sui boschi delle campagne che io mi stavo già immaginando.<br />
La maestra mi lasciò sfogare un po’ nel<br />
pianto e subito cominciò a prepararmi anche lei alla triste<br />
realtà, persuadendo la mia innocenza.<br />
– Diventerai un grande pastore. Tuo padre ti insegnerà<br />
a mungere le pecore e le mucche. Sono molto<br />
belle, sai! In campagna, poi, ci sono tanti fiori, molta<br />
erba e tanti alberi pieni di uccelli che pigolano e cantano.<br />
Fanno i nidi nei cespugli, per terra, sugli alberi e tu<br />
ne potrai prendere quanti ne vorrai. Qui a Sìligo non<br />
c’è nulla!<br />
Mi sussurrò queste cose lisciandomi i capelli, cercan-<br />
12<br />
do di calmare il mio pianto, asciugandomi le lacrime<br />
con il suo fazzoletto. Mio padre stava lì, rigido nel suo<br />
abbigliamento pastorale, aspettando che mi adattassi<br />
alla verità, giunta troppo in fretta. Ma dalla sua rigidezza<br />
traspariva un insopportabile imbarazzo. E come per<br />
vincere il suo stato di disagio, mentre si allontanava<br />
spingendomi verso la porta, non poté fare a meno di<br />
cercare ulteriori giustificazioni di fronte alla maestra e<br />
agli scolari, storditi dal discorso.<br />
– Io ho bisogno di lui, in campagna... diversamente<br />
non riuscirò a mandare avanti la famiglia. Ecco! Se il governo<br />
mi pagasse un uomo per custodirmi le pecore o<br />
mi aiutasse in altro modo, io, glielo lascerei... a studiare.<br />
Il ragazzo è mio. Cosa vuole questo governo? Che per<br />
mandare lui a scuola, gli altri miei figli muoiano di fame?<br />
No. No. Io, il ragazzo me lo prendo e lo uso perché<br />
non ne posso fare a meno. E voglio vedere la barba di<br />
questa legge vigliacca, che cosa sarà in grado di farmi.<br />
Mi sento tranquillo! È la legge che non è tranquilla.<br />
Vuole rendere la scuola obbligatoria. La povertà! Quella<br />
è obbligatoria.<br />
Con le lacrime agli occhi e con quel tuono che stava<br />
ancora rintronandomi nella testa diedi così l’ultimo<br />
sguardo, penetrante, a tutta l’aula, quasi me la volessi<br />
portar via passando in rassegna frettolosamente tutti i<br />
banchi. Nel mio silenzio salutai tutti i compagni imprimendoli<br />
nella mente per non scordarli più. Ancora una<br />
volta fissai i particolari dell’aula che avevano colpito di<br />
più la mia fantasia: la lavagna, la cattedra e le carte geografiche.<br />
– Beh! Buongiorno, signora maestra.<br />
13
– Coraggio, Gavino, – sussurrò la maestra facendo<br />
scomparire pian piano il suo volto sorridente, accostando<br />
i battenti della porta.<br />
Uscito dall’aula, improvvisamente, mi sentii come la<br />
lepre snidata dal covo (iscovàda dae sa tana), messa in<br />
fuga dal cane e sparata da cacciatori che non potevo vedere<br />
anche se i loro spari mi stavano già ferendo. Scendendo<br />
le scale del municipio, nel cervello mi rimbombavano<br />
le parole, le frasi del discorso del babbo: – Mi<br />
custodirà le pecore mentre io marrerò il grano... poterò<br />
la vigna... per i suoi fratelli più piccoli... Lui è il fratello<br />
maggiore e deve aiutare gli altri a farli grandi e a non<br />
farli morire di fame...<br />
Io volevo bene ai miei fratelli e non volevo che morissero<br />
di fame. Per un attimo, nella mia fantasia, vidi i<br />
miei fratellini in pericolo che mi esortavano a seguire<br />
mio padre. Per questo, dopo i primi pianti mi rassegnai<br />
a seguirlo senza che mi divenisse odioso. E il tempo che<br />
trascorse tra l’uscita dall’aula e l’arrivo in casa, bastò a<br />
prepararmi alla partenza.<br />
– Mariantòò!! Mintòò!! – fece mio padre una volta in<br />
casa.<br />
– Eccomi, – rispose preoccupata la mamma dal solaio<br />
dove stava preparando le provviste per il babbo e per il<br />
cane mettendole nella bisaccia di lana (in sa bértula).<br />
– Prepara Gavino. Subito! Lo porto in campagna<br />
con me, – urlò furiosamente. La mamma non fece storie.<br />
Forse era già al corrente della cosa. Così in meno di<br />
mezz’ora fui trasformato: pantaloni di fustagno, scar-<br />
14<br />
poni e cappotto. Un vero pastore! Nel frattempo, lui di<br />
fuori aveva imbastato il somaro. Spalancò le imposte<br />
ed entrò in casa frettolosamente. – Sei pronto? – Risposi<br />
con il mio silenzio, dirigendomi verso la porta d’ingresso.<br />
Il somaro era pronto alla partenza, con il suo carico.<br />
Era ancora legato all’anello affisso al muro di casa<br />
(a sa lóriga) scalpitando: dandosi gli zoccoli sulla pancia<br />
lanuta e scodinzolando, quasi si preparasse alla partenza.<br />
Con gesto abituale slegò il somaro dalla lóriga.<br />
Fermò la bestia. Lasciò andare a terra per un attimo il<br />
capestro (su murràle) e mi scaraventò in groppa, mentre<br />
lui, subito dopo aver messo la mano sinistra sulla<br />
criniera, cavalcò con un solo lancio, affossando il culo<br />
sul basto. Con le gambe penzoloni scrollandole addosso<br />
alla bestia, irrigidendosi sul tronco e agitando la fune<br />
mise in moto il nostro veicolo verso la strada che<br />
portava all’ovile (a su cuìle).<br />
In silenzio, in groppa, ascoltavo il trotterellare della<br />
bestia e oscillavo al passo dell’animale che mi sbatteva<br />
ritmicamente contro le spalle di mio padre, che, dentro<br />
la sua giacca di velluto, per la prima volta mi apparve<br />
robusto e massiccio. Ripassammo subito davanti alla<br />
scuola. Tanti pensieri mi turbinavano nella mente in<br />
quel momento. Ma io non ero più un alunno. Ero già<br />
un pastore. E il somaro, nel suo trotto, lasciava indietro<br />
la scuola con i compagni che mi ero impresso nella<br />
mente. Io, rivoltato indietro, guardavo la scuola dalla<br />
groppa del somaro il cui passo me la faceva vedere tremolante,<br />
quasi fosse ancora scossa dal terremoto del<br />
discorso. E subito scomparve dalla mia vista l’apice del<br />
suo tetto, dietro il rinculo della groppa. Così la mia<br />
15
scuola sprofondò per sempre nel buio vivo del ricordo.<br />
E lasciate alle spalle le ultime case di Sìligo, solo dopo<br />
un po’ di trotto, fummo in aperta campagna.<br />
La bestia andava veloce sulla strada polverosa e cosparsa<br />
di ghiaia, e posando gli zoccoli tra una pietra e<br />
l’altra, in fretta, si allontanava da Sìligo: mi trasportava<br />
come spesso aveva trasportato le provviste per il cane,<br />
il mangime per i maiali e le sementi che mio padre seminava<br />
sempre sul maggese. Ora anch’io ero una semente<br />
e dovevo nascere e germogliare (nàschere e tuddhìre)<br />
solo sul nostro campo e seguire le leggi del regno vegetale<br />
sul maggese della solitudine, come tutti i pastorelli<br />
della <strong>Sardegna</strong>.<br />
La giornata comunque era bella e la passeggiata mi<br />
stava piacendo. Le valli e le montagne lontane, dalla<br />
groppa, le vedevo mosse dal passo della bestia, quasi<br />
fossero in preda alla danza per la mia accoglienza. Tutto<br />
questo mi stava divertendo. Subito però Sìligo mi ritornò<br />
alla mente. Le parole della maestra ed il discorso di<br />
mio padre mi risuonarono nel cervello. Ora però avevano<br />
un senso diverso: mi davano conforto e coraggio.<br />
Per strada, di tanto in tanto, incontravamo altri pastori<br />
che salutavano mio padre con le solite frasi, spesso<br />
anche senza senso, con un saluto di maniera, tanto per<br />
non passare l’uno di fronte all’altro senza farsi parola.<br />
La strada li obbligava a incontrarsi e l’incontrarsi a distanza<br />
ravvicinata vinceva, almeno per un attimo, tutta<br />
quella diffidenza che, di solito, l’uno nutriva per l’altro.<br />
Spesso così nasceva l’amicizia. Qualcuno però faceva<br />
eccezione, dicendo qualcosa che usciva fuori dal comune<br />
saluto, quasi imposto dalla circostanza.<br />
16<br />
– Finalmente potrai lavorare la tanca con tranquillità,<br />
– diceva uno. – Ora che siete in due le cose andranno<br />
meglio: l’unione fa la forza... E poi il ragazzo, abituandolo<br />
da piccolo, non contrae vizi e impara bene il<br />
nostro lavoro.<br />
– Bah! Incominci presto a domare il puledro. Speriamo<br />
sia docile, – fece un altro allontanandosi sul suo somaro<br />
in senso opposto e parlando fino a scomparire.<br />
– Ma come fai a portarti Gavino in campagna a questa<br />
età? – interloquì ancora un terzo. – Te lo porti via a<br />
svezzare (ti che lu giùghes a istittàre)?<br />
Mio padre tutto preso dai suoi propositi, sul basto,<br />
non dava peso a queste dicerie e quasi posseduto dall’angoscia<br />
del lavoro incitava il somaro al passo scrollandogli<br />
gli scarponi sulle spalle e sui fianchi (in sos armos<br />
e in sos costàzos).<br />
Un’ora e mezza di trotto e giungemmo alla nostra tanca.<br />
Subito, nella immobilità del suo comignolo di stoppie<br />
ci si presentò la capanna (sa pinnètta) attorniata dagli<br />
alberi frondosi che la accarezzavano mossi dal vento.<br />
Il cane, Rusigabèdra (rosicchiapietra), salutò il nostro<br />
arrivo abbaiandoci e venendoci incontro, saltando e<br />
scodinzolando. Si reggeva sulle zampe posteriori annusando<br />
le provviste. Finalmente il nostro veicolo si fermò<br />
sullo spiazzo dell’ovile. Mio padre scese dal somaro e mi<br />
pose per terra. La capanna, che fino ad allora avevo visto<br />
solo occasionalmente, mi parve bella. Corsi a rivederla<br />
meglio, ad osservarla e a conoscerla. Entrai per la<br />
porta rivolta a mezzogiorno e il mio sguardo si posò sul<br />
tetto e sull’impalcatura interna incrostati di fuliggine.<br />
Dalla pietra centrale, dal focolare (dae su foghìle) in di-<br />
17
ezione della sua cuspide (de su colomìnzu) si alzava il<br />
fumo. C’era ancora il fuoco che vi aveva lasciato il babbo:<br />
brace e cenere accesa (bràgias e faddhìgia). Lui la<br />
squartò con il soffietto (cun su suladòre) e ci riscaldammo<br />
le mani cancrenate dal freddo.<br />
– Ora facciamo il fuoco e mangiamo subito, – disse il<br />
babbo. – Andiamo a prendere la legna.<br />
Uscimmo e rientrammo con la legna mentre Rusigabèdra<br />
ci seguiva in tutto. Il babbo uscì fuori di nuovo a<br />
scaricare la bestia, che aveva lasciata legata a una quercia.<br />
La alleggerì del basto e la mise in libertà. Diè di piglio<br />
alla bisaccia delle provviste e tenendola tra le mani<br />
sull’addome la portò dentro la capanna. La mise per<br />
terra. Il cane gli faceva festa. Mio padre gli buttò un pane<br />
di crusca che Rusigabèdra non mancò di agguantare<br />
al volo tra le mandibole ergendosi in piedi. Il babbo tirò<br />
fuori anche le nostre provviste. Scaldò il pane sul<br />
fuoco e alla meglio improvvisò il nostro pranzo.<br />
Al primo pranzo nella capanna seguì la prima esplorazione<br />
per il campo. Incominciava così la scuola pastorale.<br />
Nella prima perlustrazione si preoccupò di impartirmi<br />
le nozioni sull’orientamento in campagna e<br />
nel bosco. Mentre avanzavamo, lui si industriava a fissarmi<br />
nella mente i punti caratteristici del terreno, le<br />
querce che spiccavano in modo particolare, per la loro<br />
forma, per la loro grandezza, curvature varie o per i loro<br />
difetti: buchi e gibbosità (tuvas e thoccas). Oppure i<br />
macigni e i cespugli (crastos e barrasòlos). Con tutta la<br />
sua esperienza mi aiutava a vederli nel loro insieme con<br />
18<br />
le cose: a farmi un quadro della loro disposizione naturale<br />
in modo da avere dei punti fissi di riferimento nel<br />
caso mi fossi trovato da solo o mi fossi smarrito.<br />
– Devi imparare a conoscere il campo e il bosco punto<br />
per punto, fissandoti nella mente i particolari degli<br />
alberi, dei rovi, delle querce, del terreno e delle sue scoscesità<br />
(de su terrìnu e de sos iscamèddhos). D’ora in<br />
poi, qui resterai da solo e devi imparare ad orientarti in<br />
qualsiasi punto e da qualsiasi parte. La vedi quella<br />
grossa quercia, giù in fondo? Si chiama s’àvure manna.<br />
Questa valle qui la chiamano su addhìju de su palòne.<br />
Quella collina boscosa lassù la chiamano su montìju de<br />
su carràsu. E quella piccola radura lì, si chiama su piànu<br />
de su aladérru. Il monte che ci sovrasta è Monte Santu.<br />
Quelle due rocce ai suoi piedi si chiamano sa rocca de<br />
Thiantìna (...) e sa rocca de su nidu de s’untùsu (la rocca<br />
del nido dell’avvoltoio). La località si chiama Baddhevrùstana.<br />
Come vedi tutte le parti del campo sono state<br />
così denominate dagli anziani (dae sos antìgos). Tutti<br />
questi punti ti serviranno, oltre che per orientarti, anche<br />
per sapermi dire in quale punto del campo si troverà<br />
il gregge, il somaro (s’ama e s’àinu) e le nostre bestie<br />
quando te lo chiederò. Ora, per esempio, il nostro<br />
gregge si trova in issu addhìju de s’ampìddha e l’asino è<br />
in sa tuppa de sos suèsos.<br />
Ascoltavo attentamente le sue descrizioni e la sua<br />
“matematica naturale” come rapito, quasi la sua bocca<br />
fosse la fucina in cui le cose divenivano realtà e io le vedessi<br />
nascere per incanto. Mio padre mi appariva il creatore<br />
di quel mondo che lui per me creava con le parole.<br />
Con la sua prima “lezione” giungemmo a issu addhìju<br />
19
de issa ampìddha, al nostro gregge: 19 pecore e un cane.<br />
Così grande era allora la nostra mandria. C’era anche<br />
qualche agnellino. Mio padre ne prese uno per farmelo<br />
toccare e lisciare. La sua lana era soffice e arricciata. Il<br />
suo respiro ansimante. Il cuore gli picchiava alle costole.<br />
La sua bocca belava e sbuffava. Una pecora, mentre<br />
io me lo tenevo al petto tra le mani, lisciandolo, ci si<br />
profilò davanti belando a singhiozzo e dimenandosi<br />
preoccupata.<br />
– È la madre, – disse mio padre che non si lasciava<br />
sfuggire l’occasione per completare la sua lezione. Ad<br />
un cenno di mio padre, lasciai sgattaiolar via l’agnello<br />
dalle braccia che appena raggiunse la madre le infilò il<br />
muso sotto le mammelle scuotendole rigidamente con<br />
il muso (cun su muzzighìle).<br />
La punzecchiò con forza succhiandola avidamente e<br />
schiacciandole il capezzolo avvinghiato nella sua lingua.<br />
La madre gli accarezzava il culetto con le labbra.<br />
L’agnello allora si eccitò nella lattazione turbinando la<br />
sua piccola coda. – Sta poppando.<br />
Nel primo periodo, mio padre quando andava a Sìligo<br />
per portarvi il latte o a fare provviste, non mi lasciava<br />
mai in campagna da solo, ma mi portava sempre con<br />
sé in groppa e spesso mi lasciava in paese per uno o due<br />
giorni. E questo per adattarmi in modo più graduale e<br />
meno violento alla solitudine del pastore. Per me erano<br />
giorni di sollievo. In quei due giorni rinfrescavo l’amicizia<br />
con i miei compagni di Sìligo ma per mio padre,<br />
dopo, diventava più difficile ricondurmi all’ovile.<br />
20<br />
– Ci vieni oggi in campagna?<br />
– No.<br />
– Ho trovato un nido di merla a quattro uova, dentro<br />
un cespuglio.<br />
– E come sono le uova? Me lo dici?<br />
– Verdognole, a chiazze nocciola.<br />
– Me le fai vedere?<br />
– Sì! Se vieni, stasera, ci andiamo a vederle. Il nido è<br />
grosso e molto bello.<br />
– E come è fatto?<br />
– All’esterno è di fieno; all’interno è rivestito di peli e<br />
di lana che le pecore lasciano tra i rovi e i cespugli al loro<br />
passaggio... Poi ne ho trovato un altro di allodola per<br />
terra: ci sono già gli uccellini (est già a puzzonèddos).<br />
Cose che mi incuriosivano al punto che i compagni di<br />
Sìligo per quel giorno non esistevano più. E così mio<br />
padre con questi accorgimenti mi riconduceva in campagna<br />
senza che me ne accorgessi.<br />
Per qualche mese mio padre non applicò completamente<br />
il rigore dell’educazione alla vita dei campi.<br />
Quando ritornava a Sìligo, dopo due o tre giorni, per le<br />
provviste, mi riportava a casa per farmi lavare da mia<br />
madre e per farmi riprendere fiato. Così alternavo la vita<br />
campestre a quella paesana. Però in campagna ci riandavo<br />
sempre più a malincuore. Ben presto i nidi delle<br />
allodole dei merli e delle piche (de issas chilàndras, de<br />
issas mérulas e de issas pigas) con le loro uova chiazzate<br />
e variopinte, che il babbo trovava casualmente pascendo<br />
le pecore, non bastavano più ad allettare la mia fantasia<br />
e a farmi contento e curioso.<br />
Era il tempo dei nidi, ma ormai me ne aveva fatto ve-<br />
21
dere abbastanza e conoscevo già quasi tutte le varietà<br />
degli uccelli del posto. E lui non poteva crearne degli<br />
altri per intrappolarmi dolcemente. Inoltre razionava<br />
sempre più la mia permanenza a Sìligo e naturalmente<br />
non poteva trovare né inventare nuovi zuccherini per<br />
attirarmi in campagna. Se nel primo periodo la curiosità<br />
della campagna e della natura mi distoglieva dalle<br />
distrazioni che mi offriva Sìligo, ora la monotonia della<br />
vita agreste suscitava in me la nostalgia del mondo che<br />
avevo lasciato.<br />
Così si attuarono il distacco dall’ambiente paesano,<br />
l’allontanamento forzato dalla scuola e la conseguente<br />
“deportazione” a Baddhevrùstana a otto chilometri da<br />
Sìligo anche se tra uno zucchero e l’altro li stavo accettando<br />
per amore dei miei fratelli, che avrebbero corso<br />
il rischio di morire di fame. Ma non potei seguire mio<br />
padre passivamente. Anche se non possono far niente<br />
contro i grandi, i bambini protestano. Magari soltanto<br />
con il loro querulo pianto. Certo io non ne avevo colpa<br />
se ormai gli zuccherini del babbo non ottenevano più<br />
l’effetto desiderato. Lui, però, doveva pure svezzarmi.<br />
Già al terzo mese l’educazione divenne più severa. Mio<br />
padre passò al secondo stadio. Incominciò a lasciarmi<br />
solo con il gregge anche quando si recava a Sìligo. Ma<br />
per non farmi pesare troppo il distacco dai miei fratelli<br />
e da mia madre, continuava a portarmi in paese una<br />
volta la settimana. Ora, però, non mi rilasciava più a Sìligo<br />
e nello stesso giorno quasi sempre nella stessa mattinata,<br />
mi riconduceva all’ovile. In questo modo la mia<br />
permanenza con i miei fratelli o con qualche vecchia<br />
amicizia si riduceva a una o a due ore al massimo. Ep-<br />
22<br />
pure quel tempo bastava per rinsaldare con loro un legame<br />
di inseparabilità, per cui io non ripartivo mai senza<br />
piangere.<br />
Il babbo purtroppo ad una certa ora doveva imbastare<br />
il somaro e mi chiamava alla partenza. Dalla gioia e<br />
dal gioco, allora, passavo subito al pianto di protesta,<br />
con la vana speranza di convincere il babbo a lasciarmi<br />
a Sìligo. Io però ero un agnello da svezzare (fio un anzòne<br />
de istittàre) che mio padre doveva portare in un<br />
gregge estraneo perché non poppasse più la mamma.<br />
Era venuta l’ora che la mamma la mungesse il pastore<br />
tutta per sé e che l’agnello si nutrisse solo di erbe e di<br />
arbusti. Come un agnello anch’io belavo il mio dolore.<br />
Ma mio padre applicò tutto il rigore dell’educazione<br />
che conosceva e che anche lui forse aveva subito. Il mio<br />
pianto e i miei belati non avrebbe potuto sentirli. Una<br />
volta riuscii ad eluderlo con l’astuzia. Restai nascosto.<br />
E quando all’ora della partenza sentii il suo richiamo<br />
non uscii dal mio covo come il somaro al richiamo del<br />
<strong>padrone</strong> che lo deve imbastare. Mio padre aveva fretta<br />
di ritornare tra le pecore e non poteva spendere molto<br />
tempo a cercarmi. Allora ripartì da solo e io per tutta la<br />
sera e fino al suo ritorno potei scorrazzare con i miei<br />
compagni per Sìligo, imparare i giochi che loro conoscevano.<br />
Fu durante una di queste evasioni che mi aggregai a<br />
una combriccola di compagni più grandi di me. Mio<br />
padre non esisteva più. E mentre si scorrazzava con<br />
quegli scapestrati che quasi tutti avevano marinato la<br />
scuola come io l’ovile, ci imbattemmo nella capanna di<br />
Tore.<br />
23
– O compà! – fece Antonio.<br />
– Che c’è?<br />
– Entriamo dentro la capanna e vediamo chi fa prima<br />
a farsi una sega. L’altra volta aveva vinto Baìngio, ma<br />
ora voglio vedere!<br />
– Andiamo, – disse Juànne, – oggi vi sfido tutti.<br />
Si entrò nella capanna con tutta la combriccola. Ci<br />
mettemmo a culo per terra disponendoci a cerchio attorno<br />
il muro circolare della capanna! Tutti i più grandi<br />
si sbraghettarono tra lo stupore dei più piccoli che come<br />
me non sapevano ancora cosa stessero per fare.<br />
Io feci lo spettatore imbarazzato come altri due o tre<br />
della mia età o anche più piccoli. La stessa soggezione,<br />
però, ci impediva di allontanarci. Così dovemmo assistere<br />
alla gara che stava incominciando.<br />
– Siamo pronti... Che nessuno parta prima.<br />
– Non ci giuoco... Tu sei partito prima... Fermati!<br />
– Va bene! Incominciamo da capo!<br />
– Via!<br />
Tutti si masturbarono a gara in quella scomoda posizione<br />
almeno per un mezzo minuto. Poi si levarono<br />
delle grida contrastanti.<br />
– Ho vinto io...<br />
– Cosa hai vinto tu? Io ho fatto prima! Ho alzato la<br />
mano prima di te!<br />
Due giorni dopo il babbo fece ritorno a Sìligo e mi<br />
picchiò, sonoramente. Mi riportò all’ovile e rimasto solo<br />
tra le pecore volli fare l’esperimento che Tore e compagni<br />
mi avevano messo in testa. Mi accasciai dietro un<br />
cespuglio al riparo dal vento e incominciai a giocolarmi<br />
la bestiolina. Con mio grande piacere subito mi venne<br />
24<br />
un dolce pruritino, tanto che mi distesi per terra a pancia<br />
all’aria quasi svenuto. Beato in mezzo all’erba. Ripetei<br />
l’esperimento dopo tre o quattro minuti: la stessa<br />
beatitudine in quel silenzio profondo dove solo le sonaglie<br />
delle pecore mi ricordavano di tanto in tanto che<br />
ero un pastorello. In tutto il pomeriggio ho ripetuto la<br />
faccenda almeno venti volte, ammacchiato qua e là, a<br />
seconda del pascere delle pecore. Finalmente a meno<br />
di sei anni e solo dopo tre mesi di pastorello avevo trovato<br />
l’unico vero sollazzo della solitudine. Da quel giorno<br />
fu sempre la solita storia. Quando non avevo null’altro<br />
da fare, entravo nei cespugli prediletti e le mie trenta<br />
quaranta seghettine al giorno non me le toglieva nessuno.<br />
Il babbo continuava comunque a ricondurmi a<br />
Sìligo almeno una volta la settimana. Ne approfittavo<br />
per mettermi con la solita combriccola. Una volta, stavamo<br />
facendo un gioco molto bello, sentii il richiamo<br />
del babbo all’ora della partenza. Allora scoppiai nel<br />
pianto più dirotto e belai più del solito sbattendo i piedi<br />
per terra. Ancora non avevo contratto la soggezione<br />
alla patriarcalità. Ma mio padre, quella volta, forse perché<br />
stufo di ricorrere ai suoi zuccherini o perché convinto<br />
che fosse venuta l’ora di attuare il massimo rigore<br />
nell’educazione selvaggia ed agreste, passò improvvisamente<br />
dal paterno al patriarcale. Mi rincorse e mi<br />
picchiò, alternando gli schiaffi ai colpi di bastone e ai<br />
calci che tirava alla rinfusa, finché nella disperazione<br />
del dolore mi uscì di bocca: – Non piangerò più... Vengo<br />
con te...<br />
Tutto trafelato, con il livore in faccia, afferrò la fune<br />
del somaro. Mi aggavignò e mi sbatacchiò in groppa<br />
25
come aveva sempre lanciato la bisaccia o i sacchi di biada.<br />
Saltò sul basto anche lui. Scrollò nervosamente le<br />
gambe addosso alla bestia e via in silenzio.<br />
Nonostante avessi rimediato una buona dose di colpi<br />
e di rimproveri, appena ci lasciammo dietro le ultime<br />
case del paese, alla vista dei primi campi, la paura, anzi il<br />
terrore di restare di nuovo solo in campagna mi turbinarono<br />
nel cervello, mi rivoltarono le viscere. Subito mi<br />
pervase uno stato d’animo misto di sentimenti contrastanti,<br />
instabili e fugaci: l’uno in preda all’altro. La paura<br />
della solitudine. Il terrore quasi incontenibile della<br />
furia di mio padre (che ora già conoscevo) e il piacere di<br />
giocare con i miei coetanei di Sìligo che io stavo sognando<br />
in groppa. Era un brutto stato d’animo sollecitato da<br />
tanti pensieri in lotta furibonda. Incominciai così a piagnucolare.<br />
Non sapevo come fare dato che lui mi minacciava<br />
e mi picchiava solo perché piangevo. Seduto<br />
sul basto si rivoltava e mi scandiva qualche schiaffo di<br />
ammonizione. Il somaro, come sempre, trottava sulla<br />
strada bianca. Io però volevo scappare. Improvvisamente<br />
smisi di piangere e mi preparai per scivolare giù.<br />
Il ritmo degli zoccoli della bestia sembrava potesse confondere<br />
i miei movimenti ed eludere la sorveglianza di<br />
mio padre. Scivolai di groppa. Caddi a culo per terra,<br />
come un oggetto. Morendo dal dolore mi sollevai subito<br />
in silenzio! Mi misi a correre senza fiatare con tutte le<br />
forze, disperatamente, verso Sìligo. Il tonfo che feci nella<br />
caduta, purtroppo, avvertì il babbo. Io, poi, avevo le<br />
gambe corte ed il mio tentativo di fuga finì lì. Dopo una<br />
breve rincorsa, mi scaldò la faccia di schiaffi e di pugni.<br />
Mi lanciò di nuovo in groppa con tutte le mie urla e le<br />
26<br />
mie proteste e via di nuovo. Quel giorno però evidentemente<br />
ero risoluto a tutto e ostinato. Certo, ero terrorizzato<br />
al pensiero di stare solo in quel bosco pieno di cose<br />
e di animali di cui allora avevo ancora paura. E poi quella<br />
solitudine mi sembrava un silenzio interminabile:<br />
ascoltarlo mi stordiva l’esistenza. Un nuovo attacco di<br />
pensieri in lotta, bastò a farmi fare un altro tentativo.<br />
Così mi gettai per terra una seconda volta. Sgusciai<br />
giù, ma senza ottenere nient’altro che un uragano di<br />
percosse. Il mio corpicino, però, doveva resistere alle<br />
torture educative. Io ero ribelle e indocile. Ma la mia<br />
ora era giunta e il babbo doveva svezzarmi e domarmi.<br />
Però ero ostinato come uno di quegli agnelli terribili<br />
che immersi improvvisamente nel gregge estraneo in<br />
cui svezzano, si turbano e belano paurosamente assordando<br />
tutti. Saltano il recinto in cerca della mamma<br />
finché il pastore è costretto ad impastoiarli. Io ancora<br />
non ero impastoiato e potevo continuare a belare e a<br />
saltare. E mi gettai a terra per una terza volta. E mio padre<br />
allora mi impastoiò.<br />
Come senz’altro aveva visto fare ai ragazzi ribelli in casi<br />
analoghi, decise di legarmi. Spiegò la fune del basto. E<br />
dopo avermela fatta assaggiare a duri colpi, me la cinse<br />
alla vita: ero prigioniero della sua volontà. E tuonando<br />
una fiumana di improperi, mi lasciò per terra. Cavalcò<br />
su tutte le furie e ripartì sbraitando. Quasi per recuperare<br />
il tempo che gli avevo fatto perdere, scrollava continuamente<br />
le gambe addosso alla bestia facendola correre<br />
più del solito anche per farmi paura. Per non rischiare<br />
di essere trascinato, allora, io dovevo seguire meticolosamente<br />
il trotto e cercare di non inciampare.<br />
27
In quel modo feci molta strada. Per mia fortuna con<br />
quel trotto sfrenato raggiungemmo altri pastori che<br />
conversavano animosamente sui loro somari. I loro<br />
rimproveri decisero mio padre a cedere. E costretto<br />
dall’imbarazzo di aver applicato la massima punizione,<br />
mi slegò e mi rimise in groppa. Per quel giorno il supplizio<br />
era finito. Ma mi guardai bene dal piangere ancora.<br />
Il mio divagamento ferino era iniziato.<br />
A Baddhevrùstana non passava quasi mai nessuno al<br />
di fuori di banditi in transito verso o dalla Barbagia, o<br />
cacciatori in cerca di selvaggina di cui io diffidavo sempre.<br />
Naturalmente il babbo non pretendeva ancora che<br />
io sbrigassi le cose in modo inappuntabile: era già molto<br />
che dopo soli tre mesi rimanessi solo ad aspettarlo<br />
con il cane. Era già maggio e per sentito dire sapevo che<br />
le serpi (sas colòras) stavano per destarsi dal loro letargo.<br />
Non ne avevo mai viste, ma di esse avevo paura.<br />
Avevo sentito cose strane sul loro conto durante l’infanzia<br />
a Sìligo.<br />
Tutto ora era diventato più rigido. Le lezioni si facevano<br />
sempre più severe e più rigorose. Era ormai tempo<br />
di passare alla pratica. Il periodo introduttivo richiedeva<br />
ancora molto tempo. E almeno in certe cose<br />
mio padre volle passare subito ai fatti.<br />
La prima prova che mi fece sostenere fu quella di<br />
condurre le pecore (de jùghere sas bivèghes) da un punto<br />
ad un altro del pascolo.<br />
Un pomeriggio di maggio, poco prima della mungitura,<br />
senz’altro perché voleva una prova concreta di<br />
28<br />
quello che sapevo fare e di quello che lui mi aveva insegnato,<br />
mi ordinò energicamente di condurre le pecore<br />
al recinto per mungerle (a sa mandra pro las mùrghere).<br />
Tutto scosso dai suoi ordini non trasgredibili, infilai la<br />
prima mulattiera che mi capitò tra i piedi verso il gregge,<br />
che pasceva in una collinetta, in lontananza (in d’una<br />
palìnza, lontàna).<br />
Come al solito, ero scalzo. Nella bella stagione i ragazzi<br />
ne facevano a meno degli scarponi, per risparmiarli<br />
per l’inverno (a su iérru). I miei piedi però, a furia<br />
di camminare tra gli sterpi e sul fieno arido e secco si<br />
erano insuolati con una striscia callosa quasi impenetrabile.<br />
La mulattiera, nonostante si snodasse a zig-zag,<br />
polverosa, senza sterpi né macigni, di tanto in tanto,<br />
era sbarrata dall’invadente rigoglio dei rovi che per l’esuberanza<br />
primaverile irrompevano dappertutto. Inoltre<br />
i cardi e gli altri arbusti (sos baldos e issos àtteros arrasòlos)<br />
ai lati, vi lasciavano cadere le loro spine che poi<br />
il vento e l’andirivieni delle pecore confondevano nella<br />
polvere su cui io frettolosamente e incurante affossavo<br />
i piedi. Così di tanto in tanto dovevo interrompere il<br />
mio trotto. Mi fermavo. Poggiavo il piede punto sul ginocchio<br />
della gamba su cui mi reggevo ed estraevo la<br />
spina che aveva passato la suola dei miei piedi. Con uno<br />
strappo secco cercavo che la spina venisse fuori senza<br />
rompersi. E prima di buttarla fuori dalla mulattiera per<br />
evitare che mi pungesse una seconda volta, guardavo se<br />
ne era uscita fuori intera con tutta la sua punta, come<br />
mi aveva insegnato il babbo.<br />
Tra una spina e l’altra, tra una puntura e un’estrazione<br />
spesso zoppicando (toppi toppi), raggiunsi il gregge<br />
29
che era sommerso dall’erba, dalla ferula e dall’asfodelo<br />
(dae sa férula e dae s’ammùttu). Le pecore si vedevano a<br />
stento. L’erba era più alta di loro. I rampolli e le foglie<br />
(sos siriònes e sas fozas) si piegavano al loro passaggio<br />
sotto le loro pance lanute e piene (lanòsas e chìbberas).<br />
Le aggirai dalla parte opposta alla direzione del recinto<br />
come mi aveva insegnato mio padre. Le pecore si<br />
raccolsero e si misero in movimento.<br />
Improvvisamente però per terra vidi strisciare una<br />
serpe (una colòra) color verdognolo a chiazze nere. Mi<br />
veniva in senso opposto sulla mulattiera. Sfortunatamente<br />
non trovò nessuna tana o buca che la inghiottisse.<br />
Aveva il passaggio obbligato e avanzava strisciando<br />
in modo orripilante. Io non avevo mai visto una serpe,<br />
né sapevo che lì ce ne sarebbero potute essere. Lo spavento<br />
fu grande al punto di andare quasi in delirio.<br />
Uscii fuori dalla mulattiera sui rovi e sui cardi, irrompendo,<br />
senza sentirli né vederli anche se mi stavano solcando<br />
e sfregiando le gambe e pungendo i piedi.<br />
Allora le spine non le sentivo più. Quasi per istinto,<br />
mi diressi verso mio padre che già alle mie urla stava venendomi<br />
incontro, per la macchia.<br />
– Che c’è? (E ite bada?) – mi disse meravigliato.<br />
– C’era una serpe! (bi aìada una colòra!)... Ho visto<br />
una serpe tra le pecore!<br />
Mio padre che non volle farsi sfuggire l’occasione per<br />
insegnarmi come mi sarei dovuto comportare in simili<br />
circostanze, mi raggiunse e mi impartì la sua lezione. E<br />
anziché consolarmi si slacciò la cintura di cuoio (sa<br />
chintòsa dae chintu) e me ne diede a non finire sulle<br />
gambe nude e già sanguinanti dall’inciampare sulle fra-<br />
30<br />
sche spinose, in modo che avessi più paura della cintola<br />
che delle serpi.<br />
– Non devi aver paura delle serpi! Non fanno nulla<br />
quelle! E anche se facessero molto male sarebbe la stessa<br />
cosa. Questo pascolo è nostro e ce lo dobbiamo difendere:<br />
sfruttare, mangiare.<br />
Dopo questa introduzione di staffilate e di sentenze<br />
furiose, si calmò un po’. E spingendomi verso il gregge<br />
continuò con tono più moderato la sua lezione.<br />
– Quando le incontri devi armarti di un bastone o di<br />
quello che trovi per caso (anzi dovresti andare sempre<br />
armato e non come si va a cacare... qui bisogna stare a<br />
bastone in mano anche cacando) e ucciderle, se non se<br />
ne scappano o ti danno fastidio... Staremmo freschi se<br />
lasciassimo tutto per una serpe!... Anche il diavolo<br />
dobbiamo cacciar via se venisse nel nostro campo a<br />
darci fastidio con il suo seguito. Sì, anche il diavolo! (fina<br />
su diàulu!) E perché non si presenta? Che venga<br />
qui! Il gregge dovrai sempre ricondurlo all’ovile anche<br />
se andasse a finire all’inferno.<br />
– Dove l’hai vista, questa serpe?<br />
– Laggiù (in cuddhàne josso!).<br />
– Andiamoci!<br />
In un baleno piombammo lì. Mio padre aveva in mano<br />
un enorme bastone e avanzava, <strong>padrone</strong> di tutto,<br />
come se volesse divorare anche le pietre, per dimostrarmi<br />
che quel luogo era solo nostro.<br />
La serpe non c’era più. Io ero ancora terrorizzato e al<br />
pensiero che l’avrei potuta incontrare ancora da solo<br />
trasalii.<br />
– Se la incontrassi di nuovo quando lui va a Sìligo?<br />
31
Quella serpe è lì! Chissà quante altre ce ne saranno?<br />
Chissà quante amiche avrà sparse per il campo, sotto le<br />
pietre o per i covi!<br />
Erano le frasi che mi martellavano il cervello. Il babbo<br />
mentre ci spingevamo verso il gregge mi diede una<br />
letta con il suo sguardo penetrante. E intuì subito la cosa.<br />
Continuò la lezione fino in fondo per distruggere<br />
con l’esperienza e la verità questo mostro che ormai era<br />
penetrato nel mio essere con dimensioni paurose: io lo<br />
avevo visto al di là della sua natura e solo come una chimera<br />
che già mi ero creato per sentito dire.<br />
Da esperto della situazione, senza perdere tempo, mi<br />
fiutò. Ustò la paura che avevo della serpe, lasciò perdere<br />
il gregge e mi portò in una forra (in d’una duppa): in<br />
un serpaio.<br />
Come una forza della natura scatenata, si mise a<br />
scuotere i cespugli e a rivoltar sassi (a istrutinàre mattas<br />
e a bostulàre crastos dae bare) da tutte le parti. Con molta<br />
naturalezza perlustrava frettolosamente ogni buco e<br />
ogni punto laddove la sua esperienza gli suggeriva potevano<br />
essercene, quasi ne sentisse l’usta, così come<br />
fanno i cani inseguendo la selvaggina. Io, impalato, ma<br />
incuriosito, osservavo la scena. I cespugli oscillavano<br />
tutti, quasi si fosse scatenata una bufera di vento e i sassi<br />
rotolavano verso la valle (sos crastos loddhuraìana a<br />
s’addhe), quasi la collina se li volesse scrollare di dosso.<br />
Io stavo dietro la sua tempesta. Così erano gli ordini.<br />
Finché, a un certo punto mi si presentò l’orribile vista<br />
di una serpe come quella di prima, attorcigliata sotto<br />
un masso che mio padre stava rivoltando con tutte le<br />
sue forze.<br />
32<br />
– Eccola! Uccidila! (Milla! Bócchila!).<br />
La serpe, trovatasi all’improvviso a ciel sereno, spiegò<br />
la spirale tortuosa del suo corpo. Si ritrasse in se<br />
stessa. Si allungò di colpo e sgusciò fuori dalla sua tana.<br />
Mio padre teneva sempre il bastone tra le mani ma non<br />
la colpì subito. Non voleva perdere l’occasione per<br />
darmi una lezione dal vero, ora che aveva la serpe di<br />
fronte. Mi fece cenno di avvicinarmi al suo teatro pastorale.<br />
La serpe, contorcendosi e dispiegandosi continuamente,<br />
cercava di scappare ma lui la tratteneva sbarrandole<br />
il passo con il bastone in ogni direzione.<br />
– Non la vedi che non fa nulla? La puoi uccidere<br />
quando vuoi o lasciarla alla sua vita... Col bastone sei<br />
<strong>padrone</strong>. Basta metterglielo davanti... Lo vedi, eh?<br />
Guarda! Cosa ti fa? Nulla ti fa!<br />
Lui sembrava si volesse divertire e quasi si compiaceva<br />
di prolungare la scena. Mi scagliò tra le mani un<br />
altro bastone e sotto il suo sguardo attento mi affidò il<br />
rettile.<br />
Lo toccavo, come faceva lui, col bastone e subito imparai<br />
a tenerlo prigioniero. Il babbo da una parte e io<br />
dall’altra si faceva a gara a sbarrare il passo alla serpe<br />
che provava e riprovava a sgusciar via. Il rettile però era<br />
esasperato. E spinto dalla forza della disperazione e<br />
dall’istinto di conservazione, si contrasse più del solito,<br />
tutto in se stesso dimezzando la sua lunghezza, disponendosi<br />
in una terribile sinusoide: era all’ultima mossa.<br />
Il collo gli si ingrossò accorciandosi in proporzione.<br />
La bocca sbuffò e spruzzò bava, tirando fuori ripetutamente<br />
la sua lingua biforcuta.<br />
Io, impaurito di nuovo, uscii di scena, lasciando a<br />
33
mio padre la serpe che indietreggiò ancora nell’ultimo<br />
scampo. Ma quando mio padre le precluse ancora una<br />
volta la strada con il bastone, la serpe tentò il tutto per<br />
tutto. Passò all’attacco. Avanzò impetuosamente scagliandosi<br />
contro di lui: fingendo, nella sua innocuità, di<br />
produrre un terrore che per nulla avrebbe potuto imbarazzare<br />
un pastore già temprato. Mio padre però forse<br />
non se la sentiva più di scherzare con una serpe, di<br />
servirsi ancora di un pericoloso rettile per educarmi al<br />
coraggio. La lezione era durata abbastanza. E la trasformazione<br />
iraconda e brutale della serpe così contratta,<br />
turgida nel collo e tesa nella bocca sanguigna,<br />
suscitò in mio padre, per riflesso, un’ira altrettanto<br />
brutale così da coinvolgerlo nell’aggressione e nella<br />
violenza. Fu lo scontro. Irrigiditosi di colpo, mio padre<br />
la colpì col bastone in piena testa, schiacciandogliela<br />
infine col tallone del suo scarpone destro mentre la serpe<br />
gli si avvinghiava alla gamba in una spirale disperata<br />
con tutto il resto del corpo morente, quasi gliela volesse<br />
strozzare. La lanciò lontano con la punta del suo scarpone<br />
e poi la raccolse soddisfatto. Quindi librandola<br />
con il bastone mi venne incontro con il mostro distrutto.<br />
– Hai visto come si fa... E guai a te, se avrai ancora<br />
paura di una serpe o di altro qui... – E come per riepilogare<br />
la sua lezione, me la scagliò addosso, sul petto, ancora<br />
sanguinante.<br />
– Prendila con il bastone e portatela dietro: la daremo<br />
al gatto... Andiamo a mungere ora...<br />
– Ahi! Ahi! – gli gridai dietro.<br />
– Che c’è?<br />
34<br />
– Sono tutto graffiato... oih!... oih!<br />
– Eh! Hai visto che ti succede?... Cosa ti fa la paura?<br />
Ti sei messo a fuggire all’impazzata in mezzo ai rovi e ai<br />
cardi escoriandoti le gambe e i piedi. Fermati. Bisogna<br />
medicare le ferite...<br />
– Con che cosa?<br />
– Con l’urina. Quando non c’è altro è la medicina!<br />
– Io non ho voglia adesso, – gli dissi. Avevo vergogna<br />
di pisciare davanti a lui. – E, poi, non mi viene bene... a<br />
medicarmi le ferite...<br />
Anche a lui si presentò il solito problema che risolse<br />
subito.<br />
– Aspetta, – mi disse, anche lui imbarazzato.<br />
Si fece dietro un macchione. Si pisciò, dandomi le<br />
spalle, sulla mano destra raccolta e mi mise la sua urina<br />
sulle ferite più grosse.<br />
– Mi frigge.<br />
– Lo so! Ora lo farai anche tu quando ne avrai voglia,<br />
– mi disse dopo che ripeté la scena due tre volte. – Andiamo!<br />
Su!<br />
Mio padre, come al solito, continuava ad andare presto<br />
a Sìligo a portarci il latte dopo la mungitura. Io restavo<br />
solo in quel serpaio, nel bosco, in compagnia delle<br />
piche che sulle querce modulavano i loro interminabili<br />
canti. In compagnia degli astori e delle volpi (de<br />
sos astòres e de sos groddhes). Spesso al suo ritorno mi<br />
portava i vestiti lavati dalla mamma e potevo cambiarmi.<br />
Ricordo che i vestiti quando me li toglievo non erano<br />
solo sporchi di sudore e di untume, ma anche di<br />
35
sangue. Le pulci che avevo addosso imbrattavano i miei<br />
indumenti con il loro sterco: era la misera fine del mio<br />
sangue succhiato digerito e cacato beatamente dagli<br />
insetti.<br />
Così ogni volta che mi cambiavo, nei miei indumenti<br />
a chiazze di sangue, si poteva leggere il loro bivacco e<br />
l’ematografia stercoraria del mio martirio notturno e<br />
quotidiano. E nel nostro mondo civile mentre ai pastori<br />
mancava il pane quotidiano, le pulci avevano anche<br />
quello notturno.<br />
La notte, quando ci si distendeva sulla stuoia (in sa<br />
udijèdda), le pulci uscivano a pascere le loro valli e le loro<br />
pianure più ubertose. Scorrazzavano nel mio corpo<br />
contendendosi i punti in cui la pelle era più vulnerabile<br />
e il sangue usciva più facilmente e più gustoso.<br />
Prendere sonno in tali condizioni era difficile. Addosso<br />
sentivo i morsi, le succhiature, le loro gambuzze<br />
e i loro turbinosi spostamenti per cambiar “pastura”.<br />
Ora sul petto, ora sulle spalle, sotto le ascelle o alle costole,<br />
a seconda del loro capriccio e del loro appetito.<br />
Mi rivoltavo continuamente e nel buio della capanna<br />
me le immaginavo succhiare e mi dibattevo quasi me le<br />
volessi scuotere di dosso. Le pulci però conoscevano<br />
bene i loro prati fioriti e le mie contorsioni, forse, non<br />
facevano altro che stuzzicare la loro fame insaziabile.<br />
Disteso sulla stuoia tra il buio che vinceva la debole luce<br />
del fuoco morente della capanna, mi immaginavo le<br />
loro cene, i loro brindisi, e i loro sollazzi: i loro giochi<br />
amorosi.<br />
Era una cosa disgustosa e spesso scattavo in brividi di<br />
repulsione. E ogni sera prima che il sonno vincesse<br />
36<br />
questo abominevole martirio, mi sentivo a un tempo<br />
mensa e pastura di questi intrusi luridi ghiottoni, che<br />
nonostante li nutrissi mi pagavano cacandomi a gettito<br />
continuo. Per fortuna ero ancora piccolo e appena mi<br />
coricavo il sonno mi avvinceva subito. Spesso, anzi, la<br />
sera ero molto stanco e quando mio padre mi stendeva<br />
la stuoia e mi copriva con una coperta logora, mai lavata<br />
e con i panni che metteva sotto il basto del somaro<br />
(cun sos bàttiles de s’àinu), il sonno mi vinceva di colpo<br />
e le pulci uscivano dalle loro tane e potevano così spassarsela<br />
sul mio corpo addormentato. Finché mio padre,<br />
quando aveva già munto le pecore ed era già pronto<br />
per partire a Sìligo, mi svegliava all’alba e mi dava le<br />
sue disposizioni.<br />
Questo era il supplizio che dovevamo subire ogni<br />
notte, io e mio padre. A questa situazione si cercava di<br />
reagire in qualche modo. Il babbo metteva in luce tutta<br />
la sua esperienza e si richiamava ai suoi anziani. Quando<br />
c’erano le belle giornate, sin dalla mattina, stendeva<br />
le coperte, la stuoia e gli stracci vari con cui ci si copriva,<br />
sui muri o sui cespugli vicini alla capanna e li sbattevamo<br />
con i bastoni, alla meglio. Le lasciavamo al sole<br />
per gran parte del giorno. La sera, prima che il giorno<br />
morisse, iniziavamo l’operazione anti-pulce. Le coperte<br />
le passavamo punto per punto: maglia per maglia e<br />
piega per piega, dove si riparavano.<br />
– Stai attento prima di acchiapparle. Saltano e si nascondono<br />
tra le pieghe (brìncana e si costóini in sas pijas).<br />
Sono furbe, – mi diceva, – e appena smuovi la co-<br />
37
perta sgusciano e si nascondono... E quelle che ti sfuggono<br />
ora, ti pungeranno stanotte... Devi cacciarle ben<br />
bene.<br />
Era molto bravo. Le prendeva e le schiacciava fra le<br />
unghie dei pollici rovesciati. E certo, quando si dava<br />
la caccia a queste sanguisughe silenziose, ma scattanti,<br />
la notte la trascorrevamo più tranquilla e si dormiva<br />
meno punzecchiati. Malauguratamente mio padre<br />
non aveva il tempo di dar loro la caccia tutti i giorni.<br />
L’oliveto era la sua selvaggina e l’unico campo di caccia.<br />
Le pulci, poi, si riproducevano rapidamente, specie<br />
al caldo della primavera e dell’estate, e dopo due<br />
tre giorni facevano di nuovo strage sui nostri corpi addormentati.<br />
Quando, raramente, il babbo mi riportava a Sìligo,<br />
una volta ogni due tre mesi, e gli indumenti me li cambiavo<br />
in paese, la mamma per non farsi infestare la casa<br />
ricorreva a certe sue precauzioni. Mi teneva vicino al<br />
fuoco su cui aveva già messo a bollire un grande paiuolo<br />
d’acqua. Mi toglieva gli abiti possibilmente tutti assieme<br />
e avvolti li metteva a cuocere. A me faceva il bagno<br />
in un’altra bacinella. Quell’operazione, tanto triste<br />
quanto salutare, mi riportava nell’ambiente della mia<br />
breve infanzia di Sìligo. E da quella bacinella sotto lo<br />
sfregamento nervoso delle mani della mamma, rivedevo<br />
e rivivevo la spidocchiatura che le mamme durante<br />
la guerra facevano ai propri figli. In tre o in quattro ci<br />
catturavano e ci sottoponevano al torchio. Ci distendevano<br />
per terra con la testa tenuta per il collo su un foglio<br />
di giornale e la spidocchiatrice incominciava a sfregare<br />
le teste. I pidocchi grandinavano tonfando sul<br />
38<br />
giornale insieme al lendine. Ora i miei indumenti mi<br />
apparivano come uno di quei fogli di carta che arrotolati<br />
venivano tempestivamente gettati sul fuoco.<br />
– Queste pulci non hanno nulla da invidiare ai pidocchi<br />
della guerra, – diceva la mamma. – Succhiano avidamente.<br />
– Eh, non è che ora me li attaccano i ragazzi che non<br />
vengono puliti dalle loro mamme, come mi dicevi allora.<br />
Io ora non ci vado più a giocare con ragazzi pieni<br />
di pidocchi come allora. Magari! Ora sono solo...<br />
Eppure sono pieno di pulci più di allora... Più di<br />
quando andavo a giocare con i figli di thia Franzisca,<br />
che non aveva il petrolio da mettere sulla testa spidocchiata<br />
dei loro figli.<br />
L’unica cosa confortante nella spulciatura che ora mi<br />
faceva la mamma era che la testa non me la sentivo<br />
sgraffignata e dolorante come nella spidocchiatura e la<br />
testa non puzzava di petrolio. Mi rivestivo e sentivo<br />
odore di pulito. Gli abiti finalmente mi solleticavano<br />
piacevolmente.<br />
Venne così il cuore dell’estate, periodo in cui i pastori<br />
nel Logudoro effettuano la transumanza estiva (l’unica<br />
in questa zona rendendosi inutile quella invernale<br />
per la dolcezza del clima, al contrario di quanto avviene<br />
nelle zone dell’interno dell’isola) verso le pianure cerealicole:<br />
nelle stoppie mietute (in sas istùlas).<br />
Baddhevrùstana così rimase sola con le sue volpi e i<br />
suoi uccelli a caccia di cavallette. L’unico gregge che vi<br />
rimase fu il nostro. Mio padre non volle affittare pascolo<br />
estivo. Voleva risparmiare. Quell’anno per pagare<br />
l’affitto di una tanca a Baddhevrùstana ci rimise quasi<br />
39
tutto il latte che aveva prodotto. Le cavallette l’avevano<br />
completamente rosicchiata. Il <strong>padrone</strong> volle però l’affitto<br />
pattuito. A stento il babbo riuscì a farmi gli scarponi<br />
nuovi.<br />
Il nostro piccolo gregge comunque poteva star bene<br />
anche a Baddhevrùstana purché abbeverato due volte al<br />
giorno. Durante la notte, come si fa d’estate, con il babbo<br />
conducevamo il gregge a pascere il fieno ammorbidito<br />
dalla rugiada: quel poco che le cavallette avevano risparmiato.<br />
Si dormiva all’aperto, sotto gli alberi, per evitare<br />
la rugiada mattutina. A me piaceva molto, quando<br />
c’era la luna piena in mezzo al cielo. Vedermela spuntare<br />
all’orizzonte però era tutt’altro spettacolo. Mi sembrava<br />
rialbeggiasse.<br />
L’unico imprevisto per la nostra salute erano le zanzare<br />
(sa thìnthula).<br />
Il babbo era sempre provvisto di chinino e la sera il<br />
più delle volte me lo somministrava al tramonto dopo<br />
la nostra cena con pane e pere rosse e mature. Molti pastorelli<br />
incauti morivano sul campo. Lui me lo diceva:<br />
ne aveva visti tanti.<br />
Verso la fine di settembre rientrarono dalle stoppie<br />
tutti i pastori della contrada. E la notte in compagnia<br />
del babbo tra i canti delle volpi in lontananza potevo risentire<br />
lo sferragliare dei vari greggi. Lui mi faceva notare<br />
la differenza delle diverse sonaglie e il suono d’insieme<br />
di ciascun gregge. Io dovevo riconoscerlo. Era<br />
importante. Dal suono avrei potuto individuare il gregge<br />
di uno o dell’altro, nel caso fosse saltato nei nostri<br />
chiusi o fosse stato messo in fuga dai banditi. Ogni pastore<br />
doveva essere in grado di conoscere il gregge al-<br />
40<br />
trui dalle sonaglie, diceva il babbo, per difendersi o<br />
proteggersi reciprocamente.<br />
Finita l’estate si ritornò a dormire nella capanna. Meglio<br />
le pulci che il freddo dell’inverno. La notte, a parte<br />
le prime ore, il bestiame veniva immandrato dopo che<br />
se ne faceva scrupolosamente la conta mentre entrava<br />
nel varco delle diverse mandrie. Io e il babbo dormivamo<br />
a orecchio leggero, pronti a scattare al primo abbaiare<br />
del cane.<br />
Con le prime acque scomparve il colore dell’estate e<br />
venne anche per me il primo autunno pastorale. La<br />
campagna si rivestì di verde, mentre le pecore incominciarono<br />
a figliare. Il nostro gregge nel giro di dieci giorni<br />
si riempì con mio grande piacere di agnelli. Allora la<br />
mattina mi svegliavo presto insieme al babbo per rivedere<br />
gli agnelli che già conoscevo o quelli che eventualmente<br />
erano nati durante la notte. In questo periodo<br />
lui si alzava due o tre volte per notte per assistere gli<br />
agnelli appena nati e per farli poppare. Spesso il freddo<br />
impediva loro di suggere le poppe della mamma e potevano<br />
smammolarsi e morire. Allora lui li portava dentro<br />
la capanna, li riscaldava al fuoco e quando davano<br />
segno di vitalità li imboccava. Apriva loro la bocca e vi<br />
spremeva il capezzolo della loro mamma o di altra pecora<br />
se la mamma malauguratamente non portava latte.<br />
Operazioni che lui faceva con molta cura.<br />
Gli agnelli crebbero subito e mentre le madri placavano<br />
di giorno la loro fame, si radunavano in un punto<br />
e si mettevano a correre sulle mulattiere come se faces-<br />
41
sero le gare. Disposti in fila indiana o in più file partivano<br />
da un punto ad un altro percorrendolo varie volte<br />
nella loro gioiosa corsa. Quasi per intesa di tanto in tanto<br />
si spandevano, poi si riordinavano stringendosi l’uno<br />
all’altro e si sollevavano tutti insieme con uno scatto<br />
simultaneo, guizzando per l’erba. Sembravano uno<br />
stormo di uccelli. Io durante le belle giornate al riparo<br />
dietro un mucchio di pietre o un rovo (accuccàdu a isségus<br />
de una moridìna o de unu ru) mi ascoltavo lo sferragliare<br />
del gregge e mi godevo la corsa degli agnelli finché<br />
non sentivano il desiderio del capezzolo. Ognuno<br />
allora si tuffava nel gregge (si ch’ettaìada in s’ama) per<br />
succhiarsi avidamente la mamma inginocchiato sotto<br />
le poppe sbatacchiate fortemente con il muso.<br />
Novembre passava con le sue poche giornate di sole.<br />
Il freddo si faceva sempre più intenso. La notte, quando<br />
il cielo era stellato, scendeva la rugiada. La fredda<br />
brezza del cuore della notte la raggelava e si formava la<br />
brina (su lentòre si elaìada e biddhiaìada).<br />
Così la mattina quando il babbo partiva per Sìligo mi<br />
lasciava all’ovile con le pecore ancora rinchiuse nel recinto<br />
con l’incarico di farle uscire soltanto quando il<br />
sole era alto e aveva disciolto lo strato bianco e luccicante<br />
della brina. Il pascolo gelato causa dissenteria al<br />
bestiame e spesso anche la morte. La capanna era dentro<br />
il recinto stesso. Seduto accanto al fuoco, allora potevo<br />
osservare le mandibole delle pecore ruminanti<br />
sdraiate di fronte alla siepe e Rusigabèdra che si attorcigliava<br />
con il muso in culo per farsi caldo. Tra una brinata<br />
e l’altra, venne per me anche il primo inverno da<br />
trascorrere nell’abituale capanna sulla stuoia e sulle<br />
42<br />
pelli di pecora. Il freddo della notte spesso ci costringeva<br />
a buttarci addosso le coperte, anche i cappotti e i<br />
sacchi con cui durante il giorno ci si riparava dal freddo<br />
e dalla pioggia. Perfino i panni che si mettono sotto il<br />
basto del somaro (sos bàttiles), facevano o da materasso<br />
o da coperta. Poco importava se questi aggeggi fossero<br />
bagnati o meno. L’importante era creare, sopra le coperte,<br />
un certo peso che ci separasse dal freddo. Il caldo<br />
veniva da sé.<br />
L’inverno si faceva sentire con le sue giornate piovose<br />
e mio padre era sempre più preoccupato di lasciarmi<br />
solo mentre lui necessariamente doveva recarsi a Sìligo<br />
per il latte. Era il periodo dell’abigeato. E ogni mattina<br />
mentre si allontanava dall’ovile più per snidare le volpi<br />
dalla tanca che per ricordarmi le sue disposizioni che<br />
mi aveva ripetuto più volte, sulla mulattiera che lo immetteva<br />
sulla via verso Sìligo a gran voce mi ripeteva le<br />
“solite”, per due o tre volte, finché non scompariva<br />
verso il bosco che se lo inghiottiva e la sua voce non si<br />
sperdeva nella folta selva delle ginestre spinose e dei<br />
rovi rugiadosi (de sa terìa e de sos ruos saurràdos).<br />
Per intimorire i banditi, anzi, ricorreva a uno stratagemma.<br />
Tutti sapevano che thiu Juànne spesso capitava<br />
da noi. Nelle giornate piovose, quando non si poteva lavorare<br />
la terra durante i temporali (in sas temporàdas),<br />
quando la terra, pregna d’acqua, non si poteva zappare,<br />
quest’uomo veniva nel nostro campo per farsi legna, e<br />
ad estirpare i ceppi e le radici degli alberi tagliati dal<br />
babbo (a bogàre truncos bezzos). Mio padre sfruttava la<br />
circostanza. E a quelli del vicinato andava dicendo che<br />
pagava thiu Juànne perché gli custodisse il gregge e an-<br />
43
che perché mi facesse compagnia e mi istruisse in sua assenza.<br />
Tutto questo era naturalmente una commedia. Di comune<br />
accordo, mio padre e thiu Juànne la recitavano<br />
anche alle pietre. Mio padre sempre, thiu Juànne solo<br />
quando capitava da noi per farsi legna.<br />
Così la mattina, quando mio padre partiva per Sìligo,<br />
riempiva la tanca di ordini e di grida che si spandevano<br />
dappertutto e che tutti sentivano. Prima che<br />
scomparisse dall’orizzonte, mi gridava con quanto<br />
aveva in canna il suo abituale richiamo: – Oh! oh! oh!<br />
Gavì? – almeno per due o tre volte, anche se io gli rispondevo<br />
già dal primo richiamo. Urlavo altrettanto<br />
forte: – Oh! oh! oh! e itéeee! – prolungando la e finale,<br />
la cui eco rimbombava nelle valli. L’importante era far<br />
baccano e ululare. Mio padre, allora, in modo che sentissero<br />
i banditi, i loro informatori locali e il vicinato,<br />
fingeva di essersi dimenticato di darmi le sue disposizioni:<br />
– Ricordati di fare quella faccenda quando arriva<br />
thiu Juànne! Digli che io ritorno presto.<br />
– Ehi... eheeeee! – riecheggiavo io, concludendo la<br />
nostra commedia quotidiana.<br />
Molti ci credevano nonostante per lo più io continuassi<br />
a rimanere solo anche quando pioveva. Thiu<br />
Juànne veniva solo quando gli pareva e solo quando<br />
aveva bisogno di legna.<br />
Quando capitava, la sua compagnia allora era la cosa<br />
più bella che mi si potesse offrire in quel bosco. Era un<br />
uomo simpatico. Mi raccontava storielle e bagatelle della<br />
sua infanzia lontana che io ascoltavo con molto interesse,<br />
mentre agitava il piccone per estirpare le radici.<br />
44<br />
Spesso mi narrava anche episodi che erano successi a<br />
Baddhevrùstana, i cui protagonisti erano stati i miei<br />
avi, e io ci tenevo. Lui li aveva sentiti dagli anziani e soprattutto<br />
dal mio nonno paterno, che non ho conosciuto<br />
(lasciò orfano mio padre sin dall’età di dodici anni).<br />
Naturalmente non tralasciava di raccontarmi qualche<br />
scapricciata infantile su mio padre.<br />
– L’antenato più interessante della tua famiglia era<br />
thiu Giommarìa Ledda. Un uomo molto coraggioso e<br />
bisnonno di tuo nonno paterno. In forze intorno al<br />
1850. Era temuto da tutta la contrada ed era una specie<br />
di capogruppo. Nessuno a Sìligo osava contraddirlo a<br />
parte i ricchi e i nobili che non potevano associarsi con<br />
un pastore e un porcaro come lui era. Tra i pastori e gli<br />
agricoltori era quello che aveva più autorità. Allora la<br />
legge, la giustizia, era molto lontana dalle campagne.<br />
Era a Sassari e a Cagliari, ma la dominava e la manovrava<br />
l’ingordigia dei nobili. I don, i conti, i marchesi e i<br />
cavalieri.<br />
– I pastori si univano in più famiglie e uno difendeva<br />
l’altro. E thiu Giommarìa era il capo del suo gruppo<br />
che non solo era il più forte di Sìligo ma anche dei paesi<br />
vicini. Come ogni capo era temuto, amato e odiato. Allora<br />
c’erano molti grassatori: pastori che si facevano<br />
ricchi con le ruberie. Certi grassatori di Mores che thiu<br />
Giommarìa aveva ripetutamente costretto a restituire il<br />
bestiame rubato, una notte lo assalirono in località su<br />
Colomìnzu nella sua capanna. Era solo con i maiali che<br />
aveva in mezzadria con un cavaliere di Bànari. All’abbaiare<br />
dei cani lui tolse il cespuglio (su càlamu) con cui<br />
si chiudeva la capanna. Allora nella capanna non ce<br />
45
n’era di porta, no! Si precipitò fuori per non farsi cogliere<br />
in trappola. Non era un uomo da nulla, no... La<br />
mosca se la sapeva scacciar via... I moresi erano tanti:<br />
tra servi e padroni erano più di dieci, erano. E si fecero<br />
su di lui per ucciderlo a colpi di mallo. La notte era<br />
molto buia. E quest’uomo non poté fare altro che prendere<br />
i colpi che gli piovvero da tutte le parti. Era una<br />
volpe, però. E riuscì a infilare la testa sotto una radice<br />
di un albero di lentischio. Allora c’erano anche alberi<br />
di lentischio... Ora sono rari... Quelli al buio non se ne<br />
accorsero. Picchiarono e colpirono sul suo corpo servi<br />
e padroni finché qualcuno non disse: “Basta! Sarà<br />
morto già tre volte. Controllatelo.” Lui allora da quel<br />
momento si finse veramente morto. Uno dei grassatori<br />
allora fattoselo rizzare, gli ha suonato le mandibole e<br />
quando ha visto e sentito che si muovevano come le tabelle<br />
della settimana santa, ha detto: “È morto!”<br />
– “Non è morto,” fece un altro dei grassatori.<br />
– “Sì, che è morto.”<br />
– “No! Io prendo il pugnale e lo squarto!”<br />
– “Tu non squarti nulla: non è giusto sfregiare un cadavere!”<br />
– “Se vuoi porta la lesina e lo pungi dove vuoi, ma<br />
non voglio che siano sfregiati i cadaveri freddati da<br />
me.”<br />
– Quel terribile grassatore, allora, afferrata la lesina<br />
tolse gli scarponi a thiu Giommarìa e con la furia di una<br />
belva lo morse al piede tagliandogli il mignolo di un<br />
piede. Gli dette alcune stoccate con la lesina e se lo<br />
guardò. Thiu Giommarìa non si mosse: “È morto,” disse.<br />
“Possiamo andare. È morta l’anima dannata!”<br />
46<br />
– I grassatori allora fecero uscire i maiali dal porcile e<br />
s’incamminarono verso Mores: il loro ovile.<br />
– Thiu Giommarìa, che aveva riconosciuto i suoi attentatori<br />
dalla voce, si alzò dolorante, più morto che vivo.<br />
E scalzo com’era, si recò a Paulubeddhàri all’ovile<br />
del fratello. Sembra impossibile, ma ci devi credere.<br />
Chi me lo disse lo ha visto.<br />
– “Avete scarponi?” Fu la sua prima preoccupazione.<br />
– “Sì! Che è successo? Che è successo?”<br />
– “Mi hanno rubato i maiali e mi hanno lasciato per<br />
morto!”<br />
– “Ti hanno rubato i maiali? Chi sono stati? Li hai riconosciuti?”<br />
– “Dammi gli scarponi, dammi. Sella due cavalli che<br />
andiamo a Banari. Subito. Voglio avvertire il mio mezzadro.”<br />
– Sellati i cavalli, trottarono verso Banari. Avvertito il<br />
mezzadro, gli ordinò di recarsi a Mores con loro. La<br />
mattina a sole alto si presentarono all’ovile dei grassatori<br />
che presero thiu Giommarìa veramente per un’anima<br />
dannata. Il cavaliere di Banari prese per primo la<br />
parola.<br />
– “Bella robba siete.”<br />
– “Siamo disposti a ridarvi tutti i maiali.”<br />
– “Certo che li voglio tutti,” fece il cavaliere.<br />
– “Certo! Ve li diamo tutti! Quello che manca lo abbiamo<br />
ucciso per mangiare e fare a salsicce, ve li paghiamo<br />
come volete.”<br />
– “Al mio mezzadro li date,” fece thiu Giommarìa.<br />
“La mia parte ve la potete anche tenere.”<br />
– Voltò le spalle ai grassatori che rimasero di merda, e<br />
47
se ne andò con il suo mezzadro dietro la sua terribile<br />
minaccia.<br />
– Quando guarì dalle ferite e si mise in buona salute,<br />
thiu Giommarìa radunò i suoi amici più fidi scegliendoli<br />
tra quelle famiglie di cui lui era l’autorità indiscussa<br />
e s’incamminò con loro verso Mores. Giunti all’ovile<br />
dei moresi i cani fecero avvertiti i grassatori di quanto<br />
stava per accadere. Thiu Giommarìa piombò con i suoi<br />
sulle capanne. I capi erano due fratelli e vi erano due famiglie<br />
e due capanne. Sullo spiazzo uscirono le donne<br />
in delirio con i figlioletti in braccio. Uno dei grassatori<br />
allora si nascose sotto una caldaia rovesciata dentro la<br />
stessa capanna. L’altro riuscì a fuggire. Non avendo<br />
trovato nessuno dei responsabili thiu Giommarìa si infuriò.<br />
– “Mettiamo fuoco alle capanne. Subito,” ordinò ai<br />
suoi.<br />
– “Per le creature che vi giacciono dentro... in nome<br />
di Dio! Abbiate misericordia almeno delle creature,”<br />
gridarono le donne piangendo.<br />
– Allora thiu Giommarìa e i suoi uomini si recarono<br />
alla mandria dei vitelli e li sgozzarono tutti. Al muggito<br />
dei vitelli accorsero anche le mucche che uccisero una<br />
dopo l’altra non appena si facevano loro davanti. Spari<br />
a non finire. Sangue e bestiame stramortito anche per i<br />
cani di mezza <strong>Sardegna</strong>.<br />
– Finita la strage, se ne ritornarono a Sìligo, ognuno<br />
ai propri ovili.<br />
– E quei due fratelli e i loro amici che fine fecero? –<br />
gli chiesi.<br />
– Con il passare del tempo thiu Giommarìa e compa-<br />
48<br />
gni li fecero fuori tutti. Nemmeno uno riuscì a scampare.<br />
Con quell’uomo chi sbagliava pagava con la pelle,<br />
pagava! E faceva bene!<br />
– Raccontatemi qualche altro episodio di thiu Giommarìa.<br />
– Eh, ce ne sono tanti, ce ne sono. A Sìligo allora dominava<br />
un certo don Peppe Mannu. Un prepotente e<br />
un dissoluto come tutti i don... hummm! La Giustizia<br />
se li avesse portati via tutti... E questo signore andava a<br />
caccia delle figlie di thiu Giommarìa... Erano molto<br />
belle. Le migliori ragazze del paese. Il tuo antenato, che<br />
seppe subito le intenzioni di don Peppe, non ebbe paura<br />
di mostrargli i denti. E da qui seguì tutta una serie di<br />
vendette che durarono almeno due tre anni. Chi pagò<br />
per primo fu naturalmente thiu Giommarìa. Era un<br />
semplice porcaro, anche se dominava e amministrava<br />
la giustizia di mezzo Sìligo tra la gente di campagna.<br />
– Una sera sull’imbrunire thiu Giommarìa si stava recando<br />
a casa sua a Sìligo e passò davanti alla casa di don<br />
Peppe. Sull’uscio della casa del don c’era un suo leccapiatti<br />
che con spavalderia si mise a fare il gradasso.<br />
– “Che ne fai di quel laccio di cuoio,” fece rivolto a<br />
thiu Giommarìa.<br />
– “Potrebbe anche affogare il tuo collo.”<br />
– “Eh! vai vai! Verrà presto la tua ora,” fece il lecchino<br />
sicuro della protezione del don.<br />
– Thiu Giommarìa non dimenticò mai più quella minaccia<br />
di morte. Venne il carnevale. E una notte si mascherò<br />
da gentildonna. Dietro la sala da ballo c’era un<br />
albero di melograno e thiu Giommarìa vi si appostò e<br />
vi stette finché non gli venne a tiro il lecchino di don<br />
49
Peppe e lo freddò con una fucilata. Sorpresa dei danzatori!<br />
– Don Peppe, che sapeva ciò che passava tra i due,<br />
forte della sua autorità sulla Giustizia, fece chiamare i<br />
carabinieri di Banari e sul sospetto fece arrestare thiu<br />
Giommarìa. Certo! non lo aveva visto nessuno, no.<br />
– I carabinieri mentre lo portavano in caserma passarono<br />
davanti alla casa del don che era sull’uscio.<br />
– “Ora don Pè può stare tranquillo: ha fatto arrestare<br />
Giommarìa Ledda.”<br />
– “Certo! Guardateli bene gli alberi di Monte Santu.<br />
Quando tu sarai libero saranno già alberi fatti.”<br />
– “Ho l’animo che io ritorno.” Fece thiu Giommarìa<br />
tra le braccia dei gendarmi. “E credo che lei non ci sarà<br />
più qui.”<br />
– Quello che diceva quell’uomo era una sentenza,<br />
era. Non parlava mai all’aria.<br />
– Don Peppe era un uomo senza scrupoli e faceva<br />
razzia delle donne dei paesi vicini, specie delle mogli<br />
dei pastori suoi dipendenti e delle loro figlie. Più volte<br />
avevano tentato di eliminarlo, ma riuscì sempre illeso<br />
dagli assalti. Correva fama che le palle non lo passassero.<br />
Era fatturato.<br />
– Una notte lo appostarono in Parruogliàri, tra Banari<br />
e Sìligo, dove sarebbe passato di ritorno. Allo scalpitìo<br />
del suo cavallo i suoi attentatori lo presero di mira e<br />
lo spararono a palle d’oro. L’oro passa qualsiasi fattura,<br />
anche se viene fatta dallo stesso demonio. Lo crivellarono<br />
di colpi e lo ridussero a colabrodo.<br />
– E chi erano?<br />
– Indubbiamente amici di thiu Giommarìa.<br />
50<br />
– Lui non c’era?<br />
– Lui era ancora in prigione in attesa del dibattimento.<br />
Uscì poco dopo: assolto per insufficienza di prove,<br />
dopo oltre due anni di carcere.<br />
Thiu Juànne raccontava sempre senza interruzione<br />
estirpando le radici senza tregua tra una scorreggia e<br />
l’altra che tuonavano nel silenzio del bosco. Quando<br />
c’era lui la giornata mi passava senz’accorgermene.<br />
Purtroppo se non faceva brutto tempo lui non veniva.<br />
Io pregavo che piovesse e spesso l’inverno mi dava retta.<br />
Così mi rivedevo thiu Juànne spuntare all’orizzonte.<br />
– Ciao! Gaviné! Come va? Hai freddo?<br />
– No. Oggi me ne raccontate di storie di thiu Giommarìa?<br />
– Sì. Ora però mangiamo alla capanna. Poi mentre io<br />
farò la legna...<br />
Così come al solito thiu Juànne si sceglieva un ceppo<br />
e incominciava a sterrarlo praticando delle gore per recuperare<br />
anche le radici. Al mio invito non si tirava mai<br />
indietro e raccontava.<br />
– Per dimostrarti quanta stima e rispetto avesse thiu<br />
Giommarìa a Sìligo e nei paesi vicini ti racconto questa.<br />
Un suo amico, thiu Jonbattìsta, durante l’inverno aveva<br />
affidato il gregge minuto e non figliato, montoni<br />
compresi (sa laghìnza), al suo servo, qui, in Bestìa. Era<br />
costui un semplicione, senza spirito. Solo un buon pastore.<br />
Thiu Jonbattìsta se ne stava a Baccattìna con il<br />
gregge da latte (cun su madrigàdu) dove aveva anche un<br />
allevamento di cavalli (unu asòne de caddhos). Una volta<br />
la settimana si recava a Bestìa per portare le provviste<br />
e il vino al servo e per perlustrare il suo pascolo. Un<br />
51
giorno, mentre lui era in visita al servo e tastava il bestiame<br />
sulla schiena per vedere se erano grassi o meno,<br />
come si fa, si vide piombare uno di questi grassatori a<br />
cavallo con in groppa il proprio servo. Erano di Mores<br />
anche costoro. Era uno dei Magàri. Uno di quelli che<br />
andavano per gli ovili e dicevano: “Tu mi devi dare una<br />
vitella.”<br />
– “Mi devi dare un castrato, se no ti uccido tutto il bestiame.”<br />
– “Tu mi devi dare questo, tu mi devi dare quello”<br />
Eh! Allora era così, era.<br />
– “O Jonbattì!” fece il grassatore. “Mi dovresti dare<br />
il castrato. Debbo fare un bel pranzo. A casa domani<br />
vengono persone di riguardo... Sai com’è!”<br />
– “Il castrato serve a me! Prenditi quell’agnellone<br />
(cuddhu saccàju),” fece thiu Jonbattìsta per non inimicarsi<br />
simile gentaglia.<br />
– Il grassatore allora confidò al proprio servo la sua<br />
vendetta. “Domani mattina all’alba veniamo qui, gli<br />
uccidiamo il servo e ci prendiamo castrato e agnelloni.<br />
Tanto lui se ne torna a Baccattìna.”<br />
– Thiu Jonbattìsta che si stava compiacendo dei suoi<br />
agnelloni si era un po’ allontanato, non poté sentire<br />
nulla. Ma il servo di thiu Jonbattìsta sentì la sentenza.<br />
– “Allora Jonbattì, ritorneremo un altro giorno per<br />
l’agnellone. Ora vado in cerca di un castrato.”<br />
– “Va bene! Va bene.”<br />
– Il servo di thiu Jonbattìsta si mise subito a piangere<br />
preoccupato per la sua vita.<br />
– “Perché stai piangendo?” fece thiu Jonbattìsta.<br />
“Parla.”<br />
52<br />
– Il servo aveva paura di parlare e continuò a piangere<br />
tremante e pieno di paura.<br />
– “Parla ti ho detto,” insisté il suo <strong>padrone</strong>.<br />
– Non c’era verso! Thiu Jonbattìsta allora si cacciò il<br />
suo pugnale e glielo pressò sul ventre.<br />
– “Parla, se no ti uccido subito. Parla e basta! Cosa<br />
vuol dire il tuo silenzio?”<br />
– “Ma non lo avete sentito?”<br />
– “No.”<br />
– “Domani mattina all’alba uccidono me e si prendono<br />
il castrato e il resto.”<br />
– “Ah! Così eh?...”<br />
– “Vai di corsa a Sìligo e di’ a mia moglie che ti dia<br />
quella polvere. Ci sta facendo danno la volpe.”<br />
– Il servo per avere salva la vita la strada verso Sìligo<br />
se la inghiottì dalla paura e subito fu di ritorno.<br />
– “Tu te ne vai a Baccattìna. Stanotte ci sto io qui,” fece<br />
thiu Jonbattìsta.<br />
– Era uomo che aveva fegato: si proteggevano a vicenda<br />
con thiu Giommarìa, come era costume.<br />
– La mattina prima dell’alba, ecco il Magàri con il<br />
servo. Visto che non c’era nessuno (thiu Jonbattìsta si<br />
era nascosto a tiro utile) il grassatore ordinò al suo servo<br />
di prendere il castrato.<br />
– Thiu Jonbattìsta anziché far fuoco sul servo, sparò il<br />
Magàri che aspettava e osservava ancora sul suo cavallo<br />
e cadde a terra morto. Il cavallo si dette alla fuga. Il servo<br />
del grassatore si avventò allora su thiu Jonbattìsta,<br />
che si mise a correre: era già avanzato negli anni e aveva<br />
forse paura di uno scontro fisico con il servo morese,<br />
che era giovane e robusto. Ma pratico del posto rag-<br />
53
giunse la palude. C’era l’acqua alta e ci si mise dentro<br />
cercando di dileguarsi. Il servo morese ostinato lo inseguiva.<br />
Thiu Jonbattìsta, scaltro, si mise a gridare con<br />
quanto aveva in canna: “O Giommarìa Ledda! Vieni a<br />
salvarmi! Vieni a salvarmi! Aiutoòòò!”<br />
– Il morese non appena sentì il nome di Giommarìa<br />
Ledda, voltò le spalle e cercò di svignarsela. Thiu Jonbattìsta<br />
ne approfittò. Uscì come un lampo dalla palude<br />
caricò il fucile (era un fucile a avancarica, a un solo<br />
colpo), sparò il morese e gli spaccò l’osso della spalla.<br />
– Come vedi Thiu Giommarìa era temuto. Certo non<br />
meritava di fare la fine che ha fatto.<br />
– Perché? Che fine ha fatto?<br />
– Degli amici lo invitarono a un ovile per la tosatura<br />
delle pecore. È un invito che non si rifiuta mai. E lui ci<br />
volle andare. In famiglia non volevano. Avevano sentito<br />
qualcosa... qualche sospetto...<br />
– Lui però non temeva nemmeno il demonio. Il suo<br />
servo fidato insieme alla cognata cercò di dissuaderlo<br />
per tutta la notte a Paulubeddhàri. Due ore prima dell’alba<br />
cercò di mettersi in viaggio alla volta di Coròna<br />
Majòre.<br />
– “Non andateci,” dicevano le donne, avvinghiate al<br />
suo gabbano nero.<br />
– “Non andateci, vi uccidono. Non andateci, vi uccidono.”<br />
– Lui però era ostinato. Le donne gli tennero dietro<br />
per oltre un chilometro fino a Riu Ruzzu. Poi si allontanò<br />
e non tornò più.<br />
– Arrivato a Coròna Majòre un certo Francesco Rassu<br />
di Thiesi, sicario di thiu Antóni Luìsi di Banari, riuscì a<br />
54<br />
introdursi nella compagnia. E siccome i soldi hanno<br />
sempre accecato molta gente, invitarono thiu Giommarìa<br />
a confettare gli agnelli per il pranzo. Alla fine lo pregarono<br />
di mantenere la testa di un agnello su un ceppo.<br />
Francesco Rassu che teneva la scure, anziché colpire la<br />
testa dell’agnello, colpì la testa di thiu Giommarìa, che<br />
cadde cadavere. Per Sìligo fu un dolore grande. Thiu<br />
Giommarìa era stato sempre una spina per i signorotti<br />
dei paesi vicini. Difendeva i deboli e soffocava le brame<br />
dei ricchi.<br />
– Ma i carabinieri non li arrestavano quelli che uccidevano<br />
la gente? Ora se succedesse una cosa del genere<br />
li arresterebbero! Ma come? Tutti questi cadaveri? La<br />
Giustizia dov’era?<br />
– Te l’ho già detto l’altra volta. La Giustizia allora dormiva.<br />
Certo, c’era, ma era come se non ci fosse. I ricchi<br />
e perfino gli stessi grassatori la corrompevano con l’oro<br />
e col denaro. L’unica Giustizia che c’era allora erano le<br />
compagnie barracellari che, insieme a uomini come thiu<br />
Giommarìa, e spesso anche banditi divenuti banditi<br />
per casi particolari, proteggevano, dietro compenso, il<br />
bestiame dei vari comuni.<br />
– Che cosa erano queste compagnie barr...<br />
– Era un’istituzione autorizzata dallo stesso governo<br />
su richiesta del popolo. Era formata dai barracelli, specie<br />
di guardiani che hanno l’obbligo di custodire il bestiame<br />
del comune cui appartengono. Se viene rubato<br />
lo pagan loro al proprietario. Eh, ne avrai visti aggirarsi<br />
qua e là.<br />
– Non mi è capitato mai.<br />
– Prima o poi ti capiterà.<br />
55
– E i soldi a loro chi glieli dà?<br />
– Ogni proprietario dà loro un tanto. Poi sta a loro<br />
sorvegliare.<br />
Questi racconti mi esaltavano e stuzzicavano la mia<br />
fantasia. Spesso riuscivo a vedere thiu Giommarìa nelle<br />
sue gesta con i suoi nemici. Don Peppe... Thiu Jonbattìsta.<br />
Erano degli eroi per me ormai: io che non sapevo<br />
leggere dovevo imprimermi nella mente le gesta di quei<br />
personaggi giganteschi che osavano tutto perché tutto<br />
erano in grado di affrontare. Erano gli uomini e la legge<br />
stessa degli uomini.<br />
Mio padre a Sìligo non si tratteneva molto. Come i<br />
pastori autentici, non si crogiolava con la moglie più di<br />
tanto. E sbrigate le sue faccenduole, nel giro di quattro<br />
ore era sempre di ritorno. Aveva paura che i banditi ci<br />
rubassero il gregge, nonostante ci fossimo io e il cane.<br />
Molti pastori che nel paese ogni giorno si godevano<br />
la propria moglie, al loro ritorno trovavano amare sorprese.<br />
Le pecore non c’erano più e le riserve dei loro<br />
pascoli spesso devastate dai greggi del vicinato.<br />
Una volta i banditelli ci tentarono con me. E siccome<br />
pastorelli come me ce n’erano dappertutto, essi si comportavano<br />
più o meno nello stesso modo per raggirare i<br />
ragazzini che durante l’assenza dei padri custodivano<br />
le pecore. Si trattava di distrarre il bambino in qualche<br />
modo.<br />
Uno di loro, in genere, piombava nella capanna o dove<br />
si trova il bambino, mentre gli altri fugavano il bestiame.<br />
56<br />
Così un giorno sullo spiazzo antistante la capanna, si<br />
presentò un giovanotto. All’abbaiare di Rusigabèdra,<br />
mi proiettai fuori dalla capanna. Il giovanotto aveva<br />
tutta l’aria di essere uno dei tanti cacciatori che di tanto<br />
in tanto scorrazzavano per la macchia.<br />
– Hai visto lepri da queste parti? È tutta la mattina, –<br />
continuò con tono arrabbiato e senza darmi il tempo<br />
della risposta, – che oggi vado in giro e non riesco a scovarne<br />
una... Ci devono essere passati altri cacciatori, da<br />
poco... Ne hai visto ieri o stamattina?<br />
– No. Lepri ne vedo sempre saltar fuori dai cespugli.<br />
Anzi l’altro giorno per poco non ne calpestavo una.<br />
Spesso mi escono quasi di sotto i piedi... Solo che il mio<br />
cane corre di meno e non ne prende mai. Sono troppo<br />
veloci. E poi quelle si dirigono sempre in alto verso la<br />
collina... Hanno le gambe di dietro più lunghe e in salita<br />
corrono più che in pianura. Non le batte nessuno...<br />
Solo lo sparviero riesce a prenderle se non trovano<br />
scampo nella macchia o nei loro covi (in sos majònes o<br />
in sas quilèttas).<br />
– E tu ne hai visto, di sparvieri prendere le lepri? –<br />
continuò lui cogliendo la palla al balzo per continuare a<br />
distrarmi.<br />
– Sì. Una volta per il campo, con mio padre ne abbiamo<br />
trovato uno, intento a divorarsela. Al nostro arrivo<br />
casuale lo sparviero cercò scampo con la lepre appena<br />
agguantata. Spiccò il volo, ma la lepre era grossa e pesante.<br />
Gli cadde dal rostro e dagli artigli e per mettersi<br />
in salvo se ne dovette volar via, a bocca asciutta. La lepre<br />
la prendemmo noi. Era ancora calda... Fu molto<br />
buona e saporita...<br />
57
La cosa era bell’e riuscita, al giovanotto. Rusigabèdra<br />
però, che era legato ad un alberello sullo spiazzo,<br />
continuava ad abbaiare incessantemente in direzione<br />
del gregge. Sull’istante, io credetti che volesse essere<br />
soltanto slegato. E così lo sguinzagliai e lo misi in libertà.<br />
Ma nell’ovile chi aveva veramente capito quanto<br />
stava accadendo era proprio il cane che, una volta<br />
sguinzagliato, si proiettò velocemente verso il gregge.<br />
Come una palla di fucile, ululando a testa china tra i<br />
cespugli, con i peli irti sulla schiena. Con furiosi latrati<br />
si avventò contro altri due giovanotti che avevano già<br />
raggiunto le nostre pecore e riuscì a scacciarli via.<br />
– Ma guarda questa gente! Ti volevano fregare qualche<br />
capo (calchi fiàdu), – fece il giovane cacciatore. E<br />
scomparve fingendo di riprendere la sua caccia.<br />
Le pecore non erano molto distanti dalla capanna:<br />
erano sotto i miei occhi. E così ho potuto vedere questi<br />
banditelli che una volta smascherati dal cane non osarono<br />
più far preda nel “mio” gregge e scomparvero anche<br />
loro dietro le querce. Certo per procurarsi una pecora<br />
da un’altra parte presso qualche ovile dove c’era<br />
un altro pastorello come me, che, forse, non aveva la<br />
fortuna di avere un cane come Rusigabèdra.<br />
Di solito banditelli di tal fatta erano servi pastori mal<br />
nutriti, a pane e acqua e raramente formaggio, brodaglie<br />
varie e latte, che in assenza del loro <strong>padrone</strong> si industriavano<br />
a procacciarsi una pecora tra i pastori del<br />
vicinato, a rotazione, per alternare il loro cibo abituale<br />
con una bella scorpacciata di carne arrosto. Il tutto dovevano<br />
fare con molta cautela. Questi servi pastori (custos<br />
teràccos pastòres), non potevano permettersi di es-<br />
58<br />
sere scoperti. La cosa avrebbe messo in cattiva luce l’onore<br />
del <strong>padrone</strong> di fronte alla gente, e avrebbe suonato<br />
come una inconfutabile testimonianza del fatto che<br />
li nutriva male. Spesso era proprio la condotta irreprensibile<br />
dei servi, a garantire al <strong>padrone</strong> il proprio<br />
prestigio sociale, che poi lui sfruttava come “copertura”<br />
quando compiva qualche grassazione. Inoltre i servi<br />
che venivano “scoperti” venivano “licenziati” e messi<br />
al bando dal loro <strong>padrone</strong>.<br />
L’episodio mi scosse. E in cerca di compagnia, una<br />
volta che il giovane “cacciatore” si dileguò anche lui<br />
dietro i cespugli, chiamai il cane che accorse veloce leccandomi<br />
le mani. Mi saltò addosso. E rizzatosi sulle<br />
gambe posteriori, mi avvinghiò e mi abbracciò con<br />
quelle anteriori. Mi leccò la faccia e le orecchie in segno<br />
di contentezza. Non riuscii però a reggere il suo peso e<br />
le sue impennate, sicché mi rovesciò a terra sull’erba.<br />
Andammo insieme quindi a fare un giro per il campo.<br />
Rusigabèdra ustava per i sentieri e i cespugli bagnati. Io<br />
lo seguivo. Di tanto in tanto gettavo un urlo nel silenzio<br />
interminabile e pauroso del bosco. Le mie urla e il fischio<br />
che modulavo, incitavano il cane a scovare le volpi<br />
dalle grotte, dalle forre e dalle macchie. Poi di quel<br />
silenzio, allora, avevo paura e il fatto che lo rompessi io<br />
stesso, anche se lo rompevo con un urlo in parte prodotto<br />
dalla paura, mi metteva coraggio. Così accadeva<br />
che la stessa paura che avevo di quel silenzio generava<br />
tramite le urla una costante di coraggio con cui riuscivo<br />
a vincere il terrore che quel silenzio mi incuteva con la<br />
sua interminabile monotonia.<br />
Ora ho appreso, per averlo vissuto, che un simile<br />
59
comportamento è proprio anche degli animali quando<br />
si smarriscono dietro il <strong>padrone</strong> per le fratte. Così per<br />
esempio, si comportava un mio cucciolo quando si<br />
smarriva per qualche vallata, dietro le mie spalle a causa<br />
della vegetazione.<br />
Senza che lui mi potesse vedere, allora, se io lo richiamavo,<br />
avanzava, sommerso dall’erba e dagli sterpi in<br />
direzione della mia voce ululando per farsi coraggio,<br />
proprio come facevo io con Rusigabèdra.<br />
Ad un tratto quel silenzio fosco e impenetrabile si dileguò<br />
come per incanto. In lontananza si avvertì il potente<br />
raglio primaverile (su órriu eranìle) del nostro somaro.<br />
Rusigabèdra mi lasciò all’improvviso per farsi fedelmente<br />
incontro al <strong>padrone</strong> che ritornava con le provviste. Mi<br />
diressi verso la capanna in attesa che mio padre spuntasse<br />
all’orizzonte dei cespugli sotto gli alberi, scrollando<br />
come al solito le gambe sulle spalle del somaro.<br />
Rusigabèdra gli faceva strada e mi raggiunse sullo<br />
spiazzo leccandomi le mani quasi anch’io dovessi condividere<br />
con lui una comune contentezza che non poteva<br />
esprimersi altrimenti, ma che tradiva un evidente<br />
compiacimento per il ritorno di mio padre e per i cibi<br />
che ci portava nella solita bisaccia. I suoi salti giocosi e<br />
le sue energiche leccate mi dicevano che dovevamo<br />
partecipare insieme alla gioia per l’arrivo del babbo,<br />
del <strong>padrone</strong>, del pane.<br />
– Come è andata oggi? È successo nulla? – Mi fece<br />
come al solito, seduto ancora sul basto non appena<br />
giunse sullo spiazzo a distanza di voce.<br />
Gli raccontai l’accaduto e tutto preoccupato mi ricordò<br />
che le sue lezioni erano sempre utili.<br />
60<br />
– Hai visto quanto è importante seguire quello che ti<br />
dico io? Devi stare sempre attento alle mosse del cane,<br />
che si accorge di tutto. Sente più di noi e ha il fiuto (lèada<br />
su seru) che gli permette di accorgersi anche di quello<br />
che non vede.<br />
– Thiu Juànne mi ha detto che i barracelli custodiscono<br />
il bestiame di tutti, come mai i banditi si fidano così<br />
apertamente?<br />
– Prima di tutto i barracelli non ce li hanno tutti i comuni.<br />
Sìligo ora non li ha. Dipende dalla amministrazione<br />
comunale. In secondo luogo i banditi non hanno<br />
paura dei barracelli. Terzo, quelli saranno stati dei servi<br />
del nostro vicinato in cerca di qualche pecora per cuocersela.<br />
I loro padroni li lasciano morire di fame. Tu in<br />
tutti i casi devi stare sempre attento. Devi sempre ululare,<br />
sempre gridare in modo che tutti sentano che il<br />
nostro ovile è animato.<br />
– Poco fa è passato zio Salvatore. Mi ha detto che stanotte<br />
al servo gli hanno rubato il gregge minuto. Lo<br />
hanno legato a fil di ferro e lo hanno trovato stamattina<br />
a sole alto ancora pieno di brina e tutto intirizzito in un<br />
angolo dell’ovile.<br />
– L’ho già sentito. Bisogna stare molto attenti, bisogna<br />
stare!<br />
La sera quando il babbo ritornava dal paese, mi sentivo<br />
più tranquillo, anche se mi toccava seguire i capricci<br />
del gregge per la tanca, per dove cresceva l’erba migliore<br />
e verso gli alberi che portavano le ghiande più dolci.<br />
Lui lavorava all’oliveto bonificando il terreno, rivoltando<br />
zolle ed estirpando la gramigna ed il cisto (su ràmine<br />
e su mudéju).<br />
61
Spesso anche senza vederlo né notarlo, da lontano,<br />
sentivo il ritmo scatenato del suo lavoro dal continuo<br />
rumore della zappa che lui affossava sulla terra dura e<br />
soprattutto dal tipico frastuono che spesso gli zappatori<br />
producono quando con la loro zappa inavvertitamente<br />
cozzano su una pietra nascosta oppure quando<br />
per pulirla ne sbattono il rovescio contro il primo masso<br />
che capita.<br />
Si era già in febbraio e l’inverno imperversava con<br />
neve e gelo. Thiu Juànne non veniva più con frequenza<br />
come aveva fatto in dicembre e in gennaio. Era malato.<br />
Soffriva di reumatismi. E io dovevo cercare compagnia<br />
con le sbuffate del vento. La capanna di notte, esposta<br />
a tutti i venti, che la filtravano attraverso i pertugi dei<br />
muri rudimentali a secco, quasi in stile nuragico, era divenuta<br />
la mia dimora.<br />
Purtroppo la mia amica capanna non poteva ripararmi<br />
del tutto dal vento gelido e per tutta la notte le raffiche<br />
del vento ululavano tanto che minacciavano di<br />
portarsi via il suo tetto di stoppie. Il freddo spesso mi<br />
svegliava nonostante il ceppo vi rimanesse acceso ininterrottamente<br />
facendo danzare con la sua tremula<br />
fiamma gli arnesi che di giorno ci facevano compagnia<br />
nel lavoro.<br />
I primi freddi di quel terribile febbraio mi regalarono<br />
un tremendo raffreddore che mi accese di febbre. Per<br />
qualche giorno, acceso dal male, mio padre mi lasciò<br />
disteso sulla stuoia al coperto, a pancia a fuoco, in attesa<br />
di segni di miglioramento sotto le sue cure con cui mi<br />
62<br />
aveva guarito l’autunno precedente. Anche in tale circostanza<br />
mi somministrò i rimedi che conosceva: latte<br />
caldo zuccherato, un po’ di chinino. Ma solo il mattone<br />
ardente, avvolto di carta e di stracci che mi cambiava<br />
ogni ora da mettere sul petto dolorante, avrebbe dovuto,<br />
secondo lui, essere la medicina migliore. La mamma<br />
in paese si preoccupava, ma lui era sicuro di guarirmi<br />
nella capanna, così come c’era riuscito in autunno. A<br />
Sìligo una vecchia, thia Fiorentìna, come aveva fatto altre<br />
volte, mi fece gli scongiuri contro il malocchio e il<br />
babbo mi portò degli amuleti (sas pungas) da tenere attaccati<br />
al vestito. Purtroppo né la pietra filosofale del<br />
babbo né gli amuleti riuscirono a guarire i miei bronchi<br />
infiammati. Solo con il respiro emettevano i rauchi<br />
suoni del catarro più acuto. Il mattone mi faceva sudare,<br />
ma non sfebbrare. La fronte scottava sempre e i polsi<br />
pulsavano come percorsi da un fiume in gran tempesta.<br />
In capo ad una settimana, il babbo, quando vide<br />
che le cure non davano alcun segno di miglioramento,<br />
decise di portarmi a Sìligo.<br />
Una sera, munte le pecore, sull’imbrunire (ass’interighinàda),<br />
tutto avvolto di giacche logore e di cenci con<br />
cui avevo trascorso tante fredde giornate, mi mise sul<br />
basto e via in paese.<br />
Faceva molta attenzione a non farsi notare dal vicinato.<br />
Guidava attentamente la bestia perché, come al solito,<br />
per disfarsi del carico, non sfregasse contro i cespugli<br />
o i muri del sentiero (in sos muros de s’ottorìnu).<br />
Bisognava eludere le orecchie dei cani vicini. Era preoccupato<br />
per il gregge, che aveva affidato alla sola custodia<br />
di Rusigabèdra. Ed era meglio passare inosservati.<br />
63
Il vento tirava gelido, mentre io bollivo dalla febbre<br />
dentro gli stracci che il babbo mi rimboccava perché<br />
non rimanessi scoperto. Sudavo e deliravo e bisognava<br />
tenermi perché non cadessi dal basto mentre la bestia<br />
s’industriava a valicare i punti più scoscesi del sentiero.<br />
Le orecchie mi rimbombavano e alle tempie sentivo<br />
l’afflusso del sangue al cervello dove ad ogni battito del<br />
cuore avveniva un’esplosione che mi stordiva continuamente.<br />
Il somaro andava forte incitato dalle gambe<br />
di mio padre che seduto in groppa gliele scrollava dalla<br />
pancia alle cosce.<br />
La notte ormai era già piombata. Sìligo si stava avvicinando.<br />
Le sue fosche e rade lampadine ce lo annunciarono<br />
nel suo silenzio.<br />
Giunti a casa, legò la bestia all’anello. Mi scese dal basto<br />
e mi spinse dentro. Ero esausto. E ricordo solamente<br />
che mi accasciai sul pavimento non appena entrai.<br />
Agitai le gambe e il sonno mi calò con la fronte sul dorso<br />
delle mani, che avevo istintivamente poggiato per terra.<br />
Subito mi ritrovai a letto. In camera entrò il dottore.<br />
Mi levò le coperte e mi aiutò a sollevarmi sul letto. Mi fece<br />
dire trentatre un paio di volte. Mi appoggiò l’orecchio<br />
alle spalle. Auscultò e si allontanò dal letto. Mentre<br />
mi sdraiavo di nuovo notai che sgranò gli occhi e sporgendo<br />
il suo labbro inferiore espresse tutta la sua meraviglia<br />
e la preoccupazione ai miei.<br />
– Questa è una gravissima polmonite doppia, – disse.<br />
– Solo un miracolo potrà salvarlo. Speriamo che ce la<br />
faccia, – continuò allontanandosi per non farsi sentire<br />
da me.<br />
– Ha oltre 41 di febbre. È preoccupante. Tentiamo. –<br />
64<br />
Il dottore aprì la sua borsa. Mi fece una grossa iniezione<br />
alla natica. E mi disse di dormire.<br />
La febbre durò per qualche giorno. Ai polmoni sentivo<br />
dolori atroci e lancinanti come se si stessero dilatando.<br />
Nella disperazione tentavo di chiamare qualcuno.<br />
Ma non ce la facevo. Finivo sempre per sfogarmi nel<br />
pianto solitario della stanza, contorcendomi tra le coperte.<br />
Mia sorella Vittoria un giorno mi sentì gridare e<br />
si avvicinò al letto.<br />
– Hai la broncopolmonite doppia! L’ha detto il dottore.<br />
– Ma... io non guarirò?<br />
– La broncopolmonite non guarisce.<br />
– Ma allora si muore?<br />
– Sì.<br />
– Io, non voglio morireeeee! Non voglio morire! Io<br />
non ho fatto nullaaa... Se muoio, mi portano al cimitero!<br />
Io non ci vado! Ho paura!... Ma io non mi addormento!<br />
Così la morte non potrà portarmi via.<br />
Tre giorni dopo, il dottore come al solito mi rivisitò e<br />
mi misurò la febbre. Lesse il termometro come faceva<br />
tutte le mattine. Si alzò di scatto dalla sedia e mi riauscultò<br />
smaniosamente le spalle.<br />
– Di’ trentatre.<br />
– Trentatre... trentatre... trentatre.<br />
– Ce l’abbiamo fatta. Non c’ha più la febbre! I polmoni<br />
rispondono bene. È tutto cicatrizzato. Che portento!<br />
Non sarei più morto, allora. Potevo dormire.<br />
La convalescenza a Sìligo durò oltre un mese. Fu<br />
65
l’occasione per riallacciare le amicizie perdute e farne<br />
delle nuove. Mi accodavo alle combriccole come avevo<br />
fatto durante la mia infanzia, ma i giochi con i compagni<br />
non mi dicevano più nulla. Essi avevano un’altra<br />
fantasia. Io ero già diverso da loro. Un solo anno di<br />
campagna mi aveva maturato di almeno dieci anni rispetto<br />
a loro. Alla scuola del babbo si imparavano cose<br />
ben più profonde di quelle aste e di quelle consonanti<br />
che loro ora sapevano a memoria. I loro giochi non me<br />
li ricordavo più e non mi attiravano. Solo il silenzio della<br />
campagna e scoprire la natura mi incuriosiva. Volevo<br />
ritornarvi al più presto.<br />
Ero stato fortunato. Avevo superato quel febbrone e il<br />
primo anno di svezzamento che molti pastorelli non riuscivano<br />
a finire. Molti miei coetanei morivano come<br />
agnelli invernali (comènte anzònes berrìles) nati in gelida<br />
notte che i loro padri non riuscivano a imboccare tempestivamente<br />
mentre sbucavano dall’utero della madre. Il<br />
primo anno di campagna era veramente il banco di prova.<br />
Chi lo superava poteva poi sperare di non morire giovane.<br />
Questa volta il mio ritorno, quasi desiderato, coincideva<br />
con la volontà di mio padre. Confesso che non<br />
vedevo l’ora di ritornare in campagna. Ormai mi ero<br />
affezionato a tutto ciò che vi avevo lasciato e mi ero<br />
abituato a sentire e a capire quel silenzio che un anno<br />
prima mi faceva paura. Sulla terra ormai non esisteva<br />
più nulla di tanto apprezzabile e amabile quanto il nostro<br />
campo con i suoi alberi e le sue scoscesità; Rusigabèdra<br />
e le pecore. La natura tutta del nostro campo era<br />
qualcosa di cui ormai io facevo parte. Ero rinato con<br />
66<br />
essa. Ero entrato e ricresciuto nel mondo animale, minerale<br />
e vegetale e non potevo più sentirmene fuori. La<br />
solitudine del bosco e il silenzio profondo dell’ambiente,<br />
interrotto solo dal vento, dai tuoni o dallo<br />
scoppio del temporale in lontananza d’inverno, orchestrato<br />
dal canto degli uccelli e dal crogiolarsi della natura<br />
in primavera, ora per me non era più silenzio. A<br />
furia di ascoltarlo avevo imparato a capirlo e mi era divenuto<br />
un linguaggio segreto per cui tutto mi sembrava<br />
animato, parlante e in movimento. E almeno al livello<br />
affettivo della mia fantasia potevo comprenderlo<br />
e parlarci. Quasi conoscessi tutti i dialetti della natura<br />
e li parlassi correttamente al punto da impostare con<br />
essa, nel mio silenzio raccolto, le uniche conversazioni<br />
che mi erano possibili.<br />
Il discorso sulla matematica naturale di mio padre,<br />
ormai, era divenuto una cosa normale e spontanea. Non<br />
solo avevo imparato a conoscere i nomi dei punti e dei<br />
particolari del campo come avevano fatto gli anziani.<br />
Ero andato oltre. Sulla loro scia, senza che me ne accorgessi,<br />
anch’io denominavo la natura.<br />
A ogni albero, a ogni macigno, a ogni pecora, a ogni<br />
punto o conformazione del terreno del “nostro” campo<br />
o dei monti circostanti e dell’orizzonte, avevo appioppato<br />
un nomignolo affettivo che tenevo segretamente<br />
nascosto in quel silenzio con cui, in un certo modo,<br />
ogni cosa mi parlava e per me era viva.<br />
La mia fantasia trasferiva nomi e figure, vissute durante<br />
la breve infanzia sociale di Sìligo, nelle cose o nella<br />
realtà fisica del nostro campo o dell’orizzonte che osservavo<br />
vivendolo dalla capanna o dal bosco.<br />
67
Tutta la realtà, dagli alberi ai picchi delle montagne,<br />
dalle rocce alle grotte, dalle pecore alle bestie, la rassomigliavo<br />
a persone o cose che io, occasionalmente, avevo<br />
visto altrove. A causa della solitudine, la natura per<br />
me rappresentava un “tu” indefinito: l’unico “tu” amico<br />
con cui poter comunicare senza vergogna né soggezione.<br />
Ogni particolare della realtà circostante mi evocava<br />
un nome che la animava e me la rendeva parlante.<br />
Thiu Pulinàri (un vecchio pastore del vicinato che vedevo<br />
occasionalmente mentre si abbeverava le pecore)<br />
era una roccia lontana che spiccava all’orizzonte su un<br />
monte. Su Gobbe (un povero gobbo che avevo conosciuto<br />
nella mia infanzia di Sìligo e che era divenuto tale<br />
sin da bambino a causa di una incornata di un montone)<br />
ora per me era un albero gobbo del nostro campo.<br />
Questa lingua intima tra me e la natura che, in fondo,<br />
era la lingua del silenzio, mi era divenuta naturale e<br />
familiare quasi la realtà fosse il silenzio e le cose fossero<br />
le sue parole. I nomignoli ed il “taglio” della realtà che<br />
io creavo o facevo all’unisono con quel silenzio, li usavo<br />
anche quando parlavo con mio padre. Gli denominavo<br />
le nostre bestie e le cose come esse parlavano a me<br />
nel loro silenzio.<br />
Così mio padre nei nostri discorsi si immedesimava<br />
nella mia fantasia creatrice senza difficoltà. Non aveva<br />
ancora dimenticato quella della sua infanzia solitaria<br />
vissuta negli stessi luoghi e nelle stesse condizioni. Anche<br />
lui forse aveva denominato persone e cose a furia di<br />
guardarle, ascoltandone il silenzio. La facilità con cui<br />
recepiva i nomignoli che io ingenuamente davo alle cose<br />
ed il modo con cui poi anche lui li usava con me, era-<br />
68<br />
no il segno di come aveva trascorso una infanzia simile<br />
alla mia e che ancora si trascinava nel suo intimo, nella<br />
sua mentalità di pastore temprato.<br />
Spesso facevo dei soliloqui. E a furia di star solo e di<br />
parlare con il mio intimo o con la natura tramite il silenzio,<br />
la parola per me stava perdendo importanza. La<br />
lingua e la gola (sa limba e sa ula), il fiato e le corde vocali,<br />
le usavo solo per emettere gridi ed urla contro le<br />
volpi. Così se all’improvviso mi capitava di dovermi<br />
esprimere nella “lingua sociale” con mio padre e peggio<br />
ancora con altri, mi trovavo impacciato. Non parlavo<br />
quasi mai. E anche se nelle vicinanze c’erano altre<br />
capanne ed altri ovili con i rispettivi pastorelli, non ci<br />
potevo andare. Mio padre me lo impediva. La tradizione<br />
lo proibiva. I padri non permettevano che i loro figli<br />
si incontrassero tra di loro. Avevano paura che si scambiassero<br />
i vizi e si distraessero lasciando il gregge incustodito.<br />
Se talvolta accadeva che noi pastorelli ci si incontrasse<br />
tramite sotterfugi o per caso e i genitori venivano a<br />
saperlo, erano botte furiose. Si aveva paura di incontrarci.<br />
E se casualmente l’uno doveva cadere sotto l’occhio<br />
dell’altro ci si metteva in fuga scappando lungo i<br />
muri di confine.<br />
La paura dell’incontro veniva alimentata anche dal<br />
fatto che quasi sempre tra i pastori del vicinato non<br />
correva buon sangue. Per un motivo o per un altro, si<br />
era sempre in briga. Di solito il motivo principale che<br />
ci inaspriva era il fatto che le pecore di uno sconfinavano<br />
o saltavano nel chiuso dell’altro (in su cunzàdu de<br />
s’àtteru). E per paura dei grandi, i piccoli dovevano<br />
69
ignorare gli ovili vicini o per lo meno ricordarli come<br />
focolai nemici.<br />
D’estate, però, qualcosa cambiava. Le squadre antizanzara<br />
battevano dappertutto le campagne per spruzzare<br />
con il DDT paludi, canali, case e ovili.<br />
Noi che non si faceva mai la transumanza estiva, stavamo<br />
sempre a Baddhevrùstana e così io potevo notare<br />
questi strani visitatori e le loro macchine e attrezzi vari<br />
con cui effettuavano la disinfestazione e si accertavano<br />
della presenza delle zanzare maligne sulle paludi.<br />
Ciò che cambiava l’ambiente d’estate, però, era altro.<br />
Il nostro campo come tutti gli altri, allora, si popolava<br />
e si riempiva di cavallette che allagando pascoli e seminati<br />
(pàsculos e laòres) irrompevano dappertutto come<br />
una fiumana inarrestabile. Nel primo periodo della<br />
mia vita campestre, non esistevano provvedimenti contro<br />
di esse. Nella mia beata ignoranza, questa loro invasione<br />
che per gli altri suonava fame e morìa, per me era<br />
quasi un trastullo e una compagnia. Per le strade e per i<br />
sentieri non si poteva passare né irrompere. Erano letteralmente<br />
gremite e ammantate dalle locuste: un vero<br />
strato di sabbia o di polvere ghiaiosa. Durante certe ore<br />
mi si presentava puntualmente uno spettacolo che mi<br />
attraeva. Il cielo cambiava colore. Da azzurro diveniva<br />
opaco affumicato. L’orizzonte si oscurava di una nebbia<br />
strana. L’atmosfera cambiava e nuvole di cavallette<br />
si addensavano a ciel sereno. Senza tuoni né lampi, subito,<br />
scoppiava il più terribile dei temporali. Le cavallette<br />
fioccavano dall’alto a miriadi, atterrando una sul-<br />
70<br />
l’altra nel vortice delle loro ali. Il sole si eclissava e per<br />
due tre ore non si intravvedeva più, come se sovrastasse<br />
il fumo di un violento incendio. Molti pastori legavano<br />
agli alberi o al grano gli amuleti per esorcizzarle, ma<br />
non c’era nulla da fare.<br />
Tra le pecore sotto la merìa all’ombra di una quercia<br />
allora io mi divertivo a seguire questa ondata devastatrice<br />
che calava in piena estate sotto il sole. Con lo<br />
sguardo fisso mi veniva spontaneo seguire fino al suo<br />
atterraggio una cavalletta così come d’inverno seguivo<br />
un fiocco di neve. E questa “nevicata estiva” me la gustavo<br />
come in inverno mi ero spesso gustato la neve,<br />
dalla finestra della casa di Sìligo, fissandomi con lo<br />
sguardo un punto del terreno o la tegola di un tetto vicino<br />
e aspettando, ansioso, che venisse sommersa da altri<br />
fiocchi giocati e mulinati dal vento.<br />
Così quei meriggi li trascorrevo guardando massi e<br />
cespugli mentre venivano “cavallettati” dal cielo e ne<br />
seguivo la lenta sommersione come quando venivano<br />
coperti dalla neve d’inverno. Le cavallette però fioccavano<br />
a grappoli (a budrònes), e molto più intense e più<br />
veloci di quanto non scendesse la neve. Ma come la neve<br />
dava un aspetto diverso alle vallate ed al terreno,<br />
confondendo tutto nel suo manto uniforme, così le cavallette<br />
riempivano solchi e fossati con la loro turbinosa<br />
ed inarrestabile grandine. La sola differenza che colpiva<br />
la mia fantasia era che il manto della neve rimaneva<br />
immobile e bianco nella sua lucentezza, mentre<br />
quello che si formava quando il cielo “cavallettava”,<br />
ondeggiava come la distesa di un campo di grano spigoso<br />
al soffiare del vento, a seconda del capriccio fre-<br />
71
netico di questi insetti voraci. Il terreno appariva mosso<br />
e danzante. Era come se fosse coperto da una neve<br />
animata che si muoveva e si spostava seguendo la sua<br />
danza affamata.<br />
Quando un campo veniva così “cavallettato”, il primo<br />
giorno appariva un suggestivo tappeto privo dei cespugli<br />
e dei sassi. Due o tre giorni dopo sassi ed arbusti<br />
spiccavano sopra quel manto divoratore, spogli e rosicchiati<br />
(isfozìdos e rozzigàdos). Resti di un terribile incendio<br />
e di un vorace bivacco. Dopo una settimana<br />
quel manto si sprofondava sempre di più, affossandosi<br />
sulla superficie creando delle piazzuole enormi, una<br />
confinante con l’altra. Il campo sembrava arato, pronto<br />
per la semina. Le radici del pascolo e del fieno scomparse.<br />
E si intravvedeva solo la terra polverosa e corrosa<br />
dalla devastazione, come un maggese erpicato. Alla<br />
fine anche i robusti tronchi dei rovi, dei sugheri (de sos<br />
chercos e de sos suèsos), i massi e i muri avevano cambiato<br />
aspetto. Così anche i macigni potevano cambiare i<br />
loro “vestiti” e farsi la “barba”. La loro antica lanugine<br />
veniva completamente rosicchiata. I sugheri che si stagliavano<br />
con i loro tronchi sanguigni (quasi a testimoniare<br />
la sofferenza e la povertà dell’ambiente) e gli alberi<br />
tutti sulla loro scorza riportavano le cicatrici di<br />
questa fame dilagante. Insomma questi insetti divoravano<br />
tutto: per essi non esisteva nulla di velenoso tra le<br />
erbe e le piante. Era una pulizia generale. La visita della<br />
fame doveva lasciare tutto ripulito.<br />
La furia era proporzionale al caldo. Solo al crepuscolo<br />
la loro devastazione veniva meno, anche se non cessava<br />
la loro fame. Il fresco e la brezza della sera impac-<br />
72<br />
ciavano le loro ali e le rattrappivano, togliendo loro la<br />
forza di mangiare. Così trascorrevano tutta la notte accavallate<br />
una sull’altra in silenzio e immobili fino alla<br />
tarda mattinata.<br />
All’alba, specie se durante la notte scendeva la rugiada,<br />
quella distesa mi appariva inanimata. E se per caso<br />
ne prendevo un pugno osservavo che le locuste potevano<br />
muovere a stento solo le gambe e la bocca.<br />
In queste ore i maiali di ogni ovile (e così cani, volpi<br />
e rapaci) uscivano a cavallettare (a tilibiscàre). La mattina<br />
presto in due ore si saziavano (s’azzibbaìana e si<br />
faghìana a boe) senza faticare né correre, quasi le locuste<br />
le bevessero dal terreno senza ricorrere alla caccia.<br />
Se però ai maiali veniva l’uzzolo durante le ore calde<br />
(il loro <strong>padrone</strong> non aveva molto mangime), uscivano<br />
lo stesso. Prenderne allora non era facile. Si affidavano<br />
all’istinto. Quelli più bravi e più abili nella corsa,<br />
riuscivano a catturarne ugualmente. Correvano all’impazzata.<br />
Senza sosta. Avanzavano senza una direzione<br />
precisa e senza meta con la bocca spalancata come<br />
una trappola in agguato. La corsa costringeva le cavallette<br />
a levarsi in volo capitando spesso tra le fauci affamate<br />
che quasi istintivamente si alternavano in un<br />
ritmo incessante. Si aprivano e si chiudevano ora per<br />
inghiottire le malcapitate, ora per rimettersi in agguato<br />
e cacciarne altre. Così i pastori per uno strano<br />
scherzo della situazione a onta della carestia in quegli<br />
anni, almeno nel periodo estivo, avevano grassi i maiali.<br />
Certo per le altre bestie era un problema. Le pecore<br />
a mala pena riuscivano a portare avvolto dalla loro<br />
pelle slanata lo scheletro del loro corpo per gli inter-<br />
73
stizi tra un’aiuola e l’altra che le cavallette quasi come<br />
limite di confine risparmiavano e dimenticavano di divorare.<br />
Spesso te le vedevi arrampicare e cadere per le<br />
colline dove di solito le locuste non si calavano. Comunque,<br />
spinti da una fame che lentamente li stava<br />
portando alla morte, spesso gli erbivori si trasformavano<br />
in insettivori. Una vera tragedia che li poneva come<br />
esseri altri da sé. Spesso mi capitava di vedere Pacifico<br />
farsi scorpacciate di cavallette che divorava insieme<br />
al poco fieno che la mattina trovava ammorbidito<br />
dalla rugiada. Più impressionante era vedere le<br />
pecore in quell’inesorabile lotta contro la morte. A testa<br />
bassa e chine la mattina non trovando altro sul loro<br />
campo mangiavano un pascolo animato: la neve<br />
estiva terribile e vorace. E mentre masticavano le locuste,<br />
sembrava esprimessero quasi una sfida contro<br />
la stessa natura, contro le locuste quasi a dire: “tu mi<br />
mangi il fieno e io mi mangio te.”<br />
La gente era disperata dalla fame e i rimedi rudimentali<br />
riuscivano inefficaci contro questo flagello. Gli ortolani<br />
circoscrivevano i loro orti con paglia o fieno misto<br />
a frasche che facevano bruciare lentamente. Il fumo<br />
era un rimedio abbastanza efficace. Ma dove c’era<br />
il bestiame, questo sistema non si poteva applicare.<br />
Non restava che intervenire fisicamente. La mattina i<br />
pastori approfittando della immobilità e della fiacchezza<br />
delle locuste, imitando i maiali, cavallettavano<br />
anch’essi.<br />
Provvisti di teloni, di sacchi logori e di scope di asfo-<br />
74<br />
delo o di erica (de ischeréu o de cantentàsu), assalivano i<br />
loro campi per debellare il nemico. Dispiegavano i teloni.<br />
Agitavano le scope ululando con contorsioni nervose<br />
dei corpi. Strisciavano i piedi per terra e con azioni<br />
di disturbo vi facevano capitare le cavallette con la<br />
loro marcia lenta e con il loro volo incerto ed inceppato.<br />
Quando il telone veniva sommerso dagli insetti, lo<br />
prendevano per le cocche e avvicinandole, buttavano<br />
tutto nei sacchi, che una volta legati e caricati sui loro<br />
somari, portavano nei rispettivi comuni, dove l’amministrazione<br />
comunale per incentivarne la caccia retribuiva<br />
questi “cacciatori” in ragione dei chili che vi portavano.<br />
Tristi aurore (tristes avvéschidas). Sempre il solito<br />
spettacolo. Maiali, cani e tanti altri animali, bisce,<br />
cornacchie e volpi (colòras, corróncias e groddhes) scorrazzavano<br />
in cerca di cavallette.<br />
La risposta dei pastori, però, era una nota dolente.<br />
Gareggiavano con le bisce e le cornacchie anch’essi<br />
nella caccia riempiendo e legando, tragicamente pieni<br />
di cavallette, quegli stessi sacchi che per tante annate<br />
avevano riempito di grano o d’avena. E tutti presi dalla<br />
caccia se li lasciavano ritti dietro le spalle quasi fossero i<br />
covoni del loro raccolto sui campi dove magari avrebbero<br />
potuto mietere il grano ormai “tosato”: mietuto e<br />
trebbiato dagli insetti. Le strade erano animate dall’andirivieni<br />
dei somari che in continuazione trasportavano<br />
i sacchi ai comuni. L’opera purtroppo riusciva inutile.<br />
L’assalto dei maiali, degli altri animali, imitato ad arte<br />
dai pastori si risolveva nel nulla. Come togliere un<br />
secchio d’acqua dal mare. Le cavallette si riproducevano<br />
in modo pauroso. La terra le pullulava dappertutto.<br />
75
Migliaia e migliaia di uova si schiudevano giorno per<br />
giorno sotto l’azione del sole. Tutta la terra sembrava<br />
un’immensa sorgente di locuste, turbinata dall’interno<br />
dallo schiudersi delle uova e bombardata e crivellata<br />
dall’esterno dalle cavallette che vi piombavano e vi<br />
grandinavano durante i lunghi meriggi. E come quando<br />
durante i lunghi temporali è costretta a pullulare<br />
d’acqua e di polle oltre che a subire gli scrosci continui<br />
del cielo, la terra similmente traboccava di locuste per<br />
ogni dove. Così i pastori senza saperlo venivano a trovarsi<br />
in un mare e non nella palude di cavallette che essi<br />
credevano di prosciugare con i secchi della loro costanza<br />
e della loro rabbia svuotandoli nello stesso mare.<br />
I pastori si preoccupavano sempre di più. Non si sapeva<br />
come fare. Si ricorse agli esorcismi. Le vecchie facevano<br />
per i singoli campi la formula contro il malocchio<br />
e molti amuleti, come per qualsiasi altra disgrazia<br />
capitasse, si disseminavano per i campi o si appendevano<br />
agli alberi. Le cavallette misero in crisi tutta quella<br />
superstizione antica: con o senza amuleti esse avanzavano<br />
travolgendo tutto e spesso arrivavano anche a<br />
mangiarsi gli amuleti appesi al grano o alle viti, quasi<br />
volessero dimostrare che erano <strong>padrone</strong> di tutto. In occasione<br />
delle feste patronali il parroco pregava incitando<br />
i fedeli a fare altrettanto.<br />
Alcuni tra i più ferventi portavano ripetutamente il<br />
loro parroco addirittura nei propri pascoli o nei propri<br />
seminati. Il parroco, sempre pronto a soddisfare i fedeli,<br />
non si faceva aspettare. Si avviava con il suo seguito<br />
(cun sa cufarìa) a fare le processioni per i boschi e per le<br />
pianure. La processione sostava presso un seminato o<br />
76<br />
un pascolo. Tutti si mettevano a pregare con gli occhi<br />
raccolti e le mani rivolte al cielo, mentre per terra le cavallette<br />
pascevano.<br />
Le ragazze e i chierichetti intonavano canti adeguati<br />
alla circostanza insieme alle mogli e alle sorelle del proprietario.<br />
Il parroco, anche lui assorto nel canto, con<br />
gesto abituale riconduceva tutti al silenzio. Pronunciava<br />
gli scongiuri in latino, accompagnandoli con spruzzate<br />
di acqua santa, prima che si sperdessero nel silenzio<br />
del campo. Alla fine i chierichetti avevano l’incarico<br />
di prendere per lui e per la parrocchia i doni del pastore<br />
o dell’agricoltore che aveva chiesto la benedizione. E<br />
via verso un altro campo.<br />
Si racconta che in un paese dei dintorni, alla festa di<br />
San Narcisio, dopo la processione per il paese, i credenti<br />
portarono per i campi vicini il santo. Ultimate le<br />
preghiere di rito e la dovuta benedizione, alla fine lo<br />
deposero con lo scopo di fugare le cavallette su una collina<br />
che dominava una ubertosa e fertile valle cerealicola.<br />
Il parroco, dopo aver benedetto la vallata, data una<br />
ennesima benedizione con abbondanti spruzzate di acqua<br />
santa, si mise alla testa del corteo per fare ritorno in<br />
paese. Il giorno era caldo. E nel primo pomeriggio, a<br />
onta di San Narcisio, le cavallette grandinarono sullo<br />
spiazzo e sul suo simulacro di legno. In capo a due giorni<br />
i fedeli andarono a riportarlo in chiesa e con grande<br />
stupore lo trovarono monco di un braccio e rosicchiato<br />
da per tutto.<br />
Finalmente vennero provvedimenti più efficaci e più<br />
organizzati. Le varie amministrazioni comunali ingaggiarono<br />
apposite squadre anticavallette che durante<br />
77
l’estate battevano ed animavano le campagne. Il loro<br />
intervento, però, anche se tempestivo, si rivelò inefficace<br />
sin dall’inizio. Era sempre un intervento localizzato<br />
come quello dei teloni dei pastori. Si trattava infatti di<br />
squadre fornite di lanciafiamme a benzina da usare sui<br />
punti dove le cavallette si ammassavano. Ma le uova<br />
che la terra conteneva e fecondava erano inesauribili e<br />
nonostante i campi fossero ridotti a piazzuole nere e<br />
sparse di roghi, continuamente, il giorno successivo<br />
erano sempre zeppi di nuove locuste più affamate,<br />
giunte in volo o sbucate dalla terra.<br />
La stessa cosa accadde più tardi con la “crusca avvelenata”<br />
che i pastori erano obbligati a spargere per il<br />
proprio campo, ma sempre in maniera localizzata. Succedeva<br />
che la benzina si esauriva, la crusca avvelenata<br />
finiva, ma le cavallette aumentavano sempre quasi per<br />
incanto. Calavano dal cielo o spuntavano dal suolo,<br />
dalle uova dell’anno precedente.<br />
Il loro ciclo vitale durava da maggio a luglio. Ma<br />
quanta strage. Negli ultimi giorni della loro vita covavano<br />
nel suolo, crivellandolo letteralmente con il loro<br />
culo acuminato per deporvi le uova. Io osservavo questa<br />
operazione con curiosità. La femmina si disponeva<br />
in un punto del terreno (duro e possibilmente solido).<br />
Lentamente con il culo appuntito cercava di far breccia<br />
sforzandosi sulle zampe. Una volta che il suo culo era<br />
indirizzato verso il suolo, quattro compagni le si affiancavano<br />
e la sorreggevano ritta dirigendola e spingendola<br />
verso il basso perché la coda penetrasse più profondamente<br />
possibile. Così sorretta, con il culo allungato<br />
dallo sforzo e per metà sprofondato nella terra, secer-<br />
78<br />
neva dei succhi e in breve fabbricava una specie di capsula<br />
impenetrabile all’acqua invernale e al freddo comune<br />
e vi deponeva le uova senza mai muoversi. Finita<br />
questa operazione, i compagni che avevano solo il compito<br />
di spingere e sorreggere la femmina mentre avveniva<br />
la deposizione delle uova, si allontanavano uno alla<br />
volta lasciando che la femmina completasse il proprio<br />
compito.<br />
Lungo i sentieri quando passavo con il gregge dietro<br />
il suo nembo di polvere, io potevo osservare l’ultima<br />
operazione delle cavallette prima che morissero. Ai lati<br />
del sentiero o dove si passava, questi gruppi a cinque si<br />
sperdevano a vista d’occhio. Qualcuno, anzi, lo segnalavo<br />
per rivedermelo a due o tre ore di distanza. Quando<br />
ci ripassavo potevo notare che il culo della femmina,<br />
ben sorretta dai compagni, era sprofondato sempre di<br />
più. Spesso il gruppo lo trovavo già disciolto. Qualche<br />
volta mi divertivo a scavare per estrarre la capsula delle<br />
uova, e spesso a schiacciare questi gruppi in azione finché<br />
non mi stancavo.<br />
Un’operazione più efficace venne però nel quarantasei<br />
tramite l’irrorazione periodica dei pascoli, a rotazione,<br />
con l’arsenico. I pascoli venivano completamente<br />
avvelenati più volte, a turno e per contrade, in tutto il<br />
territorio del comune (a cussòsas, in s’aidattòne), in modo<br />
da consentire ai pastori di sfamare il proprio gregge<br />
senza che corresse il rischio di morire avvelenato. I<br />
chiusi divenivano pascolabili dopo una leggera pioggia<br />
o dopo un determinato periodo. Il veleno era potente.<br />
79
Terribile. Nessuna cavalletta che si trovasse sul campo<br />
o vi sopraggiungesse in volo o vi sgusciasse dalle capsule<br />
poteva sopravvivere. Finalmente la campagna a poco<br />
a poco cambiò aspetto al punto da sembrare un campo<br />
nevicato da una grandine vulcanica e rossiccia. Da una<br />
“neve” di insetti morti e bruciati dal veleno, che non<br />
ondulava né giocava più il terreno nell’orgia della sua<br />
danza famelica.<br />
Con queste squadre feci alcune conoscenze. Era quasi<br />
tutta gente di Sìligo e spesso anche parenti. Solo che<br />
io non potevo godere della loro fugace e transitoria<br />
compagnia. Ormai l’annosa solitudine mi aveva contratto<br />
la soggezione verso gli altri. E solo da lontano e<br />
spesso dall’interno dei cespugli, ben nascosto per non<br />
essere notato, riuscivo ad osservare il loro comportamento,<br />
i loro scherzi e le loro azioni.<br />
Nonostante stessi quasi sempre lontano da loro e li<br />
osservassi quasi sempre da lontano, qualcosa riuscii a<br />
imparare. E quando ero da solo, cercavo di imitarli.<br />
Passata la stagione anticavallette, la mia vita ritornò ad<br />
essere quella di prima. Mi rinchiusi di nuovo nel silenzio.<br />
Quando passava qualche cacciatore facevo di tutto<br />
per scomparire. Se non me ne davano il tempo, mi infrattavo<br />
nella macchia o mi abbassavo dietro i macigni<br />
o i mucchi di pietra (a isségus de sos crastos o de sas moridìnas)<br />
o mi rintanavo dentro le cavità delle querce (intro<br />
de sas tuvas de sos chercos). Spesso correvo il rischio<br />
addirittura di essere scambiato per selvaggina da parte<br />
dei cani. Io, però, non potevo comportarmi altrimenti.<br />
Non ero in grado di parlare con nessuno. Mi vergogna-<br />
80<br />
vo e avevo soggezione della presenza altrui. Conoscevo<br />
solo le pecore, le cose del nostro campo e il suo silenzio<br />
che nella sua parola segreta non poteva gabbarmi né<br />
burlarsi di me, come spesso facevano i ricchi cacciatori<br />
che non sfuggivo in tempo e che conoscevano bene la<br />
mia condizione.<br />
Compiuti i sette anni, dopo quasi due anni di divagamento,<br />
nella mia vita avvenne una rivoluzione. Ero già<br />
in grado, una volta che mi ci si metteva, di tenermi sul<br />
somaro ed avevo imparato quasi a trovare da solo la<br />
strada da Baddhevrùstana a Sìligo.<br />
Mio padre poteva già rischiare di farmi fare il percorso<br />
per portare il latte in caseificio. Fu una grande conquista<br />
per me. Avevo la possibilità di rivedere spesso i<br />
miei fratelli e mia madre. Almeno per qualche ora, potevo<br />
godere della loro compagnia e mangiare qualcosa<br />
di caldo a tavola. Di questa mia conquista anche mio<br />
padre era contento e fiero. Per lui era una cosa grande.<br />
Poteva starsene tutto il giorno all’oliveto come voleva,<br />
una volta che aveva munto le pecore e mi aveva messo<br />
sul somaro e me lo aveva immesso nel sentiero verso Sìligo.<br />
Mi ricordo bene il grande giorno. Una mattina, quando<br />
il somaro era già pronto con il carico (i bidoni del<br />
latte, la bisaccia e un po’ di legna per casa), mio padre<br />
mi adagiò sul basto. Mi mise in mano la fune di guida e<br />
via. – Stai attento a non cadere, la strada la troverà l’asino<br />
da solo, se tu non la ricordi. Tu lascialo andare, – mi<br />
disse mentre mi allontanavo dalla capanna. – Tieniti<br />
81
forte al basto e stringilo bene con le gambe. Se l’asino<br />
cercherà di correre tira la fune e non cadere.<br />
Il somaro camminava affossandosi nel sentiero senza<br />
che io lo guidassi. Uscire dal bosco per imboccare la<br />
strada maestra per Sìligo, ora, mi sembrava ancora più<br />
difficile del solito. Quanti saliscendi stavo notando!<br />
Ma ero contento. Stavo andando a Sìligo. Mi dondolavo<br />
sulla bestia e per la prima volta mi sentii un uomo di<br />
campagna. Mi sembrava che fossi veramente io a guidare<br />
il somaro. Finalmente l’asino imboccò la strada<br />
bianca. Lì era più facile anche perché in caso di difficoltà<br />
avrei sempre trovato pastori o agricoltori di passaggio.<br />
Il giorno era bello ed il sole mi stava scaldando<br />
dentro il mio cappotto.<br />
Giunto così nelle vicinanze di Sìligo, mi fu possibile<br />
riconoscere posti che già conoscevo: sa cheja de Mesu<br />
Mundhu su riu de Iddha Noa e issa iscia. Sìligo lo avrei<br />
trovato. Esultante giunsi al caseificio (a sa casàra). Solo<br />
che non sapevo come scendere dal basto. Mi sembrava<br />
di essere collocato in un punto non scendibile. Alcuni<br />
pastori amici del babbo, però, mi presero la fune di<br />
mano. Legarono la bestia e mi tirarono giù dal basto.<br />
Mi scaricarono i bidoni del latte e me li portarono dentro<br />
l’edificio. Misurarono il latte e mi ricaricarono di<br />
nuovo i bidoni con il siero sulla bestia. Mi rimisero a<br />
cavallo e via a casa. Per me fu una gioia immensa. Mia<br />
madre mi ridiscese dal basto. Legò il somaro e finalmente<br />
entrai in casa a scaldarmi. C’era un grande fuoco.<br />
Mia madre mi rifocillò. Mi fece il solito bagno antipulce.<br />
Mi cambiò e per un’ora potei scorrazzare per<br />
Sìligo.<br />
82<br />
Purtroppo non andava sempre così. L’asino era vecchio<br />
e faceva le bizze. Andare a Sìligo era sempre più<br />
difficile. In dicembre la mattina presto (chitto chitto)<br />
faceva molto freddo. E quando il babbo, dopo la mungitura,<br />
mi metteva in groppa, il sole spesso non era ancora<br />
sorto. Quando la notte faceva sereno e brinava, all’ora<br />
della partenza i campi sembravano nevicati. Per<br />
me era un martirio fare un’ora e mezzo di trotto su un<br />
somaro “arrogante e vizioso”.<br />
Immobile in groppa, il freddo era insopportabile. Io<br />
non potevo rischiare di scendere per scaldarmi sui passi.<br />
Mi sarebbe toccato fare tutto il cammino a piedi. E<br />
questo sarebbe stato ancora il meno.<br />
Se per caso cadevo dal basto o cadeva la bestia o me<br />
ne scendevo disperato tutto intirizzito dal freddo, una<br />
volta a terra, il somaro si fermava: non camminava più e<br />
si metteva di traverso per la strada. Mi toccava quindi<br />
affrontare la situazione in groppa. Già dopo un quarto<br />
d’ora di strada, il freddo mi prendeva ai piedi e alle<br />
gambe pendenti e nude fuori dai pantaloni arrotolati.<br />
A metà strada, a Riu Ruzu, i piedi li avevo già cancrenati<br />
al punto che mi mettevo a strillare e a piangere disperatamente<br />
dentro il cappotto del babbo. Il volto livido,<br />
con il corpo rattrappito e curvo sul basto in balia del<br />
passo della bestia, quasi per forza di inerzia mi tenevo<br />
con le mani nude e screpolate dal freddo.<br />
Le mie urla e il mio pianto riempivano le vallate ora<br />
brinate e ora annebbiate lungo la strada maestra e spesso<br />
impietosivano qualche pastore che veniva, umanamente,<br />
a soccorrermi. Una mattina di brina (de astràdu),<br />
mentre ululavo per il dolore ai piedi congelati, al-<br />
83
l’improvviso dal suo chiuso sulla strada balzò un pastore.<br />
Era Tonni. Mi sbarrò la strada. Fermò il mio somaro<br />
e mi portò nella sua capanna. Mi fece scaldare a distanza.<br />
Gradatamente. Mi offrì un bicchiere di latte tiepido<br />
con un po’ di sale. – Non avvicinare molto le mani e i<br />
piedi gelati al fuoco, se no sentirai un dolore tremendo...<br />
Bisogna disgelarli pian piano, anzi... anzi, infila le<br />
mani dentro il paiuolo, nel siero (intro su labiólu, in sa<br />
jotta). Stavo proprio facendo la ricotta quando ti ho<br />
sentito ululare come un cane smarrito... Come te le senti?<br />
– Ora ho caldo alle mani, ma, i piedi...<br />
– Tra un po’ non sentirai più nulla. Mah!... Non poteva<br />
andarci tuo padre a portare il latte? – mi disse chino<br />
attizzando il fuoco.<br />
– Sta potando la vigna e deve lavorare all’oliveto (est<br />
illistrènde sa inza e dèvede trabagliàre in issu oliàriu), –<br />
feci io rinvenendo dal freddo.<br />
– E già! Dèvede illistrìre sa inza! – continuò muovendosi<br />
per la capanna. Ben riscaldato, Tonni mi rimise in<br />
groppa sulla strada per Sìligo, mentre dalla bocca sbuffavo<br />
una striscia di vapore quasi palpabile. Questo per<br />
me fu un giorno fortunato. Quasi sempre mi toccava<br />
fare tutta una tappa. Arrivavo al caseificio congelato,<br />
tutto di un pezzo. Non ero in grado nemmeno di scivolare<br />
giù di groppa. I pastori lo sapevano. E appena arrivavo<br />
mi scendevano e mi portavano al fuoco dove si<br />
scaldavano le caldaie del latte (a issa furràzza).<br />
Spesso il viaggio andava anche peggio. Al congelamento<br />
in groppa, si aggiungevano altre complicazioni:<br />
le bizzarrie della vecchiaia della bestia. Il somaro era<br />
84<br />
“vizioso” e con me ne approfittava. Per sbarazzarsi del<br />
carico sfregava i cespugli e le piante dove passava.<br />
Spesso si coricava per terra nonostante mi aggrappassi<br />
disperatamente al basto e alla cavezza, o cadeva apposta<br />
per liberarsi del mio gelido peso. Io allora ruzzolavo<br />
per la strada e non mi restava che rimettermi in piedi.<br />
Piangere e urlare nella speranza che mi sentisse<br />
qualcuno. In tali circostanze, mentre la bestia si riposava<br />
sdraiata per la strada, ad aiutarmi era thiu Zirómine,<br />
il cantoniere. Per me allora era divenuto un protettore.<br />
Sulla strada lo incontravo sempre e mi aiutava<br />
per qualsiasi cosa.<br />
Un giorno sul rettilineo di Capiàna mi capitò una cosa<br />
di cui avevo avuto sempre paura. I carabinieri a cavallo<br />
che mi venivano incontro. La bestia andava piano<br />
piano di contro al ritmo sfrenato dei loro cavalli. Colto<br />
all’improvviso mi sentii come qualcosa che dovevo essere<br />
necessariamente catturato e preso da loro. Sulla<br />
groppa della bestia mi venne in mente un episodio di<br />
cui mi ero dimenticato o credevo di aver dimenticato.<br />
E quasi non fossi più sul somaro, le immagini di quel ricordo<br />
che andava affiorando mi assalirono. Durante la<br />
guerra, quando non avevo più di quattro anni, in base a<br />
un ordine di requisizione, i carabinieri irruppero in casa<br />
e senza chiedere né permesso né niente si misero a<br />
perquisire la casa.<br />
– Dove tiene le provviste, signora? – chiese il brigadiere.<br />
– Nel solaio, – rispose la mamma.<br />
Il brigadiere salì con i gendarmi e guardò la roba.<br />
– Prendete mezzo maiale. Qui ce n’è uno intero.<br />
85
– Per carità, – fece la mamma. – Io sono sola. Mio marito<br />
è soldato. I miei figli debbono mangiare!<br />
– Eh... signora! Non è colpa mia... Io sto facendo il<br />
mio dovere. Lei, però, può star tranquilla: gliene stiamo<br />
lasciando la metà proprio perché suo marito è dove<br />
è. C’è gente però che di maiale non ne mangia più da<br />
anni. Questa roba va al fronte... A quei poveretti che ci<br />
stanno difendendo con il loro sangue. Prendete anche<br />
un po’ di grano, – continuò il brigadiere. – Signora!<br />
Non è che ne ha nascosto dell’altro in qualche parte,<br />
come fanno molti, per le grotte in campagna o sotto<br />
terra dentro le damigiane? C’è una contravvenzione salata.<br />
Il sequestro del grano...!<br />
– È tutto qui.<br />
– Che sia la verità. Ci può andar di mezzo suo marito.<br />
Mi ritornò in mente l’immagine dei carabinieri con<br />
mezzo maiale tra le mani e la paura aumentava sempre<br />
di più. Il rettilineo era lungo, ma la distanza diminuiva<br />
continuamente. E quando me li vidi a cinquanta metri<br />
non seppi resistere. Scivolai di groppa. Abbandonai il<br />
somaro con i bidoni e mi misi a correre scappando sulla<br />
strada ghiaiosa verso Baddhevrùstana. Thiu Zirómine,<br />
che veniva appunto da Sìligo in bicicletta lungo la sua<br />
strada, una volta sorpassati i gendarmi, mi raggiunse<br />
quasi in preda al delirio che mi aveva sbloccato dal gelo.<br />
– Perché stai correndo? Perché stai scappando e<br />
piangendo? Cos’hai?<br />
– Ci sono i carabinieri, – feci disperato.<br />
– Ma... hai fatto nulla? Hai combinato qualcosa?<br />
– Noooo! Noooo! No! Io non ho fatto nulla!<br />
86<br />
– E allora di che hai paura?<br />
– Quelli si prendono tutto. Mi prendono e mi mettono<br />
in prigioneeee... Una volta sono entrati in casa in<br />
paese e si sono presi mezzo maialeee!<br />
– Cosa stai dicendo. Era tempo di guerra. Ora quelli<br />
cercano solo i banditi... Fermati! Ci sono io, no?<br />
Thiu Zirómine con i suoi ragionamenti riuscì a farmi<br />
rallentare la corsa. Mi sbarrò il passo con la bicicletta.<br />
Scese per terra. Mi prese per mano e mi fermò. I carabinieri<br />
ci passarono subito davanti. Forse capirono la cosa<br />
e per fortuna filarono dritti. Il cantoniere mi ricondusse<br />
dal somaro che profittando dell’occasione si era<br />
coricato sulla strada. Thiu Zirómine a furia di botte e di<br />
calci riuscì a metterlo in piedi con il carico che equilibrò<br />
alla meglio e mi rimise in marcia sulla bestia.<br />
La bestia però, stava invecchiando e con l’andar del<br />
tempo diveniva più bizzosa. Mio padre, subito pensò<br />
anche a questo. Si recò alla fiera del bestiame in cerca<br />
di un somaro più giovane. Prima di assentarsi, si fece<br />
sostituire da thiu Costantìnu cui affidò il gregge, il cane<br />
e me stesso.<br />
Thiu Costantìnu era molto simpatico. Sempre sorridente<br />
e rubicondo con il sigaro in bocca a fuoco dentro<br />
(per non farselo spegnere dal vento e dall’acqua e di<br />
notte anche per non farsi notare). Era di costituzione<br />
robusta e un grande bevitore. La sera che giunse all’ovile,<br />
dopo che mio padre gli diede le consegne, sull’imbrunire,<br />
ci recammo alla mandra per mungere il gregge.<br />
Io glielo condussi dal pascolo e glielo rinchiusi dentro<br />
escludendone i capi non da latte, il montone e gli<br />
agnelloni.<br />
87
Il buio scendeva dai monti confondendo tutto. E la<br />
luna piena all’orizzonte, proiettava, lunghe, le ombre<br />
degli alberi e delle cose. Il gregge nel recinto, ben disposto<br />
per la mungitura, si ruminava nel frattempo quanto<br />
aveva nel rumine (remuszaìada cantu jughìada in sa<br />
entre bizzàdile). Tra la brezza della sera, l’odore che<br />
esalava dalla bocca delle pecore, si diffondeva dominando<br />
sugli altri odori. Thiu Costantìnu assiepò l’accesso<br />
della mandra con un cespuglio (cun d’unu càlamu)<br />
e valicò la siepe con il secchio (cun sa cannàda). Entrò.<br />
Si abbassò con il secchio tra le cosce adagiandovisi<br />
quasi fosse uno sgabello. Gettò una fortissima scorreggia.<br />
Rispose alla mia risata e la sua faccia nella penombra<br />
si stagliò con le sue guance rosse. Abbassò la testa.<br />
Si fece sulla prima pecora. La prese per la mammella si<br />
sputò l’indice ed il pollice della mano destra e incominciò<br />
a scapezzolarla.<br />
Io dall’esterno mi ascoltavo lo scroscio del latte mentre<br />
usciva dalle poppe. E Thiu Costantìnu inumidendosi<br />
di tanto in tanto le dita nella schiuma del latte fece<br />
tutto il giro del recinto mungendo le pecore una per<br />
una. Con lui mi divertivo e non mi fece rimpiangere<br />
l’assenza del babbo. La notte dormivo al suo fianco.<br />
Mi copriva bene. Si metteva il suo bariletto del vino a<br />
guanciale. Si distendeva e si ricopriva scaldandomi con<br />
il suo fianco mentre fumava il suo sigaro. Spesso un<br />
glu-glu-glu concitato mi svegliava nel silenzio della capanna.<br />
Thiu Costantìnu tracannava dal suo bariletto.<br />
Dopo tre giorni, di sera, finalmente sulla radura della<br />
88<br />
capanna, spuntò mio padre con un somaro nero, grosso<br />
e lanuto. Sembrava un cavallino.<br />
Era molto alto e montarlo mi sembrava difficile. Però<br />
era ben domato e mansueto. Il suo trotto era veloce e<br />
ora potevo essere certo che il mio somaro non si sarebbe<br />
più fermato né coricato per strada. Sulla strada, anzi,<br />
ora potevo gareggiare al trotto con gli altri pastori. Il<br />
nostro Pacifico, così lo aveva denominato mio padre,<br />
allora era il somaro più grande e più forte di Sìligo. Ero<br />
orgoglioso di cavalcarlo.<br />
Anche se ora ero già “grande” e in grado di portare il<br />
latte a Sìligo con Pacifico, in paese non è che ci andavo<br />
ogni giorno. Anche il babbo doveva sbrigare le sue faccende.<br />
Vedere i miei fratelli e la moglie. Quindi era lui<br />
che spesso andava a Sìligo. Il mio divagamento, tutto<br />
sommato, veniva interrotto, per un’ora, due tre volte la<br />
settimana. Per il resto, continuavo a star solo con le pecore.<br />
Le conducevo al pascolo per il campo. I cani mi<br />
facevano sempre strada. E dietro di loro riempivo di<br />
gridi e di urli i sentieri e le valli che percorrevo per farmi<br />
coraggio e per mettere in fuga le volpi che, specie<br />
nelle giornate piovose, calavano al piano minacciose in<br />
cerca di cibo.<br />
Quando pioveva, un “ombrellone verde d’incerata”<br />
era la mia dimora, mobile, a seconda del piacere e delle<br />
abitudini del gregge che si spostava a suo piacimento<br />
in cerca di cibo o di riparo dal vento (de mànigu o de<br />
abbàrru dae isu entu). L’acqua scendeva violenta, a rovesci,<br />
sull’ombrellone che io tenevo opposto alle frecciate<br />
del vento per schivare la pioggia giocata dal turbine.<br />
Il gregge si fermava a testa bassa in una forra o in<br />
89
un bacìo e si metteva al riparo dal vento (e si ponìada a<br />
barru a bentu). Per farmi compagnia, spesso intonavo<br />
qualche canto sardo e lo accompagnavo al picchiettio<br />
delle gocce (de sos buttìos) sull’ombrellone.<br />
Acóllu fattènde die<br />
ponzènde grinas in mare<br />
e deo ancòra a tocàre,<br />
bella, su pettus a tie... 1<br />
Il canto in “re”, il più tipico canto sardo logudorese,<br />
sotto lo scatenarsi della natura con i suoi accordi che<br />
scaturivano dalle fronde in preda al vento, dai tuoni e<br />
dalla pioggia, usciva meravigliosamente e io ammazzavo<br />
il tempo. La giornata era lunga e subito ricadevo nella<br />
solitudine più profonda e mentre la natura faceva il<br />
suo fragoroso discorso dialogando con terra e cielo,<br />
punteggiandolo e apostrofandolo di lampi e di tuoni<br />
scrivendo il vento l’acqua e il gelo, io ricadevo in uno<br />
stato tale da entrare in sintonia biologica con esso. Lo<br />
scrosciare dell’acqua nel bosco, i tuoni ed il vento, erano<br />
allora le uniche parole che mi era dato di sentire e<br />
con loro stavo bene.<br />
Quando il gregge si spostava, gli tenevo dietro, sfruttando<br />
come copertura il frondoso tetto di sugheri che<br />
in alcuni punti formava un riparo quasi impenetrabile.<br />
I loro tronchi color sanguigno si stagliavano come tor-<br />
1 Eccolo! Il giorno sereno / sorgendo albori sul mare / ed io ancora<br />
toccare, / bella, non posso il tuo seno...<br />
90<br />
ri e sotto le sue branche poteva ripararsi una mandria.<br />
Sotto questi enormi fusti grinzosi e ricurvi, scalpitando<br />
i piedi per il freddo, intonavo un altro canto (unu<br />
mutu).<br />
Sos anzònes currèndhe<br />
cùrrene a totta vua<br />
poi tòrrana a s’ama.<br />
Sos anzònes currèndhe<br />
se beru chi mi ama<br />
dae intro ’e ucca dua<br />
tia chèrrere intèndhere.<br />
Cùrrene a totta vua<br />
se beru chi mi ama<br />
tia chèrrere intèndhe<br />
dae intro ’e ucca dua.<br />
Poi tòrrana a s’ama<br />
dae intro ’e ucca dua<br />
tia chèrrere intèndhe<br />
se beru chi mi ama. 2<br />
Anche nelle giornate più uggiose, però, quasi sempre<br />
presto o tardi all’orizzonte, faceva capolino il sole e ritornava<br />
la calma. La nebbia si diradava dalla cresta dei<br />
2 Gli agnelli nella corsa / corrono a tutta foga / al gregge tornan<br />
poi. / Gli agnelli nella corsa / se tu bene mi vuoi / dalla tua bocca<br />
toga / sentir vorrei con forza. / Corrono a tutta foga / se tu bene mi<br />
vuoi / sentir vorrei con forza / dalla tua bocca toga. / Al gregge tornan<br />
poi / dalla tua bocca toga / sentir vorrei con forza / se tu bene<br />
mi vuoi.<br />
91
monti e la natura ricompariva. Un altro linguaggio allora<br />
si spandeva per le distese circostanti. Quel tremendo<br />
discorso della natura si rompeva e ogni ovile riprendeva<br />
a parlar nella sua lingua abituale. L’abbaiare di un<br />
cane, i colpi di una scure che tagliava legna (sos maschéddhidos<br />
de una istràle seghèndhe linna) o il raglio di<br />
un somaro o i belati delle mandrie.<br />
Le greggi del vicinato allora incominciavano ad uscire<br />
dai ripari naturali. Si scrollavano di dosso l’acqua scuotendosi<br />
in tutte le membra e si avviavano per il pascolo<br />
emettendo il solito “concerto” con lo scampanio della<br />
loro ferraglia. Io lo sentivo e lo ascoltavo. E senza quasi<br />
pensarci mi veniva spontaneo distinguere, dai diversi<br />
“concerti”, un gregge dall’altro (sas amas de sa cussòsa).<br />
Le capanne degli ovili allora fumigavano tutte all’orizzonte.<br />
I pastori vi si stavano riscaldando e si preparavano<br />
ad affrontare un altro temporale: un’altra “arringa”<br />
della natura. Durante questi intervalli di quiete dopo<br />
la tempesta, quando la natura cessava di esprimere<br />
gelo, vento e neve, io con i cani me ne andavo a vedere i<br />
ruscelli e le polle (sos rios e sos tónchinos) che qua e là<br />
pullulavano per i campi dalla terra traboccante e inzuppata<br />
di pioggia. Alla mia fantasia ogni rivolo sembrava<br />
un fiume. Ogni pozzanghera, ogni conca, piscinetta<br />
o cavità del terreno o sui macigni, sembrava il mare<br />
che non avevo mai visto e che mi ero soltanto immaginato<br />
attraverso idee fugaci, echi di discorsi riferitimi<br />
occasionalmente.<br />
Così a ogni schiarita, percorrevo vallate e colline per<br />
osservare la metamorfosi. Nella mia rassegna spesso mi<br />
soffermavo in silenzio ad orecchie tese (a orìjas paràdas)<br />
92<br />
nella speranza di sentire un nuovo rigagnolo scorrere<br />
sull’erba. Di corsa andavo a vederlo. A metterci le mani<br />
dentro e sentire l’acqua che mi passava tra le dita trattenendone<br />
le foglie e i fuscelli che vi scorrevano. Trovarli,<br />
questi “fiumi” e questi “laghi” nel nostro campo, per<br />
me era la più grande gioia ed il più grande diletto. Spesso<br />
nutrivo invidia dei campi in cui si formavano laghetti<br />
e fiumi più grandi che nel nostro. Non li potevo raggiungere.<br />
Mi era proibito. Erano campi nemici.<br />
Questo dialogo e questo gioco con la natura, purtroppo,<br />
cessava di colpo, non appena il raglio del somaro<br />
mi annunciava l’arrivo del babbo oppure me lo<br />
vedevo spuntare all’orizzonte. La sua presenza ci zittiva<br />
e ci rendeva muti. Io e la natura. E ognuno si rinchiudeva<br />
nel guscio del proprio silenzio. Mio padre era un<br />
ostacolo improvviso che colpiva le quattro corna di<br />
due lumache nel loro gioco. Si inghiottivano rattrappite<br />
nel loro guscio, proponendosi di ri-uscire al più presto<br />
al primo temporale per pascere sul morbido fieno<br />
lungo i canali e le piscine del campo. La sua sola presenza<br />
mi staccava dal mio mondo per richiamarmi al<br />
suo. Al lavoro.<br />
Una volta tanto, capitava di astenerci dal lavoro, specie<br />
se lui non stava bene o aveva mal di testa. In tali circostanze<br />
si andava a fare una visita a qualche pastore vicino<br />
(a calchi ighinàdu). Per me era un’esperienza curiosa.<br />
Era l’occasione per conoscere gente. Sentire ed<br />
ascoltare episodi e vicende. Così una sera capitammo<br />
nella capanna di un grosso ovile.<br />
Al nostro arrivo sette cani ci vennero contro, furiosamente<br />
padroni della natura: la coda attorcigliata, la<br />
93
schiena irsuta ed abbaiando a strascico. Il <strong>padrone</strong>, che<br />
stava scaricando il cavallo, era appena arrivato dal suo<br />
paese; zittì i suoi guardiani. Salutò mio padre con fare<br />
abituale. Si conoscevano bene, e senza per nulla interrompere<br />
le sue faccende, parlottando con mio padre,<br />
afferrò la bisaccia ancora sulla sella. La mise per terra<br />
davanti ai cani e ai servi (canes e teràccos). Gli uni e gli<br />
altri scodinzolando e sbirciando la bisaccia. Il <strong>padrone</strong><br />
tolse le provviste che aveva portato disponendole in tre<br />
mucchi: uno per sé, uno per i cani, uno per i servi. La<br />
mia attenzione fu attratta, spontaneamente, dal diverso<br />
colore del pane: candido quello del <strong>padrone</strong>, cruschello-orzo<br />
quello dei servi, crusca pura quello dei cani.<br />
Alla fine il <strong>padrone</strong> fece cenno al servo più anziano di<br />
prendere la roba, il quale scodinzolando si preoccupò<br />
di vedere e sapere cosa avrebbero potuto mangiare.<br />
Portò tutto dentro la capanna e tra il fagotto trovò una<br />
pentola che conteneva una specie di brodaglia (sicuramente<br />
come di consueto avanzi racimolati giorno per<br />
giorno dai pranzi consumati in paese). La mise sulle tre<br />
pietre, al fuoco. Nel frattempo i suoi compagni spiegarono<br />
davanti al fuoco un sacco e si misero a spezzettare<br />
pane di orzo. Ne fecero un bel mucchio. Quando la<br />
brodaglia cominciò a bollire, il servo più anziano afferrò<br />
le cocche del sacco che fece roteare sulla pentola lasciandovi<br />
cadere il pane spezzettato.<br />
Io me ne stavo sull’uscio della capanna appoggiato al<br />
muro che la riparava dal maestrale (a sa pedrìssa) e osservavo<br />
la scena come un intruso obbligato. Il babbo e<br />
il <strong>padrone</strong> dell’ovile, fuori, stavano discutendo di pascoli<br />
e di bestiame. Di tanto in tanto, i servi assaggiava-<br />
94<br />
no la loro cena scambiandosi sguardi di famelico compiacimento.<br />
A fine cottura fui spettatore di una scena disperata e<br />
crudele. Il servo più anziano scese la pentola dal fuoco<br />
e la mise da una parte per la capanna. Gli altri fecero<br />
ruota intorno alla pentola da cui usciva un cilindro di<br />
fumo che sembrava un fusto d’albero che reggeva la capanna.<br />
Si disposero alla meglio aspettando che l’intruglio<br />
sfreddasse, per assalire e divorare finalmente il<br />
piatto caldo, di cui raramente usufruivano.<br />
All’improvviso tutti si fecero sui cucchiai che erano<br />
infissi su un interstizio del muro a secco della capanna.<br />
Malauguratamente risultò che c’era un cucchiaio in<br />
meno delle bocche. Uno restò escluso.<br />
I fortunati, curvi sulla pentola, aspettarono un po’ il<br />
loro compagno. La fame, però, li vinse subito. Il caposervo,<br />
per primo, immerse il cucchiaio, seguito dagli altri<br />
due che il caso e la tempestività aveva provvisto di<br />
cucchiaio. E dal semplice atteggiamento di assaggio<br />
iniziale (più apparente che reale), quasi a testimoniare<br />
un indugio di solidarietà e dar tempo al compagno che<br />
trovasse il cucchiaio si passò all’assalto. Si sprigionò la<br />
fame come una furia incontenibile. Tutti e tre si fecero<br />
sotto cozzandosi le teste ogni qualvolta immergevano il<br />
cucchiaio nella pentola, tracannando più avidamente<br />
del solito, quasi la fame ora avesse annullato la comprensione<br />
iniziale per il compagno e suggerisse di finire<br />
il pasto prima che il poveretto si fosse procurato un<br />
qualche espediente.<br />
Il loro malcapitato compagno tentò con le mani. Ma<br />
la roba un po’ perché era calda e un po’ perché era bro-<br />
95
dosa, non si lasciava prendere. L’escluso dalla preda,<br />
visto che i suoi compagni ricevevano dalla fame una<br />
spinta più grande della loro volontà e che non potevano<br />
avere più comprensione per lui, volgeva gli occhi<br />
dappertutto cercando il cucchiaio che mancava. E nella<br />
smania di sfamarsi si contorceva tutto, dimenandosi,<br />
con gli occhi sgranati, quasi tesi in uno sforzo disperato<br />
per fabbricare un cucchiaio con lo sguardo.<br />
I suoi compagni chini sulla pentola, producevano un<br />
gorgoglio da truogolo. Le loro gole ingoiavano fragorosamente<br />
senza masticare né gustare tutto quello che vi<br />
capitava, quasi ogni cosa si sciogliesse non appena entrava<br />
in bocca. Le succhiate e la rapacità dei suoi compagni<br />
gli lancinavano lo stomaco più della stessa fame.<br />
Si vedeva. Si agitava e non si dava pace. Quel fragore lo<br />
scompigliava, lo sconvolgeva.<br />
A un tratto, però, un lampo di genio istintuale! Spinto<br />
dalla disperazione dell’escluso (stare un’altra settimana<br />
o un altro mese senza gustare cibo caldo sarebbe<br />
stato poco consolante, sommato allo sconforto di andare<br />
a letto senza cena) volse gli occhi in alto verso il comignolo.<br />
Una luce si sprigionò dai suoi occhi e nella penombra<br />
della capanna gli si illuminò una sonaglia sbattagliata<br />
che pendeva dal tetto di stoppie (dae su covàccu<br />
de restùju), arrugginita e sporca dal sudore e dall’untume<br />
della pecora che l’aveva portata. Il cucchiaio era<br />
fabbricato. Stava lassù.<br />
Con un salto disperato balzò verso l’alto. Strappò la<br />
sonaglia dalle stoppie suscitando un nembo di fuliggine<br />
che lo annerì con i compagni. E come posseduto<br />
dalla smania, la immerse disperatamente in quella bro-<br />
96<br />
daglia che i suoi compagni (che in quel momento erano<br />
solo bocca cucchiaio e pentola) avevano già mezzo divorato.<br />
Se la appoggiò alle labbra e calda come era la<br />
vuotò tutta d’un fiato cercando di recuperare e di raggiungere<br />
i suoi compagni nel pasto. Così ripeté la scena<br />
fino a che il cibo non fu consumato del tutto.<br />
Al <strong>padrone</strong> che allo sghignazzo dei servi si fece sulla<br />
porta non poteva capitare di più spettacolare sotto gli<br />
occhi. Sghignazzò sarcasticamente, quasi per esprimere<br />
la sua potenza. Si sentiva il creatore della scena.<br />
– Che te ne pare? – fece rivolto a mio padre che non<br />
poté fare a meno di ridere sulla cosa, anche se dovette<br />
aver compassione di quel servo che aveva mangiato alla<br />
campana. Così dicendo il <strong>padrone</strong> si calò in un angolo a<br />
mangiare anche lui. Tolse i suoi cibi dal sacchetto. E di<br />
nuovo notai che il suo pane era bianco, confezionato ad<br />
arte dalle serve che aveva in paese. Il suo companatico<br />
era agnello arrosto. Mise in piedi un fiasco di vino e attorniato<br />
da tanta altra roba ci invitò a mangiare imperiosamente,<br />
lontano dai servi come era costume. Mio<br />
padre accettò l’invito e io quindi mangiai un pezzo di<br />
carne che mi porse quel signore.<br />
Mentre stavo mangiando i miei occhi si fissarono in<br />
un punto indefinito e incantati ed immobili vedevano<br />
quel pane nero dei servi al punto che anche il pane<br />
bianco, che tenevo con la sinistra, mi sembrava nero.<br />
Avevo sette anni. Secondo mio padre avrei già dovuto<br />
essere un pastore completo. Non potevo più starmene a<br />
pancia a sole, riparato sui cespugli del cisto o del lenti-<br />
97
schio (de su puléju o de sa chessa) come le pecore a ruminare<br />
o come gli altri animali dopo che si erano riempiti<br />
la pancia. Il mio lavoro allora, negli intervalli che mi consentiva<br />
la custodia delle pecore, consisteva nello sbrigare<br />
le faccenduole dell’ovile: asportare il letame dal porcile<br />
o dal recinto (dae s’àrula o dae su corràle), fare qualche<br />
fascio di legna per Sìligo o assiepare i muri di confine<br />
(inchesubràre sos muros de sas làccanas).<br />
Io, naturalmente, quello che potevo lo facevo quasi<br />
sempre. Traducevo sempre in lavoro le mie risorse anche<br />
perché con mio padre era inutile fingere o lavorare<br />
a mala voglia (a mala gana). Al suo ritorno controllava e<br />
stimava sempre il mio lavoro. Quasi sempre le cose filavano<br />
lisce. Ma i patriarchi erano troppo severi ed esigevano<br />
che i loro bambini divenissero uomini contro il<br />
tempo. Dovevano produrre da uomini. Le bagatelle<br />
non trovavano giustificazione. Tutto doveva essere saggezza<br />
e maturità.<br />
Una mattina, mio padre, mentre partiva per Sìligo,<br />
mi lasciò le sue disposizioni: asportare il letame delle<br />
pecore dal recinto con la carriola. Non appena scomparve<br />
all’orizzonte disseminando, come al solito, ordini<br />
ed urlando avvertimenti, mi sentii libero. Il “re” di<br />
Baddhevrùstana. E certo fino al suo ritorno lo ero veramente.<br />
Quel senso di libertà illimitata mi ingigantiva!<br />
E come un gigante, <strong>padrone</strong> della natura, divorai la solita<br />
zuppa di latte e sale. Sullo spiazzo uscii forte come<br />
un leone. Pronto a sbranare il lavoro.<br />
Ascoltai il tintinnio del gregge. Era pacato. Tutto regolare.<br />
Pasceva tranquillo. Io potevo lavorare!<br />
Diedi di piglio alla carriola e mi diressi verso il recin-<br />
98<br />
to. Ma la voce melliflua e melodiosa di Nicolàu (un pastore<br />
vicino, a duecento metri dalla nostra capanna) mi<br />
raggiunse e mi avvinse:<br />
Daghi inàsprid’ su dolòre<br />
fiòres chisco in totùe<br />
ammenténdhemi chi tue<br />
lis dedìcas tantu amore<br />
giòia! In dogni fiòre<br />
mi pared’de di miràre:<br />
appo dispòstu a passàre<br />
tristas sas dies pro de! 3<br />
Il solito canto in “re” mi appese all’incertezza e mi fece<br />
oscillare tra gli ordini del babbo e la fuga verso Nicolàu.<br />
Ero ansioso di andare a trovarlo, di parlare con lui<br />
e di sentirlo cantare. Ed ora che mio padre trottava verso<br />
Sìligo, con Pacifico, potevo spiccare il volo per dove<br />
volevo!<br />
Su dou non fid’amòre<br />
fidi néula passizzèra<br />
podes ingràta Glicèra<br />
su chi affìrmo eo negàre. 4<br />
3 Quando inasprisce il dolore / cerco fiori giù e su / ricordandomi<br />
che tu / gli dedichi tanto amore / gioia! ché in ogni fiore /<br />
sembra ti possa trovare: / ho disposto di passare / tristi giornate<br />
per te!<br />
4 Il tuo non era amore / era nebbia passeggera / puoi ingrata<br />
Glicera / ciò che affermo io negare.<br />
99
Il “re-do” di Nicolàu bastò ad aprirmi le ali e a farmi<br />
spiccare il volo. Abbandonai subito la carriola sul letame<br />
(sa carrètta subra eissu ladàmine) e in un baleno percorsi<br />
i duecento metri sull’erba bagnata e più alta di<br />
me. Saltai il muro della nostra tanca e sbucai sullo<br />
spiazzo dell’ovile di Nicolàu. Cantava col cuore, mentre<br />
con la mente sbrigava le sue faccende, come fanno i<br />
“buoni pastori”. Stava spostando il recinto della mungitura<br />
(sa mandra ’e mùlghere) e rinforzando la siepe<br />
dell’ovile (sa chesùbra de issu corràle).<br />
– Ciao, Gavinè! Come mai sei potuto venire qui?<br />
– Il babbo è andato via, a Sìligo. Oggi tocca a lui.<br />
– Ah... beh!... capisco....<br />
– Pòdese ingràta Glicèra<br />
su c’affìrmo deo negàre. 5<br />
Nicolàu, come d’abitudine, cantava e lavorava insieme.<br />
Sentirlo, ascoltare ed imparare il suo canto e i versi,<br />
era un piacere.<br />
– E tu non hai nulla da fare? Mi sembra strano che<br />
Abramo non ti abbia detto di fare qualcosa!<br />
– Sì. Debbo portar via un po’ di letame dae su corrale.<br />
– Eh, allora... non trattenerti molto.<br />
In su monte ’e Gennargéntu<br />
bogo sa robba a pàschere<br />
a sa asciàda ’e s’istèlla.<br />
5 Puoi ingrata Glicera / ciò che affermo io negare.<br />
100<br />
In su monte ’e Gennargéntu<br />
tra nois duos, bella,<br />
amòre deve nàschere<br />
dai custu moméntu... 6<br />
Per me non esisteva più nulla, né muriccioli né siepi:<br />
quel canto era tutto! Il letame poteva anche aspettare.<br />
Nella peggiore delle ipotesi avrei preso i soliti colpi.<br />
Temporale più temporale meno, ormai mi c’ero abituato.<br />
Meglio un piacere che cento malanni (mezzus unu<br />
gustu che chentu malànnos).<br />
La mattina così passò senza accorgermene, tra un<br />
canto e l’altro di Nicolàu.<br />
Sul tardi purtroppo mi venne un forte mal di testa.<br />
Gli ordini del babbo non li potei eseguire. Tentai di<br />
sforzarmi, ma le fitte alla testa mi toglievano ogni brio e<br />
dovetti accasciarmi sul letame. Quel giorno finì che<br />
avevo asportato solo cinque-sei carriole di letame. Verso<br />
le cinque del pomeriggio, il raglio poderoso di Pacifico,<br />
in lontananza, mi raggiunse agghiacciandomi e<br />
scaraventandomi nella disperazione. Cercai di reagire.<br />
Di recuperare almeno in quell’ultimo quarto d’ora. Le<br />
tempie mi stavano scoppiando. E inesorabilmente il<br />
<strong>padrone</strong> fece irruzione sullo spiazzo.<br />
Insistere era inutile. Mi trovò all’opera. Ma lavoro<br />
fatto non ce n’era.<br />
6 Sul monte Gennargentu / conduco il gregge a pascere / al sorgere<br />
della stella. // Sul monte Gennargentu / tra noi due, bella, /<br />
amore deve nascere / sin da questo momento...<br />
101
Con il suo sguardo torvo, terrificante ed esperto, lesse<br />
la mia “colpa”. Subito si accorse che a lavorare avevo<br />
incominciato solo da poco.<br />
– È inutile che ti faccia trovare al lavoro! Che incominci<br />
a lavorare quando senti il raglio del somaro (su<br />
órriu de s’àinu).<br />
– No! No! Io... ho cercato di lavorare, ma mi è venuto<br />
un forte mal di testa. Non ce l’ho fatta! Non ce la faccio<br />
più!<br />
Il mal di testa mi giustificò e calmò mio padre che mi<br />
si stava avventando. Tutto sembrava finito. L’alibi del<br />
malessere si oppose, per il momento, al decalogo pastorale.<br />
Sul tardi però il babbo capitò da Nicolàu e il giubbino<br />
che, in seguito al raglio del somaro, mi ero dimenticato<br />
lì, fu il segno inconfutabile che io vi ero stato. Nicolàu<br />
cercò di giustificarmi, ma non convinse il patriarca.<br />
E in mio padre si scatenò l’uragano punitivo. Il mal<br />
di testa, ora, era una scusa, non esisteva più. In un baleno,<br />
lui si spiegò la mia disubbidienza tutta a modo suo.<br />
– Mi hai mentito. Sei stato da Nicolàu, – mi disse<br />
sbattendomi il giubbino addosso. – La cosa è grave,<br />
ora la paghi. – Ed afferrato il primo cespuglio che gli<br />
capitò sotto mano (unu arrasólu de mattisùja), mi aggredì<br />
urlando come una furia e mi tempestò di colpi<br />
senza guardare dove andassero a finire, come si faceva<br />
con le bestie. Io mi misi a correre disperatamente, cercando<br />
di schivare i suoi attacchi in attesa che si sfogasse.<br />
Ma lui mi veniva dietro colpendomi continuamente.<br />
Uno dietro l’altro si correva forsennatamente intorno<br />
all’ovile.<br />
102<br />
E mentre io correvo per schivare i suoi colpi, non appena<br />
avevo un margine di sicurezza, mi voltavo disperatamente<br />
per vedere se finalmente la tempesta fosse finita.<br />
Dietro di me, purtroppo, vedevo sempre i nembi e<br />
i lampi della sua rabbia. Come un cane idrofobo e privo<br />
della serenità della ragione, mi raggiungeva continuamente<br />
e mi colpiva di nuovo. Preso dal fantasma della<br />
violenza educativa, non guardava. Colpiva e basta.<br />
Mi sbatteva ritmicamente il cespuglio in faccia. Il<br />
suo braccio era divenuto il pendolo della sua rabbia.<br />
Ogni volta che mi voltavo lo prendevo in faccia netto.<br />
Questa “aia cruenta” si protrasse per oltre dieci minuti<br />
sgattaiolando tra i rovi, i cespugli e i massi dei dintorni<br />
della capanna. E durò più del solito per una ragione<br />
che allora non conoscevo. Perché cercavo scampo<br />
nella corsa. Io non lo sapevo che avrei dovuto subire<br />
la punizione e i colpi stando fermo. L’istinto mi<br />
suggeriva la fuga. Non conoscevo quelle regole! Così<br />
si verificò il tragico paradosso, che tanto più cercavo<br />
scampo tanto più subivo la violenza e tanto più lui mi<br />
s’aizzava contro.<br />
Finalmente dopo dieci minuti di “aia cruenta”, quando<br />
mi vide sanguinante in faccia, con gli occhi gonfi e<br />
arrossati (cun sos ojos rujos dae su sàmbene), il ciclone<br />
pedagogico cessò. Il “maestrale” fugò quei nembi come<br />
per incanto. Il ruggito educativo ammutolì nella<br />
schiarita, ma era troppo tardi.<br />
Lì per lì, non si rese conto della gravità della cosa. Mi<br />
lasciò al pianto desolato appoggiato a un macigno.<br />
Sbraitò. Mi spruzzò le sue bestemmie che riepilogavano<br />
la lezione e andò a portare la mucca per mungerla.<br />
103
Dopo un quarto d’ora mi passò davanti trascinandosi<br />
dietro la bestia con la fune alle corna. Mi gettò uno<br />
sguardo frettoloso, e quando mi vide sfregiato nel volto,<br />
deformato dal gonfiore, si spaventò. Il leone si mutò<br />
in agnello. Il suo ruggito in belato.<br />
– Ci vedi? – fu la sua domanda preoccupata.<br />
– Ci vedo! Ma gli occhi... gli occhi mi friggono. Mi<br />
fanno molto male. Il volto mi brucia, – gli dissi con<br />
paura.<br />
Di corsa abbandonò la mucca. Entrò nella capanna e<br />
prese la tintura di iodio. Mi medicò le ferite e i solchi<br />
scavati dal continuo sbattere del cespuglio e mi lasciò<br />
con il volto quasi arroventato e giallognolo.<br />
– Oh, Nicolà! Oh, Nicolààà!<br />
– Oh! Ehi... Abrà!<br />
– Avvicinati!!<br />
– Che c’è?!!<br />
– Debbo portare il ragazzo in paese, subito. Ho esagerato.<br />
Gli occhi... gli occhi mi preoccupano. Non mi<br />
capiterà più di usare i cespugli. Basterà una verga o la<br />
cintola.<br />
– Lo hai capito... finalmente!<br />
– Ti prego di mungermi la mucca. Le pecore le mungerò<br />
domattina. Per una sera non succederà nulla. Dài<br />
uno sguardo all’ovile. Io tornerò subito.<br />
Così mise il basto a Pacifico. Mi infilò nel suo cappotto.<br />
Mi imbavagliò di altri cenci e via.<br />
– Ci vedi? Ci vedi?<br />
– Sì. Sì.<br />
– Chiudi il destro.<br />
104<br />
– Sì.<br />
– Chiudi il sinistro.<br />
– Sì.<br />
– Tu non dovevi correre! Guai a te se scapperai un’altra<br />
volta che meriterai una punizione!<br />
– Ma io non lo sapevo.<br />
Era già buio. Le tenebre della notte ci assalirono calando<br />
dai monti mentre la bestia ci trasportava a casa<br />
entrambi addolorati.<br />
Giunti a Sìligo fu una tragedia. La mamma mi riconobbe<br />
a stento. Più dal corpo e dall’abbigliamento che<br />
dall’aspetto.<br />
Si mise a piangere. – Che hai fatto? Io vado in caserma.<br />
Ti denuncio.<br />
– Lo so! Questa volta ho sbagliato io! Chiama il dottore<br />
per ora. Poi si vedrà cosa fare. Corri... il dottore! Il<br />
dottore!<br />
– Il dottore! – fece la mamma infilandosi lo scialle nero<br />
e precipitandosi nel buio della strada.<br />
Tornò col dottor Ruju, quello stesso che mi aveva<br />
guarito dalla broncopolmonite.<br />
– Che è successo?<br />
La sua domanda non ebbe risposta. Mi guardò stizzito<br />
e preoccupato dentro gli occhi, sgranandomeli con<br />
le dita.<br />
– Siete fortunati! Fortunati: gli occhi sono salvi, – fece<br />
quasi con un respiro di sollievo. – Il resto guarirà da<br />
solo. Col tempo. Ma come si fa a fare queste cose! È<br />
pazzesco!<br />
– È caduto in un burrone. Dentro un macchione di<br />
rovi e di sterpi, – disse la mamma, cercando di salvare la<br />
105
faccia del marito una volta che sentì che gli occhi erano<br />
salvi.<br />
– In un macchione? Queste sono percosse! Sono colpi!<br />
Il babbo stava lì al focolare. Voleva quasi sprofondare<br />
nel pavimento dalla vergogna. E rannicchiato in silenzio<br />
subì, senza smentire, la tirata violenta del medico.<br />
– Voi vi mettete a educare i figli come le bestie che<br />
educate alla soma o al giogo! Usate sempre la frusta e il<br />
bastone! Educare è difficile e non si educa col bastone<br />
o coi cespugli, ma con la parola. Ti dovrei denunciare,<br />
caro Abramo! Non lo faccio perché mi rendo conto<br />
della vostra condizione e non voglio aggiungere miseria<br />
alla miseria che vi sta addosso da tutte le parti. Ma ti<br />
serva da lezione!<br />
Il dottore uscì di casa lasciando mio padre mogio mogio<br />
come un cane picchiato dal <strong>padrone</strong>.<br />
– Beh, il gregge è incustodito. Io me ne ritorno all’ovile.<br />
– E uscì di casa per non subire oltre il peso della<br />
sua situazione.<br />
Mia madre mi riportò a letto e mi mise sul materasso<br />
e sul guanciale che non ricordavo più. Il volto e le ferite<br />
mi prudevano ancora. E nel silenzio della stanza tra il<br />
dormiveglia rivissi i brani salienti dell’attacco iracondo.<br />
Sul guanciale mi veniva quasi spontaneo contorcermi,<br />
scrollare il capo e chiudere gli occhi in tempo, prima<br />
che il cespuglio mi si sbrandellasse in faccia e mi accecasse.<br />
Ero stanco e indolenzito. E il sonno mi avvinse<br />
e mi tolse dall’episodio mentre schivavo il cespuglio<br />
che mi stava tempestando ancora le tempie.<br />
La mattina, sul dormiveglia, “ero” all’ovile. Mi sem-<br />
106<br />
brava strano però il fatto che non sentissi il linguaggio<br />
dell’alba di Baddhevrùstana (che ascoltavo sulla stuoia,<br />
mentre il babbo mungeva le pecore). Lo ascoltavo tra le<br />
coperte e non sentivo l’abbaiare dei cani, lo scampanio<br />
delle greggi del vicinato. Quella mattina la natura non<br />
rideva. Le upupe non cantavano, i cucculi e le piche<br />
non modulavano il loro canto. Eppure io “ero” sulla<br />
stuoia, nella capanna. Non appena mi rivoltai, le ferite<br />
strisciando sul guanciale mi richiamarono alla realtà e<br />
mi piombarono sull’aia della sera prima. Mia madre si<br />
avvicinò al letto con una tazza di latte zuccherato.<br />
– Ora non devi uscire con questa faccia! È vergogna.<br />
Finché non sarai guarito resterai in casa. – Mi tenne<br />
chiuso in casa per una settimana. Doveva salvare la reputazione<br />
del marito. La cosa agli occhi della gente sarebbe<br />
stata uno scandalo. Una sera il babbo mi ridette<br />
la libertà. Al buio mi ricondusse all’ovile. E la mia faccia<br />
turgida, abbrucciacchiata dalla tintura di iodio, riacquistò<br />
il colore e le proporzioni normali all’aria di<br />
Baddhevrùstana. È rimasta solo qualche traccia ancora<br />
visibile agli zigomi, e nell’animo il ricordo dolente che<br />
mi prude ancora.<br />
Fino ad allora mio padre non aveva mai preteso che<br />
producessi materialmente. Gli bastava che io lo guardassi<br />
con attenzione mentre svolgeva le sue faccende.<br />
Anche quando mungeva me ne ero stato sempre fuori e<br />
avevo sempre ascoltato lo scrosciare del latte nel suo<br />
secchio. Di solito avevo sempre fatto la guardia sul varco<br />
del chiuso in modo che le pecore non scappassero.<br />
107
Gli avevo sempre condotto le pecore alla mandra fugandole<br />
come mi aveva insegnato. Spesso, anzi avevo<br />
imparato a farle venire attirandole con dei versi tipici. E<br />
ai miei eh, eh!eh, lè, lè!lè, lè!lè, lè!dààà!ddddd!eh,eh!<br />
eh, eh!beh!lè, lè!lè, se erano sazie mi venivano fino ai<br />
piedi e compiaciute dalle mie modulazioni fatte ad arte<br />
e accompagnate dai tipici fischi, si raccoglievano spontaneamente.<br />
E brucando gli ultimi steli d’erba si introducevano<br />
nella mandra da sole. Il babbo si metteva al<br />
varco e faceva scrupolosamente la computa giornaliera.<br />
Nella mandra le pecore si disponevano in maniera abitudinaria<br />
quasi ognuna avesse il proprio posto, parallele<br />
a se stesse: l’una a fianco all’altra e perpendicolari alla<br />
siepe. Il modo tipico della mungitura logudorese, tutta<br />
diversa da quella barbaricina. La mandra come in tutte<br />
le parti dell’isola era sempre di forma ellittica, ma la sua<br />
disposizione faceva sì che al centro si creasse uno spazio<br />
geometricamente simile al recinto stesso. Lo spazio su<br />
cui mio padre faceva perno passando le pecore una per<br />
una. Mi era sempre piaciuto osservare la disposizione<br />
delle pecore e mio padre che stava chino con la testa sulla<br />
coda della pecora per tapparle il culo alla maniera logudorese.<br />
Era l’unico espediente per evitare di farsi cacare<br />
nel secchio.<br />
Il cane dopo aver percorso più volte la coltre di lana<br />
che le pecore formavano con la loro disposizione, una<br />
accanto all’altra, lungo la siepe, scendeva a bersi la<br />
porzione del latte che gli spettava (come cane pastore),<br />
e risaliva sul suo trono, dove si crogiolava sdraiato sulla<br />
schiena lanuta delle sue due pecore preferite. Fuori,<br />
nel silenzio, mi ero sempre annasato l’alito del rumine<br />
108<br />
delle pecore e osservato il movimento pendolare delle<br />
loro mandibole: lo scendere e il risalire lungo il collo<br />
del bolo. Mi ero sempre sentita la beatitudine dei loro<br />
rutti sonanti e le scapezzolate delle poppe sul secchio<br />
di cui seguivo lo scrosciare sulla schiuma calda. Mi dicevano<br />
il crescere del volume del secchio attimo per<br />
attimo. Mi dicevano puntualmente quando dovevo<br />
porgere il bidone sulla siepe in cui il babbo vi versava il<br />
latte.<br />
Dal giorno di quella tremenda punizione non potevo<br />
più starmene impalato lì al varco a sentirmi e gustarmi<br />
l’odore del rumine. Mio padre pretese che anch’io<br />
svolgessi la mia parte. Dovevo ficcarmi in testa che ormai<br />
all’ovile eravamo in due e che anch’io ero un pastore<br />
fatto. E per togliere ogni dubbio mi insegnò subito<br />
l’unica cosa importante che ancora mi mancava per essere<br />
un vero pastore. Mi insegnò a mungere. Era necessario.<br />
Fece fare un secchio anche per me.<br />
La prima volta che entrai nella mandra le pecore si<br />
strinsero una all’altra. Si spaventarono. Come mungitore<br />
non mi conoscevano e alcune saltarono persino la<br />
siepe. Ci volle tutta l’esperienza del babbo per ricondurre<br />
il gregge e ricomporlo alla calma.<br />
Io avevo solo otto anni, ma la mungitura logudorese<br />
si presta anche ai bambini. Mio padre mi fece abbassare<br />
ed assumere la posizione dietro la pecora più mansueta<br />
del gregge, quella di più facile mungitura (sa pius<br />
ladìna). Mi fece incosciare il secchio con il fondale sotto<br />
il culo. E mi insegnò come si doveva tenere la mammella<br />
e come spremere i capezzoli con le dita bagnate o<br />
con la saliva o con la schiuma del latte già munto.<br />
109
La cosa non fu facile. Scapezzolavo male nei primi<br />
giorni e la pecora, Mutighèddha, rinculava e mi faceva<br />
andare a gambe all’aria.<br />
Nel primo periodo, mentre il babbo mungeva tutto il<br />
gregge, a stento riuscivo a fare un quarto di latte nel<br />
mio secchio, anche perché molte scapezzolate non cadevano<br />
nel secchio. Mi andavano a finire sulla braghetta<br />
(che ce l’avevo sempre sporca di latte) o sulle gambiere<br />
dei pantaloni o fuori completamente.<br />
In capo a due settimane, però, Mutighèddha la mungevo<br />
bene. E mio padre mi affidò anche Leperèddha<br />
(denominata così perché aveva le orecchie ritte come<br />
una lepre). In seguito mi poté affidare s’aivèghe aza (la<br />
pecora invaiata). Tutte di facile mungitura. Tutte ladìnas.<br />
Ben presto così mungevo quanto mi consentivano<br />
le forze.<br />
Nel primo periodo io, che non ero né forte né furbo,<br />
subivo le loro bizze e gli imprevisti dei loro capricci.<br />
Spesso quando avevo il secchio pieno quasi fino all’orlo,<br />
tutto bianco e parlante con il friggio della schiuma, e<br />
mi apprestavo a farlo vedere al babbo, la pecora che<br />
mungevo recalcitrava e rinculava. E nonostante mi<br />
sforzassi di tenerla alle mammelle, frenando il suo rinculo<br />
con la testa sulla coda, spesso me la faceva. Perdevo<br />
l’equilibrio. Mi metteva a gambe all’aria. Il secchio<br />
si rovesciava e il latte si spandeva sulla culata dei pantaloni<br />
(in sa culàtiga de sos cassònes). La mia prova svaniva<br />
dietro il calcio di una pecora “matta”. Allora spesso<br />
mi toccava subire gli schiaffi a man rovescio del babbo<br />
e ricominciare a mungere con il culo bagnato.<br />
La cosa più sconfortante, umiliante, però, era quando<br />
110<br />
la pecora mi cacava dentro il secchio senza che me ne<br />
accorgessi. Io continuavo a mungere e me ne accorgevo<br />
o dall’odore o dal color verdognolo del latte, una<br />
volta che lo sterco si scioglieva dentro. Bisognava buttar<br />
via tutto. Un secchio di latte equivaleva a una giornata<br />
lavorativa dell’agricoltore più bravo. Il babbo non<br />
me la perdonava. Spesso mi salvavo buttando via il latte<br />
di nascosto e tuffandomi di nuovo a mungere per recuperare.<br />
Ma lui quasi sempre se ne accorgeva. – Che<br />
hai oggi? Non hai munto nulla... Ma di pecore ne hai<br />
munto un sacco... Ahh. Ti hanno cacato, brutta bestia!<br />
Te la sei fatta la giornata, oggi! – Seguiva una scarica di<br />
schiaffi! – Tè! Tè! Miserabile! Ti fai gabbare dalle pecore...<br />
ancora non hai imparato. Te l’ho detto. Il culo<br />
glielo devi tappare con la coda pressandola con la testa.<br />
Tu hai sempre la testa fra le nuvole (jughes sempre sa<br />
conca in sas nues). – Spesso la sorte mi vendicava. Le<br />
pecore cacavano anche mio padre, lui che pur aveva<br />
sempre la “testa nel recinto”. Allora, umiliato, si scatenava<br />
contro di esse. – Una pecora cazzu! Huu! Huu!<br />
Brutta bestia merdosa. Paru gagàdu (animale cacato).<br />
Te la faccio assaggiare la tua merda, io. To’. Mangiala.<br />
Mangiala. To’, ora ti tappo anche gli occhi, le orecchie...<br />
tutto con la tua merda. To’. To’.<br />
Come era costume tormentava le pecore “viziose”.<br />
Le prendeva per le zampe posteriori (a issos aschìles).<br />
Le metteva la schiena per terra e via il piede sul collo.<br />
– Tè! tè! Ti ammazzo! Tu non mi devi prendere in giro<br />
a me... Hèè! Pecora matta (bivèghe addhinòsa).<br />
Erano scenate favolose. Chino sulla mia pecora, me<br />
le godevo crepando dalle risate. Certo, le risate le trat-<br />
111
tenevo al massimo, mentre lui parlava alle pecore come<br />
se capissero il sardo. Sapevo che ai suoi occhi dovevo<br />
anch’io partecipare alla sua rabbia. Per questo affondavo<br />
il volto tra le pecore. Se si fosse accorto che me la<br />
stavo ridendo ne avrei beccate anch’io.<br />
Gli stava bene, però. Per quel giorno lui non avrebbe<br />
potuto dirmi nulla anche se mi fosse successa la stessa<br />
cosa e potevo mungere tranquillo. Più d’una volta ne<br />
uscivamo cacati tutti e due cercando di nascondere la<br />
cosa o nel silenzio o nel fare frettoloso. Altre volte invece,<br />
il babbo non si conteneva. – Oggi ci hanno fatti belli<br />
queste bestie. Ci hanno cacati! Tutto perso! Che beffa<br />
(Ite ciònfra!).<br />
Ora che sapevo anche mungere, ero un pastore completo.<br />
Bastava solo crescere ed attendere che la biologia<br />
mi desse la forza. Il tempo idilliaco era per sempre<br />
finito.<br />
Mio padre allora passò all’educazione agricola cui fino<br />
ad allora ero rimasto estraneo. Subito mi insegnò a<br />
zappare all’oliveto e nella vigna. La sua educazione fu<br />
più fugace che mai: ciclonica come imponevano le circostanze.<br />
Lui zappava come un dannato, al punto che<br />
non sopportava di perdere un minuto per introdurmi<br />
alla nuova attività. Di tanto in tanto, e solo rapidamente,<br />
mi faceva vedere come tenere la zappa.<br />
– La destra la metti davanti, la sinistra dietro. La mano<br />
sinistra, con questo movimento... così; abbassando<br />
il manico ti aiuta a rivoltare bene le zolle. È un tocco segreto<br />
che si acquista con il tempo.<br />
112<br />
La lezione me la ripeteva due, tre volte al massimo. Al<br />
resto dovevo pensare io. Toccava a me rubargli il mestiere<br />
e i segreti osservandolo attentamente e con paura.<br />
Come avevo appreso a mungere e tutte le altre cose.<br />
E nonostante la rapidità delle sue lezioni, non ci misi<br />
molto a zappare, a rivoltare bene le zolle (a bostulàre<br />
ene sas cheves). In poco tempo, in questo modo frettoloso,<br />
con un’educazione “fuggiasca” e inesorabile, mio<br />
padre mi insegnò quanto l’agricoltura comportava.<br />
Quando potava (candho illistrìada), lo seguivo sul filare<br />
e portavo via, ricomposto in fasce, il sarmento da una<br />
parte e lo accatastavo.<br />
Nel periodo dell’innesto (in s’iffescónzu), quando innestava<br />
le viti o i peri selvatici (sas bides o issos piràstos),<br />
io lo dovevo seguire. Lo dovevo assistere cun su ajòne<br />
(una specie di catino di sughero), dove erano tutti gli<br />
arnesi: gli stracci, il rasoio, l’argilla e i giunchi. Dovevo<br />
intuire cosa volesse volta per volta senza che lui mi dicesse<br />
nulla.<br />
Si lavorava dall’alba al crepuscolo (dae s’avvéschida a<br />
iss’interighinàda). In continuazione. E durante i temporali<br />
invernali e le nevicate, quando gli agricoltori se ne<br />
stanno nei loro paesi, nelle loro cantine a gustarsi il vino,<br />
perché la terra non si può lavorare, il babbo non se ne<br />
stava a pancia a fuoco comènte ’e battu chijinéri in pagu<br />
fogu (come gatto ceneroso sul fuoco morente). Lui trovava<br />
sempre qualcosa da fare. – Andiamo a controllare i<br />
muri. Il vento di stanotte avrà tolto via la siepe da qualche<br />
varco. Il bestiame altrui (su bestiàmene anzénu) può<br />
introdursi nel pascolo ancora intatto (in su pàsculu ìnnidu).<br />
Andiamo! Tu vai da quella parte. Io da quest’altra.<br />
113
– Eh, va bene! Ci incontriamo in su addhìju, come<br />
l’altra volta.<br />
Spesso non si faceva in tempo nemmeno a fare il giro<br />
della tanca che ci si richiamava.<br />
– Ohoo Gavì! Ohoo Gavì!<br />
– Heee.<br />
– Vieni qui. Il muro ha franato. Bisogna rifarlo.<br />
– He, che tratto lungo ne è franato (nd’est ruttu).<br />
– È l’acqua di stanotte. Forza. Su!<br />
Per lui, però, questo non era lavoro. Non suonava<br />
produzione. Era un incidente.<br />
In questi periodi, l’unica cosa che per lui suonava lavoro<br />
era l’unico lavoro che si poteva fare: abbattere alberi<br />
ed estirpare ceppi nel bosco.<br />
– Appena schiarisce, prendiamo gli arnesi e andiamo<br />
ad abbattere s’àvure ’e sa codìna. Non ce ne stiamo qui<br />
tappati. Fuori, al lavoro, si fa movimento e ci si mette il<br />
sangue in moto (su sàmbene in motu). – Il suo temperamento<br />
laborioso e volitivo presto aveva fatto di me un<br />
perfetto spaccalegna prima ancora che fossi in grado di<br />
reggere al peso della scure.<br />
Nei primi tempi, abbattere gli alberi mi attraeva. Mi<br />
piaceva vederli cadere dall’alto delle loro cime. Mio padre<br />
ci metteva tutta la sua esperienza. Con la scure sulle<br />
spalle se lo squadrava bene. E già prima di farsi sotto<br />
sapeva quasi sempre da quale parte bisognava tagliarlo.<br />
Per essere più sicuro, però, lo colpiva con gli occhi<br />
alle branche ed al fusto (a sas naes e a su truncu). Lo<br />
soppesava e senza fallo stabiliva da quale parte pendesse.<br />
In base a questo, faceva un piccolo intaglio sul fusto<br />
dalla parte che doveva cadere. Poi si spostava dalla par-<br />
114<br />
te che conveniva tagliare in modo che cadesse senza arrecargli<br />
danno. Io osservavo bene tutte queste operazioni.<br />
Lui dava sul fusto con la scure. E durante le pause<br />
che faceva per prendere fiato, se lo riteneva opportuno,<br />
mi spiegava sempre qualcosa. – Abbattere un albero<br />
non è facile! La prima cosa è sapere da quale parte<br />
pende. Da quale parte cade. Tu devi tagliare sempre<br />
dall’altra parte in modo che te lo veda cadere senza pericolo!...<br />
– Ta! Ta! Ta! Ta! gli faceva la scure sul fusto,<br />
scaraventando le schegge intorno.<br />
– Una volta thiu Forìccu era venuto qui a far legna: a<br />
Thiantina... per farsi un carro di legna. Di poco senno<br />
(de pagos sentìdos) e inesperto, si tuffò subito a tagliare<br />
l’albero che il <strong>padrone</strong> gli aveva assegnato, così asinescamente<br />
(a issa ainèsca), senza guardare da quale parte<br />
l’albero sarebbe caduto. Forse non era nemmeno in<br />
grado. Per sua sfortuna l’albero era dritto dritto. Non<br />
era facile. E neanche a farlo apposta, il caso non gli fu<br />
favorevole. Si mise a tagliare proprio dalla parte sbagliata.<br />
Era un tipo che faceva di testa sua. Uno di quelli<br />
che non tornano indietro una volta che hanno incominciato,<br />
anche se hanno incominciato male. Me ne accorsi<br />
dall’oliveto di lontano. “Oh Forì!” gli gridai. “Taglia<br />
dall’altra parte. Dall’altra parte.” Macché! Lui dava<br />
e dava con la sua scure. Finché non si vide l’albero<br />
venirgli addosso. Poi, minchione, invece di indietreggiare,<br />
si è messo a correre dalla parte sbagliata, dove<br />
l’albero stava precipitando. L’albero lo raggiunse prima<br />
che si mettesse in salvo. Vista la cosa, ero lì nella collina,<br />
corsi subito. Con il suo amico, bell’altro stupido<br />
(àtteru bellu grabiòne) lo togliemmo di sotto. Lo met-<br />
115
temmo privo di senso sul carro e via a Sìligo. Era grave.<br />
Tutto fracassato (fidi tottu ibbisestràdu). Purtroppo, in<br />
capo a tre giorni morì (a issas tres dies est mortu!). Eh...<br />
stare attenti, bisogna stare. Lavorare con il cervello.<br />
Non con le calcagna (non cun issos cascànzos). Vedi, io<br />
so che l’albero cade da quella parte. Ho fatto i calcoli.<br />
Le vedi quelle branche? Eh? Fanno peso dall’altra parte.<br />
E poi basta squadrare il fusto e considerare! Certo,<br />
spesso succede che è difficile stabilire da quale parte<br />
cade. Allora devi stare attento. Appena vedi oscillare<br />
l’albero, le branche e le sue cime (sas naes e sas chimas<br />
suas), non bisogna perdere il controllo. Se il fusto ti viene<br />
addosso, basta aggirarlo. Non metterti a correre all’impazzata<br />
(a issa macconàzza) come thiu Forìccu. L’albero<br />
ruzzola a terra in fretta e se corri dalla parte sbagliata,<br />
fai la sua fine.<br />
Lui raccontava la sua lezione senza interrompere l’opera.<br />
Io ero lì, impaziente di vedere finalmente l’albero<br />
cadere. Sentirne il tonfo e lo schianto quando rovinava<br />
al suolo. Me ne stavo impalato, ma attento, finché mio<br />
padre non affondava l’ultimo colpo. La quercia oscillava<br />
sulla cima e veniva giù sfracellandosi a terra nelle sue<br />
branche. Una volta che l’albero era disteso, armato di<br />
roncola e di scure (de rustàgliu o de istràle) subentravo<br />
anch’io nel lavoro, a tagliare le fronde e le piccole branche<br />
(a ischimàre).<br />
Pulito dei rami, il grosso del fusto e delle branche si<br />
stagliava sul terreno sterposo in tutta la sua lunghezza e<br />
si procedeva con la sega.<br />
Non era facile manovrarla con la forza e il tocco dovuti.<br />
Muovere i gomiti con geometria e con ritmo. Fare<br />
116<br />
un bel taglio. Ma per non suscitare e per evitare la rabbia<br />
del babbo, per esaudire la storia, dovevo sempre resistere.<br />
Nel nostro campo continuava a non passare quasi<br />
mai nessuno. I pastori vicini (sos bighìnos), spinti dalla<br />
miseria, dovevano per necessità pensare a procacciarsi<br />
da vivere: non avevano il tempo di venirci a trovare.<br />
Inoltre, per ovvie ragioni, avevamo rotto quasi con<br />
tutti. Con i vicini ci si sentiva quasi avversari. Di notte<br />
uno cercava di rubare il pascolo all’altro, introducendo<br />
le pecore nei chiusi altrui. Di giorno, mentre pascolavo,<br />
ne sentivo le reazioni, gli effetti. I pastori si azzuffavano<br />
e litigavano scuotendo tutta la zona. – Stanotte,<br />
tu, brutto verme, ladro, delinquente, figlio di puttana,<br />
testa di cazzo, miserabile, farabutto, mi hai mangiato il<br />
pascolo, mi hai mangiato! (mi as manigàdu su bàsculu,<br />
as incujàdu in su meu!). Non ti permettere più! Se capitiamo<br />
insieme (si faghìmus paris)... ti faccio un bel giovanotto!<br />
Ti concio per le feste. Ti servo le uova sode!<br />
Mettitelo bene in testa: i coglioni ce li ho anch’io! Minchione!<br />
E in altra occasione: – L’avevo conservato per te, per<br />
le tue pecore, fin’ora, il mio chiuso! Te lo faccio vedere<br />
io quanto pesano i miei coglioni! Brutto delinquente!<br />
Traditore! Io ho i coglioni più grandi dei tuoi! Capito!<br />
Non mi fotti! (Deo jutto sos cozzònes pius mannos de<br />
isos tuos! Cumprésu asa! non mi futis pius!) Se ti trovo lì<br />
ti metto segno per i tuoi giorni! Ti flagello! Sei un vile,<br />
sei. Ne hai approfittato: ero assente. Me la pagherai...<br />
117
Ricordalo... Te lo ritornerò il piatto... non ti preoccupare.<br />
Così i pastori trascorrevano i giorni avvelenati come<br />
vespe nel vespaio scosso e le notti insonni appostati,<br />
con il fucile spianato o sul chiuso per difendersi il pascolo<br />
o il gregge mentre si ruminava la sua pastura. Di<br />
notte uno aspettava che il sonno vincesse l’altro in una<br />
gara estenuante incessante, perché potesse chiudere le<br />
pecore nel pascolo altrui.<br />
Di giorno sbrigavano i lavori agricoli per le provviste<br />
di casa. In paese non ci potevano andare quasi mai.<br />
Quelli che avevano pascoli e gregge in proprio potevano<br />
concedersi qualche capatina di giorno, ma raramente.<br />
I servi pastori o mezzadri pastori ogni quindici, venti<br />
giorni, se avevano un buon <strong>padrone</strong>. Quasi tutti erano<br />
scapoloni. Non avevano il tempo per conoscere e<br />
conquistare una ragazza.<br />
Gli sposati dopo lunghe e penose peripezie, si dovevano<br />
limitare a ustare le loro mogli solo di sfuggita. I<br />
giochi e le danze sui loro talami erano frettolosi mentre<br />
il gregge restava incustodito. I pastori in proprio, con il<br />
barbone ispido e nero, potevano concedersi almeno<br />
una volta la settimana di danzare alla svelta i loro coiti<br />
sui letti.<br />
Thiu Antonìccu, che pure era pastore in proprio,<br />
quando gli capitava, raramente, di andare a Sìligo, lasciava<br />
il suo ovile in fretta. Scrollava le gambe addosso<br />
al somaro e lo incitava alla corsa con il nodo alla gola e la<br />
libidine addosso. La bestia filava veloce sottoposta a un<br />
trotto disperato, ai sussulti e al prurito della “siccità”<br />
sessuale del suo <strong>padrone</strong>. A metà strada il trotto diveni-<br />
118<br />
va più concitato. Nell’ultimo chilometro il trotto diveniva<br />
corsa sfrenata. Finalmente giungeva sotto casa sua.<br />
Scendeva di scatto. Legava il somaro all’anello e lo abbandonava<br />
lì stanco e carico di tutto, sudato ed ansimante.<br />
Entrava in casa e cercava la moglie. Durante la<br />
danza del letto non esisteva più nulla: le pecore, i banditi,<br />
i chiusi di pascolo sparivano dalla sua mente. Si scatenava<br />
la bufera fischiando per la stanza. Grandinava e<br />
fioccava in abbondanza. La natura si sfogava e ritornava<br />
il sereno. E una volta spenta la sua sete sul letto scosso e<br />
disfatto dal ciclone di Eros, le pecore, il somaro rimasto<br />
fuori sotto il basto con i bidoni del latte, la legna e la bisaccia,<br />
gli ritornavano a comparire. – Povera bestia!... Il<br />
latte!... La legna!... Se mi hanno rubato qualcosa!...<br />
Tutto soddisfatto, sfebbrato, con il volto raggiante e<br />
ricomposto andava a scaricare la bestia, spesso tra il<br />
mormorio dei passanti: il somaro sotto carico legato all’anello<br />
parlava chiaro a tutti. Ritornato in sé, si faceva<br />
il barbone e si sentiva un uomo anche lui. Fresco, umore<br />
cristallino e cervello pronto a pensare alle cose.<br />
Non era un’eccezione. Era malattia dei pastori. Thiu<br />
Diddhìa faceva lo stesso. Lasciato l’ovile, quando veniva<br />
il suo turno per recarsi in paese, incitava il suo somaro<br />
al trotto più concitato.<br />
Anche lui arrivato in paese, soffocato dalla smania,<br />
non riusciva mai a scaricare la bestia. Si tuffava in casa.<br />
Si avventava sulla moglie. La mordeva tutta. La succhiava.<br />
La stringeva quasi la volesse strozzare. Accecato<br />
e contorto dalla smania, si scagliava contro gli abiti.<br />
Se li toglieva affannosamente con un solo gesto, come<br />
se fossero tutto un unico pezzo, scaraventandoli alla<br />
119
infusa! Con gli scarponi pieni di fanghiglia e con le<br />
gambe impastoiate dai pantaloni alle caviglie, si tuffava<br />
sulla moglie. Spesso saltando anche la spalliera: la smania<br />
non gli concedeva di fare il giro.<br />
Era la tarantella. Il letto a rete ballava quella musica<br />
lasciando cadere di tanto in tanto un oggetto che tonfava<br />
sul pavimento. La spalliera di lamiera sulla parete<br />
ballava anch’essa, esprimendosi e muovendosi a seconda<br />
della musica. Di colpo tutto si arrestava. La spalliera<br />
prendeva fiato per il prossimo ballo. Si riprendeva a suonare.<br />
Altro ritmo. Altra danza. Finalmente thiu Diddhìa<br />
impastoiato con i pantaloni alle caviglie si distendeva<br />
sulla moglie come un fiume dopo la tempesta.<br />
Spesso il frastuono della spalliera e della sua danza,<br />
tutta la battaglia con gli spari e le esplosioni, uscivano<br />
dalla finestra che thiu Diddhìa e la moglie avevano lasciato<br />
aperta.<br />
Le schioppettate colpivano i paesani sulla strada.<br />
– Bah... Thiu Diddhìa sta facendo la funzione.<br />
– Se lo sta ballando il ballo sardo!<br />
– Tu stai zitto! Abbiamo poco da dire! Noi facciamo<br />
lo stesso! Scherzi della fame!<br />
– Beh! Non perdiamo altro tempo. Quella bestia sta<br />
prudendo anche a me, ora, maledizione!<br />
– A chi lo stai dicendo...<br />
Si tuffavano sui loro somari. Si lanciavano verso le loro<br />
case a spegnere il fuoco alla fontana delle loro compagne<br />
che ardevano anch’esse, anch’esse incustodite<br />
ed incolte nella loro latitanza sessuale.<br />
Questo per quanto riguarda i pastori in proprio, già<br />
sposati.<br />
120<br />
Quanto a noi ragazzi sotto i vent’anni (forse era uno<br />
scherzo del latte o del formaggio) si sfogava la nostra<br />
esuberanza in tutte le maniere. Per le valli, le selve, il<br />
bosco e per le colline dappertutto fischiavano le seghe,<br />
rabbiose e fameliche. I cespugli come in preda alla<br />
tempesta erano scossi dalla bufera delle nostre mani.<br />
Quando si era dietro le pecore o al lavoro spesso ci venivano<br />
gli attacchi: respiro affannoso, nodo alla gola e<br />
cazzo a bastone, più duro del manico della zappa che<br />
si aveva tra le mani.<br />
Se si era soli ci si intanava nel primo cespuglio che si<br />
trovava. Ci si sbraghettava e ci si strangolava il bestione<br />
focosamente. Ci si distendeva con gli occhi chiusi per<br />
“vedere” le grazie o qualche inizio di coscia di una fanciulla<br />
che si era vista occasionalmente. Non esisteva<br />
più nulla allora, né gregge né zappa, che spesso si lasciava<br />
infissa sul terreno prima di rintanarci, né acqua<br />
né gelo così come succedeva a thiu Antonìccu e a thiu<br />
Diddhìa.<br />
E sotto il sole e nel silenzio del bosco ci si distendeva<br />
per godere di questa concessione: la distensione segale.<br />
Spesso il cespuglio, la nostra donna, oscillava a singhiozzo<br />
e subiva gli scossoni della destra inarrestabile<br />
e del corpo elettrizzato che si contorceva nelle varie riprese.<br />
Tra pastorelli, se il caso ci dava la possibilità di incontrarci,<br />
le seghe si facevano a gara. Un modo come un altro<br />
per esprimere la nostra forza e far vedere uno all’altro<br />
cosa si era in grado di fare.<br />
– Ciao compà! Oggi vi batto. Sto facendo sempre allenamento.<br />
L’altro giorno sono arrivato a otto!<br />
121
– E perché io non ci arrivo a otto? Avantieri me ne<br />
sono fatto quattro in un quarto d’ora. Anch’io mi alleno.<br />
Quando mio padre se ne va, mi sdraio sotto l’albero<br />
e non mi muovo più. Rotolo solo per seguire l’ombra<br />
quando si sposta con il sole.<br />
Quando si era sui dodici-tredici anni, con tre amici mi<br />
successe una cosa che provo quasi vergogna a confessare.<br />
Pochi giorni prima c’era stata la vendemmia nella vigna.<br />
Per tagliare l’uva il babbo aveva fatto venire alcune<br />
ragazze sui diciotto vent’anni. Tutto il giorno noi ragazzi<br />
sbirciammo le loro sottocosce. Non era ogni giorno<br />
che ne vedevamo. E naturalmente, insieme, tentammo<br />
due-tre attacchi segali, chi contro una chi contro l’altra,<br />
nella nostra fantasia ingelosita.<br />
Passati alcuni giorni piombammo sul punto dove<br />
quelle ragazze andavano a pisciare e a cacare. Quel<br />
giorno furono le seghe più violente che si potessero fare,<br />
alla vista della cacca ormai secca che ognuno si immaginava<br />
fatta da questa o da quella. Dove ci si sdraiò,<br />
ognuno pensava che quel punto fosse stato pisciato<br />
dalla sua preferita.<br />
Oppure si ricorreva ad espedienti meno frequenti,<br />
ma diffusi ugualmente: con le bestie.<br />
Un giorno, di ritorno da Sìligo, in su Tuvu io e G. fummo<br />
spettatori di una cosa del genere. Sulla strada maestra<br />
dai nostri somari che ci facevano fare capolino sui<br />
chiusi che vi si snodavano, ci capitò sotto gli occhi un<br />
pastorello alle prese con la sua somara.<br />
– Va a finire che se la fa, – fece G.<br />
Il pastorello, sui quattordici anni, provava, ma non ci<br />
arrivava da terra. Allora fece accostare la sua donna a un<br />
122<br />
mucchio di pietre. Vi salì. E finalmente le sue gambe gli<br />
permisero di congiungere il molle con il sodo. Si calò i<br />
pantaloni e cavalcò la sua bestia con un fare intraprendente<br />
come se ne avesse il diritto: era sua. Si scosse il culetto<br />
e subito si calmò abbracciandosi alla sua amante,<br />
distendendosi sopra di lei dopo averle fatta la funzione.<br />
– Tu te la faresti la somara? – chiesi a G.<br />
– Io me la sono già fatta in Capiàna. Fùria de mincra<br />
libera nos domine!<br />
Non erano i soli. La maggior parte lo faceva e tutti<br />
pensavamo di farla. Di preferenza con le pecore e con<br />
le capre.<br />
Thanne ci tentava spesso quando il padre lo mandava<br />
da solo a abbeverare il gregge, lungo il sentiero dietro il<br />
solito polverone. In genere lo faceva al cancello che<br />
sbarrava la strada al suo gregge prima di uscire dal<br />
chiuso. Le sue pecore si pressavano al varco. Lui le attraversava<br />
per raggiungere il cancello, ma non sempre<br />
riusciva ad aprirlo; veniva colto dai soliti attacchi. Allora<br />
si calava in mezzo al gregge ammassato. Si sceglieva<br />
quella che per lui era la più bella. La metteva pancia all’aria<br />
per sentire il turgore delle mammelle sul ventre e<br />
se la faceva frettolosamente coi pantaloni calati a mezza<br />
coscia mentre il gregge attendeva sotto il sole che il<br />
pastore aprisse il cancello. In quel momento neanche il<br />
cannone poteva distrarre l’amante che stava inventando<br />
la donna.<br />
Una volta degli amici mi convinsero (eravamo piccoli<br />
sui dieci anni, a Sìligo, durante una delle ore di libertà<br />
che il babbo mi concedeva di andarci) di assalire un<br />
pollaio di un amico. Eravamo in tre. Entrati dentro e<br />
123
tra lo schiamazzo delle galline ognuno se ne scelse una<br />
e si mise a fare la funzione tra le risate reciproche.<br />
– Compà, questa dal collo implume ha il culo caldissimo.<br />
È una meraviglia. – Ognuno la volle provare. Effettivamente<br />
era vero.<br />
Quanto ai servi pastori e agli scapoloni, la latitanza<br />
sessuale era completa. Molti i cespugli li continuavano<br />
a frequentare fino a che non si sposavano e qualcuno fino<br />
alla morte se la sua esuberanza gli concedeva questa<br />
beatitudine solitaria. Per i servi pastori vigeva allora<br />
una regola. Verso i diciotto anni, il <strong>padrone</strong> li portava<br />
nelle case di tolleranza almeno una volta all’anno, così<br />
potevano stuzzicare la loro fantasia per almeno molti<br />
mesi tra i cespugli del bosco.<br />
Sentivo dire dai pastori di Sìligo un fatterello curioso,<br />
ma veritiero. Il <strong>padrone</strong> aveva promesso di portare il<br />
suo bravo servo a Sassari per accoppiarlo, ma indugiava<br />
sempre, un po’ perché non trovava il tempo e un po’<br />
perché non voleva spendere soldi. Il servo insisteva<br />
sempre, mese per mese.<br />
– Thiu Antó! Ma quando mi portate lì. Eh... Me lo<br />
avete promesso!<br />
– Va bene. Domenica andiamo.<br />
E quella volta ci andarono. Per il servo Giommarìa<br />
era la prima volta.<br />
Quando il servo ritornò all’ovile, tutti gli altri servi<br />
più piccoli che aspettavano il loro grande giorno (sempre<br />
che avessero avuto un buon <strong>padrone</strong>) fecero a gara<br />
per sapere.<br />
– Beh! Giommarì, che gusto ci si prende a fare l’amore?<br />
Com’è?<br />
124<br />
– Eh! Tutt’altra cosa è. È senza coda!<br />
Agli sposati, poi, non è che bastassero i rari amplessi<br />
di turno. Spesso anch’essi dovevano ricorrere ai “lavori<br />
manuali” dentro i cespugli. Le loro mogli, nei paesi,<br />
dovevano vivere la stessa siccità; e se erano fedeli fare<br />
come i mariti.<br />
I don del paese facevano razzia di queste spose abbandonate<br />
dalle circostanze. Questi rapaci, i cui padri<br />
o avi in base alla legge delle chiudende (1824 e fino al<br />
1848) erano divenuti i più grandi latifondisti del paese,<br />
erano sempre quelli che davano le terre in affitto ai pastori.<br />
E dominavano su tutti. Aquile della situazione.<br />
Anche se non si ricordavano più come erano fatte né<br />
dove erano le loro tanche, continuavano sempre a riscuotere<br />
i tre quarti del raccolto o un fitto corrispondente<br />
senza muovere un dito. Con le ceste piene di formaggio<br />
e i granai ricolmi di biada (cun sas coves piènas<br />
de casu e sas lùscias piènas de laòre) potevano spassarsela<br />
come volevano per il paese. E quando i loro coloni<br />
pastori se ne stavano come al solito a lavorare i propri<br />
campi o al pascolo con il gregge, i don, come rapaci in<br />
pollai incustoditi, calavano sulle donne abbandonate.<br />
I don sparvieri facevano colpo su queste galline che,<br />
com’era costume, allora le accoppiava solo l’autorità<br />
del prete o quella dei loro familiari. A differenza dei loro<br />
mariti i don avevano sempre la barba fatta e le mani<br />
morbide. Non puzzavano di pecora né di cacio. E data<br />
la loro posizione non gli era difficile “sedersi” le mogli<br />
dei loro stessi pastori. Spesso, anzi, le ricattavano.<br />
– L’anno prossimo tuo marito non avrà la tanca. Se<br />
ami tuo marito, fallo, su.<br />
125
Don Juànne per vantarsi con i suoi amici sparvieri e<br />
col proprio servo addirittura diceva:<br />
– Oh, Antó!<br />
– Ei, Don Juà, comandi!<br />
– Bona ti sembra la moglie del tale?<br />
– Caspita, Don Juà!<br />
– Dille che le debbo dare un corbello di fave (una cóvula<br />
de fae) o daglielo tu stesso. Poi ci passo io.<br />
Il servo che curava i granai, sapeva già cosa doveva fare.<br />
In qualche modo cercava di dare del grano alla donna,<br />
che quasi sempre ne aveva bisogno per fare il pane<br />
ai propri figli. Don Juànne quindi aveva la scusa per capitare<br />
in casa nel pollaio incustodito. Catturare la donna<br />
con il grano coltivato dallo stesso marito della “gallina”.<br />
Thiu Laréntu, rispettato da tutti nel paese (aveva moglie<br />
e figli invidiati) un giorno si era crogiolato un po’<br />
troppo sulla sua serva e l’aveva messa incinta. Subito ricorse<br />
ai ripari in un modo abbastanza comune. – Non ti<br />
preoccupare, Luisa.<br />
– Dimmi con chi ti vuoi sposare. Quale dei miei servi<br />
ti piace?<br />
– Ma... ora sono...<br />
– Non fa nulla! Ci penso io!!!<br />
– Ma missignorì... non è...<br />
– Dimmi: Antóni, Juànne o Gavìnu?<br />
Thiu Laréntu sapeva che tra Luisa e Antóni c’era stato<br />
del tenero, ma fino ad allora lui stesso era riuscito a distoglierne<br />
la ragazza, nonostante le insistenze del ragazzo.<br />
Ormai, però, poteva finire nelle mani del servo. Sellò il<br />
cavallo e scese subito nell’ovile. Si fece chiamare Antóni.<br />
126<br />
– Senti Antó! Da domani, starai in paese fino alla fine<br />
della raccolta delle ulive. Ci vai con Luisa. Si stanno<br />
guastando: stanno cadendo in mezzo all’erba... è tempo<br />
ormai... Di te mi fido!<br />
– Sì missignorì! Va bene! Va bene! Comandi!<br />
Antóni se ne stava andando. Thiu Laréntu però lo<br />
raggiunse mentre usciva dalla capanna, con la sua voce<br />
imperiosa:<br />
– Ascolta, Antó.<br />
– Comandi, missignorì!<br />
– Prenderai la cavalla grigia (s’ebba murra). Ti metti<br />
Luisa in groppa... ehh! non toccarla, no... Hai capito?<br />
Non toccarla ehh! Tu sei un bravo ragazzo (unu teràccu<br />
onu) e mi fido. Se la tocchi, lo sai quello che succede,<br />
no? Che non ti vengano i grilli per la testa. Ti toccherebbe<br />
sposarla. Io non voglio scandali. La mia casa è<br />
onorata e rispettata da tutti.<br />
– No, missignorì! Non mi succede nulla! Eh! Non si<br />
preoccupi. Luisa con me non avrà alcun male... Raccoglieremo<br />
solo le ulive.<br />
– Eh! Così va bene! Sellati la cavalla e vai in paese.<br />
Domani potrete partire presto.<br />
Il giorno dopo, di buonora Antóni partì per l’oliveto<br />
con Luisa. Giunti sul posto, senza fare caso alle grazie<br />
della ragazzona, si arrampicò sull’albero a scuoterne le<br />
branche: ad abbacchiarle con la pertica (cun sa mazzadòsa)<br />
e a mungere i rami. Le ulive cadevano abbondantemente<br />
per terra ammassandosi sulle aiuole (in sas costìnas).<br />
Luisa per terra mungeva anche lei i rami bassi e<br />
laterali direttamente dentro il corbello. Antóni dall’alto<br />
della pianta di tanto in tanto fingeva di prendere fia-<br />
127
to e approfittava per sbirciare attraverso i fitti rami le<br />
turgide tette di Luisa, i capelli corvini e tutto quello che<br />
i suoi occhi riuscivano a prendere di sfuggita. Ad un<br />
certo punto anche Luisa si arrampicò sull’albero a<br />
mungere i rami più alti della pianta. Antóni così se la<br />
poteva squadrare meglio. Finalmente le poteva vedere<br />
il grosso delle cosce rossastre e i fianchi. La ragazza<br />
mungeva e come per rompere il silenzio, l’imbarazzo<br />
del compagno di lavoro, intonò un canto:<br />
– …unu piantòne nou / a sos campos est dendhe umbra...<br />
– Finito di abbacchiare l’albero e munti i rami<br />
bassi, presero un’aiuola ciascuno e incominciarono a<br />
raccogliere. L’aiuola di Luisa era scoscesa e più in alto<br />
Antóni poteva vedere fino in fondo e pregustava il giardino<br />
delle sue cosce dure e lisce lisce. Chino sul corbello,<br />
Antóni sembrava un ciuco in fregola. Ma Thiu<br />
Laréntu lo tratteneva.<br />
Luisa, però, istruita dal suo <strong>padrone</strong>, lo doveva provocare.<br />
Gli ordini erano questi. In mille modi quando<br />
si spostava dietro le ulive si metteva in mostra.<br />
– Antó! M’imbocchi il sacco? – diceva quando il suo<br />
corbello era pieno.<br />
E mentre si chinava per capovolgervi il corbello, opportunamente<br />
gli sfregava pudicamente le chiome sul<br />
viso. A mezzo giorno, lasciarono i sacchi ritti sotto la<br />
pianta e andarono a mangiare in una capannetta (in su<br />
pinnéttu), vicino al cancelletto d’entrata (in sa jaga). Incominciarono<br />
il pranzo. Antóni però non si contenne<br />
più di fronte a Luisa.<br />
In uno slancio di libidine si accostò a Luisa, che, benché<br />
dovesse farsi aggredire, si ritrasse. Ma Antóni or-<br />
128<br />
mai si era scoperto. Aveva incominciato. Andasse come<br />
andasse Luisa si schermiva. Antóni avanzava. Su pinnéttu,<br />
però era piccolo. Schermi schermi, le spalle di<br />
Luisa toccarono la parete. Non poteva più indietreggiare.<br />
Il momento era giunto. Antóni la ghermì sulle<br />
cosce. Ormai era sua. La ragazza si lasciò andare come<br />
succube della circostanza.<br />
Su pinnéttu, la cui impalcatura poggiava direttamente<br />
sul terreno (a fustes in terra), oscillava nella sua cuspide<br />
di stoppie e sopportò malamente la tempesta. I<br />
due amanti si sbattevano nei loro amplessi, ormai avvinti<br />
l’uno all’altra e strombazzandosi come conigli. Fu<br />
il momento più bello della vita di Antonio e forse anche<br />
di Luisa. Finalmente poteva sposarsi: le catene con cui<br />
Thiu Laréntu la teneva “zitella” si erano spezzate nello<br />
scontro con la morale comune: era libera.<br />
Nella loro foga amorosa erano andati a finire con le<br />
gambe fuori dal pinnéttu e nel frastuono più sfrenato<br />
(forse anche all’insaputa di Luisa) piombò Thiu Laréntu,<br />
che non si lasciò sfuggire l’occasione di recitare la<br />
sua parte.<br />
– Disgraziato! Delinquente! Te l’avevo detto di non<br />
toccarla... Che non avrei sopportato scandali in casa<br />
mia... Farabutto. La mia casa nello scandalo! Ora te la<br />
sposi... Sennò ti rompo le ossa!!!... Proprio con Luisa ti<br />
dovevi mettere!!!... La migliore tra le mie serve...<br />
Ehhh!!! Balle!!! Ora paghi. Preparati a sposartela...<br />
– Scusi, missignoria, io...<br />
– Io un corno!... Non c’hai visto più.<br />
– Sì, io, a Luisa le voglio bene. Ci siamo innamorati:<br />
me la sposerò. Non sarà uno scandalo, anzi, La ringra-<br />
129
zio! Sì La ringrazio ché Lei ci permette di sposarci.<br />
Grazie! Glielo prometto che non sarà uno scandalo!!<br />
– Me lo prometti? Va bene! Non te la prendere! Io<br />
sono andato in bestia! Potevate parlarmene. Non sono<br />
cose da fare di nascosto queste... Quello che ti posso fare<br />
lo farò. Metterò una buona parola con i suoi genitori...<br />
Ma la verità la dovranno sapere. Io non posso tacere.<br />
Peggio per voi! Cercherò di aiutarti per il corredo.<br />
Potrai fare il mezzadro con me... Ma è una cosa da fare<br />
subito... Prima che scoppi la grana... Stanotte stessa andrò<br />
dai suoi e vedremo di affrettare le nozze, – sentenziò<br />
Thiu Laréntu scomparendo.<br />
Mio padre era sempre desideroso di farsi onore: di<br />
accrescere il peculio familiare, di finire l’oliveto che<br />
aveva già iniziato. E si lamentava sempre del fatto che<br />
perdeva troppo tempo nell’andirivieni tra Sìligo e Baddhevrùstana<br />
per fare provviste. L’unica soluzione gli<br />
sembrava quella di ritornare all’antico: deportare tutta<br />
la famiglia all’ovile, come avevano fatto i suoi zii e suo<br />
padre.<br />
Il suo proposito si diffuse subito per il paese. E nel<br />
parentado e nella famiglia destò scalpore e sgomento<br />
insieme. Era un’abitudine antichissima far risiedere la<br />
famiglia all’ovile. Ma già nel ’49 per Sìligo e dintorni<br />
era una cosa sorpassata. I pastori, nonostante tutto, facevano<br />
il possibile perché le loro mogli rimanessero in<br />
paese con i loro figlioletti in modo che frequentassero<br />
la scuola elementare. Allora le famiglie fuori dall’ufficialità<br />
storica e segregate in campagna, erano solo sette<br />
130<br />
o otto. E quasi tutte queste famiglie erano barbaricine<br />
o dell’interno dell’isola.<br />
L’idea di mio padre quindi non poteva più trovare<br />
orecchie amiche tra gli abitanti di Sìligo. I parenti più<br />
stretti si scagliarono contro di lui.<br />
L’ultimo tentativo lo fece il nonno materno. Come<br />
tante altre volte, capitò in campagna, a Baddhevrùstana.<br />
E non mi raccontò le sue storielle né mi fece le sue<br />
battute come soleva fare scherzosamente:<br />
– Oggi sono venuto a portarmi via il pozzo che ha fatto<br />
tuo padre!<br />
– Il pozzo? E noi come facciamo... Non ci credo! E<br />
dove lo porti?<br />
– Lo metto dentro la bisaccia e me lo porto a Monte<br />
Ruju. Là, lo vedi?<br />
– Ma il pozzo è profondo e non ce la farai a toglierlo.<br />
Voglio vedere!<br />
– Lo tolgo fuori. Scavo con il piccone.<br />
Quel giorno niente di questo. Si vedeva che era venuto<br />
per qualche cosa insolita. Lui si mise a lavorare con il<br />
babbo. Fece finta di nulla. Tra una faccenda e l’altra,<br />
però trovò il modo di scivolare sull’argomento.<br />
– Ho sentito che vuoi portarti la donna qui all’ovile.<br />
Ma che ti salta in testa (ite ti pìgada a conca)? Sei geloso?<br />
Non credo sia questa la ragione.<br />
Il babbo dopo un momento d’imbarazzo e di silenzio<br />
iniziale, che superò aumentando il ritmo del suo lavoro,<br />
gli rispose con la solita foga.<br />
– Certamente! Qui, come vedi, ho molto da lavorare.<br />
Non posso perdere il mio tempo per strada. Tra Sìligo<br />
e Baddhevrùstana. Il ragazzo è ancora piccolo.<br />
131
Non può stare sempre a pane e formaggio. Io stesso<br />
quando qui ci sarà la donna, starò meglio. Lavorerò di<br />
più. Anche lei mi aiuterà in alcuni lavori. Gavino è già<br />
grande. Ha nove anni, ormai, e mi potrà aiutare nell’agricoltura,<br />
se nel gregge lo sostituisce Filippo, che<br />
ne ha già sei. Insomma quando la famiglia è qui, cambierà<br />
tutto. Il lavoro sarà in casa. Tutti produrranno.<br />
La questione è tutta qui. Ognuno si deve produrre<br />
quello che si mangia.<br />
Il discorso era concitato. Il babbo si dimenava e si<br />
sforzava per vincere l’imbarazzo e darsi più autorità.<br />
La sua foga mi ricordò il discorso che quattro anni prima<br />
aveva fatto alla maestra. Il nonno per un attimo fu<br />
travolto. Rimase allibito e mortificato. Disarmato. Si rifugiò<br />
nel silenzio e piombò in uno stato di disagio. Un<br />
attimo di attesa. Il ritmo del lavoro salì vertiginosamente<br />
sui filari della vigna. L’unico mezzo che le circostanze<br />
offrivano per vincere l’uno il disagio dell’altro. Le<br />
zappe salivano e scendevano rivoltando le zolle risalendo<br />
di nuovo come impazzite.<br />
Di colpo, il nonno si armò nella riflessione. Si rizzò.<br />
Si appoggiò il fianco al manico della zappa sul filare e si<br />
scaricò in una tirata di rabbia. – E che vuol dire perdere<br />
tempo per strada? A Sìligo ci dovrai andare lo stesso a<br />
fare provviste e a portarci il latte. Anche quando qui ci<br />
avrai la donna. Questa storia non regge. Tu non puoi e<br />
non devi assolutamente disporre della famiglia a seconda<br />
dei tuoi comodi. Devi fare gli interessi della famiglia.<br />
Devi fare come fanno gli altri. È una vergogna.<br />
Una beffa. Tu guasti l’onore della famiglia. Vergognati!<br />
Questo lo ha potuto fare tuo padre in su Colomìnzu!<br />
132<br />
Erano altri tempi. Ora ci sono le scuole e tu devi mandare<br />
i figli a studiare.<br />
– Studiare? Scuola? Prima bisogna campare. Io non<br />
posso mandarli a scuola tutti quanti. Se ne mando uno<br />
nascono le invidie tra quelli che non potrò mandare.<br />
Non farò parzialità. Il governo? Il governo ci deve pensare.<br />
Perché non ci pensa lui? Mi dia un tanto a figlio.<br />
Cosa vogliono questi?<br />
– Pastori molto più poveri di te li mandano. La famiglia<br />
la lasciano in paese. E tu? Tu che possiedi questa<br />
tanca. Io ti posso aiutare. Non fare questa beffa.<br />
– Ma che beffa! Beffa est a furàre! La tanca è tutta<br />
piena di cisto: est unu mudejàzu. Bisogna bonificarla.<br />
Sennò il pascolo e l’oliveto non crescono.<br />
Mio nonno era abbastanza saggio e forse comprendeva<br />
bene quale “rovina sociale” sarebbe stata la “deportazione”<br />
della famiglia. E anche se la decisione del<br />
babbo gli suonava come “uno scandalo del casato”,<br />
“una vergogna”, il suo discorso era giusto, ma solo per<br />
il fatto che la morale comune si vergognava già di fare<br />
un’azione del genere.<br />
– Io ho allevato otto figli, – continuò il nonno. – Il<br />
pastore l’ho fatto prima di te e anche in tempi più duri.<br />
Come tu sai, io ero un servo pastore. Lo sai che mi sono<br />
fatto da solo. Quando mi sono sposato non avevo<br />
nulla. La mia fidanzata cambiò il gherone alla camicia,<br />
l’unica che avevo. Eppure, la famiglia non me la sono<br />
portata all’ovile anche se mi avrebbe fatto comodo. Si<br />
sa che la donna piace averla sempre giorno per giorno...<br />
All’ovile ci venivano tutti. Io pretendevo molto<br />
da loro, anche dalla donna. Ma questa beffa non l’ho<br />
133
fatta, io. Un conto è farli lavorare qui occasionalmente,<br />
un altro segregarli qui come le tue bestie, per sempre<br />
nel silenzio. Se questo lo hai fatto con Gavino, ora non<br />
farlo con gli altri. La donna è bella di notte, ma il dovere,<br />
il dovere è un’altra cosa.<br />
Mio padre quel discorso lo capiva benissimo. Altri<br />
motivi e altri intenti, tuttavia, glielo rendevano banale,<br />
estraneo, non importante, quasi fosse un lunghissimo raglio<br />
di somaro come ne sentiva tanti durante i suoi lavori.<br />
Il divagamento di Baddhevrùstana da soli parlava a<br />
favore di mio padre. Si mangiava quasi sempre asciutto.<br />
I vestiti sempre sporchi e unti: sudore e latte. La solitudine,<br />
poi, di quel bosco ci divorava e ci inghiottiva.<br />
Ci masticava e ci digeriva nelle sue selve.<br />
Quando andavo a Sìligo d’estate o in autunno (in s’istìu<br />
o in s’atùnzu), spesso facevo di tutto per condurmi<br />
Filippo a Baddhevrùstana. Mi faceva compagnia, giocavo.<br />
E anche se era più piccolo riuscivo ad adattarmi.<br />
Prima fu lui stesso a pregarmi di portarlo in groppa.<br />
Alla fine, la sua curiosità per la campagna si esaurì. Mi<br />
veniva sempre più difficile portarmelo via. Si comportava<br />
come io mi ero comportato con mio padre. A me<br />
toccò fare come lui.<br />
Anch’io ricorrevo agli zuccherini con cui mio padre<br />
nel primo periodo mi riconduceva all’ovile.<br />
– Ci vieni oggi in campagna? Nella vigna l’uva sta maturando.<br />
Sta diventando nera (este dinghèndhe). Ieri ho<br />
contato otto acini già neri in un solo grappolo (deris appo<br />
contàdu in d’unu solu udròne otto puppugiònes già<br />
nièddhos).<br />
– È buona per mangiare?<br />
134<br />
– Sì! È già dolce! Su pirastùlu (una qualità di pera),<br />
poi, è già maturo. Tutto color croco (est lómpidu e grogu<br />
meru).<br />
– Allora ci vengo.<br />
– Nella vigna vengono molti uccellini a beccarsi gli<br />
acini già neri.<br />
– Il babbo ci ha fatto una baracca vicino a issa bira<br />
muntò e vi ha portato una tamborlana. Io me ne sto<br />
quasi sempre lì, a colpirla con un bastone. Fa un suono:<br />
una campana! Gli uccelli allora sorvolano, ma non<br />
s’abbassano a mangiare.<br />
– Andiamo! Voglio vedere tutto.<br />
– Monta in groppa!<br />
Così anche Filippo spesso faceva la solita strada tutto<br />
incuriosito in groppa. Una volta arrivati, si annoiava. Io<br />
non avevo molto tempo per giocare, dovevo lavorare.<br />
Il babbo, poi, non voleva che me lo portassi. Il gioco<br />
mi distraeva dal lavoro. Sotto il pero, spesso “rintoccavamo”<br />
la tamborlana: suoni e suoni: le campane<br />
di Baddhevrùstana.<br />
Così tutto il periodo estivo, da quando l’uva incominciava<br />
a tingersi (in su cabidànni), Filippo riuscivo<br />
ad allettarlo e a portarmelo.<br />
Era sempre più difficile, però. Man mano che il tempo<br />
passava esaurivo le cartucce, gli zuccherini: non<br />
avevo più curiosità da mostrargli. Io dovevo sfogarmi<br />
picchiando la tamborlana sotto il pero e gridare agli uccelli<br />
la mia desolazione.<br />
Ben presto le cose cambiarono. Il babbo si decise a<br />
condurre, tra la recriminazione della gente, tutta la famiglia<br />
all’ovile.<br />
135
– Oggi vado in paese a prendere tua madre e i tuoi<br />
fratelli: non starai più solo.<br />
– Ma veramente!<br />
– Certo.<br />
– Ora vado: stai attento al gregge!<br />
Lì per lì provai una gioia immensa: sarebbe finita la<br />
desolazione della mia infanzia e la “prigionia” del silenzio.<br />
Giunto a Sìligo, il babbo tra il disappunto della gente<br />
e la desolazione della mamma, noleggiò un camion e<br />
con l’aiuto di alcuni ragazzi vi fece caricare tutto.<br />
Si scatenò il temporale della morale comune: lui non<br />
se ne curò nemmeno: non voleva accorgersene!<br />
– Ora si porta anche gli altri, a svezzare in campagna.<br />
– Deve essere geloso della moglie! Se non l’ha sotto<br />
gli occhi non vive tranquillo!<br />
Mio padre non dava retta né peso alla morale comune<br />
più “avanzata”. Imperterrito e fermo nei suoi propositi<br />
caricava la roba sul camion. Si dibatteva da una<br />
parte all’altra dando ordini, sistemando tutto, <strong>padrone</strong><br />
della situazione.<br />
I miei fratelli, richiamati dalla scuola montarono sul<br />
carro guidato dal babbo. La mamma vi montò piangendo<br />
sotto lo scialle nero. La gente sputò gli ultimi<br />
commenti, spifferando e “leggendo” qualche brano saliente<br />
della vita del babbo. Il carro sfidò la tempesta. Si<br />
mise in moto e pian piano si allontanò sulla strada bianca<br />
verso Baddhevrùstana.<br />
Il carro era libero. Si allontanava sempre più dalla<br />
morale comune inasprita ed agitata strappando per<br />
sempre i miei fratelli dal mondo “ufficiale”, dalla sto-<br />
136<br />
ria, così come io ero stato strappato cinque anni prima<br />
dal somaro, incitato dallo scrollare delle gambe nervose<br />
di mio padre.<br />
Con loro ora tutto era diverso. La casa e la capanna<br />
addobbate assumevano un aspetto mai visto. Persino il<br />
campo ora parlava un’altra lingua. Le grida, i pianti banali,<br />
i canti dei miei fratelli, si spandevano dappertutto,<br />
modificavano la quiete delle sue valli: il silenzio mai<br />
turbato che a me parlava segretamente o quando la natura<br />
crepava dalle risate in primavera o quando d’inverno<br />
ululava gelo e bufera.<br />
E alla faccia della morale comune, ora, io stavo meglio<br />
davvero. Ogni giorno trovavo il pranzo pronto e ci<br />
si riuniva a tavola come se fossimo stati a Sìligo. Tutto<br />
era pulito. La mamma addirittura scopava lo spiazzo.<br />
La presenza all’ovile dei miei fratelli aveva fatto scattare<br />
automaticamente la scala gerarchica. Una catena<br />
che coinvolgeva tutti i membri della famiglia. Si era<br />
sciolto ora il binomio Gavino-natura. E in assenza del<br />
babbo, secondo costume, a me spettava il ruolo di capo.<br />
Quando lui si assentava, io dovevo fare il soprastante.<br />
Nei primi tempi i miei fratelli avevano paura degli<br />
animali, degli insetti e delle serpi. Allora dovevo<br />
imitare mio padre nel distruggere nella loro mente i<br />
fantasmi che si erano creati su questi intrusi abitatori<br />
del nostro spazio. Con loro così si andava a caccia di lucertole<br />
e gechi (de tilighèrtas e de tiligùgos), di scarafaggi<br />
e di serpi. Io li prendevo e li uccidevo giocando. E<br />
con il gioco spariva in loro ogni paura.<br />
La giornata, specie se non c’era mio padre, era movimentata.<br />
La trascorrevamo dietro le pecore con Filippo<br />
137
e Vittoria (la sorella maggiore chiamata da noi la maestra,<br />
l’unica che sapeva leggere) che si portava dietro<br />
tutti gli altri.<br />
Filippo incominciava a farmi compagnia. Mi aiutava<br />
a condurre le pecore e nelle altre faccende. Si asportava<br />
insieme il letame dall’ovile, si perlustrava il campo e si<br />
rinforzavano e si assiepavano i muri di cinta. Si abbeveravano<br />
le pecore dietro il loro nembo di polvere.<br />
Venne l’inverno. Le cose cambiarono. La vita animosa<br />
e idilliaca svanì come le foglie d’autunno. Il freddo<br />
invernale rintanò in casa i miei fratellini. Li inchiodò al<br />
focolare. E il campo riparlò nella sua lingua di sempre e<br />
nei suoi dialetti. Ritornai ad essere solo nella custodia<br />
delle pecore, obbligatoria durante i temporali.<br />
Si dormiva tutti in una stanza, separati da tende. Le<br />
notti erano lunghissime. Si andava a letto prestissimo.<br />
E la mattina si parlottava molto prima dell’alba. Nostro<br />
padre appena ci sentiva si preoccupava del nostro stato<br />
di salute perché doveva programmare per ognuno la<br />
giornata lavorativa.<br />
La mattina dal suo letto faceva il dottore.<br />
– Gavì, come ti senti oggi?<br />
– Bene!<br />
– La gola ti fa male?<br />
– No, no!<br />
Il furbacchione di mio fratello (che era sempre il secondo<br />
ad essere intervistato) se non lo aveva fatto già da<br />
prima, incominciava a rantolare, a raschiarsi la gola l’avesse<br />
o non l’avesse infiammata. Emetteva suoni strani<br />
espirando l’aria forzatamente. Era molto abile nel farlo.<br />
Faceva suonare il suo apparato respiratorio come una<br />
138<br />
fisarmonica con le ance sporche. Tutto stonato. Il babbo<br />
si preoccupava. Filippo insisteva per provocare l’intervento<br />
del “dottore”.<br />
– Filìì, eh, tu, come stai?<br />
– Mal di gola! Mal di petto (dolòre ’e pettòrra). Tosse.<br />
– Specie se sentiva la pioggia o la grandine picchiare<br />
sulle tegole o se vedeva i lampi danzare alla finestra.<br />
Il “dottore” allora si ammutoliva come per ascoltare<br />
il temporale. Filippo insisteva nel buio della stanza e<br />
suonava con i suoi bronchi un catarrone. Io gli davo dei<br />
calci perché non esagerasse.<br />
– Eh! Oggi sembri preso male. Sei tutto suoni. Sembri<br />
una fisarmonica. Oggi te ne stai a casa. Non uscire.<br />
Alle pecore ci pensa Gavino!<br />
– Sì, sì! – concludeva Filippo suonando i suoi bronchi.<br />
– Prendi il latte caldo zuccherato.<br />
– Sì. Va bene!<br />
– E tu, – rivolto a me – copriti bene. Oggi è una brutta<br />
giornata (oe est una die mala). Le pecore falle pascere<br />
nella valle (fàghelas pàschere in su addhìju). Starete più<br />
riparati. Io dovrò andare in paese.<br />
Con questo sotterfugio tracheale, mio fratello, oltre a<br />
farsi prescrivere il latte zuccherato (noi lo si prendeva<br />
con il sale) evitava vento pioggia e gelo. Non veniva<br />
nemmeno a darmi il breve turno che spesso mi consentiva<br />
di rifocillarmi in su foghìle e riscaldarmi dalla cancrena<br />
del freddo.<br />
Così a me toccava stare solo dietro le pecore ininterrottamente,<br />
come prima, sotto l’ombrellone verde, dentro<br />
un cappotto del babbo, inzuppato d’acqua, che mi<br />
scendeva fino a terra. Se non pioveva molto me la spas-<br />
139
savo ammaestrando qualche pecora, ammansendola,<br />
facendola venire da me per toccarla. Con i soliti versi affettivi...<br />
ddddd! lè,lè,lè!lèèèèlè lèlè! e con le ghiande<br />
raccolte sulla destra chiamavo Leperèddha. Si avvicinava<br />
timidamente, poi, lasciandosi vincere dai miei suoni<br />
e dalle ghiande, allungava il muso e si mangiava quello<br />
che le offrivo. Alla fine, quando facevo colazione, Leperèddha<br />
mi si metteva davanti e belava. Voleva il pane.<br />
Le piaceva non solo il formaggio, ma perfino la salsiccia.<br />
Quando si scatenava la natura, però, l’unico passatempo<br />
era ascoltare il discorso della pioggia. Osservare<br />
la sua danza come scendeva ritmata, giocata e frantumata<br />
dal vento. Sul tetto frondoso del bosco, scosso dal<br />
vento, che ululava sulle foglie come un lupo affamato,<br />
l’eco del temporale si spandeva. E nella solitudine, la<br />
parola della natura scatenata dominava su tutto. Io, appoggiato<br />
al fusto di un albero, riparato dalla sua cavità<br />
(in calchi tuva) o sotto la semiluna di qualche macigno<br />
(in calchi perca), riascoltavo di nuovo il vecchio silenzio,<br />
che non avevo dimenticato. Il dialogo rinasceva.<br />
Spesso, mentre parlavo con le pietre e con gli alberi, mi<br />
imbattevo casualmente con Battòre lungo i muri di<br />
confine. Anche lui era sperduto come me con la sua famiglia<br />
in Bestìa vicino al nostro ovile. Era del Bittèse.<br />
La sua famiglia era emigrata nel Logudòro dalla Barbàgia<br />
come tante altre in cerca di pascoli più feraci.<br />
Quando ci si incontrava, mentre mio padre trottava<br />
verso Sìligo, non ci interessava più di nulla, né della pioggia<br />
né del vento. Con versi affettivi, vezzi e mosse, fischi<br />
modulati e gemiti abituali ammaliavamo i nostri greggi<br />
lungo i muri in modo da stare insieme più a lungo possi-<br />
140<br />
bile. Parlavamo di cose ingenue. Solo del nostro mondo<br />
vissuto. I discorsi su cose in generale non esistevano.<br />
Quasi sempre, però, quando ci si incontrava, si finiva<br />
per parlarci con un’altra lingua più familiare alla nostra<br />
esperienza. Con la forza. Non è che ci si azzuffasse, ma<br />
si faceva di tutto per esprimere l’uno all’altro il nostro<br />
fisico. Si incominciava con le gare alla corsa sulle mulattiere<br />
correndo da un punto ad un altro imitando gli<br />
agnelli. E anche se stava piovendo a rovescio, ci si superava<br />
senza risparmiarci, guizzando come leprotti inseguiti<br />
dai cani.<br />
La lotta era il discorso più pastorale. Si giocava a s’istrùmpa.<br />
Consisteva nell’atterrare l’avversario mettendolo<br />
con la schiena a terra. Ci si piazzava prima l’uno di<br />
fronte all’altro senza commettere vigliaccheria alcuna.<br />
Ci si avvinghiava alla vita o alla cintola a seconda della<br />
nostra preferenza (purché si fosse tutti e due nello stesso<br />
modo), incrociandoci le braccia a X.<br />
A un segnale convenuto – sono pronto, – se l’altro rispondeva<br />
– sono pronto, – si dava il via. La lotta incominciava<br />
sull’erba senza risparmiarci. La mia carta segreta<br />
era nello sgambetto. Battòre (nonostante fosse<br />
più forte di me) spesso ruzzolava a terra una volta che<br />
lo squilibravo.<br />
– E una per me.<br />
– Voglio la rivincita.<br />
– Va bene! Sei pronto?<br />
– Sì.<br />
– Forza!<br />
– E una anche per me.<br />
– Ora la bella.<br />
141
– Va bene, aió (dài).<br />
– Pronto?<br />
– Sì.<br />
– Via!<br />
– Ho vinto, io.<br />
– Va bene. Incominciamo da capo.<br />
– Aiò (dài).<br />
E così per ore intere.<br />
Più che la forza, in questo giuoco conta l’astuzia, la<br />
prontezza dei riflessi, la presa alla vita dell’avversario e<br />
lo sgambetto. Spesso un’istrùmpa durava anche mezz’ora.<br />
E così si stava anche ore in lotta continua. Era<br />
questione di resistenza.<br />
Un po’ giocando alla lotta, un po’ facendo le nostre<br />
gare ingenue alla corsa sulle mulattiere, ci si scaldava<br />
come gli agnelli, in attesa che passasse il tempo e il rigore<br />
della stagione.<br />
Questo spasso, purtroppo, non poteva durare. Il raglio<br />
di Pacifico o un altro allarme ci richiamava dai nostri<br />
patriarchi.<br />
Nei due anni successivi 1950-52, Filippo mi subentrò<br />
nella custodia delle pecore: totalmente nelle giornate<br />
buone e parzialmente in quelle gelide. Ormai anche<br />
lui, a nove anni dovette conoscere i “suoni” della pastorizia<br />
forzata, che non poteva più evitare emettendo i<br />
suoni scordati dei suoi bronchi come aveva fatto fino<br />
ad allora. Anche lui ora doveva seguire il gregge come il<br />
cucciolo pastore, al vento e al gelo. Anche lui doveva<br />
guardarsi, intirizzito, i comignoli fumiganti delle capanne<br />
vicine ed ascoltarsi il silenzio della natura.<br />
Certo, nel primo mattino, il gregge lo pascolavo io.<br />
142<br />
Lui mi subentrava con due tre metri di sole all’orizzonte<br />
(cun duas cannas de sole). Gli risparmiavo il rigore dell’alba.<br />
E secondo gli ordini del babbo, così all’ora stabilita,<br />
me lo vedevo spuntare incappucciato sotto un sacco<br />
di iuta.<br />
– Ciao, Gavì.<br />
– Oh, sei arrivato? Le pecore, lasciale qui ancora un<br />
po’. Più tardi, portale al chiuso di sopra (a su cunzàdu ’e<br />
subra). Scaglia un urlo o un fischio di tanto in tanto. Incita<br />
il cane ad ustare. Le volpi sono sempre in agguato.<br />
– Ehi! Lo so!<br />
– Beh! Ciao!<br />
– Oh, Gavì!<br />
– E it’est! (Che c’è!)<br />
– Il babbo ha detto di andare a zappare alla vigna: a<br />
issu colomìnzu.<br />
– Eièèèèèèèè!<br />
Ormai mi dedicavo completamente ai lavori agricoli:<br />
alla vigna e all’oliveto. E a quattordici quindici anni<br />
zappavo a gara con mio padre. Di pomeriggio appena<br />
ritornava da Sìligo, mi raggiungeva per zappare al mio<br />
fianco. Prima di incominciare, come al solito, controllava<br />
la mia resa (sa faìna mia).<br />
– Beh! Oggi sei stato bravo. Ne hai fatto abbastanza.<br />
Le zolle, però, le devi rivoltare meglio. L’erba va sotterrata<br />
completamente. Altrimenti ricresce di nuovo: ’sa inza<br />
bene zappàda in s’istagiòne. Come diceva un poeta.<br />
Chie fàghere torra non la chèrede<br />
dogni faìna chere bene fatta:<br />
thappe binza e in tempus chi essèrede<br />
143
avèna o trigu, basólu o patàta.<br />
Est mezzus sa zizzània chi la fèrede,<br />
irraighinàda rested dogni matta<br />
ca si sa mala erva non bi féridi<br />
issa ìnchede! e su trigu bi péridi! 7<br />
Se invece il mio lavoro era poco o fatto male, al suo arrivo,<br />
spesso mi picchiava con il manico della zappa o se<br />
riusciva a trattenersi, sbraitava per tutta la giornata. Mi<br />
dava il filare guida e mi incalzava dietro a ritmo sfrenato.<br />
– Oggi non hai fatto nulla. Non as zappàdu terrìnu de<br />
ti coscàre: malu fainéri (oggi non hai zappato nemmeno<br />
il tratto che basta per sdraiarti: pessimo lavoratore).<br />
Quello che hai fatto lo hai fatto male. Si vede che te ne<br />
sei stato a fare i tuoi comodi. Poi hai zappato alla menefrego.<br />
Quel giorno avevo subìto un attacco di libidine e mi<br />
ero incespugliato un paio di volte. La zappa stette per<br />
molto conficcata sul filare, ma da sola non zappò!<br />
– Stamattina, non mi sentivo molto bene. Non avevo<br />
voglia.<br />
– La voglia te la devi far venire, malu fainéri. Il lavoro<br />
qui è sempre d’urgenza: uno attende l’altro.<br />
– Beh! Sto bene! Volete fare a gara con me. Volete vedere<br />
quanto so zappare. Seguitemi allora, su!<br />
7 Chi non vuol rifare il suo lavoro / ogni cosa per ben sia fatta:<br />
/ zappi per tempo la vigna e in tempo loro / avena o grano, fagiolo<br />
o patata. / Alla zizzania non lasci ristoro / ogni radice venga<br />
sradicata / ché se la mala erba non ferisce / essa vince! e il grano<br />
vi languisce!<br />
144<br />
Io tenevo il filare guida (sa manu de nantis). Punto<br />
nell’orgoglio, anche se lui per punirmi mi incalzasse<br />
come un dannato, non mi lasciavo superare. Morivo,<br />
ma mantenevo sempre la dovuta distanza: due o tre<br />
ceppi. Le nostre zappe danzavano sui filari, rivoltando<br />
zolla su zolla, disseminando il loro incalzante tintinnio:<br />
za-za-za! za-za-za! faceva la mia, accompagnata dal zaza-za!<br />
zaza-zaza-zaza! di quella del babbo. Ne veniva<br />
fuori un zaza-zaza-zaza! zazazaza-zaza! interrotto solo<br />
dal forte buhmmm allorché si sbatteva opportunamente<br />
l’occhiello della zappa (s’oju ’e su zappu) rovesciata<br />
contro la prima pietra che ci capitava, per pulirla della<br />
terra che vi si appiccicava. Finito il filare, una volta che<br />
si giungeva al lembo estremo (a su cabidàle), non si ridiscendeva<br />
giù come si fa normalmente con la zappa sulle<br />
spalle. Sarebbe stato troppo comodo. Si sarebbe ripreso<br />
fiato. Il filare si ricominciava contromano anche<br />
se si era in discesa. Così sembravamo un giogo impazzito<br />
nell’aratura, sotto il pungolo del <strong>padrone</strong>: la nostra<br />
zappatura era bustrofedica.<br />
La gara durò per quattro ore in silenzio: senza fermarci<br />
e senza nemmeno bere acqua (la gara lo imponeva).<br />
Parlavano solo le zappe. La nostra rabbia faceva<br />
miracoli. In breve tempo, molto lavoro fatto. Tanti i filari<br />
rivoltati e neri. Dopo quattro ore di gara senza vincitore<br />
né vinto, mio padre un po’ perché era stanco, un<br />
po’ perché pensava alla mungitura, ruppe il dialogo<br />
delle zappe impazzite.<br />
– Beh!... Il sole sta calando (su sole si ch’est ettènde).<br />
Che ne dici, stacchiamo?<br />
– Io non sono ancora stanco. Zappate, ora!<br />
145
Dopo altri due filari, però, lui smise di fare il contendente<br />
con me. Non stette più al gioco e ritornò al patriarcale.<br />
– Vedi, Gavino! Quando vuoi tu, sai zappare bene e<br />
ne fai anche molto. Zappi anche forte. Ma non basta<br />
zappare solo in gara. Si deve zappare continuamente<br />
giorno per giorno con senno (a su dinu). Andiamocene.<br />
Compiuti i quindici anni avvenne un’altra evoluzione.<br />
Non fu una conquista, però, come quella che mi<br />
consentì di cavalcare il somaro a sette anni e di andare a<br />
Sìligo da solo. Ora, man mano che crescevo, la vita diveniva<br />
più aspra e più austera. Per potermi usare meglio,<br />
il babbo allora mi comprò i buoi. Così a me ora<br />
toccava fare di giorno l’agricoltore e di notte il pastore.<br />
Posseduto dal demone del peculio e del potere patriarcale,<br />
poteva, come era abitudine, senza rendersi<br />
conto della sfacciataggine, sezionarmi in due, pretendere<br />
che lavorassi in continuazione come lo scorrere<br />
del tempo: che oscillassi come un pendolo tra le due attività<br />
fuori dalle leggi biologiche.<br />
Se aravo nel nostro campo o nel vicinato, alla giornata,<br />
la mattina ancora prima dell’alba dovevo mungere<br />
le pecore con lui. All’alba partivo per arare. La sera, al<br />
ritorno, dovevo rimungere con lui all’imbrunire. Durante<br />
la notte, spesso, dovevo vigilare il gregge, condurlo<br />
al pascolo, schiacciato dal sonno senza sfogo. Era<br />
una bufera interminabile dal buio alla luce. Spesso al<br />
pascolo mi associavo al sonno dei macigni, all’aperto.<br />
La stanchezza mi faceva dimenticare quello che stavo<br />
146<br />
facendo e ancora un po’ e sarei morto. La vita cessata.<br />
Ero un pendolo che oscillava tra la vita e la morte senza<br />
saperlo. E nulla è più dolente di questa tragica oscillazione.<br />
I buoi mi resero la vita ancora più brutale. Piccolo di<br />
statura, quando aravo, se avanzavo dentro il solco, solo<br />
la testa folta di ciuffi sfiorava la stiva dell’aratro. Eppure<br />
dovevo arare.<br />
Quando la giornata arativa mi usciva fuori zona (fora<br />
de issa cussòsa) le cose andavano peggio. Ogni giorno<br />
dovevo fare la spola tra Baddhevrùstana e il campo da<br />
arare, quello che capitava.<br />
– Perché non lascio i buoi sul campo e io me ne torno<br />
a Sìligo? È più vicino. Oppure mi compri una bicicletta.<br />
Io non ce la faccio più.<br />
– Non fa assolutamente, – diceva il babbo. – I buoi ce<br />
li ruberebbero. Sono la nostra unica speranza. L’altro<br />
giorno li hanno rubati a thiu Pàulu. Siamo in pericolo<br />
brutto: l’abigeato... Altro che lasciarli sul campo a chi li<br />
vuole. È già molto che non ci rubano l’aratro dal solco.<br />
E, poi, la biada, il fieno e la paglia, come te la porti? Sulle<br />
spalle o in bicicletta? No!! Non fa: è meglio soffrire.<br />
Il più delle volte il campo da arare distava otto dieci<br />
chilometri da Baddhevrùstana: Melédu, Chercos, sas<br />
Baddhes, sa Pedròsa. Per percorrerli ci voleva oltre<br />
un’ora e mezzo di marcia lenta, sulla brina o sotto la<br />
pioggia e altrettanto al ritorno, durissimo più che l’andata.<br />
Dopo nove ore di aratura, per far contento il <strong>padrone</strong><br />
dietro l’aratro senza sosta, sulla strada che tante volte<br />
mi aveva sentito ululare, dal freddo, mi sentivo tutto<br />
147
d’un pezzo, rattrappito in un dolore unico. Solo i piedi,<br />
gonfi e sbucciati dentro gli scarponi sempre grandi e il<br />
culo scaldato e irritato dallo sfregolio delle natiche sui<br />
solchi, riuscivo a sentirmeli separatamente. Morivo dal<br />
bruciore. La notte fregavo, di nascosto, il borotalco alla<br />
mamma. Me lo sbattevo in culo. E cascavo nel sonno<br />
più profondo.<br />
La mattina alle due mio padre mi scuoteva dal sonno<br />
con la sua voce imperiosa che usciva dal suo letto.<br />
– Oh, Gavì! Gavì!<br />
– Hummm! Uhmmmm.<br />
– Alzati! Foraggia i buoi! Metti loro la biada (sa proènda).<br />
Ci mettono molto per mangiare. Alle quattro<br />
devono essere pronti per partire.<br />
Io lo facevo quasi meccanicamente, cascante dal sonno.<br />
Poi riandavo a dormire. Alle quattro puntualmente,<br />
la voce di mio padre mi ricolpiva: entrava nel tepore<br />
dolce del riposo.<br />
– Oh, Gavìì! Oh, Gavìì! – – Ohoo! UhMMMmmm!<br />
Ehhh.<br />
– È ora. Parti!<br />
Partivo a cavalcioni su Boìta, il bue più giovane del<br />
giogo (de su giù), mentre il suo compagno, Piluoro (Pelodoro)<br />
seguiva trascinato dalla fune alle corna e all’orecchio.<br />
Meno male che Boita si lasciava cavalcare. Mi risparmiava<br />
le gambe, i piedi sudati e sanguinanti. Solo che la<br />
schiena del bue con il deretano in quelle condizioni,<br />
non era certo una comoda poltrona.<br />
Una mattina, stanco ed esausto dall’intera fatica della<br />
stagione arativa, mio padre, come al solito, alle due<br />
148<br />
ruggì dal suo letto. Io risposi al suo richiamo, subito,<br />
come sempre. E nel sonno gli feci capire di avere sentito.<br />
Ma non mi alzai. Non ce la facevo. Il sonno come un<br />
cumulo repressivo era più pesante di me. Mi schiacciava<br />
come una montagna e mi inchiodava al letto.<br />
Il <strong>padrone</strong> mi richiamò ancora per qualche volta ad<br />
intervalli di pochi minuti. Non poteva concepire ribellioni<br />
o cambiamenti. Io continuavo a non sentirlo. Ero<br />
morto, sfinito, crollato, non mi era mai successo. Allora<br />
lui senza preoccuparsi di nulla, se mi sentissi male o mi<br />
fosse accaduto qualcosa, si spiegò il fatto in sé e per sé:<br />
io avevo disubbidito. Dovevo pagare. Avrei potuto essere<br />
anche morto in quel momento: avrei disubbidito<br />
lo stesso. Avrei pagato lo stesso. Uscì fuori. Prese una<br />
delle due bacinelle in cui noi si metteva la biada ai buoi.<br />
Rientrò in casa a lunghi passi e nervosi. Si accostò al<br />
mio letto dove dormivo con i miei fratelli. Mi strappò<br />
violentemente le coperte di dosso. Mi sfregò in testa ed<br />
in faccia la bacinella di zinco tutta brinata (totta iddhiàda)<br />
e smaltata di ghiaccio. Mi richiamò alla vita. Una<br />
cosa terribile. Poi prese un cespuglio di quercia e mi<br />
percosse a sangue per un paio di minuti, sfogando la<br />
sua solita ira incontrollata.<br />
– Se ti succede un’altra volta, – ruggì per finire, – ti<br />
caccio di casa. Qui si lavora. Non si mangia pane a tradimento.<br />
Se non ti va, te ne vai a servire (ti che andhas a<br />
teràccu). Sei libero di fare come vuoi!<br />
Mal conciato dalle botte e dal dolore, nel pianto, andai<br />
a foraggiare i buoi.<br />
Quella mattina, naturalmente, non riandai a dormire<br />
dalle due alle quattro. Tanto ero umiliato ed offeso.<br />
149
Attesi la partenza nella stalla meditando vendetta contro<br />
mio padre tra il fragore delle mandibole dei buoi<br />
mentre trinciavano il fieno. Volevo fuggire. Andarmene.<br />
Volevo fare come Efis, un altro pastorello come me.<br />
Anche a lui il padre lo picchiava sempre più spesso e<br />
ingiustamente. Per sua disgrazia gli aveva anche rotto<br />
le vertebre lombari. Esasperato Efis un giorno si armò.<br />
Si mise il fucile sulla spalla. Si imbottì bene di cartucce<br />
e sparì lontano in un bosco. Solo, ma libero! I parenti<br />
alla fine lo scovarono dalla sua tana: dalla sua libertà.<br />
– Cosa volete? Io non ritorno più da mio padre! Mi<br />
picchia sempre... Se una cosa la faccio in un modo, lui<br />
mi dice che aveva detto di farla in un altro. La scusa la<br />
trova sempre... Io ho deciso di starmene qui. Se ritorno,<br />
lui mi picchia di nuovo e mi rompe tutto.<br />
– No! No!<br />
– Ci ha promesso che non ti tocca.<br />
– Vieni con noi, su! su!<br />
Efis scoppiò in lacrime e mise fine al suo banditismo,<br />
accasciandosi sulle braccia dello zio.<br />
“Io faccio come Efis,” pensavo nel buio della stalla,<br />
“sono ancora piccolo. Ma anche lui era piccolo. Lui però<br />
all’ovile era solo e poteva tentare la fuga. Come faccio<br />
io a prendermi il fucile del babbo e la cartuccera<br />
con le munizioni? No. Non posso farlo ancora. Se fuggo<br />
poi mia madre e i miei fratellini piangono. Non li potrò<br />
più vedere. Sarò un bandito. I carabinieri! Ma che<br />
me ne frega dei carabinieri a me? Ora, non ho paura di<br />
loro, io! Non so cosa fare. Mi dispiace abbandonare<br />
Boìta, Pacifico, Leperèddha: tutto quanto con cui sono<br />
cresciuto. Me ne dovrei andare a servire, cambiare pa-<br />
150<br />
drone. Sono tutti uguali. Anche Tore me l’ha detto. Lo<br />
picchiano anche. Me l’ha detto! E Gigi? Gigi è divenuto<br />
zoppo. Il <strong>padrone</strong> gli ha rotto il lombo e rimarrà così<br />
per sempre!<br />
“Oggi ho disubbidito! Puh! Se anziché sentire la sua<br />
voce, sotto il letto avessi sentito il vago sentore dello<br />
scoppiettio di un incendio, sarebbe stata la stessa cosa!<br />
Io ero morto. Mi sento tutto dilatato dagli sforzi come<br />
un ferro arroventato. Il culo mi prude: è ancora arroventato<br />
dal sudore. Ma io non sono una bestia! Magari!<br />
Avrei sofferto di meno! Boìta e Piluòro, voi, come<br />
state? Non rispondono. Forse soffrono lo stesso. Beh,<br />
Sì! Ma sono robusti. I buoi e Pacifico sono grandi. Finirà<br />
anche per me. Non appena sarò grande, me ne andrò<br />
da questa casa. Lui rimarrà da solo, rimarrà. Me ne<br />
andrò carabiniere come tutti i miei cugini e tutti gli altri.<br />
Se crescerò glielo farò vedere io! Oppure emigrerò<br />
a fare il minatore in America o da qualche parte. Ho<br />
sentito che ci saranno migrazioni. Almeno sarò libero.”<br />
Il problema più grosso venne per la mietitura (sa messe).<br />
Alla fine della primavera, le cose si complicarono.<br />
A fine maggio, prima l’orzo e l’avena, poi il grano, in<br />
giugno, s’indorarono. La prima mietitura mi attendeva.<br />
Io non la conoscevo. I mietitori li avevo sempre visti<br />
disposti in schiera lungo le spighe e davanti ai covoni in<br />
piedi sin da piccolo dal basto del somaro che mi faceva<br />
fare capolino sui seminati mentre mi recavo a Sìligo,<br />
ma la falce non l’avevo mai impugnata. Quello che mi<br />
faceva paura di fronte a mio padre era il fatto che ragaz-<br />
151
zi come Nanni, mietevano sin dai dieci anni così bene<br />
come io a otto sapevo fare il pastore. Era il suo mestiere.<br />
E ora la mietitura era lì anche per me. Mio padre me<br />
l’avrebbe insegnata sempre con due o tre lezioni fugaci<br />
e cicloniche.<br />
Toccò al grano de sa Pedròsa inaugurare l’impresa.<br />
La mattina del giorno di San Pietro piombammo sul<br />
campo, vicino a Sìligo, armati di falci. Giunti sul grano<br />
per mio padre iniziò la battaglia, per me la lezione. In<br />
fretta e in furia mi insegnò subito come fare. Come tenere<br />
la falce. Come tagliare le spighe e tenerle in mano.<br />
Come fare la manciata e legarla e come fare i covoni (comènte<br />
la incrabistàre e comènte fàghere sos mannùjos).<br />
Non era passata mezz’ora dall’inizio della lezione che<br />
lui pretendeva fossi già divenuto un mietitore, quasi lui<br />
fosse il creatore che avesse la facoltà di infondermi in<br />
un attimo tutta la sua esperienza e mi rendesse simile a<br />
lui con un balenio del suo cervello.<br />
– Tu non sei buono a nulla. Nanni sa mietere da quando<br />
era piccolo. E ora è capace di legarti dentro il covone,<br />
insieme alle manciate. Smidollato. Non vedi che ti<br />
cadono tutte le spighe che tagli? Sei un disastro.<br />
– Non ci riesco perché non l’ho mai fatto.<br />
– Così devi fare! Uhmmmmm! Hummmmm! Così!<br />
Cosìì! – infuriava tondendo furiosamente le stoppie.<br />
– Prova! Su! Su!<br />
Io mi sforzavo al massimo, fino allo spasimo. La cosa<br />
non era facile. Sotto la tempesta, poi, impossibile. E<br />
quando si accorse che le spighe che tagliavo non riuscivo<br />
a tenerle tutte per mano e che molte mi cadevano tra<br />
le stoppie tosate, la sua bocca tuonò di nuovo.<br />
152<br />
– Rammollito! Poltrone! Mangiapane a tradimento!<br />
Mangione (budegòne)!<br />
Con quanta rabbia aveva in corpo mi faceva vedere<br />
nervosamente ancora una volta come mietere. Evidentemente,<br />
preoccupato, per altre ragioni, si angosciava<br />
ancora di più per il tempo che stava perdendo ad insegnarmi<br />
a fare le manciate. Che io sapessi mietere dopo<br />
mezz’ora, purtroppo, non era possibile. È un’arte che<br />
si apprende con il tempo. Come al solito, la lezione da<br />
rabbiosa si fece feroce. Come se le spighe che mi cadevano<br />
fossero una parte del suo sangue e avesse paura di<br />
essere dissanguato, perse la calma. Rituonò con le sue<br />
bestemmie quasi per suscitare il temporale delle sue<br />
botte. Subito fischiò la bufera. Dietro di me sentii il<br />
turbine. I nembi s’addensarono e l’uragano scoppiò<br />
subito. Fu la grandine dei suoi colpi. Mi percosse atrocemente.<br />
Gli schiaffi si alternavano ai pugni sull’aiuola<br />
che avevo mietuto, mentre i suoi calci uno mi atterrava<br />
e l’altro mi rimetteva in piedi per ricolpirmi con le mani.<br />
Uno dei suoi pugni, purtroppo, mi prese alla nuca.<br />
Il buio mi sommerse. Vidi le stelle, un turbinio di luci,<br />
di bagliori e caddi per terra stramortito, privo di sensi<br />
sulle stoppie. Mi lasciò lì finalmente; lui si sfogò mietendo<br />
covoni a catena. Se li lasciava in piedi alle spalle e<br />
con la loro testa foltissima di ariste sembravano dirmi<br />
continuamente: – I tuoi covoni non nascono! Dài che<br />
anche tu diventerai come tuo padre! Qui ce ne sono<br />
passati di ragazzi ad imparare a mietere. Poi son ripassati<br />
mietendo come atleti. Messa, Gavì, messa! (Mieti,<br />
Gavì, mieti!).<br />
Si prese in affitto un’altra tanca vicina. Era boscosa e<br />
153
piena di sterpi: ginestre spinose, rovi, cisto (tirìa, ruos e<br />
mudéju). Pascolo ce n’era ben poco. L’unica cosa di<br />
buono per le pecore erano le ghiande e le frasche (sa<br />
landhe e issa sida), indispensabili in caso di siccità o in<br />
periodo nevoso. Il babbo si era ficcato in testa di bonificarla.<br />
Il rimedio c’era: sdebbiarla, dissodarla e seminarla<br />
a rotazione per qualche anno. Il sottobosco sarebbe<br />
andato distrutto. Non era un’impresa facile. I<br />
pastori precedenti ci avevano rinunciato. Gli sterpi e le<br />
macchie gareggiavano con gli alberi nel rigoglio.<br />
Non appena finì la stagione arativa nell’agro paesano<br />
coltivabile (su laósu in s’aidattòne), dove io aravo<br />
alla giornata, si diede il via al disboscamento, alla debbiatura.<br />
Disposti a terziglia, io, Filippo e mio padre,<br />
armati di roncole, di scure o di falce (a seconda dell’opportunità),<br />
si avanzava contro l’interminabile selva<br />
sterposa che rovinava sotto l’incalzare dei nostri<br />
colpi. La legna fine e non spinosa la si componeva in<br />
fasce, mentre quella sterposa la si ammassava lontano<br />
dagli alberi. Le si dava fuoco. E i roghi la riducevano<br />
in cenere. Un mese di debbiatura. In seguito si incominciò<br />
ad arare, a rivoltare quella terra forse mai<br />
“scocciata”, ricca di antica lanugine e di muschio. Nel<br />
giro di due tre anni, la tanca fu tutta pulita e in gran<br />
parte dissodata. L’orzo e l’avena crebbero feraci e il<br />
pascolo rifiorì sulle sue valli ripagando in parte le nostre<br />
fatiche.<br />
Mentre noi ci dibattevamo qua e là per le tanche, la<br />
mamma amministrava la casa. Lei si dedicava all’alleva-<br />
154<br />
mento delle galline. Nel giro di due tre anni da che lei<br />
era all’ovile, tutto lo spiazzo già brulicava di galline<br />
bianche, nere e di vario colore. Da lontano mentre io pascevo<br />
le pecore mi sembrava tutto grandinato: si spandevano<br />
dappertutto e si spingevano lontano in cerca di<br />
insetti e di cavallette, divenendo spesso facile preda degli<br />
sparvieri che adocchiatasene una librandosi per l’aria,<br />
si calavano a picco e abbrancatasela tra gli artigli ed<br />
il rostro, decollavano lontano per divorarsela dove volevano.<br />
Al pi, pi, pi! pi, pi, pi, pi! pi, pi, pi!: al tica, tica! tica,<br />
tica! e al ri-pi, pi, pi! pi! pi, pi! pi, pi, pi! della mamma<br />
sbucavano da tutte le parti all’impazzata: dai cespugli,<br />
dalla vigna, dall’orto. Tutte di corsa si adunavano sull’aia<br />
dove si buttava loro da mangiare.<br />
La mamma ci teneva. Ed era allora che si sentiva se<br />
stessa. E mentre spargeva l’orzo o l’avena alle galline<br />
intonava i canti che aveva imparato dal padre: quelli<br />
che cantava quando faceva la contadinella specie durante<br />
la marratura del grano o la mietitura.<br />
Finas in sa campágna amèna<br />
chisco su regìru meu<br />
fattèndhe votos a Deu<br />
chi mi che oghed’ dai bena. 8<br />
In poco tempo il pollaio, che contava oltre 300 galline,<br />
8 Anche nella campagna amena / inseguo l’affanno mio / aih!<br />
facendo voti a Dio / che mi tolga dalla pena.<br />
155
era divenuto un vero problema per il babbo. Devastavano<br />
il seminato, assalivano l’orto e devastavano la vigna.<br />
Salivano sulla capanna di stoppie in cerca di qualche<br />
chicco di grano o di qualche insetto, nonostante<br />
fosse assiepata sui muri. Vi si posavano e lo sgraffignavano.<br />
La rovinavano tutta, riducendola ad aiuole e a<br />
covi per deporvi le uova, a seconda del loro capriccio.<br />
Dentro già vi pioveva come fuori. Insomma, queste galline<br />
invadevano tutto. Si stavano imponendo. Il babbo<br />
si era veramente stufato. Quando i lavori agricoli gli<br />
concedevano una tregua, sbrigava le sue faccenduole<br />
sullo spiazzo, aguzzava le roncole, le scuri o gli rimetteva<br />
i manici. Lui però non sopportava che quest’invasione<br />
avvenisse così impudente e sfacciata sotto i suoi occhi.<br />
E gli artigli che sgraffignavano e scompigliavano il<br />
tetto della capanna sembrava gli squarciassero il cuore,<br />
il becco quando pungiglionava e rostrava il seminato e<br />
la vigna sembrava gli rodesse il fegato. Così non si poteva<br />
più crogiolare allo spiazzo. Subito vedeva qualcosa<br />
di irregolare. Quell’invasione lo sconvolgeva e lo turbava.<br />
Si scatenava. Spesso si raccoglieva: il silenzio gli<br />
stuzzicava sempre nuovi sistemi precauzionali. Dalla<br />
meditazione lancinante, spesso passava all’attacco. Le<br />
rincorreva. Le prendeva. Le agguantava per le ali. Afferrava<br />
la scure e gliele tarpava a fondo su un ceppo in<br />
modo che non potessero volare sulle siepi.<br />
– Queste galline mi stanno graffiando lo stomaco!<br />
Prendete quella. Sì! Quella. Dammela!<br />
Al tac-tac! tac-tac! della scure sul ceppo mentre tagliava<br />
le piume, faceva seguire minacce che destavano<br />
le nostre risate.<br />
156<br />
– Ora voglio vedere se voli. Gallinaccia maledetta! Io<br />
ti taglio il collo, ti taglio, – diceva sfregandole la scure<br />
sul collo come se glielo stesse tagliando veramente e come<br />
se la sua minaccia potesse attuarsi.<br />
Dava l’impressione che stesse litigando con dei servi,<br />
con dei dipendenti. Sentirlo solo da dove non si poteva<br />
vedere, dava la sensazione di udire una masnada di intriganti<br />
in briga! Questo mi capitava spesso il giorno<br />
che zappavo all’orto (ero io l’ortolano). Una volta dentro,<br />
con i muri alti ed assiepati (inchesubràdos), si vedeva<br />
solo il cielo. Le scenate del babbo le potevo solo<br />
sentire e le immaginavo. Era molto divertente ricostruire,<br />
dal tono della sua voce, severa e rabbiosa, dal frastuono<br />
che suscitava con i piedi che sbatacchiavano nella<br />
corsa, le sue impennate e le sue bestemmie affannose:<br />
– Diàulu su santu chi t’ha fatta! Su fogu bos brùgiede!<br />
Chi non ndhe càmpede una!<br />
Spesso dall’orto al di sopra della siepe, con mio grande<br />
stupore, potevo osservare le parabole variopinte<br />
della sua rabbia, descritte dalle galline che lui acchiappava<br />
per il collo e scaraventava per il cielo. Diverse galline<br />
morivano. Ma non ci dispiaceva: quel giorno almeno<br />
si mangiava un po’ di brodo.<br />
Una mattina, lui, come al solito, stava facendo il formaggio<br />
incosciando il paiuolo. Tutto preso, stava palpando<br />
il latte cagliato. Lo palleggiava facendolo roteare<br />
su se stesso prima che gli ricadesse sulle mani giunte<br />
e con cura lo lavorava e lo metteva sulla scodella che<br />
sgocciolava il siero attraverso i suoi fori. Io lo assistevo.<br />
Nel momento più delicato, una volta fatta la ricotta,<br />
doveva insierare il formaggio. Era l’operazione finale.<br />
157
Dentro il siero ancora bollente mise le scodelle del formaggio<br />
già pressato bene dalle sue mani e dalle apposite<br />
pietre. A turbargli la concentrazione fu una gallina<br />
invadente. Da prima si limitò a cacciarla via (a la isuliàre,<br />
a la giagaràre) urlando e sbuffandole contro. Agitava<br />
i piedi seduto sullo sgabello e scuoteva le braccia<br />
senza togliere le mani dalla pezza del formaggio. Alla<br />
fine si mise in piedi con le mani sempre sulla pezza e<br />
tra uno – sciù sa bù! Siuuuu!! HUUU! Huaaa! – e l’altro<br />
si contorceva tutto. Si sfogava parlando alla gallina:<br />
– Te ne abusi perché ho il formaggio tra le mani: brutta<br />
bestia infame.<br />
La gallina dei suoi – sciù; sc, sc! – se ne fregava, nonostante<br />
fossero frequenti e concitati. Si allontanava, faceva<br />
un giro fuori dalla porta e ricompariva.<br />
– Maledetta bestia! Uààà! Sciuuuu! Puààà! prrrrr!<br />
rrrrr! sc, sssc! È per questa pezza. Altrimenti ti tirerei il<br />
collo. – Lui si dimenava in una ginnastica concitata con<br />
la bocca e il corpo, ma non c’era nulla da fare. La gallina<br />
era padrona della situazione. La sua invadenza lo urtò<br />
al massimo quando nonostante egli agitasse i piedi<br />
facendo acrobazie con il culo sullo sgabello di sughero<br />
e le sbuffasse contro il suo fiele e la sparasse con i suoi<br />
furiosi – sciù, sciuà, – si avvicinò al paiuolo e tra una<br />
beccata e l’altra si aprì nelle sue penne come un mantice.<br />
La gallina allora si scosse tutta starnazzando, sollevando<br />
un nembo di polvere: il nembo del temporale.<br />
Lui non si contenne più, la sua ira dilagò. Anche la pezza<br />
del formaggio rimase travolta e sepolta da quel nembo.<br />
Il <strong>padrone</strong> partì all’assalto.<br />
– Sciù sa bù. Una puddha cazzu. Sciù gallì (una gal-<br />
158<br />
lina, cazzo). Huuu! ti fóscigo su tuju (ti torco il collo).<br />
Furente uscì dalla capanna avvelenato come una belva:<br />
cane dietro la selvaggina.<br />
Alla gallina non restò che cercare scampo nella fuga:<br />
nella corsa per il prato esprimendovi i suoi disperati<br />
coccococcodèè! coccodè. Il babbo non la perse di vista<br />
e la rincorse armatosi fortuitamente di un bastone. La<br />
isolò dalle altre e nella corsa ansimante continuò la sua<br />
maratona senza tregua. Dopo qualche minuto il fiato<br />
incominciò a mancargli e le sue bestemmie, che inizialmente<br />
intronarono tutto, ora si stavano smorzando. La<br />
corsa però, era sempre accanita: una gara. Il babbo dietro<br />
e la gallina davanti starnazzando con le sue ali e levandosi<br />
in un volo incerto e vano, emettendo continuamente<br />
dal suo collo implume i suoi concitati coccococcodè.<br />
Per qualche minuto il bipede ebbe la meglio.<br />
Alla fine, però, le forze cominciarono a tradirla. La sua<br />
corsa divenne marcia stanca, avanzava a zig-zag sgusciando<br />
malamente tra i cespugli. Il babbo ora sembrava<br />
rinvenire e, anche se era stanchissimo, aveva energie<br />
bastanti per la cattura. Stava per prenderla. La gallina<br />
allora spinta dall’istinto di conservazione, giocò l’ultima<br />
carta: la sua stupidità senza senso. Tentò ancora gli<br />
ultimi passi sull’erba e, stanca e spossata, emise le sue<br />
ultime “grida”, come per crearsi un riparo e infilò il<br />
collo implume in un cespuglio, senza curarsi di nascondere<br />
il resto. Mio padre ansimante, ma inferocito più<br />
che mai, celebrò la sua vittoria raggiungendola. – Huuu!<br />
Huuuuu! Anima fea (ànima mala). – Così la calciò<br />
arrabbiato: un rigore mortale. La gallina cadde stramortita<br />
in mezzo all’erba. Lui le premeva il piede de-<br />
159
stro sul collo mentre le cantava il requiem: – Mori, mori,<br />
bèstia fea; morii!<br />
Non si fu fortunati nel prendere la tanca in affitto e<br />
nell’accrescere il gregge in quell’anno. La tanca, anche<br />
se sdebbiata e bonificata dalle nostre roncole e dal<br />
mio aratro, per quell’anno non poté produrre pascolo.<br />
L’autunno trascorse senza piogge. Si era già in dicembre<br />
e ancora non era piovuto (non aìada ispezzàdu abbas).<br />
Il terreno non era germogliato (su terrìnu non<br />
aìada criàdu). I campi, aridi e secchi, riposavano, nudi,<br />
sotto l’interminabile estate prolungatasi fino all’inverno.<br />
Così, quando i pastori dai pascoli estivi delle pianure<br />
(dae issas istùlas) fecero ritorno sulle loro colline,<br />
vi trovarono solo le ghiande delle millenarie querce e<br />
le frasche dei sugheri sempre verdi (sa landhe e sa sida).<br />
Le bestie sopravvivevano a stento. Sui loro corpi si<br />
leggeva la fame da lontano. I loro scheletri si stagliavano<br />
avvolti dentro la loro pelle. I pastori si affidavano<br />
alla loro esperienza. Ricorsero alla biada, alla paglia e<br />
al foraggio dei loro granai in attesa dell’acqua, che<br />
non voleva cadere.<br />
Il bestiame, a furia di pastura a secco, deperiva e moriva<br />
a mandrie intere. Sui nudi campi nascevano così le<br />
carogne assalite dai corvi che vi si tuffavano con i loro<br />
famelici crocro. I pastori risposero con la loro disperazione:<br />
con i loro “cro-cro” lamentosi.<br />
Le greggi erano già decimate in dicembre quando finalmente<br />
arrivarono le piogge, che non furono proficue.<br />
Purtroppo insieme sopraggiunsero anche i freddi<br />
160<br />
invernali (sos frittos e sos rigòres malos). La terra così si<br />
sfreddò come una bevanda che il consumatore non ha<br />
potuto bere per qualche motivo. E non ebbe nemmeno<br />
il tempo di fermentare. L’erba rimase sotto: germogliò<br />
e basta. La brina, poi, nelle notti stellate, il vento e il gelo<br />
inaridirono anche i miseri germogli. La campagna rimase<br />
nuda fino a marzo. Fu necessario ricorrere al mangime<br />
venduto “a mercato nero” da privati o nei vari<br />
consorzi comunali. Noi grazie all’esperienza di nostro<br />
padre riuscimmo a salvare il gregge per intero e in primavera<br />
perfino a produrre anche un po’ di latte: il fitto<br />
della tanca.<br />
Di giorno, la smania di sopravvivere incalzava da tutte<br />
le parti. I pastori per le campagne abbattevano giornalmente<br />
branche di sughero: l’unica pastura reperibile<br />
nei loro campi. I tac! tac! delle loro roncole disseminavano<br />
segni di reazione alla morte. I sugheri, immobili<br />
con i loro fusti color sangue, quasi a testimoniare la<br />
morte lenta ed affannosa del bestiame, piangevano dappertutto<br />
mutili o atterrati e divorati dalle bocche insaziate<br />
del bestiame: – Mangiateci pure. Ricresceremo in<br />
primavera. – Questo il discorso nel loro silenzio, quasi<br />
si sentissero pascolo d’emergenza.<br />
La nostra salvezza però oltre che dai sugheri, venne<br />
da un orto di fichi d’india che il babbo abbatteva giornalmente<br />
e distribuiva cautamente. Alla fine si consumò<br />
anche il terribile ed interminabile autunno e il micidiale<br />
inverno. Venne la primavera con il suo rigoglio:<br />
dette le stampelle ai sugheri “invalidi”. Dette erba alle<br />
bestie, tranquillità ai pastori “sopravvissuti”. Il nostro<br />
gregge fu salvo.<br />
161
Nonostante avessimo salvato anche i buoi con cui aravo<br />
alla giornata, in casa si accusò il colpo.<br />
In molte altre famiglie fu il disastro.<br />
– Mi è morto il gregge. Non so come fare per pagare il<br />
fitto della tanca. I proprietari vogliono il fitto pattuito.<br />
Per loro non esistono annate brutte.<br />
– Proprio così. Loro ti dicono: “La mia tanca te l’ho<br />
affittata per tanto e tanto deve essere. Ti sei arricchito<br />
nelle annate buone, ora mi dai almeno il fitto.” Sono incoscienti,<br />
spietati questi padroni: vogliono il nostro<br />
sangue.<br />
– Il nostro sangue! E quale sangue? Io non ne ho più.<br />
L’annata me lo ha succhiato tutto. Voglio vedere cosa si<br />
prende il <strong>padrone</strong> al posto del fitto della tanca. Mi è<br />
morto tutto quel bestiame che mi ero comprato facendo<br />
il bracciante, zappando le vigne a cottimo, mietendo<br />
tante stagioni nella Nurra. Ora sono nullatenente.<br />
Me ne vado servo pastore. E quello che mi danno me lo<br />
tengo io, me lo tengo.<br />
– No! Io farò il servo! D’accordo! Il mio sporco <strong>padrone</strong>,<br />
che non mi vuole fare nemmeno uno sconto, lo<br />
pagherò. E mi sentirò libero.<br />
– Anch’io. Le pecore che sono riuscito a salvare, basteranno<br />
per il fitto della sua tanca. Me ne andrò servo<br />
pastore o all’estero, almeno nessuno mi dirà nulla.<br />
Fuori di Sìligo nessuno mi dirà: “da <strong>padrone</strong> sei ritornato<br />
servo.”<br />
– Si capisce. Anch’io farò così. All’estero. Ho sentito<br />
che vogliono braccianti in Australia. Bene. Me ne andrò<br />
lì e pagherò. Devo salvare l’onore della famiglia.<br />
– Servo <strong>padrone</strong>, bracciante o all’estero, fa lo stesso.<br />
162<br />
Pagherò questo sporco <strong>padrone</strong>. Gliel’ho detto: “Fammi<br />
uno sconto.” Macché. Lui con il sigaro in bocca sbuffando<br />
come una locomotiva sghignazzava le sue risate:<br />
“La mia tanca vale tanto e tanto voglio. Dell’annata non<br />
me ne frega una cicca.” È un figlio di puttana.<br />
– Eh! Vi state a preoccupare tanto. Male che vada faremo<br />
i banditi.<br />
Sin dalla giovinezza mio padre aveva incominciato a<br />
piantare un oliveto a Baddhevrùstana. Aveva sconfitto<br />
la natura, distrutto la selva e le querce secolari, riducendole<br />
a carbone (a cheas de cavvòne) e dissodato un<br />
terreno vergine. Con amore viscerale, lo aveva bonificato<br />
estraendone le pietre che ordinava e componeva<br />
in mucchi (chi ponìada in moridìnas) estirpandone la<br />
gramigna. E in mezzo al bosco millenario quale la natura<br />
lo aveva creato spontaneamente, lui creò quest’isola<br />
dell’arte umana lungo un rettangolo di sei ettari.<br />
Io lo conobbi già tracciato. Circoscritto dai muri su<br />
cui da ogni lato faceva capolino ancora la selva che con<br />
il suo rigoglio invadeva, quasi se la volesse inghiottire,<br />
l’aiuola del lavoro di mio padre. I rovi e la macchia, le<br />
querce che sovrastando il fitto sottobosco testimoniavano<br />
l’antica vegetazione. Con maestria ed assiduità,<br />
mio padre aveva tracciato i filari mediante fossati interminabili,<br />
ora tra l’argilla, ora sulla terra nera, ora sulle<br />
pietre e vi aveva piantato gli olivastri a distanza geometricamente<br />
regolare senza servirsi mai del metro, ma<br />
solo del buon senso, dell’occhio e dei passi. Nella loro<br />
lunghezza i filari venivano intercalati ed evidenziati da<br />
altre piante da frutto più precoci (peri, meli, fichi) che<br />
pagavano la zappatura dell’oliveto ancora infeconda.<br />
163
La sua architettura la si poteva osservare ogni anno, il<br />
giorno di San Elìa. Dalla sommità di monte Santo dove<br />
ci si recava per la festa.<br />
Scalando il monte l’oliveto si stagliava sempre di più.<br />
E la gente raggiunta la vetta, dove si accampava a crocchi<br />
e si sparpagliava sul piano a giara del monte, poteva<br />
mirare la meraviglia di Baddhevrùstana. In mezzo a<br />
quella selva di querce e di sugheri disordinati e incessantemente<br />
in lotta tra di loro, i filari dell’oliveto opponevano<br />
la natura coltivata alla natura spontanea.<br />
I cacciatori che vi sbucavano all’improvviso dalla selva<br />
si trovavano nel giardino del deserto e non potevano<br />
fare a meno di ammirare e di stupirsi di fronte a un’opera<br />
ormai quasi inarrestabile.<br />
– E tu chiamalo fesso Abramo. Molti dicono che è arretrato,<br />
ideoso, qua e là. Guardate che meraviglia. È<br />
l’oliveto più grande dell’agro!<br />
– Eh! Avete visto? La gente spesso si sbaglia. Spesso<br />
qualcuno che non è capace neanche di pulirsi il culo si<br />
mette a scorreggiare giudizi a destra e a manca. Qui parlano<br />
i fatti. Questi sono monumenti, sono. È un grande<br />
lavoratore. Quando si mette è un vulcano. Fossero tutti<br />
come lui, la <strong>Sardegna</strong> sarebbe un giardino, sarebbe.<br />
E pensare che trent’anni fa era una vera pazzia il solo<br />
pensarlo. Lui lo ha fatto!<br />
– Eh molti gli dicono che è pazzo! Osservatela la sua<br />
pazzia: è il paradiso! Anch’io avrei voluto essere pazzo<br />
così!<br />
Questi i commenti che avevo sempre sentito da piccolo<br />
dentro i cespugli per sfuggire all’attenzione dei<br />
passanti. Mi vergognavo e avevo paura di essere visto!<br />
164<br />
Erano giusti, però, quei commenti. Il babbo aveva vinto<br />
la sua battaglia. L’oliveto giustificava allora la deportazione<br />
della famiglia, la severità dell’artefice.<br />
– Quando sarò vecchio questa sarà la mia fonte, – diceva<br />
sempre alle persone che vi capitavano o che vi lavoravano.<br />
– Io non voglio fare la fine di tanti vecchi che<br />
una volta che le loro braccia non riescono più a produrre<br />
vengono disprezzati dai propri figli prima che dagli<br />
altri. L’oliveto sarà mio fino alla morte... Quando creperò<br />
se lo godranno loro. Sotto terra non avrò bisogno<br />
di quello che nasce sopra.<br />
Il babbo ci teneva molto. E da quando ero a Baddhevrùstana,<br />
il suo edificio stava venendo su bene, sensibilmente<br />
anno per anno. Io lo vedevo potare e lavorare<br />
le sue piantine con una brama incontenibile e con passione<br />
quasi gelosa. Le accarezzava tutte sui rami e sul<br />
fusto fino alle radici, quando le zappava. Cosa che non<br />
poteva fare con i figli. Le cingeva con un involucro di<br />
spine (las acchilandraìada) per evitare che divenissero<br />
facile preda di bestiame abusivo.<br />
Per raddrizzarle, ad ognuna aveva affisso un paloguida<br />
legandovele con il giunco che lui si procurava<br />
nei meriggi estivi: lo mungeva sutta ’e s’àvura fozzìda<br />
(lo mungeva sotto l’albero frondoso). Alle piantine<br />
non faceva mancare nulla: le uniche figlie per le quali si<br />
poteva intenerire. Con loro era sempre paterno. Se le<br />
nostre pecore o altrui le assalivano, l’uragano delle bestemmie<br />
scoppiava. Percorreva l’oliveto a grandi passi,<br />
quasi avesse bisogno di dimostrare agli altri che era solo<br />
suo. Come un falco, se vi sentiva lo sferragliare di un<br />
gregge estraneo, spalancava le sue gambe, ed accorreva<br />
165
in difesa delle sue figlie. Fischiando ed emettendo i suoni<br />
e i latrati della sua rabbia, piombava sul bestiame lapidandolo<br />
sin da lontano e allontanandolo a botte e a<br />
calci finché non lo faceva uscire dal suo “rettangolo intoccabile”.<br />
Se sopraggiungeva il <strong>padrone</strong>, o, come spesso<br />
accadeva, lo raggiungeva nel suo ovile, non si lasciava<br />
sfuggire l’occasione per regolare i conti e per mostrargli<br />
i denti e gli artigli.<br />
– Questo è il mio sangue. Tu me lo stai succhiando.<br />
Mi stai uccidendo. Le pecore custodiscitele: anziché<br />
startene nella capanna, a coglioni a fuoco (a cozzònes a<br />
fogu) o a strombazzarti tua moglie a Sìligo, assièpati i<br />
muri. Guàrdateli ogni tanto. Fai quello che vuoi. Stringi<br />
il garetto alle bestie (aschìladi sa robba). Impastòiatele<br />
(trobeidìlas). Che non ci ritornino a saltare, altrimenti<br />
ci azzufferemo e lo dirò al maresciallo. Le piante sono<br />
la mia vita, sono! Sono il mio sudore che sta crescendo...<br />
e tu me lo vuoi mangiare con la tua negligenza!<br />
Tieniti a bada le bestie. Sappiti regolare.<br />
Si faceva sempre rispettare. E come una vespa difendeva<br />
il vespaio pungendo con l’ago della sua lingua.<br />
D’inverno si andava in giro insieme in cerca di olivastri<br />
per rimpiazzare quelli che il gelo, il caldo o il bestiame<br />
abusivo avevano distrutto.<br />
Lui sapeva dove scovarli. Me lo aveva insegnato. Tutti<br />
e due in diverse direzioni ci si sparpagliava per le<br />
macchie del lentischio o per la fitta boscaglia.<br />
– Qui gli uccelli durante i temporali trascorrono la<br />
notte con il gozzo pieno di ulive. Spesso loro qui le portano<br />
dagli alberi per mangiarsele indisturbati. I semi li<br />
lasciano per terra, dentro i cespugli. Al caldo una volta<br />
166<br />
che vengono sommersi dalla terra, germogliano. Al riparo<br />
dal gelo e dal vento e dalle bocche mangiatutto<br />
delle capre, crescono bene.<br />
Così si andava a caccia di olivastri in competizione.<br />
– Ne ho trovato due qui!<br />
– Va bene! Segnali e ricorda. Anch’io ne ho trovato<br />
due lì, uno là e altri due in quel macchione di rovi. Ho<br />
segnato tutto. Vi ho fatto un segno nel terreno con la<br />
zappa.<br />
– Oggi ne abbiamo trovati parecchi.<br />
– Prendiamo le gerle e la zappa, su. Vieni.<br />
Con un solo colpo di zappa affossandola bene sul terreno<br />
lui estraeva l’olivastrello insieme alla terra (cun su<br />
pane de sa terra) senza che se ne accorgesse e lo deponeva<br />
nella gerla.<br />
– Accomodalo bene insieme agli altri. La zolla non si<br />
deve sfasciare. Messo così nel fossato (in sa cheddha sua),<br />
lui non se ne accorge nemmeno di essere stato spostato.<br />
Non conoscerà nemmeno arresto nello sviluppo (non<br />
ada a connòschere mancu paschìnzu).<br />
– Le gerle sono piene, bà!<br />
– Allora? andiamo! Questi stasera li mettiamo nella<br />
palinza. È un posto un po’ sterile. Non vogliono attecchire.<br />
– Ci sono i sugheri che soffocano tutto.<br />
– E anche quello.<br />
– Questa gerla mi pesa. Ce ne sono cinque.<br />
– Cambia spalla. Così!<br />
– Non ci riesco. Provo. Eh! Ah, sì! Solo che è più difficile.<br />
– Ti devi abituare al peso. Il lavoro ti deve mungere<br />
167
come una mammella. Il peso ti deve pressare come la<br />
vinaccia al torchio.<br />
– Siamo arrivati.<br />
– Sì. Mettila lì, la gerla. Da questa parte. Prendi la zappa.<br />
Fai il fosso. Così. Allarga un po’. Spòstati! Lo vedi?<br />
Non se lo sarebbe mai immaginato di farsi una passeggiata<br />
sulle tue spalle e di finire qui. Quando sarai grande<br />
te lo ricorderai. Sarà pesante: grande, alto. Tu potrai<br />
mangiare le sue olive quando sarà innestato e ricresciuto<br />
come ulivo.<br />
– Eh! Anche tu, le potrai mangiare.<br />
– Eh! Che cosa vuoi mangiare. Ci vuole una vita per<br />
fare un ulivo. Io me lo auguro di mangiarle. Mah! Chissà<br />
come sarò, quando questo olivastrello diverrà un ulivo!<br />
È una pianta secolare. Gli anziani piantano e i giovani<br />
colgono i frutti. È stato sempre così. Io ho mangiato<br />
i frutti delle piante che ha messo mio padre e tu mangerai<br />
il frutto di queste. Guarda quante ce ne sono. Non<br />
riesci nemmeno a contarle.<br />
– Eh! Ma anche tu cominci a mangiare il frutto delle<br />
piante che hai piantato tu stesso.<br />
– Beh! Se uno incomincia da giovane a lavorare un<br />
oliveto, quando è vecchio può godere dei frutti delle<br />
sue piante. È da quando avevo meno di trent’anni che<br />
ho incominciato a piantare. Molte di esse non hanno<br />
attecchito e come vedi le stiamo rimpiazzando. Ci vuole<br />
molto per fare un oliveto: una vita.<br />
Ci faceva vivere nella speranza: un giorno ci avrebbe<br />
arricchito. Ci faceva vivere più che mai l’angoscia propria<br />
del pastore e del contadino in proprio. Ci avvinghiava<br />
sempre di più con gli artigli della speranza di di-<br />
168<br />
venire potenti anche noi: leoni come Thiu Laréntu e<br />
don Juànne. Nella povertà più meschina e più nera, già<br />
ci faceva vivere il giorno della ricchezza. Non aveva importanza<br />
quando sarebbe avvenuto, vicino o lontano.<br />
L’importante era sentirlo e viverlo in quella angoscia.<br />
Sentirsi liberi e illudersi di viverlo presto o tardi. Noi lo<br />
si pensava. Si cercava anzi di farlo sorgere con il pensiero<br />
quel giorno. Non potevamo sapere che al di là dell’orizzonte<br />
dell’oliveto c’era la storia che aveva sbrandellato<br />
l’economia dei campi e che noi stessi eravamo divenuti<br />
un’appendice. E allora perché questo entusiasmo<br />
e questo dinamismo per la produzione? Perché<br />
tanta fantasia per la costruzione delle chimere e tanta<br />
foga per inseguirle? L’anelito della ricchezza si era sprigionato<br />
dentro di noi in maniera cieca e irrazionale.<br />
L’egoismo personale insomma, che nella cattiva sorte<br />
prima era la difesa che alimentava lo spirito di conservazione,<br />
ora nella buona l’oliveto lo trasformò in egoismo<br />
feroce, in cieco furore per il guadagno gettando<br />
uno spettro letale sulla nostra esistenza. Così come altre<br />
chimere lo gettava su tutta la massa di campagna. I<br />
paraocchi per cui non era possibile vederci e rivelarci<br />
come classe sfruttata da un’altra. Guardando le pecore<br />
che crescevano di numero e l’oliveto che s’innalzava<br />
sempre di più verso il cielo, ci succedeva dunque di vivere<br />
quello stesso egoismo che nella mala sorte ci tuffava<br />
come cani famelici sul tozzo di pane, sulla preda.<br />
Eravamo figli di quell’egoismo che ci salvò dalla fame e<br />
ora nella buona sorte non potevamo mutare metro. E<br />
quella speranza che ci fece vivere contenti, nella nostra<br />
beata ignoranza, tutto il rigore dell’esistenza preceden-<br />
169
te, ora ci lanciava nella lotta del possesso. L’unico linguaggio<br />
per divenire era il guadagno: la competizione<br />
sul lavoro come base morale per entrare nel prestigio<br />
sociale. Una vera sfida spietata e senza quartiere.<br />
Ora so che tutta questa corsa sfrenata per l’accrescimento<br />
del peculio in antagonismo con gli altri non era<br />
altro che il senso incontrollato dell’inconscio alla ricerca<br />
rapace del “mio” opposto al “tuo” come terreno necessario<br />
per divenire. Era il nostro “io”, ora lo riconosco,<br />
che diveniva come le querce in continua lotta tra di<br />
loro e con il sottobosco che soffocavano con le loro<br />
branche. Ognuno di noi era una quercia in lotta spietata<br />
e dichiarata in aperta campagna. Tutti i pastori erano<br />
un bosco di querce che infiltravano a gara le loro radici<br />
nel terreno e innalzavano le loro branche in cerca di<br />
spuntare una sull’altra: in cerca di sottrarre l’aria all’altra.<br />
Querce che avevano la facoltà di ridersi del sottobosco<br />
(dei loro servi) e delle altre piante che avevano<br />
superato in altezza.<br />
Che strano bosco e che razza di lotta dell’istinto! Ora<br />
capisco che noi, come gli altri pastori e gli altri contadini,<br />
articolavamo la nostra esistenza sull’istinto e sulla<br />
brama del possesso come quelli che al di là dell’orizzonte<br />
del nostro campo facevano la storia e ne tracciavano<br />
il senso. È una scoperta che mi ha stupito, ma che<br />
sento di confessare. Facendo le dovute proporzioni,<br />
noi tutti non eravamo meno borghesi di quelli che ora<br />
definisco borghesi. La stessa lotta nel guadagno basato<br />
sull’istinto del possesso: la stessa aspirazione a primeggiare<br />
sugli altri quasi per distruggerli. Certo, una borghesia<br />
in embrione, ma sempre con gli stessi caratteri e<br />
170<br />
con la medesima ferocia nel voler essere tale. Con sue<br />
norme rigide prima nel far fronte alla sopravvivenza e<br />
nello strafare nel potere poi quando le circostanze lo<br />
favorivano.<br />
Naturalmente allora non lo sapevamo. Quello stato<br />
era la molla della nostra esistenza istintuale. Il paradosso<br />
più assurdo era però che accanto alla borghesia che<br />
deteneva il potere, noi stessi vivevamo la nostra “borghesia<br />
inconscia” come base della borghesia effettiva.<br />
Una crudele scoperta. Altro che individuarci come massa<br />
sfruttata. Noi tutti inseguivamo le chimere del nostro<br />
egoismo sulla base dei singoli egoismi contrapposti<br />
e pronti a sbranarci a vicenda come in lotta per la<br />
preda.<br />
È triste veramente ora per me sapere che i pastori<br />
non la conoscono questa tremenda verità. Ed è dolente<br />
che loro continueranno a urlarsi come i loro cani il<br />
“mio” e il “tuo” in modo bestiale e ferino. Vivranno ancora<br />
sbranandosi a vicenda e sputando sangue tragicamente<br />
per padroni che non conoscono.<br />
Su questa base di egoismo granitico e rapace, mio<br />
padre aveva costruito l’oliveto. Sulla morale dell’istinto,<br />
sostenuto dalla chimera della ricchezza. Ora mi<br />
sembra strano che anche lui battesse una strada curioso<br />
e contento come quando io in groppa al suo somaro<br />
inseguivo i suoi zuccherini. Una forza impalpabile e<br />
invisibile glieli offriva. E lui come tutti gli altri la inseguiva<br />
per prenderli. E contento soffriva con piacere.<br />
Curvo, lavorava come un dannato, ma la brama del<br />
possesso gli rendeva leggero ogni peso. Gli faceva impazzire<br />
la zappa e gli arnesi di lavoro. E per realizzare<br />
171
il più possibile, quasi per lasciare le tracce ai posteri,<br />
inseguiva anche lui questo mostro comune. La tirannide<br />
titanica del suo egoismo lo costringeva incessantemente<br />
a dilatarsi senza dolore i muscoli sul lavoro. Lo<br />
mungeva veramente. Lo prendeva con la sua mano e<br />
come un pastore esperto e avaro lo spremeva come se<br />
fosse la mammella di una pecora. Non gli lasciava una<br />
stilla di latte. Tutti eravamo come incorporati da questo<br />
demone che ci svegliava di notte e ci pungiglionava<br />
di giorno sui campi per la produzione.<br />
Il nostro sangue ribolliva nello sforzo. Cadeva a terra.<br />
Si raggrumava. E noi si era contenti. Non potevamo<br />
pensare che il frutto del nostro sangue se lo sarebbero<br />
mangiato i rapaci urbani, lucidi e riposati nelle loro comode<br />
case. Ognuno costruiva da giovane per la vecchiaia,<br />
senza sapere che, in una società siffatta, la vecchiaia<br />
sarebbe stata, “oliveto o meno”, tragicamente<br />
disprezzata da tutti i giovani! E si affidava a questo demone<br />
che spandeva per i campi le nostre energie disseminandole<br />
a suo capriccio, rendendoci felici di questo<br />
sbrandellamento delle nostre carni: ignorando le calamità<br />
e i capricci della natura.<br />
Venne così lo spazzachimere: il gelo. Nel 1956 l’inverno<br />
fu molto caldo fino a tutto gennaio. Le proverbiali<br />
secche del primo mese dell’anno sembravano addirittura<br />
i primi caldi primaverili. La natura si stava<br />
svegliando. Le piantine giovani del nostro oliveto, tradite<br />
dal clima, si svegliarono prima del tempo. In pieno<br />
inverno stavano già in succhio: in amore, crescendo co-<br />
172<br />
me in primavera. Il tempo subdolamente le richiamò al<br />
rigoglio e non potevano disubbidire alla natura. Venne<br />
febbraio. Fu il finimondo. Un freddo polare. Mai visto<br />
né prima né dopo. La mattina del due febbraio, come al<br />
solito, ci si svegliò per la mungitura. La bufera muggiva<br />
e ci avvertì dai nostri giacigli. Fuori tutto era bianco. Le<br />
valli otticamente ricolme nelle loro depressioni, erano<br />
scomparse: gli alberi tappezzati di bianco. E la contrada<br />
tutta si spiegava così in una pianura indefinita che si<br />
era inghiottita il bosco e le colline. Nembi di neve calavano<br />
o si sollevavano rovinando e cozzandosi in preda<br />
al turbine. Il vento era forte e tagliente. Le mani si screpolavano.<br />
Stare in piedi era difficile. E nonostante la<br />
gamba ferma fosse continuamente conficcata sulla neve,<br />
si camminava barcollando. Sollevare i passi era quasi<br />
impossibile. Togliere la gamba dalla neve faticoso: se<br />
non si stava attenti lo scarpone male abbottonato rimaneva<br />
sotto la neve. Nevicava a rovina. I fiocchi della neve<br />
scendevano a grappoli come le cavallette del 1945.<br />
Le pecore scorrendo sulla neve, mentre le conducevamo<br />
per la mungitura, vi sprofondavano fino alle cosce.<br />
La loro pancia vi sfregava sopra. Uno spazzaneve. Il<br />
gregge non era più bianco come al solito, ma a testa<br />
bassa e pressato per farsi caldo, si muoveva a stento con<br />
il suo colore d’urina. Una palla di sterco sul secchio<br />
schiumoso della neve. Ci abbassammo per mungere.<br />
Le pecore ci riparavano dall’uragano e dal turbine.<br />
– Oggi è una giornata infernale, – disse il babbo.<br />
– Questo rovina tutto. Ti uccide. Le pecore, se non<br />
stiamo attenti, ci possono morire. Biada, biada, ghiande<br />
e frasche subito. Appena munto. Portami la scure.<br />
173
Abbatteremo il primo sughero che ci capita. Le volpi<br />
ora scendono anche sulla pianura.<br />
– Oggi le pecore non ne fanno di capricci mentre le<br />
mungiamo! Le loro mammelle non sono turgide.<br />
– Ma che turgide (ma ite ghìbberas). Con questo gelo?<br />
Se non muoiono è già tanto. Oggi le pecore le portiamo<br />
giù a issu addhìju. C’è riparo. Forza! Apri il varco<br />
(abbéri s’àidu)!<br />
– Sì.<br />
Finito di mungere le pecore, le conducemmo alla valle.<br />
E passammo per l’oliveto. Il manto bianco oscillava,<br />
ondeggiava, come il mare in tempesta. I cavalloni di neve<br />
si sbattevano frantumandosi uno contro l’altro. Si<br />
sollevavano e danzavano turbinandosi e intrecciandosi<br />
come flutti sparendo nei loro frantumi. La terra così ci<br />
nevicava più del cielo. Le pecore si rifiutavano di camminare.<br />
Il babbo, mentre si passava così per l’oliveto, dietro<br />
le pecore, per caso o perché presentiva qualcosa di grave,<br />
si avvicinò frettolosamente ad una piantina, sommersa<br />
dalla neve, con le branche piegate fino a terra. La<br />
agguantò con forza e la scosse sul fusto come per liberarla<br />
di quel gelido peso. Strappò un ramo dalla sua figlia<br />
e si rese conto subito del disastro. E quasi esterrefatto<br />
frantumò più volte il ramo in più punti tenendolo<br />
tra le mani come un proprio organo ferito: lo osservò<br />
attentamente come se stesse leggendolo e si contorceva<br />
tutto, ma in silenzio. E nervosamente strappava e riguardava.<br />
Scattò d’improvviso verso un altro alberello.<br />
Strappò di nuovo. Sbucciò il ramo e lo lesse. Lo buttò<br />
via sempre in silenzio. E come un forsennato corse ad<br />
174<br />
un’altra pianta. Stessa scena. Lui si dimenava più dei<br />
cavalloni della neve che lo assiepavano da tutte le parti.<br />
Correva ansimante, quasi piangendo, con il volto e gli<br />
occhi coperti dal nevischio. E quasi nutrisse ancora<br />
qualche speranza strappò tutte le piante che gli stavano<br />
attorno. Leggeva e rileggeva spasmodicamente la loro<br />
scorza affossando i suoi pollici callosi, ma leggeva sempre<br />
la stessa cosa. E spinto dal dolore come per dimostrare<br />
alla tormenta che solo lui aveva il diritto di uccidere<br />
le proprie figlie sradicò un alberello biforcuto e<br />
correndo avanti e indietro come volesse percuotere la<br />
bufera come tante volte aveva percosso bestiame abusivo<br />
o pastori incoscienti, urlò agli ululati del vento la<br />
sua disperazione.<br />
– Est tottu mortu! Est tottu mortu! I miei lavoriii! I<br />
nostri sacrifici! Tutto perso. Non c’è più speranza. La<br />
mia vita valeva solo una notte di gelido vento! Uno sfogo<br />
della natura ha bruciato tuttoo! Hummmm! Hummmm!<br />
– Ululava insieme al vento sparandogli le fiche a<br />
pollici spianati. – Huuuuu!! Fatti i conti. La speranza!<br />
Dio, dove seiii! Sui miei coglioniii!... Lascia pure qui le<br />
pecore! È tutto bruciato: tutto arso. Non c’è più niente<br />
da preservare dalle bestie. Il gelo si è mangiato tuttooo!!<br />
Il vento gli soffocava la voce in gola riempiendogliela<br />
d’aria. I suoi urli però andavano spegnendosi mentre<br />
la tormenta non abbassava mai la sua voce. Il suo avversario<br />
quella volta era impalpabile e non lo poteva<br />
strozzare.<br />
Io, attonito, lo guardavo nella sua corsa e nella sua<br />
violenza. Tra i nembi del nevischio che lo avvolgevano<br />
era come se si volesse divorare anche la neve.<br />
175
– Guarda! Strappa! Strappaaa! Strappaaa! Non avere<br />
paura! Vedi tra il legno vivo e la buccia c’è uno strato<br />
nero... Lo vedi? È tutto secco! Fra qualche giorno qui<br />
vedrai tutto nero come se ci fosse passato un incendio<br />
mai visto. Le piantine erano in amore.<br />
Così il babbo spezzando quei rami che sin da piccoli<br />
aveva sempre accarezzati, non fece altro che strappare<br />
tutta la sua vita già strappata. Le sue aspirazioni, i suoi<br />
lavori, gli entusiasmi, i sacrifici e le rinunce della sua<br />
travagliata esistenza di pastore e di agricoltore. E con la<br />
sua corsa all’impazzata, e con i suoi lamenti non fece altro<br />
che fare i funerali alle sue figlie.<br />
Dopo alcuni giorni, i segni della morte si potevano<br />
leggere sui tronchi delle piantine. Le screpolature e i<br />
solchi lunghi fino alle radici esponevano il tronco sbucciato:<br />
nudo e lucido. I geroglifici del gelo erano leggibili<br />
a distanza e la morte delle piantine venne inesorabile<br />
come il babbo aveva detto disperatamente nella sua via<br />
crucis da una pianta all’altra, mentre le “visitava”, come<br />
loro dottore, le sue figlie morenti, urlando al loro<br />
capezzale.<br />
Il gelo stroncò e distrusse irrimediabilmente l’oliveto.<br />
La chimerica e deludente speranza per cui saremmo<br />
divenuti ricchi si dissipò nel nulla. Un capriccio della<br />
natura arrestò e arrostì il giardino e lo divorò. Arrestò<br />
la corsa di mio padre. Sbrandellò il suo egoismo riducendolo<br />
a un cencio dilaniato dal gioco dei cani.<br />
Il solo freddo di una notte divorò ciò che mio padre<br />
aveva costruito in trent’anni costringendolo ad esiliarci<br />
176<br />
nel campo, svezzandoci dalla storia. Uno sghiribizzo<br />
della natura, un gelido vento, un forte abbassamento di<br />
temperatura, dilaniò tutta l’amorosa e assidua costruzione<br />
di mio padre: il suo passato vivente che sorrideva<br />
sugli ulivi e la nostra infanzia (e pubertà mia) tradotta<br />
in un rigoglio poderoso che avrebbe sfidato i secoli accanto<br />
alle vecchie querce che dai lati ancora invadevano<br />
per cielo e per terra il rettangolo sudato, la scacchiera<br />
su cui noi si giocava inconsapevolmente alla morte.<br />
La famiglia tutta accusò il colpo. Il disorientamento<br />
si protrasse a lungo. Le autorità non intervennero in<br />
nostro favore. Il nostro passato ferino perse ogni senso.<br />
Di colpo ci sembrò assurdo. La permanenza bestiale<br />
nei campi, l’isolamento civile, non trovavano più nessuna<br />
giustificazione. La nostra prigionia nel deserto<br />
umano ci faceva quasi paura.<br />
Nostro padre era stato battuto. Nella sua corsa aveva<br />
anche agguantato la chimera, ma gliela tolsero forze superiori<br />
e non ci poté offrire un futuro migliore. Nel<br />
frangente non fu aiutato da nessuno e il mondo “civile”<br />
ha lasciato che la natura spontanea operasse di nuovo<br />
la traduzione in selva, come prima.<br />
La famiglia rimase così come uno sciame di api (comènte<br />
una gheddha de abes) cui è franato l’alveare. Un<br />
nido d’uccelli ancora implumi buttato giù da una tromba<br />
d’aria. La nostra tradizione ci indicò la via della riscossa.<br />
Il passato stesso dei pastori ci aveva insegnato la<br />
rassegnazione, a tornare subito dal sogno alla triste realtà:<br />
a riprendere la rincorsa.<br />
Dopo la distruzione dell’oliveto, la pastorizia e l’agricoltura<br />
rappresentarono le uniche attività della fami-<br />
177
glia. Il babbo non se la sentì di rifare l’oliveto a sue spese.<br />
Ormai si era disgustato. Non aveva più l’ardore e<br />
l’entusiasmo di ricostruire.<br />
Ora avevo diciotto anni. Ero la colonna della famiglia.<br />
Gli altri erano ancora piccoli. Non usabili nel lavoro<br />
agricolo. Solo Filippo, minore di me di tre anni, lavorava<br />
e produceva. Giacomo aveva solo undici anni.<br />
Le sorelle, a parte Vittoria che dovette andare a servire<br />
a Sassari (a fàghere sa teràcca), erano piccole anch’esse.<br />
Tutti schierati e al proprio posto, però, si lottò per la<br />
sopravvivenza e si reagì con il solito spirito di conservazione.<br />
Si attuarono le leggi severe della pastorizia forzata.<br />
I più piccoli (Giacomo, Domenica e Elisa), a turno,<br />
pascolavano le pecore. Noi grandi, il babbo, Filippo ed<br />
io, ci dedicavamo completamente all’agricoltura durante<br />
il giorno e durante la notte sorvegliavamo il bestiame.<br />
Con Filippo si zappava, a cottimo, le vigne del vicinato.<br />
Di comune accordo “appaltavamo” le vigne circostanti<br />
prima che lo facessero gli altri.<br />
– Thiu Michè? Ce la date a zappare la vostra vigna?<br />
– Se mi fate un bel lavoro. Certo. Io sono esigente.<br />
– Noi ve la facciamo bene. Ce la date a cottimo. Però<br />
non dovete dire nulla di questo a nostro padre. Facciamo<br />
così. Noi ve la zappiamo e pagate lui. Poi ci pensiamo<br />
noi. Abbiamo bisogno di qualche soldo.<br />
Naturalmente il tempo che ci rimaneva lo impiegavamo<br />
a farci, anche a sbalzi, la vigna di un altro.<br />
Così si faceva con molti. Un simile lavoro ci faceva<br />
comodo. Era lì a due passi e ci liberava dalla giurisdi-<br />
178<br />
zione patriarcale. Ci rendeva liberi. Se si faceva ritorno<br />
presto all’ovile, il babbo con la scusa che avevamo fatto<br />
la giornata, si asteneva dall’usarci in altri lavori extra.<br />
Spesso la sera allora restavamo in libertà, anche se ci<br />
toccava mungere al crepuscolo e all’alba. La distruzione<br />
dell’oliveto era ormai un brutto ricordo e ci si poteva<br />
concedere anche un po’ di sollievo.<br />
Avevo diciotto anni e da sempre oltre alla passione<br />
per lo studio soffocata, ma rimasta viva e gelosamente<br />
nascosta nel mio intimo, c’era anche la musica.<br />
Già da piccolo, quando occasionalmente mi capitava<br />
di sentire la fisarmonica della “fortuna” per Sìligo, mi<br />
bloccavo. Mi fermavo ad ascoltare rapito ed estasiato.<br />
Una volta di ritorno a Baddhevrùstana, uscendo da<br />
Sìligo, mi venne incontro un giovanotto baffuto suonando<br />
una smagliante fisarmonica rossa. Dietro c’era<br />
la solita donna che con il pappagallo vendeva la fortuna<br />
ai passanti.<br />
Il giovanotto suonava speditamente un bel valzer brillante.<br />
E io che procedevo dietro Pacifico, senza accorgermene,<br />
mi fermai, incantato, per ascoltarlo. Ammaliato<br />
e vinto da quelle note e da quei bassi, trasportato<br />
quasi da una forza magica, tallonai il suonatore che riattaccò<br />
con un bel tango e mi attrasse con una mazurka.<br />
Credo, da quello che posso ricordare, che fosse questa<br />
la sequenza dei ballabili. Mi dimenticai di tutto. In quello<br />
stato di trance musicale mi passò più di un’ora senza<br />
che me ne accorgessi. Finalmente il suonatore fece una<br />
pausa. Si appoggiò a una gradinata e aspettò la sua donna.<br />
Lo guardavo con invidia. Volevo essere come lui.<br />
Avrei venduto me stesso per avere quella fisarmonica.<br />
179
I pastori, che sbucati dalle loro case lasciavano Sìligo,<br />
mi scossero con i loro versi, incitando i somari: – Prùuuu.<br />
Prùuuu. Sàaa. Prùuu inòghe sààà! Ffffff! Pruuuù!<br />
Dààààà! Ffffff! Ffffffff!<br />
Rinvenni di soprassalto. Mi sentii soffocato dall’ira<br />
inesorabile di mio padre, prima ancora che mi potesse<br />
colpire fisicamente. Nel mio trotto mi contorcevo: sentivo<br />
e evitavo i colpi della sua punizione. Il mio trotto<br />
divenne corsa impazzita verso Baddhevrùstana, dove<br />
speravo di ritrovare Pacifico. I talloni mi sbattevano le<br />
natiche. La mia corsa affannosa, però, quasi per ironia<br />
della situazione, di tanto in tanto veniva interrotta. Gli<br />
scarponi mi erano grandi e nello sgambettio sfrenato se<br />
ne uscivano. Mi ritrovavo scalzo ora di un piede ora di<br />
un altro. Alla fine per fare più in fretta, presi gli scarponi<br />
per mano e via scalzo sulla strada ghiaiosa.<br />
– Pacifico! Pacificooo! Eccolo là! Speriamo che non<br />
abbia perso nulla. Sennò il babbo me le suona veramente<br />
oggi.<br />
La bestia si era fermata all’uscita del paese (in sa rughe).<br />
E stava mangiando i suoi cardi preferiti sulla banchina.<br />
La raggiunsi di corsa: si spaventò di me e della<br />
mia paura. Sollevò il muso dall’erba masticando gli ultimi<br />
steli e rimettendosi sulla strada. Lo tranquillizzai<br />
con i soliti ssc! sssc! esssci sàà; lèèè! pruè, pruè!<br />
Si fermò. Uno sguardo al carico. Non aveva perso nulla.<br />
Portava tutto: i bidoni e la bisaccia. Infilai gli scarponi,<br />
montai in groppa e via a trottone stringendo Pacifico<br />
con gli scarponi perché non se ne uscissero di nuovo<br />
con le gambe penzoloni.<br />
Lo incitavo fino allo spasimo per annullare il ritardo.<br />
180<br />
Ma nonostante Pacifico fosse veloce e potente, il tentativo<br />
fu inutile: il trotto più spedito non avrebbe più potuto<br />
riprendere il tempo perduto.<br />
Nella mia disperata rimonta, io speravo che il babbo<br />
fosse assente.<br />
Quel giorno, invece, quasi mi aspettasse, mio padre<br />
stava sullo spiazzo.<br />
La sua vista mi raggelò sin da lontano:<br />
– Che gli dico? Che sono dovuto ritornare indietro<br />
da Mesu Mundhu? Che la mamma non si è ricordata di<br />
mettere il pane nella bisaccia? Che Pacifico mi è scappato?<br />
Ha sentito un’asina in fregola. Mi ha buttato giù<br />
e io non l’ho trovato subito? Mi è fuggito a Riu Ruzzu?<br />
Mentre rimuginavo, costruendo le mie trincee, la mia<br />
mente fu paralizzata dalla voce del babbo. Non appena<br />
gli fui di fronte, sbottò:<br />
– Come mai questo ritardo, oggi? Due ore! Che ti è<br />
successo?<br />
La colpa mi impedì di parlare. Mi soffocò in gola la<br />
frase salvatrice. Rimasi disarmato, sul basto, con gli occhi<br />
stralunati. Il sudore e l’ansimare di Pacifico, poi, inviperirono<br />
mio padre.<br />
– Scendi! Svelto! Oggi non la passi liscia! Prima fai<br />
ritardo. Poi tocca alla bestia rimediare ai tuoi capricci,<br />
animale! Animale che non sei altro! Tutto un bagno di<br />
sudore, povera bestia.<br />
In un baleno, egli ricostruì la mia inutile rimonta. Furono<br />
le solite botte. Due ore di ritardo. Cinque minuti<br />
di furia educativa: schiaffi, rimproveri e staffilate con la<br />
fune di Pacifico. La solita “aia” davanti alle urla.<br />
Altro che musica! A questa passione mio padre non<br />
181
poteva pensare. Dalle canne che costruivo io stesso e<br />
dalle armoniche che avevo sempre in tasca, lui era al<br />
corrente di questa mia debolezza che dovevo soffocare.<br />
Dovevo suonare solo la fisarmonica del lavoro e<br />
ascoltare con lui solo la musica della nostra storia sociale.<br />
La marcia funebre forzata delle nostre giornate lavorative<br />
sulla zappa, sull’aratro o sotto l’ombrellone<br />
dietro le pecore al gelo, era più che sufficiente per appagare<br />
le mie orecchie e la mia passione.<br />
Man mano che venivo su, lo pregavo ripetutamente<br />
di comprarmi la fisarmonica. Le mie preghiere erano<br />
inutili. Era assurdo per lui concepire un simile lusso.<br />
Uno spreco inutile e fuorviante. Aveva paura che lo<br />
strumento mi distogliesse dal lavoro e mi viziasse semmai<br />
fossi riuscito ad imparare a usarlo.<br />
– La fisarmonica è difficile, – concludeva sempre, lui,<br />
quando raramente glielo ricordavo. – Bisogna andare a<br />
scuola. Quelli che se la sono comprata a Sìligo, ad impararla<br />
non ci sono riusciti. E tu, la vuoi imparare qui, a<br />
Baddhevrùstana. Puh! Non farmi ridere! Noi ce li abbiamo,<br />
qui, gli strumenti: li abbiamo imparati dagli anziani<br />
e li dobbiamo suonare. Altro che valzer, tanghi e<br />
opere. Ma lasciami la testa! Vedi! Fossimo come quegli<br />
uccelli, lassù; come quei gufi, quelle piche, quelle upupe<br />
che stanno cantando. Allora, avremmo suonato e<br />
musicato anche noi. Loro non hanno problemi. Non<br />
hanno bisogno di scarpe per camminare. Non hanno<br />
bisogno di vestiti né di casa per dormire: pernottano<br />
dove loro sopraggiunge la notte (ue lis iscùrigada fàghene<br />
notte). L’unica loro preoccupazione è cercarsi da<br />
mangiare. Nessuno tra di loro è sfruttatore. Ognuno se<br />
182<br />
ne vuole, se ne becca. Tra di loro non c’è chi becca e chi<br />
mangia: chi va a caccia e chi trangugia, come succede<br />
agli uomini. No! No! Ognuno si mangia quello che<br />
becca. Non pagano tasse né faticano, loro. Los bides<br />
cantènde e moduléndesi sa oghe, subra sas naes: ciu<br />
ciau! Ciu ciau! Ciccimpèra, Ciccimperacì! Totta die a<br />
oju a sole. Bellu fidi istàdu a èssere puzzònes, tottu. E<br />
chie si ndhe aìada biccàdu si ndhe aìada manigàdu, si<br />
ndhe aìada chérfidu. Non comènte semus nois! Noi lavoriamo<br />
e altri mangiano. Canes ’e sutta banca semus<br />
(siamo cani sotto tavolata). Noi non abbiamo il tempo<br />
di giocare e di cantare. Se non stiamo attenti moriamo<br />
di fame, moriamo. Altro che musica! Altro che fisarmonica!<br />
Il nostro destino è brutto.<br />
Questa tipica tirata del babbo rispecchiava la morale<br />
comune. I suonatori erano ritenuti dei mangiapane a<br />
tradimento: mangiano ciò che non producono. Son cicale<br />
ambulanti, rispettate e tollerate solo nelle ricorrenze<br />
festive. Per il resto, la gente li disprezzava e li ripudiava<br />
come sfaccendati. Il babbo temeva che anch’io potessi<br />
diventare una cicala. Ero una formica e dovevo rimanere<br />
tale con il pensiero rivolto sempre al grano, all’orzo,<br />
alla vigna e alle pecore, d’estate e d’inverno.<br />
Così dovetti appagare la mia passione con l’armonica<br />
a bocca e con i pifferi di canna emettendo suoni alla<br />
rinfusa. La radio a Baddhevrùstana non c’era. E la “fortuna”<br />
mi capitava di sentirla molto raramente.<br />
Un giorno mi dissero: – Thiu Gellòn conosce bene la<br />
musica. Perché non ci vai? Lui ti può insegnare a suonare.<br />
Thiu Gellòn era un mio lontano zio. Con lui, fino ad<br />
183
allora, non avevo avuto familiarità. Lui abitava a Sìligo.<br />
Lo salutavo seccamente quando mi capitava di incontrarlo<br />
sulla strada bianca, come fosse un estraneo.<br />
Ora, però, che mi avevano messo la pulce nell’orecchio,<br />
mi sembrava una carta da giocare. Un bel giorno,<br />
così, la curiosità mi portò a casa sua. Stava ascoltando<br />
la radio.<br />
– Buon giorno, zio Gellòn.<br />
– Oh! Chi si vede! Come mai qui?<br />
– Mi hanno detto che conoscete la musica.<br />
– Beh, la musica la conosco. Una volta la conoscevo benissimo.<br />
Suonavo nella banda di Porto Torres. Poi ho<br />
conosciuto tua zia e Sìligo è diventata la mia residenza.<br />
Qui non ho più praticato.<br />
– Allora me la insegnate? A me piace suonare la fisarmonica.<br />
– È una cosa difficile. Ci vuole molta pazienza, molto<br />
tempo. Non è cosa da apprendere così per passatempo,<br />
dietro le pecore o lavorando, caro ragazzo. Non è uno<br />
scherzo. A imparare si soffre.<br />
– Ma a me piace molto. Il tempo lo troverò, a costo di<br />
studiarla di notte.<br />
– Non basta piacere! Ci vuole disposizione, costanza,<br />
ambiente. E molto tempo. E tu, tu devi lavorare. Vai,<br />
vai a lavorare. Tuo padre ti starà aspettando.<br />
Zio Gellòn mi congedò bruscamente. Non mi dette<br />
soddisfazione. Ne uscii demoralizzato, ripetendomi le<br />
sue parole: – Difficile, – Devi lavorare, – Disposizione.<br />
Quando mi comprai la nuova armonica a bocca, ci ritornai.<br />
Mi dissi:<br />
184<br />
– Voglio vedere che mi dice. Io gli suono quello che<br />
so.<br />
– Buongiorno zio.<br />
– Oh, salve! Siediti. Mi sto ascoltando la nazionale:<br />
Italia-Austria.<br />
– Che cos’è la nazionale?<br />
– È la squadra di calcio, formata dai giocatori più<br />
forti d’Italia. Sta giocando con la nazionale austriaca,<br />
ma non stiamo andando tanto bene. Sta pareggiando<br />
l’Italia. Ehh...<br />
– Sono venuto...<br />
– Sta finendo, aspetta.<br />
– Sì.<br />
– Allora??<br />
– Sono venuto a farvi sentire il ballo sardo che ho<br />
imparato proprio dietro le pecore. Quello che suono<br />
durante le pause del lavoro.<br />
– Beh! Beh! Fammi sentire.<br />
– Mfù, mfù, mfù, mfù, mfù / Mfù, mfù, mfù, mfù,<br />
mfù.<br />
– Ah ah aha! Bravo! E dove lo hai sentito?<br />
– La “fortuna”.<br />
– Ah!<br />
– Suono anche il piffero. Ce l’ho in tasca!<br />
– Suona, suona.<br />
– Pibiri, bibiri, bibiri, bibiribì / pibiri, bibiri, bibiri,<br />
biribì!<br />
– L’altra volta sono stato un po’ severo. Volevo vedere<br />
se la tua era un’intenzione seria. Molti ragazzi sono<br />
venuti qui con tanto entusiasmo, ma dopo due lezioni<br />
di solfeggio, non li ho più rivisti.<br />
185
– Allora me la insegnate, la musica?<br />
– Se mi fai una promessa.<br />
– Sì.<br />
– Se tu farai quello che ti dico io e come dico io. Sennò<br />
è meglio non incominciare.<br />
– Sì! Ve lo prometto!<br />
– Va bene.<br />
L’affare era fatto. Si alzò, claudicante, dalla sua sedia<br />
e tolse fuori, da uno scaffale, un vecchio metodo di solfeggio.<br />
– Con questo ho studiato io. Trattamelo bene.<br />
– Sì.<br />
– Allora, la musica consta di 7 note naturali, intercalate<br />
dalle note alterate di un semitono. Si scrive sul pentagramma,<br />
con le figure musicali, a seconda del loro valore.<br />
Vedi? Abbiamo la semibreve, la minima...<br />
Così agitando il bacolo per la stanza, mi spiegò la prima<br />
lezione prima di quanto io non credessi e ripartii<br />
per Baddhevrùstana. Sul basto cercavo di decifrare<br />
quelle figure nuove ricercandole sul metodo tremolante<br />
al trotto della bestia. Mentalmente mi riascoltavo le<br />
sue parole inchiodandomele per sempre nell’intimo.<br />
Ai pastori e ai contadini che mi salutavano rispondevo<br />
seccamente. Ero sul pentagramma, dentro quelle righe<br />
e quegli spazi. Il petto di tanto in tanto mi si dilatava<br />
per la gioia di parlare finalmente con la musica.<br />
Quando la mattina, sia pure di rado, anche a me toccava<br />
il turno di recarmi a Sìligo, andavo sempre a trovare<br />
zio Gellòn. In paese non potevo trattenermi più di<br />
tanto. L’ora era contata. Il rientro non doveva uscire dal<br />
tempo stabilito dal mio <strong>padrone</strong>. E siccome ormai non<br />
186<br />
potevo più rinunciare allo zio e alla musica, chi ci rimetteva<br />
era Pacifico. Una volta che assalivo il basto e<br />
sgusciavo via dall’ovile, il mio pensiero fisso era la lezione.<br />
Il solfeggio. Zio Gellòn!<br />
Sul basto mi contorcevo tutto come thiu Diddhìa e<br />
come thiu Antonìccu, quando trottavano verso le loro<br />
mogli. Tutto sbuffate e scossoni, anch’io incitavo il somaro<br />
con la stessa smania. Anch’io dovevo raggiungere<br />
mia moglie. E la mia testa imberrettata che faceva<br />
capolino nei chiusi doveva certamente apparire ai pastori<br />
in lontananza l’estremità dell’albero della barca<br />
che sulle gambe di Pacifico scivolava sul mare della<br />
mia passione. Una testa che sfrecciava al vento e al gelo,<br />
facendo ponte al vento contrario con le note che<br />
solfeggiavo. I piedi mi andavano ritmicamente sia per<br />
dividere le note sia per incitare Pacifico alla corsa, che<br />
sudava sotto lo sforzo. Io, però, non potevo farci nulla.<br />
Dentro di me c’era un vulcano e la mia reazione non<br />
era altro che l’equazione psicologica delle circostanze.<br />
Mio padre, capostazione inflessibile, non avrebbe mai<br />
tollerato il minimo ritardo. Così solo la celerità di Pacifico<br />
poteva aiutarmi. Nella corsa guadagnavo mezz’ora<br />
e ci usciva la lezione.<br />
Sbrigate le faccende, di corsa, inseguito e trascinato<br />
da due fuochi che mi bruciavano insieme (lo spettro di<br />
mio padre e la musica), piombavo cotto cotto e trafelato<br />
da zio Gellòn. Lo trovavo sempre a letto, intento ad<br />
ascoltarsi la radio. Era anziano, soffriva di reumatismi e<br />
si alzava tardi.<br />
– Se tu fossi venuto prima, avresti sentito un fisarmonicista<br />
con i fiocchi.<br />
187
– Che ha suonato?<br />
– Ma! Una mazurka. Eccezionale! Su! A noi ora!<br />
Mi spiegava sempre la lezione dal suo letto, di buon<br />
grado, tutto quello che sapeva, spassionatamente. Me<br />
lo comunicava come un tesoro di cui spesso si doleva<br />
di non averlo potuto trasmettere ai figli, morti prima<br />
del tempo. Agitando la destra, mi faceva venti minuti<br />
di solfeggio e mi assegnava la lezione successiva che io<br />
studiavo di notte o di giorno dietro le pecore, se pioveva.<br />
Allora a pascolarle andavo solo quando non si poteva<br />
lavorare la terra. Per questo spesso, mentre zappavo<br />
o aravo, divoravo il cielo con lo sguardo, quasi<br />
avessi il potere di turbarlo e suscitare nuvole e temporali.<br />
Le giornate più belle per me erano quelle che per<br />
gli altri erano le più brutte. Le giornate interminabili<br />
sotto la pioggia erano tempo prezioso per il mio sogno.<br />
Dietro il gregge sotto l’ombrellone verde, con il metodo<br />
dello zio, nascosto sotto il cappotto per non farlo<br />
notare da mio padre, mi avviavo per il pascolo. E sotto<br />
le querce, quando la natura si scatenava e il gregge si<br />
metteva al riparo, ora non ascoltavo più il suo linguaggio<br />
che un tempo mi aveva parlato a lungo. Ora, la natura,<br />
la lasciavo parlare per conto suo. Non rispondevo<br />
più ai suoi dialetti. E tutto preso da quella dolce ansia<br />
che la musica aveva acceso dentro di me, mi mettevo<br />
a solfeggiare. Il gelo non lo sentivo più preso dalla<br />
mia passione, ceppo acceso che scoppiettava e scintillava<br />
sotto l’acqua. Preso dalla smania, scandivo con il<br />
loro giusto valore le note, agitando le mani e riproducendole<br />
con la bocca. Risultato: dopo tre mesi di solfeggio<br />
clandestino (mio padre non sapeva nulla), la le-<br />
188<br />
gna della mia passione si ridusse a un bel mucchio di<br />
brace su cui si poteva fare l’arrosto musicale più saporito.<br />
Zio Gellòn si convinse della mia serietà e delle<br />
mie risorse musicali.<br />
– Ora ci vuole lo strumento.<br />
– E come si potrà fare? Mio padre non me lo comprerà<br />
mai.<br />
– Io tento di parlarci. So che è un osso duro. Gli dirò<br />
che è necessario: che te lo insegnerò io.<br />
Lo scontro avvenne una mattina in sa funtanèddha,<br />
all’entrata di Sìligo. Il babbo stava abbeverando i buoi<br />
con un carro di legna da vendere, mentre zio Gellòn si<br />
stava recando al vigneto che teneva a Mesu Mundhu.<br />
– Abrà! Ti debbo dire una cosa importante.<br />
– Di che si tratta?<br />
– Di tuo figlio, di Gavino. Quel ragazzo ha una vera<br />
passione per la musica. Te lo dovevo dire da prima, ma<br />
volevo essere sicuro delle sue capacità. In tre mesi che<br />
viene da me, ha appreso molta teoria. Ti dico che mi ha<br />
sorpreso. Ora però ci vuole lo strumento per passare<br />
alla pratica.<br />
– Non posso farci niente, Antonì. Noi si lavora notte<br />
e giorno. La nostra musica è un’altra. Teoria... Pratica...<br />
Musica... No! Il ragazzo devia.<br />
– Ma guarda che basta solo lo strumento e un’ora al<br />
giorno che il ragazzo può trovare durante lo svago.<br />
– Svago? E quanto costa questo strumento?<br />
– Sulle trentamila lire. Non è molto!<br />
– Hummm! Non è molto! No! Quindici giornate di<br />
lavoro. Ma lasciami la testa. Ce ne abbiamo noi di strumenti:<br />
zappe, roncole, vanghe... Non ne parliamo<br />
189
nemmeno... Poi, musica a Baddhevrùstana? Mio figlio<br />
deve essere un lavoratore, deve essere!<br />
E Ah!Ah!Uffff!FFF!ffff furono i versi che salutarono<br />
zio Gellòn, mentre il babbo dirigeva i buoi sulla<br />
strada incitandoli con le funi e il pungolo.<br />
Alle mie insistenze però e a quelle ripetute dello zio,<br />
un giorno rimase un po’ indeciso e disarmato.<br />
– Se non mi compri la fisarmonica, appena compirò<br />
diciotto anni me ne andrò in Olanda o in Belgio. Lì me<br />
la comprerò con il mio lavoro.<br />
– E va bene. La tua vera musica però deve essere il lavoro.<br />
Così il patriarca per la prima volta cedette e lasciò entrare<br />
un gregge estraneo nel pascolo della sua morale.<br />
Ero autorizzato a suonare. Potevo comprarmi lo strumento.<br />
Il babbo però stanziò una somma modesta,<br />
con la quale avrei potuto comprare solo una fisarmonica<br />
scadente, a quarantotto bassi. Mi occorreva più<br />
grande. Bisognava darsi da fare per racimolare soldi.<br />
Non era facile. Tante soluzioni mi passavano per la<br />
mente.<br />
– Se gli rubassi tre pezze di formaggio, mezzo sacco<br />
di grano e mezzo di orzo? L’affare sarebbe fatto. Però!<br />
Rubare! No! Non è possibile. Non ci riesco, io, – dicevo<br />
sempre a me stesso con la paura di essere scoperto al<br />
solo pensare una simile soluzione. Alla fine, la via meno<br />
pericolosa mi parve quella di prendere due vigne a cottimo,<br />
nel vicinato, e zapparle a sbalzi, quando il babbo<br />
trottava verso Sìligo. Quando lui partiva, io e Filippo si<br />
piombava lì e si lavorava sodo. Una due ore. Poi, come<br />
bestie spaventate assalivamo il nostro campo per sbri-<br />
190<br />
gare alla svelta il lavoro che il babbo ci aveva assegnato.<br />
Quando faceva bel tempo e c’era la luna, nelle notti di<br />
marzo, mentre tutto dormiva, mi alzavo. Mi spingevo<br />
nel buio e andavo a zappare. A trottone, con la zappa<br />
sulla spalla destra, scendevo e salivo le valli, sgusciando<br />
per le mulattiere, in silenzio, facendo meno rumore<br />
possibile. Avevo paura che mi abbaiassero i cani del vicinato:<br />
avrebbero svegliato i loro pastori che avrebbero<br />
potuto anche prendermi per bandito o sussurrare la<br />
cosa a mio padre: scoprire le mie carte. – Anche stanotte<br />
ce l’ho fatta. Nessuno se n’è accorto, – dicevo una<br />
volta che raggiungevo la vigna eludendo le orecchie dei<br />
cani della contrada. Saltavo il muro di cinta e vi piombavo<br />
in silenzio come un morto vivente, pronto all’attacco.<br />
Era uno spettacolo straordinario rivedere le viti<br />
potate lungo le ombre dei loro filari. Sembravano dormire<br />
anche loro: uomini in riposo. Subito però lo scricchiolio<br />
della mia zappa che passava le zolle nella penombra<br />
turbava quella quiete. Quegli uomini dovevano<br />
svegliarsi per ricevere la mia zappatura. Poveretti!<br />
Li dovevo scocciare di notte.<br />
Così, furtivamente, da solo (Filippo di notte non ci<br />
veniva mai anche se di giorno mi prometteva di alzarsi a<br />
mezzanotte. Per lui la fisarmonica non era un problema)<br />
dimenandomi nelle tenebre, zappavo quattro cinque<br />
filari e me ne ritornavo all’ovile. Far ritorno non<br />
era facile. Era anche pericoloso. Spesso il brusio dei<br />
miei piedi all’improvviso sorprendeva e spaventava i<br />
nostri cani. Mi abbaiavano. E in lontananza per un po’<br />
mi scambiavano per un estraneo. Mi si proiettavano<br />
tutti contro, facendosi coraggio a vicenda con i latrati,<br />
191
e con la corsa. E di colpo con loro grande stupore si trovavano<br />
quasi per mordere il loro padroncino. Allora<br />
come scossi dall’errore e dalla colpa, mi strisciavano<br />
per terra buttandomisi sulle gambe, emettendo gemiti<br />
di una gioia dolente, quasi per chiedermi scusa. Il più<br />
piccolo, mentre avanzava strisciando, si faceva anche la<br />
pipì addosso.<br />
Mio padre all’abbaiare dei propri guardiani, si svegliava<br />
di soprassalto, ed usciva di corsa, a fucile spianato.<br />
Ci voleva tutta la mia esperienza per non farlo sparare<br />
e far passare per normale questo mio ritorno. Come<br />
era abitudine, mi facevo riconoscere subito. Un fischio<br />
o un richiamo particolare erano le parole d’ordine<br />
in tali circostanze.<br />
La scusa era sempre pronta. – Stavo facendo un giro<br />
per il pascolo. Mi era sembrato di sentire lo sferragliare<br />
di un gregge in su addhìju de su palòne. Forse era quello<br />
di thiu Baròre che si era avvicinato. Nel nostro chiuso<br />
non c’era nulla.<br />
– Hai fatto bene!<br />
Dopo tante peripezie per la Pasqua del 1955 racimolai<br />
una somma discreta, che unita allo stanziamento del<br />
babbo e a un regalo della mamma mi ha permesso di<br />
scegliermi una fisarmonica a ottanta bassi. Zio Gellòn<br />
la ordinò dalla ditta Bagnini di Roma e ci mettemmo<br />
subito al lavoro.<br />
Con singolare pazienza, lo zio incollò dei quadratini<br />
di carta sulla tastiera e vi scrisse i nomi delle note e mi<br />
descrisse bene la bottoneria dei bassi. Così dopo una<br />
breve dimestichezza con lo strumento si passò al solfeggio<br />
pratico e all’uso del mantice.<br />
192<br />
Di tempo ne avevo poco per studiare e per accontentare<br />
il mio maestro. Il babbo mi faceva una guardia<br />
spietata. Di giorno facevo tentativi di sfuggita o di<br />
breve durata. Solo la notte mi offriva la possibilità di<br />
concentrarmi. Quando a casa tutti si mettevano a letto,<br />
io, dopo il primo pisolino, mi svegliavo. Origliavo,<br />
seduto sul letto. Se tutti li sentivo dormire, a passi leggeri,<br />
di gatto, me ne uscivo fuori e me ne andavo con<br />
la fisarmonica sulle spalle dopo aver chiamato i cani.<br />
Perché non mi abbaiassero al ritorno li portavo con<br />
me. Per non farmi sentire entravo in una baracca e al<br />
lume tremolante di un lumicino galleggiante sull’olio<br />
di una tazza, sorvegliato dai cani, mi ripassavo gli esercizi<br />
che mi aveva assegnato lo zio. In maggio e in giugno<br />
lo stridulo suono del mio strumento si confondeva<br />
e si accordava col canto delle rane; coi loro infiniti<br />
grè grè che assordavano ogni valle invadendola con il<br />
loro tripudio sinfonico. E senza mai indulgere all’orecchio,<br />
ma seguendo il metodo e il solfeggio, dopo<br />
sette otto mesi il maestro ebbe la soddisfazione di sentirmi<br />
suonare qualche arietta. Certo, nella mia baracca,<br />
di tanto in tanto, abbordavo il ballo sardo: quello<br />
che sapevo suonare con l’armonica a bocca. E quegli<br />
accordi nuragici spesso mi distoglievano dall’asperità<br />
degli esercizi. Ma in compenso mi dilettavano e mi ricaricavano<br />
e mi aiutavano a rispettare la inflessibile<br />
disciplina che mi imponeva lo zio.<br />
In capo a un anno finalmente riuscii a suonare un valzer<br />
e un tango. Il mio sogno si era realizzato. E quelle<br />
note che anni prima mi estasiavano al passaggio della<br />
“fortuna”, ora che si producevano sotto le mie dita, mi<br />
193
elettrizzavano e mi esaltavano con una dolcezza tutta<br />
intima e quasi gelosa.<br />
Spesso in quelle notti quando suonavo insieme al metronomo<br />
delle rane, la musica che producevo nella baracca<br />
mi sembrava quella della “fortuna”. – Sono io<br />
che sto suonando! Non mi sembra vero. Però ci debbo<br />
credere. Anch’io suono.<br />
Con volontà rozza, animalesca, ma inflessibile, le mie<br />
dita, callose e storte dalla zappa, per la prima volta ebbero<br />
l’opportunità di esprimere, alle querce secolari, la<br />
sensibilità di generazioni e generazioni mai educate alla<br />
musica. E attraverso le mie dita l’uomo delle caverne,<br />
ancora intatto dentro di me, ma sensibile in tutta la sua<br />
umanità, incominciava a raddolcirsi con la musica: a<br />
scavare dentro di sé e a scoprire che al di là dei suoi<br />
campi il mondo non finiva con l’orizzonte e che la miniera<br />
delle sue risorse sconfinava da quel cielo che fino<br />
allora conosceva.<br />
La mia conquista, purtroppo, allora non la poté comprendere<br />
nessuno. Nemmeno io la potevo comprendere,<br />
in tutte le sue implicazioni. E i pastori vicini non potevano<br />
sentire che un’estasi istintiva per la mia musica<br />
che si inghiottiva nel silenzio del bosco, come acqua in<br />
terra secca: il luogo aveva sete di dolcezza.<br />
Mio padre non si entusiasmò mai della mia conquista.<br />
– Musicante! Fannullone! Sei buono solo a suonare!<br />
Farai una bella riuscita, come quella di thiu Luìsi.<br />
In ogni mia bagatella ci ficcava la fisarmonica, c’en-<br />
194<br />
trasse o meno. Certo, quando lui si assentava, una suonatina<br />
me la facevo, ma nel lavoro recuperavo sempre.<br />
La musica non mi distoglieva dai lavori. Era solo uno<br />
svago curioso, ma non poteva raddolcire l’ambiente. E<br />
fisarmonica o meno a diciotto diciannove anni sorsero<br />
altri problemi che non si potevano più risolvere a Baddhevrùstana.<br />
La famiglia era ormai cresciuta. E per la morale comune<br />
mio padre stava già per completare il suo dovere<br />
sociale. Come gli animali, i pastori dovevano solo mettere<br />
su i figli fisicamente: badare solo alla vegetazione<br />
dei loro figli, anziché alla loro conquista interiore. Ed<br />
era anche giusto. Nei campi serviva solo l’istinto e la<br />
forza: muscoli che questi padri educavano severamente<br />
conformandoli alla natura che dovevano conquistare.<br />
Fatta la covata, si immolavano per crescerli e prepararli<br />
alla vita che conoscevano. Per assolvere questo compito<br />
davano tutto.<br />
Una volta grandi, i figli, però, imitando gli uccelli,<br />
dovevano prendere il volo dal loro nido, possibilmente<br />
per non tornarvi mai più.<br />
E questo stato di cose andò bene finché la campagna<br />
fu il fulcro dell’economia, finché la campagna era il<br />
mondo. Già a partire dagli anni Cinquanta, quel mondo<br />
però si sgretolò e si sciolse come ghiaccio al sole. Il<br />
fuoco di un altro mondo, al di là del suo orizzonte, lo<br />
abbrustolì lentamente. Quel bosco di pastori e di agricoltori<br />
così non faceva in tempo a rigermogliare foglie<br />
nuove per respirare. Pian piano morivano senza conoscere<br />
la causa della loro tragedia.<br />
I campi non offrivano più nulla. Non bastavano. E a<br />
195
vent’anni nell’animo di ogni pastore allora sorgeva un<br />
dramma comune: scoppiava il temporale della ribellione<br />
inconscia. E come lupi durante i rigori invernali anch’essi<br />
dovevano invadere pianure infide. Insomma<br />
dovevano invadere le pianure di quell’altro mondo che<br />
a loro insaputa era sorto e per cui i loro padri non li avevano<br />
potuti preparare perché non lo avrebbero mai immaginato<br />
e anche perché non lo avrebbero potuto. Le<br />
nuove generazioni erano costrette ad emigrare. Il rigore<br />
dell’inverno della loro vita li costringeva a invadere<br />
le pianure dove erano sorte le fabbriche e dove erano<br />
appostati dei pastori speciali che li sparavano. Si era<br />
praticamente rovesciata la situazione: essi ora erano le<br />
volpi e i lupi; le fabbriche erano le pianure; gli industriali<br />
erano i pastori.<br />
Così a diciannove anni anch’io sentivo che dovevo invadere.<br />
Il cielo della mia esistenza si stava annuvolando.<br />
Il sole stava scomparendo dietro nembi neri. I tuoni<br />
incominciavano a farsi sentire.<br />
Durante le mie giornate lavorative ora rivivevo i ricordi<br />
delle emigrazioni e le emozioni che mi avevano<br />
suscitato. E nei momenti di solitudine mi venivano in<br />
mente tanti giovani che avevano vissuto come me.<br />
Quelli che nel 1951 partirono per il Canada. Tutti sui<br />
venti o trent’anni, li ricordavo tutti amareggiati ed avviliti.<br />
Molti di loro li conoscevo sin da quando ero pastorello.<br />
Spesso, anzi, mi avevano soccorso o quando il<br />
mio somaro si coricava per terra facendo le bizze per liberarsi<br />
del mio carico o quando inzuppato dalla pioggia<br />
o congelato dalla neve o dalla brina, andavo urlando<br />
per le valli. Nel mio silenzio li sentivo vivi e mi veni-<br />
196<br />
va quasi spontaneo ricostruire i loro discorsi che avevano<br />
fatto con foga da braccianti, disposti in schiera mietendo<br />
sui campi altrui pochi giorni prima della loro<br />
partenza. E dai discorsi che mi affioravano, ora che anch’io<br />
sentivo il problema, capivo bene perché quel<br />
giorno lo avevano aspettato come una liberazione.<br />
Così anch’io, spinto da questo anelito di libertà, mi<br />
lasciavo andare. Rifacevo dentro di me i discorsi che essi<br />
avevano fatto nei campi in cui stavano mietendo. E<br />
anch’io, dal mio campicello, ora, provavo la rabbia dei<br />
loro discorsi: il loro sfogo politico inconsapevole.<br />
– Per fortuna fra poco me ne vado via da queste querce<br />
e da questi rovi: da queste sterili pietre piene di serpi<br />
e di vespai. Non sentirò più la voce arrabbiata di mio<br />
padre, mai contento. Lo so che andrò sotto <strong>padrone</strong>.<br />
Ma sarà diverso. Lo puoi piantare quando vuoi e poi la<br />
tua gente non lo conosce. Qui non ci chiamano nemmeno<br />
per nome. Ti senti dire: “Hai visto il servo di Thiu<br />
Laréntu? Il servo di thiu Juànne sta mungendo le pecore.”<br />
Avete capito? Qui il nostro nome non esiste.<br />
– Tu sei solo il servo di tizio o il servo di caio e basta. I<br />
cani sotto questo rispetto, sono più liberi di noi. Hanno<br />
un nome che non li degrada e con quello continuano a<br />
chiamarti sempre. Quando ero servo pastore di thiu<br />
Pàulu, il mio nome lo avevo perduto: per tutti ero il servo<br />
di thiu Pàulu. E così siamo tutti. Là sarà diverso, il<br />
<strong>padrone</strong> ci sarà, ma almeno ti tratteranno come un cane:<br />
ti chiameranno per nome. I soldi che guadagnerò,<br />
me li spenderò io. Qui mio padre mi fa lavorare notte e<br />
giorno. Quando faccio ritorno dalla mia dura giornata<br />
lavorativa, pretende che vada a lavorare nel nostro<br />
197
campo che coltiviamo a mezzadria. E puntualmente va<br />
a riscuotersi le mie giornate. A me non dà mai nulla. È<br />
sempre affamato. È la miseria in persona. I soldi che<br />
guadagni tu, non bastano nemmeno per i vestiti tuoi e<br />
dei tuoi fratelli. E quando, raramente, e dopo tante preghiere<br />
ci manda a una festa, non dà una lira a nessuno.<br />
L’anno scorso per andare a San Elìa mi ha dato solo 50<br />
lire. Tutto il giorno come un minchione, lì a guardarmi<br />
le bancarelle del torrone.<br />
– A me il lavoro non fa paura. Più di qui non si lavorerà<br />
nemmeno all’inferno. Avrò un <strong>padrone</strong> anche là, ma<br />
almeno non sarà mio padre. Di lui ora mi sono stufato.<br />
Non ne posso più. Sentite questa. L’altro giorno, stavamo<br />
a spaccare legna. Per aver perso la lima con cui si affilava<br />
la scure, la roncola e la sega, mi ha rincorso per<br />
tutta la valle con la mazza che si trovava tra le mani<br />
mentre dava sui cunei. E come se lo avessi rovinato e gli<br />
avessi buttato giù la casa, urlò come una bufera: “Vattene<br />
da qui per lavorare disattentamente, di malavoglia:<br />
per non guadagnarti nemmeno l’acqua che ti tracanni.<br />
Fannullone.” Per fortuna che io correvo più di lui... Vi<br />
giuro che se riesco a mettere piede fuori, non ci ritornerò<br />
più in questo luogo maledetto. Si vede che il Creatore<br />
quando ha fatto il mondo avrà chiesto aiuto al diavolo<br />
e gli avrà detto di fare la <strong>Sardegna</strong>. Tutto pietre e fuoco:<br />
bestemmie e gente arrabbiata dilaniandosi la loro<br />
misera esistenza come cani idrofobi. Nemmeno da morto<br />
voglio esserci.<br />
– Che ci ritorniamo a fare qui? A vivere la nostra morte?<br />
A rivoltar sassi? A mietere questo grano inaridito<br />
sotto il sole per il <strong>padrone</strong>. A mungere pecore piene di<br />
198<br />
merda o a ripulire il loro culo lanuto per mungerle meglio.<br />
Quel culo che sotto gli attacchi della diarrea nei<br />
periodi di brina o di gelo diventa impenetrabile alle<br />
mani! E tutto per dare metà del prodotto al <strong>padrone</strong><br />
della terra, che non sa nemmeno come si munge una<br />
pecora né che odore ha lo sterco del maiale? No.<br />
– Questo è nulla. Almeno rientra nella regola. Anche<br />
noi lavoriamo un giardino a mezzadria, ma il <strong>padrone</strong><br />
non si accontenta della metà. Sentite! Quando il giardino<br />
lo lavorava lui, le piante erano mezzo morte. Il terreno<br />
lavorato con poco entusiasmo e alla svelta. Il prodotto:<br />
scarso. Naturale. Mio padre, invece, servendosi<br />
delle nostre braccia lo ha bonificato e fertilizzato con il<br />
letame. Ora lo avete visto. È vigoroso, verde: una delizia!<br />
Il prodotto naturalmente si è moltiplicato. Thiu<br />
Pedru, invece di esserne contento, ne ha invidia: la sola<br />
metà del prodotto ora è superiore di molto a tutto quello<br />
che vi produceva lui. Quindi ha paura che ci arricchiamo.<br />
Hummm! Fuoco se lo pigli! L’altro giorno,<br />
mentre stavamo dividendo le mele, lui di pugno, riempiva<br />
la cesta: una per noi e una per lui. La sua la colmava<br />
bene finché le mele non cadessero a terra abbondantemente<br />
nella sua parte. Alla nostra, invece, le faceva la<br />
barba. Con un palo che agitava energicamente come<br />
per minacciarci, la rasava. Poi altra sfrontatezza. Il colmo.<br />
Con quel palo faceva catapultare la cesta ancora<br />
sulla sua parte. Alla fine il mucchio di questo Verre stava<br />
per divenire quasi il doppio del nostro. E mio padre<br />
stava lì a guardarselo come un allocco, come se avesse<br />
paura di quel palo. Non voleva accorgersi di nulla. Tutto<br />
quello che fa il <strong>padrone</strong> per lui lo fa sempre il <strong>padrone</strong>.<br />
199
Hummm! Ho protestato, naturalmente, anche perché<br />
questo modo di spartire durava da anni.<br />
– Thiu Pedru punto nel suo egoismo allora mi ha minacciato<br />
con il suo palo sollevandolo dal colmo della<br />
nostra cesta mentre la falciava a suo pro.<br />
– “Stai zitto moccioso! Se non ti va, nessuno ti trattiene<br />
qua. Te ne puoi andare quando vuoi! Questa è roba<br />
mia. Non ti basta quella che ti do? Darvene in più è<br />
sprecata.”<br />
– Io avevo intenzione di reagire. Di venire anche alle<br />
mani se il caso lo avesse voluto. Mio padre, invece di<br />
aiutarmi e fare i nostri interessi, tutto intimorito, davanti<br />
al <strong>padrone</strong>, mi assestò un bel ceffone in piena faccia.<br />
Roba da pazzi! E come per sottomettermi a thiu<br />
Pedru si scatenò contro di me: “Stai zitto. Lo so io come<br />
difendere i nostri interessi. Non sono affari tuoi.<br />
Che ne sai tu?”<br />
– “Come che ne so? Mezzadria è mezzadria.”<br />
– “Ancora vuoi insistere? Finché ci sono io lo so io<br />
come comportarsi con il <strong>padrone</strong>. Lo sai che lui ci ha liberati<br />
dalla miseria quando tu eri ancora un bambino e<br />
può ricacciarci quando vuole? Se ci manda via di qui<br />
dovremo andare tutti a fare i servi (a fàghere sos teràccos).”<br />
– Cosa dovevo fare, io? Starmi zitto. Ubbidire.<br />
Lo stesso anelito alla libertà che mi faceva risentire<br />
dal vivo i loro discorsi, spesso mi ripiombava nella piazzetta<br />
di Sìligo e rivivevo il giorno della partenza degli<br />
emigranti: il giorno della loro “liberazione”. Quella mattina,<br />
la piazzetta si riempì insolitamente di bambini, di<br />
donne, di uomini, di madri e di padri, di amici.<br />
200<br />
Pianti, strida e lamenti di età e di sentimenti diversi si<br />
levavano sulla loro miseria da ogni parte: sull’innocenza<br />
di quei ragazzi condannati a rifugiarsi in terre ignote,<br />
ignari del loro futuro, senza sapere come avrebbero<br />
dovuto rinascere in un dove mai visto; in terre che si<br />
potevano solo immaginare. Certo, l’America non era<br />
una terribile incognita per la popolazione sarda. E il<br />
dolore per il distacco non raggiunse mai la disperazione.<br />
Nella piazzetta vi erano molti vecchi reduci da emigrazioni<br />
in America agli inizi del secolo. Ed anche se<br />
eran lì come relitti di un lontano esilio, erano lo zucchero<br />
in mezzo all’amaro meno sopportabile. La gente vedeva<br />
e leggeva in loro la speranza del ritorno dei nuovi<br />
emigranti.<br />
L’emigrazione che ricordavo di più era quella per<br />
l’Australia del 1955.<br />
A differenza dell’America l’Australia era un paese<br />
sconosciuto ai contadini e ai pastori. Nessuno di loro<br />
vi aveva mai emigrato. E nell’animo degli stessi emigranti<br />
e della popolazione produsse una desolazione<br />
tremenda.<br />
Questa volta il distacco fu tragico. – Australia! – – Oltre<br />
un mese di nave per arrivarci!<br />
– Polo sud!<br />
– Polo nord! Dov’è?<br />
– Questi non potranno più ritornare. Solo il viaggio<br />
costa il lavoro di un anno. Addio figli!<br />
Era una mattina di maggio. E verso le otto tutta la popolazione<br />
si riversò nella piazzetta di Sìligo. Gente di<br />
condizione diversa e di età: sorelle, fratelli, padri, madri,<br />
figli, mogli e bambini si erano radunati per salutare<br />
201
per l’ultima volta gli emigranti. La gente era veramente<br />
convinta che non li avrebbe più rivisti.<br />
Le grida e il pianto mi ricordarono l’emigrazione in<br />
Canada. Solo che questa volta non c’erano gli zuccheri<br />
per inghiottire l’amaro. Non c’erano vecchi che potessero<br />
incoraggiare e rincuorare la popolazione. Mancavano<br />
i relitti che li facessero sperare in un lontano ritorno.<br />
La popolazione si raccolse nella piazza con il dolore<br />
dei funerali ai quali quegli emigranti, per privilegio<br />
della storia, partecipavano da vivi. Uomini che ebbero<br />
la ventura di vedere e sentire dalla propria bara il pianto<br />
e le lacrime della propria gente. Fu quasi come se la<br />
popolazione fosse divisa in due schiere di cadaveri che<br />
dovevano autofuneralizzarsi a vicenda. Sìligo, morto<br />
per loro. Loro morti per Sìligo. L’unica speranza per<br />
gli emigranti era nella loro rinascita in una terra che<br />
non li avrebbe più cullati né cantati, ma solo usati e<br />
consumati come arnesi di lavoro.<br />
Da ogni angolo si levavano grida e lamenti disuguali,<br />
intonati a sentimenti diversi. L’unica nota fondamentalmente<br />
uguale (il pedale fisso di quel dolente concerto)<br />
era il pianto corale. Dalle grida e dai lamenti che uscivano<br />
da quelle bocche bavose ed asciutte, si poteva cogliere<br />
però lo sgomento e lo scompiglio che si stava consumando<br />
nel cervello sbrandellato di ognuno.<br />
– Restate qui! Non te ne andare figlio mio! – era l’esclamazione<br />
più frequente che si sollevava al di sopra<br />
del dolore comune.<br />
– Che avete fatto? Quale colpa avete commesso per<br />
essere espulsi dalle vostre terre? dalle vostre case? da<br />
202<br />
Sìligo? dal vostro nido che noi facemmo con tanto<br />
amore?<br />
– E noi che abbiamo fatto per non godere dei nostri<br />
figli? Non ricordo di aver fatto alcun male. Mai!<br />
Così nelle mie rievocazioni solitarie mi si profilavano<br />
quei padri e quelle madri che colti dalla disperazione,<br />
nel momento del distacco, imploravano i propri figli di<br />
accettare ciò che non avrebbero potuto loro offrire: rimanere<br />
con loro negli ovili e lavorare la terra. Le botte,<br />
le grida rabbiose di sempre e le minacce che abitualmente<br />
scagliavano sui loro figli, non esistevano più<br />
avanti alla loro tomba. Il momento del distacco, anzi,<br />
sembrava suscitare in essi un certo complesso di colpa.<br />
Forse si sentirono padri incapaci di sistemare i propri<br />
figli. E in uno slancio disperato di amore paterno, sia<br />
pure timido, volevano quasi effondere ai propri figli<br />
tutto quell’affetto che mai avevano potuto dare.<br />
La corda della loro morale tesa fino allo spasimo dalla<br />
miseria, per la prima volta si allentò e poté “suonare”<br />
in una tonalità più dolce. E per la prima volta i patriarchi<br />
divennero padri. I rapporti tra padre e figlio si umanizzarono<br />
e almeno durante i reciproci funerali la loro<br />
austerità abituale svanì. E in uno slancio di tenerezza le<br />
braccia nerborute e le mani callose, che avevano sempre<br />
picchiato, avvinghiarono affettuosamente i propri<br />
figli: le loro labbra per la prima volta s’incontrarono reciprocamente<br />
e si baciarono per l’ultima volta così come<br />
quando si bacia il cadavere di un congiunto nella<br />
cappella del cimitero prima di affidarlo alle zolle.<br />
Le urla delle donne colpivano anche quella parte della<br />
popolazione che per un motivo o per un altro la sto-<br />
203
ia per allora aveva risparmiato da quel terribile esodo<br />
oceanico. Fu così un pianto accorato e corale. Il grido<br />
di un popolo sconvolto si levò nell’aria che non aveva<br />
mai potuto accogliere le sue risate e le sue gioie. Tutti si<br />
stringevano. Genitori e figli, amici e compagni si abbracciavano.<br />
Non esistevano più né odi né litigi. Le brighe<br />
e le zuffe, gli insulti e le percosse che spesso si eran<br />
date in campagna per difendere il proprio pascolo, svanirono<br />
come per incanto di fronte alla sventura. C’era<br />
posto solo al lamento e al dolore. Fu come se tutti volessero<br />
far la pace.<br />
Solo gli emigranti, orgogliosi e fieri (al pari dei padri),<br />
trattenevano a stento le lacrime che i loro cervelli<br />
piangevano solo con gli occhi del cuore. I loro occhi<br />
dolenti non potevano piangere davanti alle loro madri.<br />
Anzi dovevano emanare una luce di contentezza.<br />
Il volere della storia però, era inflessibile. Essi lo sapevano<br />
e il loro imperativo era emigrare: andar via dalla<br />
<strong>Sardegna</strong> per far fortuna altrove.<br />
Finalmente si udirono le trombe del pullman. Spuntò<br />
dalla curva e in un baleno s’immerse in tutta la sua<br />
lunghezza nella folla concitata della piazza. Il pullman<br />
eccitò maggiormente gli animi: il tempo stringeva inesorabilmente.<br />
Quella mattina, però, vi sostò più del solito.<br />
La folla doveva farsi i funerali: la funzione non era<br />
finita ancora e ritardava la partenza. La popolazione<br />
sconvolta voleva rinviare almeno di un attimo la partenza<br />
dei propri sventurati. Il pullman prima di giungere<br />
a Sìligo naturalmente, lungo il suo percorso, aveva<br />
fatto il pieno di emigranti nei vari paesi portandosi il<br />
pianto di mezza <strong>Sardegna</strong>. E gli emigranti degli altri<br />
204<br />
centri naturalmente non volevano far notare il proprio<br />
pianto a quelli di Sìligo. Vincevano il dolore ostentando<br />
una falsa baldanza.<br />
Il fattorino chiuse gli sportelli e così la bara fu chiusa<br />
anche per gli emigranti di Sìligo. La bara finalmente si<br />
scosse. Si mise in moto e si fece largo separando il pianto<br />
dal dolore e il dolore dal pianto: i figli dai padri e il<br />
popolo dal popolo. Un altro boato di urla concitate di<br />
età diverse e di emozioni diverse si mescolò ancora al<br />
turbine del dolore. Raggiunse il pullman come per fermarlo.<br />
La rabbia degli emigranti però era più intensa<br />
del dolore di Sìligo. E la popolazione tra il pianto generale<br />
ebbe solo la consolazione di vedere le mani agitate<br />
fuori dal finestrino della sepoltura comune. Quelle mani<br />
che divenivano sempre più sottili consumandosi e<br />
scomparendo nell’infinito, nel loro triste e desolato futuro<br />
inesorabile, nelle nuove tanche senza querce e senza<br />
uccelli, nel loro tetro cimitero del silenzio cruento<br />
delle fabbriche che li attendevano nell’Oceania.<br />
I funerali finalmente erano finiti e quasi tutti seguendo<br />
le donne sotto gli scialli neri, si rintanarono nelle case,<br />
lasciando la piazza come quando si lascia il cimitero<br />
dopo avervi accompagnato un congiunto morto nel fiore<br />
degli anni.<br />
Queste rievocazioni nel loro silenzio riflessivo mi rapivano<br />
al punto da farmi rivivere veramente tutte quelle<br />
scene. Ora che per un giovane sano e robusto come<br />
me era necessario emigrare se non venivo assorbito nelle<br />
forze dell’ordine. E questa necessità sopraggiungeva<br />
205
inesorabile soprattutto dopo che le emigrazioni in Canada<br />
e in Australia avevano rotto il ghiaccio, avevano<br />
indicato un varco. Dal ’55 si emigrò in continuazione.<br />
Non si piangeva più il distacco come prima. L’emigrazione<br />
divenne abituale e perse quel senso tragico e dolente<br />
anche perché si emigrò più vicino, in Europa. Addirittura<br />
ora emigravano persino le ragazze.<br />
Quello che restava era un mondo già mutilato. Solo i<br />
vecchi, i bambini e lo scarto fisico e psichico che ne risultava<br />
in seguito alle selezioni delle emigrazioni e delle<br />
forze dell’ordine, si aggiravano in quei campi privati<br />
dei giovani sani. Durante gli ultimi due anni potevo notare<br />
questo stato pietoso di un mondo invalido. Vecchi<br />
malati, storpi, gobbi e paralitici, consumati dall’età e<br />
dalla natura, rigati e rugosi dagli anni e dal male, popolavano<br />
i campi come larve umane, sfidando le intemperie<br />
della natura. Per le strade dondolati energicamente<br />
dalla vigoria dei loro somari, si vedevano vecchi di settantacinque<br />
ottanta anni, dimezzati dalle fatiche ansimanti<br />
e morituri che svolgevano regolarmente la loro<br />
regolare attività fino all’ultimo respiro.<br />
– L’altro ieri, – mi sentii dire un giorno, – è morto<br />
thiu Pepe. L’hanno trovato morto per il campo. Evidentemente<br />
non ce l’ha fatta a raggiungere la capanna.<br />
Il freddo della notte, poi, lo avrà congelato. Poveretto.<br />
Aveva ottant’anni e ha conosciuto solo il culo della pecora.<br />
Ora avevo 19 anni e sentivo più forte che mai la tragedia<br />
che incombeva.<br />
– Io non voglio fare la fine di thiu Pepe, morto dal<br />
gelo. Lo potevano divorare anche i cani, i corvi, gli av-<br />
206<br />
voltoi. Ahh! No! Io me ne vado via di qui. Ma nei carabinieri<br />
non ci posso andare, come hanno fatto quasi<br />
tutti i miei cugini. Loro sono tutti alti. Qui conta anche<br />
la statura. Io sono basso. E poi ci vuole la V elementare<br />
e io non so né leggere né scrivere. Qui bisogna emigrare.<br />
Eh, là non conta la statura, no! Basta che tu sia sano<br />
e lavori!<br />
Così nell’autunno del 1957 venne l’ora anche per me.<br />
Con un amico di Sìligo mi balenò l’idea di emigrare in<br />
Olanda a fare il minatore.<br />
Mio padre mi mise in guardia circa i pericoli delle miniere.<br />
Spesso anche da altri avevo sentito dei cruenti<br />
disastri dei nostri emigrati nelle miniere della regina<br />
Giuliana. Il grisou lo conoscevano anche i pastori e le<br />
querce della <strong>Sardegna</strong>. Sui campi si parlava spesso degli<br />
emigranti, della loro fortuna e delle loro disgrazie. E<br />
rimanevo perplesso. Certe notizie mi infilzavano il cervello<br />
e mi calavano nelle viscere come braci accese. Ma<br />
quando nei boschi e negli sterpi scatta la molla repulsiva<br />
contro l’ambiente, l’emigrazione diventa un’ossessione:<br />
ti martella continuamente il cervello.<br />
Se sei sano, robusto e maggiorenne, non c’è nulla che<br />
possa trattenerti. Restare significa vegetare a mala pena,<br />
tragicamente, come erba o pianta condannata a crescere<br />
nel dolore a causa del giocoso capriccio del vento che<br />
un giorno scaraventò i semi da cui germogliarono nel<br />
terreno meno adatto. In quella selva tu ti senti come<br />
quelle erbe costrette a crescere sui muri o sui burroni in<br />
posizione tragica e pietosa, pendenti ora da una parte<br />
ora dall’altra: scosse, tempestate da quel vento che ha<br />
affidato i semi sventurati al suo gioco. Spesso là mi sono<br />
207
sentito come un caprifico che vidi un giorno costretto a<br />
vegetare malamente sulla cima del campanile di un paese,<br />
o come quelle piante che hanno avuto la sfortuna di<br />
nascere sui nuraghi in mezzo alle pietre senza terra. Le<br />
radici fuori, all’aria, distese in una lotta incessante per<br />
immergersi in terra o sotto qualche pietra. Le branche<br />
rugose e senza linfa che sopravvivono alla morte. Anch’io<br />
ero seme sfortunato che un vento aveva scaraventato<br />
in terreno sterile sulle pietre e avevo le radici fuori<br />
dalla società, fuori dalla vita. In quelle condizioni tu allora<br />
ti guardi e hai quasi paura di te stesso. Senti vergogna<br />
del tuo stato. Il tuo essere nudo, le tue radici fuori<br />
dalla terra, ti fanno ribrezzo e vuoi sotterrarti, ma non vi<br />
riesci come quelle piante sventurate. E l’unica fortuna<br />
che hai rispetto ad esse sono le tue gambe: la fuga. Emigrare<br />
e immergerti nel serpente nero delle miniere allora<br />
ti suona libertà. Emigrare, nella tua desolazione, ti sembra<br />
l’unica arma da rivolgere contro l’ambiente e coprirti<br />
le radici: l’unica roncola per aprirti un varco nella<br />
selva impenetrabile quando alle spalle avanza un incendio<br />
furioso che ti sta per ardere e ridurti in cenere. Darti<br />
alla fuga, scampare e salvare almeno lo scheletro della<br />
tua esistenza e cercare di rimpolparla altrove, diventa<br />
naturale e spontaneo. Allora imprechi contro chimere<br />
inesistenti. Ogni pastore si spiega i propri mali quasi in<br />
modo metafisico, da fatalista. Tu credi che la colpa sia<br />
solo della terra sarda, delle sue montagne con le loro<br />
pietre e le loro querce, delle sue bellezze insomma.<br />
Inoltre la curiosità di vedere finalmente città e altre<br />
terre ti assale e ti eccita come vento a fuoco. Vedere come<br />
è fatto il mondo diventa un’attrattiva. La smania di<br />
208<br />
vedere al di là dell’orizzonte del tuo campo ti piomba<br />
addosso. Vuoi fuggire da quella selva dove non hai mai<br />
potuto pensare al di sopra della tua fame e della tua miseria.<br />
Sai di dover andare sotto terra, come un lombrico,<br />
a scavare il carbone, sempre tra la vita e la morte, ma<br />
non te ne importa nulla.<br />
Così insieme all’amico Gigi presentai domanda all’ufficio<br />
collocamento di Sìligo per emigrare in Olanda.<br />
Senza attendere molto ci avviarono a Sassari per la<br />
visita di selezione. I medici olandesi ci sottoposero ad<br />
una visita fisica accuratissima. I nostri muscoli non delusero.<br />
I nostri polmoni non potevano non rispondere<br />
bene. Noi eravamo incalliti in ogni parte e provati ad<br />
ogni sforzo. Atleti della zappa e dell’aratro. Avevan voglia<br />
a visitarci! Il nostro fisico era una locomotiva perfetta.<br />
La notte pernottammo a Sassari in attesa di altre<br />
visite per il giorno seguente. Tutti buttati alla meglio<br />
per terra come fossimo bestiame alla fiera, si trascorse<br />
la notte parlottando sul nostro futuro.<br />
– Chissà se ci prendono. Hee! Se mi prendono me ne<br />
volo! Là in Olanda! Mi hanno detto che le ragazze ci<br />
stanno con noi italiani.<br />
– L’ho sentito anch’io. Me l’ha detto Peppe che è partito<br />
due anni fa. Quando era in ferie quest’estate mi ha<br />
detto che si fa a beffa.<br />
– Madonna, ragazzi, con la fame che ho me le mangio<br />
tutte quelle olandesine. Farei come il nostro montone.<br />
– E poi avete visto come sono educati quei dottori.<br />
Quando s’accendono il sigaro non ti buttano mai i<br />
fiammiferi per terra. Non fanno come facciamo noi,<br />
209
quelli. Li rimettono nella scatola o nel portacenere e<br />
così anche le cicche.<br />
– Questa si che è gente educata e pulita. Sono signori<br />
questi. Altro che noi.<br />
– Non ti sporcano per nulla. Quelli sì che la conoscono<br />
l’educazione.<br />
La fiera finì. Durò due giorni. E quei medici tanto<br />
educati che dalla loro bocca sbuffavano fumo ad intermittenza<br />
quasi fosse il tubo di scarico di una locomotiva<br />
a vapore, furono di manica larga nel dichiararci idonei,<br />
nel darci la licenza per fare i minatori nelle miniere<br />
della loro regina. Non ci restava che far ritorno a Sìligo<br />
e attendere la chiamata.<br />
Intanto ognuno riprese la propria attività. Il lavoro<br />
però, nell’impazienza e nell’ansia della partenza ci sembrava<br />
più duro che mai. L’ambiente più ostile di prima.<br />
Il ritmo lavorativo era sempre ugualmente teso. Solo lo<br />
stato d’animo era diverso. Nel petto ardeva il fuoco<br />
pronto a sferrare la vendetta contro il nostro passato vegetale.<br />
Curvi sulla zappa si lavorava inviperiti con il corpo<br />
teso sotto lo sforzo e con la mente tesa verso la nostra<br />
terra, l’Olanda.<br />
Più che mai ora durante i lavori mi risentivo i discorsi<br />
degli emigrati in Canada e in Australia quando anche<br />
loro schierati alla giornata sotto l’occhio vigile del <strong>padrone</strong>,<br />
trovavano il bollente ardore per inveire contro<br />
l’ambiente. Ora sì che la capivo e la sentivo quella stessa<br />
rabbia.<br />
Finalmente un giorno giunse l’ordine della partenza.<br />
Gigi mi venne a portare la notizia a Baddhevrùstana in<br />
motocicletta.<br />
210<br />
Di colpo mi sentii come una pecora cui il <strong>padrone</strong><br />
slega le pastoie. Sussultai di libertà. La notizia mi dilatò<br />
di gioia e nel petto sentii un forte strappo quasi io fossi<br />
una tavola inchiodata ad un’impalcatura e la notizia<br />
fosse un arnese che la stava per svellere. I chiodi si allentarono.<br />
Scricchiolarono. E quasi per incanto mi sentii<br />
divelto dai vegetali: da tutta quella natura, dagli animali<br />
e da quel silenzio amico e compagno inseparabile<br />
per molto tempo. Subito squadrai il nostro campo nella<br />
sua distesa tortuosa. Lo percossi con lo sguardo e lo<br />
possedetti ancora un po’ nel mio intimo, quasi me lo<br />
volessi sorbire come un bicchiere d’acqua. Ascoltai il<br />
suo silenzio che mi balbettò qualcosa. La motoretta di<br />
Gigi, però, non mi lasciò mettere in intimo contatto come<br />
al solito. Era impaziente anche lui. Gli montai alle<br />
spalle e via a Sìligo.<br />
Mia madre vi stava già preparando la roba per la partenza.<br />
Con Gigi organizzammo uno spuntino per festeggiare<br />
con gli amici l’inizio della nostra strada. Venne<br />
la notte e fu lo spuntino. Contenti come due giganti<br />
felici, padroni della nostra esistenza. Nella cantina si<br />
andava a tentoni, da una botte all’altra per trovare il vino<br />
migliore.<br />
Con allegria e baldoria così si fece il giro del paese intercalando<br />
di tanto in tanto ai canti con la chitarra un<br />
ballo sardo, un tango o un valzer con la fisarmonica che<br />
già incominciavo a suonicchiare. Tra un canto e l’altro<br />
stava quasi per sopraggiungere l’alba, ma nessuno voleva<br />
andarsene a letto.<br />
– Un’altra serenata. L’ultima, ve lo prometto, su!<br />
211
Inòghe mi vaghe die<br />
cantèndhe a palma doràda<br />
tue in su lettu coscàda<br />
e deo frittu che nie...<br />
Finì la rituale serenata, ma finì anche la notte e l’alba<br />
rese assurdo il canto. E tutti storditi dal sonno e dal vino<br />
nessuno ebbe il coraggio di presentarsi dai suoi in<br />
quelle condizioni. Allora ci ricoverammo nella casa disabitata<br />
di uno della compagnia. Ci buttammo alla meglio<br />
su un grosso letto in otto: uno sull’altro. E un po’<br />
per mancanza di posto un po’ per l’effetto del vino ogni<br />
tanto per la stanza risuonava il tonfo di qualcuno che<br />
cadeva dal letto accompagnato dalle risate della combriccola!<br />
Le ultime risate. Un pisolino a testa. E il tonfo<br />
di un compagno che cadde dal letto come una pera cotta<br />
ci svegliò. Io e Gigi entrammo in clima di distacco.<br />
Ricomposte le valige, si raggiunse subito la piazzetta.<br />
La solita cerimonia di pianti e di lamenti e via. Lo schiavismo<br />
agreste ci sembrava finito. L’ignoranza su tutto e<br />
del nostro futuro, ma soprattutto del fatto che i nostri<br />
padroni sarebbero stati sconosciuti a Sìligo e a noi stessi,<br />
rendeva meno dura la nostra partenza: meno tragico<br />
e doloroso il nostro distacco. Eravamo tanto ingenui<br />
che di fronte all’evento ci comportammo come bestie<br />
di fronte a un fatto mai visto e mai vissuto.<br />
Il nuovo comportamento non fu dissimile da quello<br />
di Pacifico un giorno di fronte all’incendio del nostro<br />
campo. Quando fu raggiunto dal fuoco in mezzo al fieno<br />
invece di scappare (come fanno alcuni animali, il<br />
cavallo, gli uccelli, ecc.) offrì il culo alle fiamme e si mi-<br />
212<br />
se a bombardarle con gli zoccoli già ustionati. Il fieno<br />
era poco. Gli arse sotto la pancia. Andò avanti, ma lui<br />
non si spostò di un centimetro. Ora, io, ci rido sopra a<br />
quest’assurdo calciare del somaro, ma mi rendo conto<br />
che la nostra esultanza di fronte alla partenza era anche<br />
più assurda di quei calci senza senso. Il fuoco che<br />
Pacifico calciava durò pochissimo, finché il fieno non<br />
si consumò. Il nostro fuoco, al contrario, era duplice e<br />
nella nostra partenza stavamo fuggendo quello sopportabile<br />
e calciando assurdamente quello che ci stava<br />
di fronte, anzi lo stavamo inseguendo. Corri, pullman,<br />
corri! Non potevo sapere che le fiamme di quella falsa<br />
libertà mi stessero bruciando e che io le stessi assurdamente<br />
calciando: bel Pacifico della situazione! Era incominciata<br />
anche per noi la partenza. Uno sguardo alla<br />
folla e ai tetti muschiosi di Sìligo e la montagna opprimente<br />
del mio passato parve staccarsi dal mio corpo<br />
inaridito. Un tonfo! E l’albero dello schiavismo<br />
parve cadere dietro il pullman, dietro la nostra sciocca<br />
euforia. L’unica cosa che mi dispiacque in quel momento<br />
fu il fatto che non avevo fatto in tempo a salutare<br />
il “mio” campo: il suo orizzonte, thiu Pulinàri, su<br />
Gobbe. Così tutta la realtà di Baddhevrùstana con i<br />
suoi alberi, i suoi burroni e le sue rocce, le colline e il<br />
monte con le sue creste in lontananza che tante volte<br />
venivano animati dalla mia fantasia desolata e che erano<br />
state le uniche persone amiche con cui avevo parlato<br />
a lungo nel loro silenzio, le avevo abbandonate così<br />
bruscamente, per inseguire quel fuoco. Tutto era avvenuto<br />
all’improvviso. Gigi era sceso a Baddhevrùstana<br />
in fretta e furia e non mi aveva dato il tempo di salutare<br />
213
la mia gente. Nella mia mente però era più viva di sempre.<br />
E fu come se il pullman dentro di me stesse trasportando<br />
tutte quelle immense querce: le rocce e le valli:<br />
Baddhevrùstana con le sue greggi e il loro sferraglio familiare<br />
a ogni pastore: l’orizzonte e il cielo. Tutto era<br />
diventato ricordo indelebile.<br />
Tra la rabbia ed il pianto, tra l’odio e l’amore, tra il<br />
sorriso e le lacrime, maledicemmo la terra sarda come<br />
se stessimo lasciando veramente la nostra prigione.<br />
E nella nostra beata ignoranza imprecavamo contro<br />
chi non ci aveva mai fatto male, contro la terra che ci<br />
aveva nutrito e contro le intemperie che l’avevano fecondata.<br />
Noi non conoscevamo altro fattore responsabile del<br />
nostro male. Il nostro vero avversario non lo potevamo<br />
ancora conoscere. E dal pullman che si snodava lungo<br />
la discesa e le pianure, di tanto in tanto, pronunciavamo<br />
l’ormai famosa frase, divenuta quasi rituale per gli<br />
emigranti: – Addio, querce di <strong>Sardegna</strong> (Adiu chercos<br />
de Sardìgna).<br />
Giunti a Sassari, a me e a Gigi accadde una cosa inaspettata,<br />
tanto spiacevole quanto poi doveva riuscirmi<br />
fortunata. All’ufficio emigrazione i nostri documenti<br />
non erano in regola. E il nostro imbarco, previsto a<br />
Porto Torres, non fu possibile.<br />
In un primo momento ci colpì la disperazione. Di colpo<br />
tutti i nostri progetti naufragarono e si sciolsero come<br />
ghiaccio al fuoco. Fu una cosa brutta. Ci eravamo<br />
già sentiti uccelli con la nostra libertà. Le nostre ali però<br />
non funzionarono, e non potemmo spiccare il volo.<br />
E come cani castrati a fresco di fronte al <strong>padrone</strong>, ci<br />
214<br />
toccò anche osservare il volo degli altri compagni convenuti<br />
a Sassari dai vari centri.<br />
– Cosa è successo esattamente, Gigi?<br />
– Maaa... Non lo so!<br />
– Che ti ha detto quella persona.<br />
– Ma, nulla. Credo che tuo padre non ti abbia dato<br />
il consenso. Tu sei minorenne.<br />
– Ma tu, tu sei maggiorenne.<br />
– He! Lo so! Avranno fatto di tutto per non farmi<br />
partire. Mio padre conosce thiu Pedru. Sai com’è!<br />
– Ma che razza di scherzo è questo? Ora debbo ritornare<br />
a Baddhevrùstana. Tu te ne freghi! La tua famiglia<br />
risiede a Sìligo e almeno la sera ti puoi vedere la televisione,<br />
uscire con gli amici...<br />
– E tu non puoi venire a Sìligo la sera? Vieni in bicicletta.<br />
– Eh, una volta la settimana. Mio padre, di più non<br />
mi farebbe venire. Io me ne vado servo pastore. Almeno<br />
al <strong>padrone</strong> glielo potrò pretendere di farmi venire<br />
in paese una volta la settimana. Glielo dirò chiaro e<br />
tondo ad Abramo. Mica sono un macigno, io.<br />
Così solo dopo cinque ore dalla partenza o per uno<br />
scherzo della situazione o per volere dei nostri genitori,<br />
dovemmo ingoiarci a ritroso quel salsiccione salato<br />
della strada che avevamo maledetto e rivedere tutti i<br />
punti dei campi che avevamo insultato gridando addio<br />
come se con quelle terre non avessimo avuto più a che<br />
fare. Sul pullman che ci riportava a Sìligo nell’ironia<br />
della sorte, seduto sul sedile mi rivedevo, con soggezione,<br />
di nuovo i campi insultati poco prima. Fu uno<br />
scoramento. E le ingiurie che vi lasciai la mattina me le<br />
215
dovetti rimangiare la sera. Nella corsa mi sembrava<br />
che mi stessi tracannando ed ingoiando a ritroso tutte<br />
le imprecazioni che avevo lanciato, non solo le mie, ma<br />
anche quelle degli emigranti precedenti.<br />
La natura tutta mi invase tempestandomi da tutte le<br />
parti. – Toh! Rimangiati le tue bestemmie. Sono ancora<br />
qui. Respiratele e rimettile dove le hai trovate. Le vedi<br />
le tue bestemmie? Su, rimangiatele!<br />
Il giorno dopo la falsa partenza ritornai nell’ovile a rivedere<br />
le gigantesche querce che sin da piccolo mi avevano<br />
sempre riparato dalle intemperie, dentro le loro<br />
cavità o dentro l’ombrello delle loro secolari ferite. Le<br />
rividi con molta soggezione. Ne avevo insultato tante simili<br />
nella rabbia della partenza e ora me ne vergognavo.<br />
Ero ritornato alla sorgente che avevo “cagato” io stesso<br />
e dovevo bere perché avevo sete. Bisognava ripulire la<br />
fontana. I primi giorni furono melanconicamente tristi.<br />
Dopo il primo approccio dimenticai tutto e la mia vita<br />
ritornò a inselvatichire. L’unica consolazione era un vago<br />
sentore del fatto che quel gioco del caso mi aveva evitato<br />
l’esilio in terra straniera dove sarei andato senza lingua<br />
né parola come era successo a migliaia di pastori<br />
prima di me. E insistendo intimamente su questo concetto,<br />
quasi per rifarmi dello scacco, quel sentore divenne<br />
uno zucchero che raddolcì l’amaro di quelle valli.<br />
Baddhevrùstana mi divenne più dolce. C’erano sempre<br />
mia madre e i miei fratelli e tutta la natura che mi riparlava.<br />
I buoi ritornarono sotto la mia giurisdizione. Ripresi<br />
ad arare alla giornata fino a tutto dicembre. E mol-<br />
216<br />
to spesso, per vincere la stanchezza, dietro l’aratro cantavo<br />
proprio su quegli stessi campi che mi avevano rimproverato.<br />
Finita la stagione arativa in agro (in s’aidattòne), continuai<br />
ad arare a Baddhevrùstana, seminando erbaggi<br />
per le pecore e per i buoi, orzo e avena per le galline.<br />
Mio padre era finalmente contento di avermi con sé.<br />
Ero il maggiore e gli rendevo più degli altri. E, poi, il<br />
fatto che io fossi in tempo di emigrare aveva rintuzzato<br />
la sua autorità, quasi incominciassi a essere meno suo. I<br />
suoi rimproveri ora erano meno feroci. La sua violenza<br />
educativa più contenuta. Aveva paura che le sue urla mi<br />
mettessero in fuga e me ne volassi proprio ora che gli<br />
producevo il massimo.<br />
Nonostante avessi ripreso il lavoro con la solita lena,<br />
non potevo rassegnarmi all’idea di fare il pastore e il<br />
massaio per tutta la vita. La partenza e la fuga erano<br />
sempre nella mia mente e la situazione me lo ripeteva<br />
continuamente. Sfuggire all’ambiente era il chiodo fisso.<br />
Mi ero rintanato a Baddhevrùstana come mi avevano<br />
ordinato quei campi. Cantavo e lavoravo. Ora, però,<br />
essi non sapevano che vi sbuffava un vento contrario a<br />
quello che mi ci aveva seminato a sei anni per crescere<br />
con loro. Quel vento mi turbinava alle spalle. E io mi<br />
ero accovacciato di nuovo lì, ma solo in attesa di spiccare<br />
il volo. Vivevo come una lepre spaventata e ansimante<br />
che per sfuggire alla bocca dei cani ripara in una forra<br />
con le orecchie tese, pronta a riprendere la rincorsa<br />
non appena i cani si stufano di snidarla o fanno ritorno<br />
all’ovile dal loro <strong>padrone</strong>.<br />
E come una lepre allora anch’io ad orecchie tese<br />
217
ascoltavo tutti i rumori che mi giungevano. Andavo a<br />
caccia di notizie sugli emigrati e passavo le mie giornate<br />
nell’ossessione della partenza.<br />
E anche se ero un pastore senza malizia, ingenuo più<br />
del montone che mi fecondava le pecore, dentro di me<br />
ruggiva un furore di conquistare qualcosa di cui non<br />
avevo consapevolezza. Calloso nelle mani e duro nei<br />
muscoli, vecchio nell’attività pratica, temprato dalle<br />
intemperie del freddo e del caldo, nello spirito ero tenerissimo.<br />
Fino ad allora avevo solo agito e reagito alla<br />
natura, ma le circostanze non avevano mai sollecitato<br />
le mie risorse interiori se non minimamente. Lottato<br />
molto, ma pensato poco. Avevo usato molto le mani e<br />
le braccia, ma il cervello non era stato mai veramente<br />
coltivato. Sempre dimenandosi tra le cose, mai al di sopra<br />
di esse. Dentro il mio fisico insuolato, però, c’era<br />
un entusiasmo fresco e incontenibile. Il mio io rimasto<br />
intatto con tutte le sue risorse interiori cercava la possibilità<br />
di uscire dalla tirannia che il fisico aveva dovuto<br />
imporgli. Stava in agguato: pronto a realizzarsi, quasi<br />
fosse una riserva nascosta pronta per un’eventuale<br />
rinascita. A mio padre avevo rubato tutta la saggezza<br />
che lui aveva rubato a sua volta agli anziani. A vent’anni<br />
anch’io nel lavoro ero adulto, “saggio”, “vecchio”.<br />
Dentro però le mie risorse rimasero come gemme su<br />
un tronco secco e aspettavano la loro stagione per schiudersi.<br />
Sapevo che la mia strada non sarebbe stata quella<br />
della pastorizia. Non c’era più posto lì per i sani come<br />
non ce ne fu per gli emigrati in Australia! Io ero sano e<br />
forte e quasi maggiorenne. E lì c’era posto solo per i<br />
218<br />
vecchi, per gli ingobbiti e per i paralitici. E poi quella<br />
gemma che anelava dentro di me, lì non avrebbe potuto<br />
mai schiudersi.<br />
Certo, anche in <strong>Sardegna</strong> c’era una strada aperta a<br />
ogni pastore, una strada che si poteva imboccare senza<br />
leccare i Don. Era il banditismo. Una strada infida dove<br />
puoi sprigionare tutto quello zelo che ti prude sotto i<br />
muscoli. Ma la tua gemma lì fa una brutta fine. Si schiude<br />
e cresce velocemente come in una primavera ubertosa.<br />
Opera la tua ribellione inconscia, irrazionale e<br />
isolata. Ma alla fine ti accorgi che la tua gemma è sbocciata<br />
sul fuoco. La tua pianta cresce contro la violenza<br />
organizzata della società che tu vorresti inconsapevolmente<br />
eliminare. E quella violenza è come una chimera<br />
sfuggevole e impalpabile. È come un vento per te, che<br />
ti brucia sino alle radici. E alla fine finisci per essere risucchiato<br />
dallo stesso turbine di quella violenza famelica<br />
e mai sazia: impastoiato nelle sue ventose e imbavagliato<br />
nella sua bava. Digerito prima di morire.<br />
Dei banditi avevo sentito parlare sin da bambino. I<br />
pastori, oltre a thiu Juànne, parlavano spesso delle loro<br />
grassazioni e delle loro gesta. Li temevano, ma li ammiravano<br />
anche. Molti di essi erano eroi, martiri della libertà<br />
che la loro gente non aveva mai avuto. Ma divenire<br />
banditi per la libertà degli altri in una giungla di serpenti,<br />
non è molto facile. Ci vogliono requisiti che non ti<br />
trovi: la consapevolezza di subire l’ingiustizia e la sventura<br />
di fare amicizia con un vero bandito, scivolare nel<br />
giro, insomma. E fu una fortuna che io non li abbia trovati,<br />
quei requisiti. Dentro di me stavo meditando cose<br />
tremende. Il banditismo puro come ribellione inconsa-<br />
219
pevole in quegli anni stava cedendo il posto a quello mafioso,<br />
degenerato nell’interesse personale e settario. Gli<br />
eroi sociali della libertà che desidera un pastore erano<br />
già scomparsi. E il banditismo era già estraneo a se stesso<br />
e a quelle cause originarie per cui era sorto.<br />
Nel mio intimo fu una scelta temporanea. La possibilità<br />
poi di realizzarmi in qualche altro modo avrebbe<br />
deciso. Continuai ad essere bandito civile, come tutti i<br />
pastori. Sapevo anche di non potermi arruolare nelle<br />
forze dell’ordine. Gli sforzi fisici fatti fin dai sei anni mi<br />
avevano impedito di elevarmi da terra oltre 1,59. I lavori<br />
forzati più grandi di me mi fecero crescere all’ombra<br />
della sofferenza succhiandomi ogni sostanza. Ero come<br />
uno sterpo all’ombra della tirannia del bosco. Piante<br />
immense mi toglievano il cielo con le loro branche e mi<br />
trafiggevano per terra con le loro immense radici diramandole<br />
in ogni direzione, asportando e convogliando<br />
le migliori sostanze sul loro fusto: sulla loro bocca per<br />
alimentare la selva folta dei loro rami, lasciandomi come<br />
sottobosco in balia della caldana a bocca spalancata.<br />
Sterpo morente sotto l’arsura in attesa dell’inverno.<br />
In quell’estate boccheggiavo anch’io in attesa della stagione<br />
che mi offrisse la via per sfuggire ai lavori forzati.<br />
La fuga in Olanda era andata male. E l’emigrazione<br />
mi aveva deluso. Avevo sentito brutte notizie sui nostri<br />
emigrati. I morti nelle miniere aumentavano. E l’unica<br />
via che mi si offrisse in Italia dentro la legge era l’arruolamento<br />
nell’esercito come volontario.<br />
Fu nell’inverno del 1957 che insieme a zio Gellòn nel<br />
220<br />
Municipio deciframmo a stento il bando propaganda<br />
per l’arruolamento nell’esercito di giovani da specializzarsi.<br />
Zio Gellòn inforcò gli occhiali e mi lesse il manifesto<br />
scorrendolo malamente con il bacolo e me lo tradusse<br />
nel suo dialetto di Porto Torres: – Inògghi di bboi arruolà<br />
ggazzu! (Qui ti puoi arruolare, cazzo!).<br />
I miei requisiti fisici non mi facevano paura. Ci voleva<br />
1,60 di altezza. Se mi stiracchiavo e tiravo il collo riuscivo<br />
a raggiungerlo. Avevo fatto le prove e spesso ci<br />
riuscivo. La mia statura effettiva allora era solo 1,59,<br />
ma un centimetro lo valeva il decollo della mia tensione<br />
sotto il metro. Era la cultura, la V elementare richiesta<br />
dal bando, che mi faceva paura.<br />
Da quando mio padre mi deportò a Baddhevrùstana<br />
la scuola non la vidi se non di passaggio quando andavo<br />
a Sìligo. Mio padre che aveva la V elementare ottenuta<br />
all’età di oltre trent’anni, quasi per ripagare i danni del<br />
mio svezzamento, tentò di insegnarmi qualcosa: l’alfabeto<br />
e un po’ di nozioni generali che lui sapeva a memoria.<br />
E se gli capitava di essere contento mentre si<br />
zappava nell’oliveto, spesso mi tempestava di domande.<br />
Cercava di farmi qualche “lezione” per trasmettermi<br />
quello che lui sapeva.<br />
– Qual è la capitale d’Italia?<br />
– Roma.<br />
– Il Monte più alto?<br />
– Il Monte Bianco.<br />
– Con chi confina l’Europa?<br />
– A est con i Monti Urali, a sud con il Mediterraneo...<br />
a ovest... boh!<br />
221
– Con l’oceano Atlantico e a nord con il Mar Glaciale<br />
Artico.<br />
– Il lago più grande del mondo?<br />
– Il Mar Caspio, mi avevi detto.<br />
– Vediamo, di storia. Giulio Cesare?<br />
– Il più grande generale romano.<br />
– Il sommo poeta?<br />
– Dante Alighieri. Ha scritto la divina commedia.<br />
– Matematica. Tre per tre?<br />
– Nove.<br />
– Sei per sei.<br />
– Trentasei.<br />
– Nove per nove?<br />
– Cinquantasei.<br />
– Ottantuno fa! Stanotte ripassati la tavola pitagorica.<br />
Non la sai ancora bene.<br />
– Sì, sì.<br />
Con questo stato culturale mnemonico e senza saper<br />
scrivere, dietro le mie insistenze, mio padre mi presentò<br />
ad una maestra di Sìligo.<br />
– Sì, ora ti pigli la licenza elementare. Non voglio<br />
questo scrupolo. È ora ormai. È un sacrificio che debbo<br />
fare. Te lo avevo anche promesso quando ti portai<br />
via dalla scuola.<br />
La maestra mi insegnò ancora meglio la conoscenza<br />
dell’alfabeto e alcune nozioni di carattere generale che<br />
mio padre era riuscito a insegnarmi tra una sfuriata e<br />
l’altra. Dopo tre mesi nel giugno mi presentai all’esame<br />
da privatista con i ragazzi di 12 anni. Fui promosso.<br />
Debbo confessare che il temino (“Una lieta scampagnata”)<br />
lo feci malissimo. Non ero in grado di scrivere<br />
222<br />
correttamente. La lettura poi era ansimante, affannosa,<br />
forzata, sillabica. Nelle parole lunghe quando giungevo<br />
alla fine mi erano già sfuggite le sillabe iniziali sicché<br />
non sapevo più che parola avessi letto. Mi risollevò un<br />
po’ l’orale. Quello che avevo sentito sin da piccolo dagli<br />
stessi pastori, da mio padre e dalla maestra non mi<br />
usciva più di testa. Tra le maestre che mi stavano esaminando<br />
c’era ancora qualcuna che si ricordò il mio allontanamento<br />
dalla scuola a sei anni. S’intenerirono<br />
nel rivedermi di nuovo sui banchi vestito da pastore.<br />
Così la commissione mi regalò la promozione. Certo<br />
non solo per fare un piacere a me. Le autorità scolastiche<br />
avevano l’ordine di promuovere i pastori già arruolabili<br />
anche se fossero quasi analfabeti. In questo modo<br />
la nazione combatteva l’analfabetismo sulla carta e<br />
creava una base arruolabile per la difesa della patria.<br />
Con questo diplomino honoris causa in latitanza esistenziale,<br />
zio Gellòn poté stendermi la domanda per<br />
arruolarmi come volontario. Ero risoluto a tutto. Avevo<br />
poco da perdere. Ero convinto che un ambiente<br />
peggiore del mio lo avrei potuto vivere solo in galera. E<br />
senza per nulla interrompere la monotonia dei miei lavori<br />
attesi con impazienza la chiamata per la visita psico-attitudinale.<br />
Così arando e erpicando da un campo<br />
all’altro, finalmente i carabinieri di Sìligo mi comunicarono<br />
di recarmi al distretto. Un “leone” si era interessato<br />
della mia domanda e fu accolta subito. In seguito,<br />
per la visita, mi mandarono a Cagliari. Non avevo mai<br />
visto un centro così grande. Sassari l’avevo vista l’anno<br />
prima approfittando della libertà che mio padre mi<br />
concesse per la festa di San Vincenzo. Con un gruppo<br />
223
di amici quella mattina ciascuno poté finalmente provare<br />
le pecore senza coda e vedere per la prima volta il<br />
mare di pomeriggio.<br />
Cagliari era più grande di Sassari e mi parve meravigliosa.<br />
Tutto era diverso da qualche paesino che già raramente<br />
mi era capitato di vedere. Fui ospite di zio<br />
Tottói, agente di custodia a Buon Cammino, anche lui<br />
sfuggito molto prima di me all’agricoltura forzata. E<br />
senz’altro per aver già vissuto la mia esperienza si rese<br />
conto sin da quando mi venne a prendere alla stazione<br />
che io, a Cagliari mi trovavo come una fiera fuori dal<br />
suo ambiente. Frastornato tra quei segnali che non potevo<br />
né conoscere né notare: dove mi era impossibile<br />
stabilire quale fosse il lato destro della strada o quello<br />
sinistro.<br />
Io lo seguivo standogli dietro finché prendemmo il<br />
tram che ancora non conoscevo.<br />
– Fatti la doccia, – mi disse, giunti a casa sua.<br />
– Che cosa è la doccia?<br />
– Vieni, vieni!<br />
Mi condusse nel bagno e mi spiegò tutto. Mi lavai<br />
con gli scrosci di quell’acqua calda con molto piacere.<br />
Le mie mani, però, non mutarono colore. Rimasero com’erano,<br />
annerite dalla terra che avevano rivoltato per<br />
tanti anni.<br />
Per rendermi presentabile zio Tottói mi fece usare la<br />
varecchina. Aveva vergogna di presentarmi in quelle<br />
condizioni alle autorità militari. Sicuramente non avrei<br />
fatto buona impressione ai medici militari: le mie mani<br />
sembravano due zoccoli di somaro. Mi agghindò bene<br />
insieme alla moglie e mi accompagnò in caserma per la<br />
224<br />
visita: alla Monfenera. Per prima cosa sostenni l’esame<br />
fisico. Con mia grande preoccupazione mi misero sotto<br />
l’ostacolo che dovevo superare: l’antropometro. Mi irrigidii<br />
tutto e mi stiracchiai fino allo spasimo in cerca di<br />
fare quel centimetro che mi mancava. Fu una lotta dura.<br />
Il collo teso, doveva sembrare quello di un galletto<br />
dal collo implume in lotta con l’avversario. La mia tensione,<br />
però, contro un simile avversario non valse nulla.<br />
Non mi sollevai oltre 1,59. Il centimetro della salvezza<br />
mi venne regalato.<br />
Un maggiore si presentò come per dimostrarci la sua<br />
fierezza, si impalò a distanza e ci squadrò tutti.<br />
– Buongiorno, ragazzi. Sappiate che state per intraprendere<br />
una strada dura, nobile e gloriosa e che state<br />
per prendere il posto di tanti eroi che conoscete dalla<br />
storia. Certo. Verranno anche le soddisfazioni. Imparerete<br />
un mestiere. Ora farete l’esame attitudinale. Un<br />
sergente deve avere molte attitudini: spigliatezza, intelligenza.<br />
L’attitudine al comando... E, soprattutto deve<br />
essere consapevole della funzione che dovrà svolgere<br />
per la sua patria.<br />
Finito il discorso, ci passarono dei quiz da compilare.<br />
Non si doveva scrivere. Non me lo sarei mai aspettato.<br />
Fu la mia fortuna. Notizie ne sapevo a sufficienza. La<br />
risposta giusta tra due sbagliate ero in grado di sottolinearla<br />
anche perché il mio vicino aveva la terza media e<br />
mi lasciava copiare. Inoltre le lezioni bomba di mio padre<br />
più o meno contenevano quelle risposte. Ero quasi<br />
abituato a questo tipo di esame. E per l’occasione mi<br />
furono utili anche notizie che sentii in bocca a dei pastori<br />
lungo la strada per Sìligo: leggevano “La Domeni-<br />
225
ca del Corriere” e a gara ciascuno citava nomi famosi e<br />
se li ascoltavano come suoni magici! Certo, se la prova<br />
fosse consistita in un tema, io sarei stato irrimediabilmente<br />
bollato. Loro, però, lo sapevano che la maggior<br />
parte non sapeva scrivere correttamente. E i quiz erano<br />
l’unico esame che noi si poteva mettere per iscritto. Fui<br />
così idoneo, come tanti altri, senza che nemmeno si venisse<br />
a conoscenza della mia grafia. E certo si dimostrarono<br />
coerenti: non potevano pretenderla.<br />
Durante il viaggio da Cagliari via Macomer-Ardara,<br />
meditavo sul mio futuro militare. E nel mio isolamento,<br />
nonostante il treno fosse zeppo, cercavo di immaginarmi<br />
la vita di un sergente. Ma non ci riuscivo. Per un attimo<br />
mi vidi nella divisa di un carabiniere, poi in quella di<br />
mio zio che ora avevo visto, quasi irriconoscibile, dentro<br />
la sua divisa. Mi guardai istintivamente come per<br />
assicurarmi che anch’io non fossi mascherato. Scossi<br />
fortemente la testa per farmi cadere il berretto. Me la<br />
toccai con le mani, ma la trovai solo folta di ciuffi. Il brivido<br />
svanì e non ci volli più pensare. Il treno filava portando<br />
tanti miei pensieri in lotta intonati al suo fracasso<br />
su quelle rotaie sgangherate. E con quel fracasso e con i<br />
suoi scossoni svanì anche il mio complesso di essere<br />
basso. La sua corsa mi stava riportando idoneo.<br />
Sotto le querce ora mi sentivo più alto, più libero. Finalmente<br />
davanti a me c’era un varco per fuggire all’incendio.<br />
E allora non pensai più di divenire un bandito.<br />
Ricacciai dentro il mio inconscio questa estrema possibilità<br />
disperata. E quasi fosse una colpa che avessi già<br />
commesso ora avevo quasi vergogna di avere pensato a<br />
una simile soluzione. Finii per concludere che sarei sta-<br />
226<br />
to bene nell’esercito. Gli anziani me lo avevano sempre<br />
detto e ora me lo ripetevano.<br />
– Sei un fortunato. Non è facile entrare sotto le armi.<br />
Humm! Ci vogliono raccomandazioni. Conoscenze!<br />
Leoni, ci vogliono!<br />
– Ora imparerai l’italiano. Conoscerai il continente.<br />
E non hai la sfortuna di andartene all’estero come mio<br />
figlio nelle miniere del Belgio.<br />
– Potrai venire in licenza una due volte all’anno. Le<br />
ragazze ti vorranno. Pastori ed emigrati loro non li vogliono.<br />
Anche loro vogliono restare in Italia a imparare<br />
l’italiano: divenire signore!<br />
– Certo, le stellette sono brutte. Maaa! Se ubbidisci!<br />
E si deve ubbidire, a chi ti dà il pane: come il cane al <strong>padrone</strong>.<br />
Che ti credi che il cane ubbidisce al <strong>padrone</strong> per<br />
amore? Ma lasciami la testa: per il pane! Gli custodisce<br />
le bestie e l’ovile perché è del <strong>padrone</strong>. Lui senza <strong>padrone</strong><br />
morirebbe.<br />
– Mio figlio è comandante di una stazione di carabinieri.<br />
Altro che stare qui a ingoiare polvere sull’aia e pane<br />
asciutto. Altro che calpestare la merda delle nostre<br />
bestie. Lui da solo guadagna quanto non guadagna tutta<br />
la mia famiglia. E la notte, stai tranquillo che non gli<br />
rubano il bestiame.<br />
Si era già in maggio. Io e mio padre ci schieravamo<br />
tutti i giorni con la falce per falciare l’erbaggio che ci<br />
cadeva sotto disposto a solchi. L’annata era ferace. L’orzo<br />
e l’avena stavano ingranendo (fini avverèndhe). Le<br />
spighe incominciarono subito a indorare. La mietitura<br />
ci attendeva.<br />
Ai primi di giugno, come guerrieri, armati con le falci<br />
227
icurve, mio padre, Filippo e io assalimmo il raccolto<br />
disposti in schiera, mietendo sotto la caldana e lasciandoci<br />
dietro i covoni ritti con i loro ciuffi dorati: creature<br />
parlanti delle nostre fatiche che giornalmente prima di<br />
staccare al crepuscolo riunivamo in biche (in mannas).<br />
In meno di un mese il raccolto lo buttammo giù e si ridusse<br />
ad un campo di stoppie. Ero contento che la mietitura<br />
finisse prima della mia partenza.<br />
Subito incominciammo a trasportare i covoni all’aia!<br />
Il giorno di San Pietro del ’58 a Baddhevrùstana giunse<br />
un tale in motocicletta, così come vi era giunto Gigi.<br />
Per trovarmi si spinse sulle stoppie immerso fino alla<br />
vita. Mi trovò con i buoi, intento a lanciare i covoni dell’ultima<br />
bica sul carro dove Filippo li accomodava alla<br />
meglio.<br />
– Devi venire subito a Sìligo. È arrivata la cartolina.<br />
Devi partire militare. Mi mandano i carabinieri. Hai tre<br />
giorni di tempo. Però devi presentarti subito in caserma<br />
per confermare le tue decisioni.<br />
Io ascoltai la notizia con il tridente tra le mani, ma alla<br />
fine quasi per vincere l’imbarazzo mi feci sotto e lanciai<br />
sul carro gli ultimi covoni quasi volessi indugiare.<br />
L’ora però era giunta. Di colpo mi vennero in mente<br />
tante cose: di quando avevo paura dei carabinieri sulla<br />
strada per Sìligo e mi sembrava impossibile che io sarei<br />
dovuto diventare un militare come loro: un guerriero,<br />
uno che dovrà fare la guerra.<br />
Con queste frasi interne dovetti lasciare carro e buoi<br />
e partire con quel tale. Filippo mi subentrò nell’aia per<br />
sgranare le biade con il lento passo dei buoi.<br />
Dietro quella motoretta sulla strada verso Sìligo pen-<br />
228<br />
savo alla prospettiva di dover fare per tutta la vita il militare.<br />
Sempre la stessa cosa, agli ordini di gente che<br />
non potrai mai conoscere se non dalla divisa. Non riuscivo<br />
a convincermi di partire.<br />
E anche se capivo poco allora di vita sociale, dietro le<br />
spalle di quel signore, la brezza della corsa (come se<br />
fosse lì per l’aria) mi fece affiorare una diceria diffusa<br />
tra i pastori: – Fare il carabiniere, il poliziotto è una cosa<br />
buona. Arruolarsi nell’esercito, come volontario, fa<br />
schifo: sono firmaiuoli.<br />
Questa diceria mi smussò un po’ l’entusiasmo! La<br />
motoretta pian piano, sotto sforzo, mi stava comunque<br />
portando in caserma. Era logora, ansimante come un<br />
somaro sotto eccessiva soma. Camminava pian piano, e<br />
le spalle di quel signore per un attimo mi ricordarono<br />
quelle di mio padre quando per la prima volta le vidi<br />
massicce ed oscillare al trotto. Quel nesso rievocativo<br />
mi ripiombò nel passato più remoto. E benché trasportato<br />
da “un somaro a fuoco”, raggiunsi quel giorno e risentii<br />
a ritroso quanto mio padre fu costretto a dire alla<br />
maestra e a me, il giorno del mio svezzamento sociale.<br />
L’immondezzaio alle porte del paese mi passò velocemente<br />
sotto gli occhi e quel primo segno della civiltà<br />
che vi avevo lasciato mi riportò al presente. Sìligo finalmente<br />
con le sue tegole muschiose, tinte dal tempo,<br />
con qualche ciuffo di erba che aveva avuto la sfortuna<br />
di nascervi, ci venne incontro. In un attimo fummo sulla<br />
piazza: sul cimitero di tanti ricordi che molti emigrati<br />
vi avevano lasciato nel pianto della loro partenza.<br />
Quel signore si fermò lì.<br />
Mi recai subito in caserma. Premetti il campanello e<br />
229
il suo suono tremolante suonò come la mia mente già<br />
scossa e intimidita.<br />
– Chi è? – Uscì una voce dallo spioncino a graticcio.<br />
– Mi avete chiamato per partire soldato.<br />
– Un momento.<br />
Subito il piantone aprì la porta e mi accompagnò nell’ufficio<br />
del suo brigadiere.<br />
– Lei è Ledda?<br />
– Sì.<br />
– Ha fatto domanda come volontario... sottufficiale<br />
nell’esercito?<br />
– Sì.<br />
– Mi è giunto l’avviso. Lei deve partire entro tre giorni<br />
al massimo, se non vuole perdere l’occasione. Naturalmente<br />
questo è un invito. Lei è ancora <strong>padrone</strong> di rinunciare.<br />
Decida subito, però.<br />
Io non sapevo cosa rispondere. Rimasi così impalato<br />
davanti alla scrivania con la mente che mi oscillava tra<br />
l’ovile, i solchi, l’aratro e quell’esercito che non riuscivo<br />
ad immaginare in nessun modo senza pensare alla<br />
parola guerra. E come se volessi dare una risposta a me<br />
stesso anziché al brigadiere, i miei occhi erano come inchiodati<br />
alla sua divisa. Il mio respiro si bloccò: la decisione<br />
mi faceva paura.<br />
– Beh! A cosa pensa? Io sto facendo il mio dovere.<br />
Debbo comunicare al distretto la sua decisione. Lo capisce?<br />
E finalmente vinta quella soggezione che mi suscitò il<br />
sopportare per la prima volta, a distanza ravvicinata, la<br />
presenza di un carabiniere, la mia bocca si contorse e<br />
incominciò a balbettare.<br />
230<br />
– La gente mi ha detto che nell’esercito si sta male. Si<br />
fa la guerra. I sottufficiali li chiamano firmaiuoli.<br />
– E perché, io non sono firmaiuolo? Tutti i militari,<br />
carabinieri, poliziotti, sono firmaiuoli. Tutti si fa la guerra,<br />
se scoppia. Anzi, nell’esercito, forse, si sta meglio<br />
che da noi. Che significa questo?<br />
– A Cagliari, poi, ho visto la caserma e i militari. Non<br />
mi è piaciuta. La gente li chiamano carne venduta, li<br />
chiamano.<br />
– Carne venduta, eh? Vorrei sapere chi è più venduto<br />
io o quegli emigrati in Australia. Lo vuole un consiglio<br />
da amico? La gente la lasci cantare. Io conosco la situazione<br />
di voi pastori qui a Sìligo e in <strong>Sardegna</strong>. È triste,<br />
come lo è dappertutto in Italia. Ti consiglio di accettare,<br />
di fare una prova. Tanto tu il militare lo dovrai fare<br />
lo stesso. Fra un anno dovrai partire di leva: sei idoneo.<br />
Tanto vale partire ora. La scelta, semmai, la farai in seguito.<br />
Vedrai che non te ne pentirai. Starai sempre meglio<br />
che a fare il pastore a Baddhevrùstana. Vedrai che<br />
molti di quelli che ti dicono o ti diranno firmaiuolo, ti<br />
invidieranno quando tornerai sottufficiale. Ma non lo<br />
sai che nell’esercito si fa carriera prima e non dovrai andare<br />
ad arrestare banditi, come facciamo noi. Lì sei più<br />
tranquillo. La gente queste cose non le può sapere.<br />
– Beh! Allora,... accetto.<br />
– Firmi qui!<br />
– La mia firma la faccio molto male.<br />
– Faccia con calma. Imparerà a farla. Su! Così! E<br />
buona fortuna.<br />
Il suo ragionamento mi parve logico e mi convinse.<br />
E con quella firma lenta ed incerta, da semianalfabeta,<br />
231
finalmente, mi consegnavo allo stato che mi aveva sempre<br />
ignorato: alla chimera inventata dai “leoni”.<br />
La partenza ora non poteva essere falsa. Avevo firmato.<br />
Scesi a Baddhevrùstana per dare l’addio alla pastorizia<br />
forzata e ai miei.<br />
E dal basto di Pacifico che mi stava riportando a Sìligo<br />
per partire per sempre, piangevo sentitamente, con<br />
dolore. Quelle campagne ormai erano parte della mia<br />
vita o meglio io ero divenuto una loro parte: un loro albero<br />
speciale sbocciato da un seme sventurato in preda<br />
al vento, ma in compenso dotato di gambe e di movimento.<br />
Mentre Pacifico mi sradicava da loro portandomi via<br />
con tutte le radici, nel silenzio più accorato mi fotografavo<br />
i luoghi a me più cari, imprimendomeli nella mente<br />
una volta per sempre per svilupparmeli con il ricordo,<br />
quasi non li dovessi mai più rivedere. Conoscevo<br />
per nome tutti gli alberi, le rocce, le calanche, i muri e<br />
gli sterpi: gli amati cespugli del campo e della contrada.<br />
Abbandonarli mi sembrava una vigliaccheria, una vergogna.<br />
Man mano che Pacifico trottava, il campo e tutta<br />
la sua gente viva nella mia coscienza ancora infantile<br />
mi salutava e sembrava volesse trattenermi, così come<br />
avevano fatto sotto gli scialli neri le madri degli emigrati<br />
in Australia.<br />
Così lasciai quelle terre e quelle bestie, tutta quella<br />
natura, con le lacrime che mi sgorgavano calde ed abbondanti<br />
rigandomi il volto come quando spesso era<br />
stato colpito dalla pioggia vorticosa mulinata dal vento.<br />
232<br />
E quasi per averne un ricordo più vivo mentre scomparivo<br />
verso luoghi da cui non le avrei riviste se non affettivamente<br />
e solo come erano nate e cresciute nella mia<br />
fantasia, non mi rivoltai più indietro.<br />
Sul trotto della bestia mi riascoltavo il loro saluto corale,<br />
pensando al fatto che l’ingresso a Baddhevrùstana<br />
era avvenuto sulla groppa di un somaro ugualmente tra<br />
il pianto, così come ora stava avvenendo l’uscita. E mi<br />
sembrava strano che il distacco da quella realtà che mi<br />
aveva fatto paura accettare, ora mi stesse causando un<br />
dolore incomparabilmente più grande.<br />
Era il 30 giugno quando partii per il CAR di Siena. Il<br />
volo non lo spiccai dalla solita piazzetta, ma dal bivio di<br />
Bànari, all’uscita di Sìligo. Mi ci accompagnò mio padre,<br />
mentre si stava recando a Baddhevrùstana. Fu l’unica<br />
persona presente alla mia partenza.<br />
Giunti al bivio, si attese il pullman in un imbarazzo<br />
reciproco che ci allacciava come un giogo dispaiato alla<br />
fiera. Nei suoi confronti mi ero sentito sempre come un<br />
capo di bestiame, come Pacifico. Mi aveva dovuto sempre<br />
imbastare ed usarmi come un attrezzo nel lavoro.<br />
Ma nell’attesa mi stavo preparando ad uscire dalla proprietà<br />
di mio padre e stavo incominciando a immaginarmi<br />
diverso dalle altre bestie domestiche. Non ci riuscivo<br />
del tutto. Il tempo stringeva e la circostanza mi<br />
stava strappando dal peculio e ci stava imponendo di<br />
recitare, almeno per un attimo, una parte mai vissuta.<br />
Dentro il nostro timido silenzio, tutti e due ci si preparava<br />
ad essere quello che non eravamo mai potuti essere:<br />
padre e figlio. Impalati lì, l’unica arma cui ognuno<br />
ricorreva per rimanere ancora dentro il nostro rapporto<br />
233
gerarchico, era il silenzio. Avevo quasi vergogna di divenire<br />
figlio davanti al mio <strong>padrone</strong> che mi aveva sempre<br />
dominato. Lui nel suo imbarazzo tradiva più o meno<br />
lo stesso sentimento: la soggezione di divenire padre.<br />
E come se ognuno si fosse abituato al proprio ruolo,<br />
ora nessuno voleva rinunciarvi. Gli attimi però correvano.<br />
E di tanto in tanto ci si stiracchiava il collo per<br />
vedere se il pullman si stesse snodando lungo la strada.<br />
Nessuno, però, voleva cedere a fare la parte che la circostanza<br />
ci imponeva in ogni caso. Il pullman con le<br />
sue trombe sbloccò quello stato d’impaccio. E ognuno<br />
pian piano riuscì, sia pure malamente, a mettersi finalmente<br />
nella posizione naturale. Io a risalire a quella di<br />
figlio, lui a retrocedere in quella di padre.<br />
Tirò fuori dei soldi e me li dette in silenzio, come se<br />
mi stesse dando la dote, spinto da una forza che forse<br />
lui stesso ignorava. Io li presi in silenzio, con soggezione<br />
come davanti al proprio <strong>padrone</strong> avevo visto sempre<br />
i servi prendersi vergognosamente quello che loro<br />
effettivamente spettava, timidi e chini: a testa bassa come<br />
quei cani pastori che per avere poca confidenza con<br />
il <strong>padrone</strong> si fanno sulla porzione timidamente o solo<br />
quando il pastore se n’è allontanato. Il pullman ci raggiunse<br />
e ci liberò da quello stato di disagio reciproco,<br />
da quella commedia che ci faceva male a recitarla.<br />
Ognuno si allineò nel nuovo ruolo: nessuno dei due naturalmente<br />
riuscì ad assumerlo. Ci salutammo compiendo<br />
reciprocamente un atto forzato e esprimendo<br />
ciascuno qualcosa che non sapeva dire e di cui quasi si<br />
vergognava.<br />
Tutti e due ci sentimmo come costretti a fare qualco-<br />
234<br />
sa che avremmo voluto evitare, ma che le circostanze ci<br />
imponevano. Ci si avvicinò. Ci si strinse un po’. Le nostre<br />
guance si sfiorarono di sfuggita: gli occhi cercarono<br />
di non incontrarsi. Avevamo vergogna di parlarci<br />
intimamente. Il nostro saluto finì così, tortuosamente,<br />
esprimendoci un affetto timido e frustrato. E ognuno<br />
come per liberarsi prese di corsa la propria via. Mio<br />
padre si tuffò su Pacifico. Io salii sul pullman. La corriera<br />
partì, subito sorpassò Pacifico e mio padre mi<br />
agitò la mano destra come per salutarmi, ma quasi per<br />
rifarsi di quell’ulteriore saluto che nel suo codice lo degradava<br />
se la prese con la bestia incitandola subito alla<br />
corsa. Io d’altra parte feci altrettanto. Gli agitai la mano,<br />
ma subito mi abbassai sotto il finestrino. Pacifico e<br />
mio padre ingobbito sul basto scomparvero insieme<br />
alla strada.<br />
La corriera mi stava portando via. Uno sguardo ai<br />
monti e subito scomparve anche Sìligo. E percorrendo<br />
la strada per Sassari, salutai i campi che però non avevo<br />
più il coraggio di insultare, come quando stavo partendo<br />
in Olanda. E questo un po’ perché ero solo, un po’<br />
perché non stavo lasciando l’Italia e anche perché, in<br />
fondo, mi ero reso conto che erano belli.<br />
Vidi la nave per la prima volta. Vi salii come vedevo<br />
fare agli altri, quasi fossi una pecora dietro il gregge.<br />
Mi feci un giro sul ponte, ma non mi entusiasmò per<br />
nulla. Finalmente sentii un ululato e la nave si mise in<br />
movimento. E mentre la vedevo strisciare sulle onde,<br />
mi sembrava un immenso aratro che rivoltava un enorme<br />
solco.<br />
La mattina, dopo aver trascorso la notte in un came-<br />
235
one su brande a teloni senza fare conoscenza con nessuno,<br />
nonostante fosse gremito di ragazzi che stavano<br />
raggiungendo i loro CAR, ero ansioso di vedere l’Italia.<br />
Sul ponte all’alba mi fu possibile, ma chissà perché non<br />
mi entusiasmò come speravo.<br />
Subito presi il treno e di tanto in tanto mi sentivo i nomi<br />
delle varie stazioni: quasi tutti mi erano sconosciuti<br />
e mi suonavano oscuri. Quelli che conoscevo mi davano<br />
un vago senso di contentezza: – Sono a Grosseto!<br />
Sono a Chiusi! – Il fatto che stessi attraversando l’Italia,<br />
mi stava dando un vago senso di orgoglio. – Qui ci<br />
sarà passato Garibaldi con le sue truppe. Qui avranno<br />
fatto la guerra molti soldati. Io spero di non farla. – Dai<br />
finestrini vedevo campagne sterminate: pecore e mucche<br />
come in <strong>Sardegna</strong> e mi ricordavano sempre Baddhevrùstana<br />
e le nostre bestie.<br />
Verso sera giungemmo a Siena. Era già il crepuscolo<br />
e la città la vidi solo sotto la sua illuminazione. La stazione<br />
mi lasciò indifferente come quelle di Giave o di<br />
Ardara che avevo visto ritornando da Cagliari.<br />
Appena scesi dal treno, quasi spontaneamente si formò<br />
un gruppo di ragazzi, tutti destinati per il CAR. Mi<br />
ritrovai con loro.<br />
Subito fummo “aggrediti” dai militari di servizio lì alla<br />
stazione. Avevano l’ordine di portarci in caserma e<br />
come se volessero soffocare la libertà che ancora ci restava,<br />
ci lanciarono una serie di improperi in gergo militare<br />
che nessuno di noi ancora conosceva.<br />
– Forza! Andiamo, burbe imbranate.<br />
– Ne dovrete mangiare di fagioli e di brodo.<br />
– Vi farete il mazzo qui, come ce lo siam fatto noi.<br />
236<br />
– E voi, maledetti firmaiuoli, dovete scoppiare. Scoppierete<br />
nelle corse, firme maledette.<br />
Io mi chiusi nel silenzio. E in un primo tempo mi nascosi<br />
dentro il gruppo. Ci chiamarono tutti per nome:<br />
io belai il mio “presente” come tutti gli altri. E subito<br />
ci incalzarono con ordini che io non capivo:<br />
– Venite qui!<br />
– Salite là!<br />
– Forza, mambruchi.<br />
Salimmo su i camion e ci portarono in caserma. E<br />
sempre assaliti dai soliti ordini, si riformò il gruppo e<br />
io seguii i miei compagni tra gli ultimi.<br />
I primi giorni furono per tutti un vero supplizio. Per<br />
me, però, fu ancora peggio. Ero abituato a quella libertà<br />
pastorale delle montagne che non ammette nel suo<br />
mondo né intrusi né ordini se non dalle sole forze della<br />
natura. Cinta di mura invalicabili la caserma mi sembrava<br />
un’immensa prigione. Non mi davo tregua. Andavo<br />
continuamente da una parte all’altra per i corridoi<br />
delle tetre camerate, interminabili labirinti. Una<br />
forza inconscia mi spingeva così ad aggirarmi solitario:<br />
le gambe appagavano la loro abitudine che avevano<br />
contratto nel percorrere le valli, ma nella mente era come<br />
se volessi trovare un varco per scappare. Più volte<br />
fui tentato di farlo. Ma una sentenza che ci avevano<br />
detto mi rintuzzava sempre: – Chiunque abbandona la<br />
caserma o non rientra nel tempo stabilito dal regolamento,<br />
viene considerato disertore: condannato e rinchiuso<br />
nelle carceri militari.<br />
237
Altro che scappare. Fuggire sarebbe stato peggio di<br />
fare il bandito.<br />
L’unico sfogo allora lo trovavo girovagando nell’impossibilità<br />
di poter fare conoscenza. Avevo ancora soggezione<br />
del prossimo. L’italiano non lo sapevo parlare<br />
che sillabicamente. Dovevo fare il balbuziente senza<br />
esserlo. Un vero smarrimento che trovava l’unico ripiego<br />
solo nei soliloqui desolati in sardo “pensato”, dentro<br />
quella divisa che mi faceva rabbrividire e che in un<br />
certo senso mi impastoiava. Le prime parole che imparai<br />
a pronunciare con una certa enfasi furono “signorsì”<br />
e “signornò”.<br />
Solo che all’inizio non sapevo quando bisognava dire<br />
la prima o la seconda formula. L’istinto alla fine mi suggerì<br />
di usare sempre “signorsì”. Tutto allora filava liscio,<br />
anche se le cose erano andate male. Signorsì per<br />
me era divenuta una formula magica e mi evitò molte<br />
punizioni.<br />
Il brusco scontro con la nuova vita mi rese ancora più<br />
diverso di quello che ero nei confronti degli altri. L’adattamento<br />
fu affannoso, come l’apprendimento dell’italiano.<br />
Spesso rasentò l’impossibilità e la disperazione.<br />
Il mio sardo lì non lo capiva nessuno. Io ero “muto” e<br />
senza una lingua: come un essere inferiore che non poteva<br />
esprimere quello che pensava.<br />
Per parlare allora dovevo fare più o meno come facevo<br />
a Baddhevrùstana nel silenzio del bosco dietro il<br />
gregge. Dovevo rientrare nel “mio” mondo che fortunatamente<br />
anche a distanza mi rapiva e mi distoglieva<br />
da quella desolazione. Il mio cervello, disperato, come<br />
238<br />
per creare un rifugio al nuovo ambiente ostile, secerneva<br />
fantasia viva: creava immagini. E con la disperata<br />
nostalgia, non potendo comunicare con altri, riviveva e<br />
si rievocava, golosamente disperato, il mondo che conosceva,<br />
anche se lo aveva lasciato al di là del mare: si<br />
rifiutava completamente di conoscere il mondo militare.<br />
Voleva vedere natura senza divisa.<br />
Dentro quelle mura annerite e scalcinate l’unica compagnia<br />
era sempre Baddhevrùstana. Sentivo sempre la<br />
voce di mio padre e dei miei fratelli: il raglio di Pacifico<br />
e il belato noto di qualche pecora. In una parola i dialetti<br />
della natura che io conoscevo annullavano il caos<br />
dei rumori e dei fatti di quella caserma ed erano l’unico<br />
sangue con cui palpitava il mio cuore che stava rischiando<br />
l’infarto.<br />
Uno spirito ferino mi ruggiva continuamente e mi<br />
stava sempre suggerendo di saltare quelle mura. Ma riuscii<br />
a controllarlo anche se come un pendolo gigantesco,<br />
oscillavo sbattendo ora la testa, ora i piedi sulla caserma.<br />
Spinto dalla disperazione, feci di tutto per mettermi<br />
a rapporto dal comandante di compagnia, per pregarlo<br />
di mandarmi di nuovo a Baddhevrùstana tra le mie pecore<br />
che sognavo ad occhi aperti.<br />
Bussai alla porta del suo ufficio con la stessa violenza<br />
con cui Rusigabèdra mi latrava quando voleva essere<br />
slegato.<br />
– Avanti!<br />
– Comandi.<br />
– Non si sa nemmeno presentare. Chi è lei?<br />
– Recluta Ledda Gavino, 1ª Compagnia.<br />
239
– Humm! Stia sul riposo.<br />
– Signorsì.<br />
– Che cosa c’è?<br />
– Io... voglio ritornare a casa.<br />
– Ha, ha, ha!!! Vuole ritornare a casa il nostro bambolone.<br />
– Mi sono pentito di essermi arruolato. Questa vita<br />
non è fatta per me.<br />
– La solita storia di voi volontari. Ormai tu hai firmato.<br />
Hai accettato volontariamente. Io non ti posso prosciogliere.<br />
Che facevi a casa?<br />
– Il pastore e l’agricoltore.<br />
– E perché te ne vuoi ritornare tra le tue pecore?<br />
– Perché le conosco. Qui io non conosco nessuno.<br />
Non so parlare l’italiano. Credevo si stesse meglio.<br />
– Di dove sei?<br />
– Sardo.<br />
– Ho capito. Ti farò conoscere tutti gli altri volontari<br />
sardi come te. Ce ne sono tanti. Con loro almeno potrai<br />
parlare. Ma come mai non ti hanno messo insieme a loro?<br />
I sardi in genere li mettiamo sempre insieme.<br />
Il comandante fece una pausa. Poi di scatto mi trafisse<br />
con gli occhi e mi assalì.<br />
– Vuoi proprio vivere ancora sullo sterco delle tue pecore?<br />
La vita è difficile dappertutto. Qui imparerai un<br />
mestiere, no? A quale specializzazione ti hanno assegnato?<br />
– Radiomontatore.<br />
– E te ne vuoi ritornare all’ovile? Tu sei matto! Ragazzi<br />
come te, me ne passano a decine. I primi giorni si disperano,<br />
poi si ricredono e accettano la realtà. Diventa-<br />
240<br />
no i nostri migliori sergenti. Tu ora prova. A fine ferma,<br />
se non ti va, ti potrai congedare e ritornerai nel tuo paese<br />
a riparare le radio e i televisori, non più a mungere le<br />
pecore. È completamente inutile che tu stia lì a disperarti.<br />
Fatti coraggio! Il servizio militare lo dovrai pure<br />
fare, no? Arrivederci, Ledda.<br />
Con quella tirata il comandante rintuzzò le mie impennate.<br />
Mi impastoiò le caviglie come bestia indocile<br />
allo svezzamento.<br />
Uscito fuori mi sentii tutto agitato e turbato come acqua<br />
sporca dentro un secchio che lui ormai aveva posto<br />
sul “terreno militare”: le mie intenzioni dovevano ormai<br />
scendere sul fondo e sedimentare dentro quella divisa<br />
che non mi poteva più concedere di valicare le mura<br />
della mia “nuova tanca”. Ormai lì ci dovevo pascolare<br />
e i miei belati non avevano alcun senso. Per qualche<br />
giorno ancora mi ci sentii come un capo di bestiame<br />
buttato improvvisamente in gregge estraneo: diffidato<br />
e diffidente dei nuovi compagni.<br />
La decisione del comandante, di mettermi insieme<br />
agli altri volontari sardi, fu proficua. In una camerata<br />
trovai veramente una piccola <strong>Sardegna</strong> composta di ragazzi<br />
con le mie stesse condizioni psicologiche. Si parlava<br />
il sardo. E anche se sul piano culturale erano più<br />
progrediti di me in senso “ufficiale” (quasi tutti avevano<br />
frequentato regolarmente le elementari), tuttavia<br />
quando erano costretti a rispondere ai superiori anche<br />
in loro potevo notare la affannosa espressione a singhiozzo.<br />
Anche loro erano balbuzienti. Le nostre risposte<br />
erano sempre delle traduzioni dal sardo. La paura<br />
reverenziale che si doveva tenere verso i “superiori”<br />
241
unita alla simultaneità della traduzione, rendevano ancora<br />
più lente e spesso ridicole le nostre risposte.<br />
I calabresi, i siciliani, i napoletani, a parità di cultura,<br />
si esprimevano nel loro dialetto e facevano più figura di<br />
noi. La lingua nazionale era sempre più lontana dal sardo<br />
che da qualsiasi altro dialetto. Tra di noi però, potevamo<br />
esprimerci in sardo a patto che non fossimo di servizio<br />
e che non ci fossero “superiori” presenti (avremmo<br />
potuto burlarci di loro impunemente).<br />
E questo era un fatto che costringeva noi sardi a stare<br />
sempre insieme: un branco di “animali diversi”. La divisa<br />
ci accomunava solo per i superiori, ma nella realtà<br />
tra noi sardi e gli altri soldati c’era di mezzo la separazione<br />
della lingua.<br />
Ora dovevo adattarmi. Ogni giorno sotto il caldo di<br />
luglio e d’agosto a piazza d’armi si svolgevano l’addestramento<br />
formale e gli esercizi ginnici. Per me che provenivo<br />
dalla mietitura, fresco fresco, gli sforzi fisici richiesti<br />
erano dei giochi, delle passeggiate. Molti, invece,<br />
anche se erano più robusti di me, li vedevo accasciarsi<br />
a terra, in un bagno di sudore mai versato.<br />
Quello che mi dava estremamente fastidio erano gli<br />
ordini e la loro scansione: – Passooo! – – Destr! rigaaaà!<br />
– – Fissi! – – Diii corsaaa! – – Segnare il passooo!<br />
– – Alt, riposo!<br />
Questi ordini collettivi riuscivo anche a sopportarli<br />
perché il movimento serviva da scarico. E provavo anche<br />
soddisfazione nel sentirmi ritmato e zig-zagato insieme<br />
agli altri nei vari movimenti, convergendo ora a<br />
242<br />
destra ora a sinistra. Mi dava piacere sentire lo schiocco<br />
del mio piede tonfare insieme a quello degli altri e così<br />
l’oscillazione del braccio.<br />
Gli ordini più opprimenti erano quelli individuali.<br />
– Ora vediamo se avete imparato a salutare e a presentarvi<br />
a un vostro superiore, – fece un tenente. – Ora<br />
chiamo un caporale. Voi guardate come mi si presenta.<br />
Lui fingerà di essere una recluta.<br />
– Tu!<br />
– Comandi.<br />
– Vieni qui.<br />
– Recluta tal dei tali, 1 a compagnia, I plotone, 3° Reggimento<br />
Fanteria Venezia CAR.<br />
– Benissimo! Puoi andare!... Avete visto? È chiaro?<br />
Nei movimenti dovete essere scattanti e precisi.<br />
Quando si passò a chiamarci uno per uno era un teatro<br />
comico.<br />
Al richiamo del superiore il soldato scattava e correva<br />
da lui e gli si impalava davanti come se fosse un oggetto<br />
mosso internamente da quelle frasi e da quei gesti<br />
imparati a memoria. La presentazione, il saluto, lo stare<br />
sull’attenti. Spesso ti dimenticavi qualcosa o la dicevi<br />
male. Tutti gli altri soldati si mettevano a ridere. Più di<br />
una volta capitava che una recluta s’impalava, talmente<br />
imbranata da non ricordarsi nemmeno il suo nome. Allora<br />
le risate erano sonore.<br />
Io ascoltavo sempre come un leprotto e osservavo come<br />
uno sparviero. Tutte quelle frasi mi servivano per<br />
imparare l’italiano. Quei gesti fatti in un solo modo li<br />
usavo per realizzarmi di fronte agli altri.<br />
Certo le figuracce che facevo davanti ai superiori a<br />
243
causa della mia espressione ferina quando mi si comandava<br />
di presentarmi, destavano le risate anche dei miei<br />
compagni sardi. Emozionato ed intontito, quelle frasi<br />
sulla mia bocca sembravano versi di animali. L’unica<br />
cosa che mi sosteneva, ora che avevo deciso di far fronte<br />
alla situazione, era l’ardore di non darmi mai per vinto,<br />
come il montone nella sua lotta cozza e ricozza, finché<br />
spesso vince proprio quello più piccolo e più testardo.<br />
E se i miei compagni sardi rispondevano meglio di<br />
me e si sapevano presentare meglio di me riuscendo ad<br />
evitare qualche risata da parte dei caporali, io sapevo<br />
che ciò dipendeva solo dal fatto che erano più socializzati<br />
di me. Io, come qualche altro (in genere analfabeti,<br />
sardi, calabresi e meridionali, ma anche veneti) dovevo<br />
fare il buffo della situazione. Spesso quando mi si richiamava<br />
mi impalavo ben composto sull’attenti esprimendo<br />
bene i gesti, ma mi toccava rimanere con la bocca<br />
spalancata senza parola con tanto fiato e tanta rabbia<br />
in corpo una volta che avevo dichiarato solo il mio<br />
nome. La formula magica scompariva. Allora dovevo<br />
subire la violenza verbale dei caporali:<br />
– Imbranato! Mambruco! Beduino!<br />
– Signorsì! – era la mia conclusione.<br />
Le giornate si facevano sempre più movimentate. Le<br />
corse e gli esercizi sempre più difficili. Dove non si doveva<br />
parlare però, io andavo bene. Vinsi addirittura la<br />
corsa di 10 Km con lo zaino. La corsa era per plotoni e<br />
io giunsi primo e solitario dopo aver doppiato tutti i<br />
plotoni che mi precedevano alla partenza.<br />
Il giorno più bello era quando si prendeva la decade.<br />
244<br />
Soldi da casa non ne ho mai ricevuto al di fuori di qualcosa<br />
che dentro le lettere mi mandava mia madre.<br />
Si faceva la fila, tutti impazienti. E spesso dovevo subirmi<br />
gli insulti dei compagni, perché per fare la firma<br />
impiegavo molto tempo: – Dài! Ledda, ma quanto ci<br />
metti a fare uno scarabocchio? Non sai fare nemmeno<br />
la tua firma? Imbranato!<br />
Con quei soldi riscossi sotto l’incalzare dei compagni<br />
uscivo in libera uscita con gli amici sardi e mi era possibile<br />
vedere un po’ come era fatto il mondo: La Piazza<br />
del Palio e tutte le bellezze di Siena mi attraevano molto.<br />
E a Siena per la prima volta guardai in faccia il mondo<br />
ufficiale con i soldi dell’esercito. E sempre con quei<br />
soldi a branchi ce ne andavamo al casino e spesso ci mungevano<br />
per bene. Donne prima di allora, a parte la volta<br />
che con amici, sfuggito a mio padre, ero andato a Sassari,<br />
non ne avevo mai toccato. E Siena per questo pagò<br />
gli arretrati: quando ero libero la prima tappa era il casino.<br />
Prima, altro non mi era possibile né di fare né di<br />
vedere. Spesso, da solo una volta sbucato fuori dalla<br />
porta della caserma, salutata la sentinella, raggiungevo<br />
il casino a trottone e, se la mia preferita la trovavo libera,<br />
me la facevo con il fiatone, focosamente, come facevano<br />
thiu Diddhìa e thiu Antonìccu con le loro mogli.<br />
Così il CAR di Siena fu l’inizio della socializzazione<br />
del mio io cavernicolo.<br />
Dopo la metà del mese di ottobre, tutti i volontari furono<br />
destinati a Roma, per il corso di specializzazione.<br />
Ero contento di capitare a Roma. La trovai piena di tutto:<br />
stupenda e meravigliosa.<br />
Le cose per me purtroppo si misero male. Tutti i com-<br />
245
pagni del CAR mi abbandonarono. Io solo di tutto il<br />
gruppo fui destinato alla caserma della scuola Trasmissioni.<br />
Gli altri furono dispersi in varie altre scuole, a seconda<br />
delle specializzazioni che avevano scelto o che le<br />
autorità avevano loro assegnato in base alle attitudini.<br />
Mi lasciò perplesso comunque il fatto che nessuno<br />
frequentasse il mio corso. Sapevo solo che chi era andato<br />
bene nelle selezioni di Cagliari aveva il diritto di frequentare<br />
il corso di specializzazione che ognuno aveva<br />
specificato nella domanda. Sul momento pensai che tutti<br />
i miei compagni del CAR di Siena a Cagliari avessero<br />
offerto una prova mediocre. Invece si trattava di un<br />
equivoco.<br />
Quando compilammo la domanda zio Gellòn ed io ci<br />
lasciammo trasportare dai paroloni e scegliemmo una<br />
specializzazione che alla nostra fantasia suonava come<br />
qualcosa di originale, di fantastico: Radiomontatore!<br />
Certo. Senz’altro. Era una delle più belle e fra le più attuali,<br />
rispetto a quelle di armaiuolo o di zappatore. Però,<br />
nella foga della scelta non ci accorgemmo per nulla<br />
che per la specializzazione di radiomontatore ci voleva<br />
la terza media.<br />
Seppi la cosa all’improvviso all’inizio del corso. I miei<br />
compagni del CAR di Siena erano andati bene e avevano<br />
compilato bene anche le loro domande scegliendosi<br />
una specializzazione in base alla propria cultura.<br />
Così rimasi di nuovo solo: unico allievo del corso con<br />
la V elementare (l’avessi almeno digerita).<br />
Fu un affronto senza colpa. La sbadataggine di zio<br />
Gellòn e la negligenza burocratica dell’esercito mi coinvolsero<br />
in un’impresa superiore alle mie forze.<br />
246<br />
I superiori ignoravano la mia situazione. Per loro era<br />
scontato che chi era lì avesse fatto la terza media. Io d’altra<br />
parte cercavo di nascondermi. E così, stranamente,<br />
l’aula che frequentai con una certa consapevolezza fu<br />
quella della scuola di Trasmissioni. Lì era tutto puntuale<br />
peggio della scuola del babbo a Baddhevrùstana.<br />
La mattina, preso il caffè, con il solito bromuro, per<br />
rintuzzare la nostra smania sessuale, alle sette ci inquadravano<br />
e ci conducevano in aula.<br />
Ognuno si sedeva al suo posto. Finalmente anch’io<br />
potevo sedere su un banco davanti a una lavagna con il<br />
gesso e la cimosa. L’unico sconforto era quell’equivoco<br />
e la perdita degli amici del CAR. Sardi ce n’erano anche<br />
lì, provenienti da altri CAR, ma non li conoscevo. E in<br />
quell’aula mi sentivo un estraneo, un intruso. Gli altri<br />
erano veramente diversi da me. Ce n’erano addirittura<br />
alcuni che avevano fatto studi superiori.<br />
E anche se nel mio intimo contavo molto sulla mia<br />
rabbia, sulla mia volontà e sulla mia applicazione, ero<br />
davvero preoccupato: non ero in regola. L’inizio del corso<br />
fu veramente un temporale di lampi e di tuoni che<br />
bombardò la mia mente con parole strane, incomprensibili,<br />
quasi magiche: atomi, elettroni, nuclei, reazioni<br />
fisiche.<br />
Le parole del tenente che teneva il corso di elettrologia,<br />
mi affascinavano, anzi, mi ammaliavano, ma non le<br />
capivo.<br />
– Se c’è qualcuno che non ha capito qualcosa, – diceva<br />
alla fine di ogni argomento, – me lo dica adesso. Coraggio.<br />
– Magari! – facevo a me stesso. Nell’aula, però regna-<br />
247
va il silenzio più profondo. Ognuno aveva paura di manifestare<br />
scarsa perspicacia, mentre io dovevo rimanere<br />
nel mio silenzio e nella mia ignoranza completa. Al<br />
CAR ci avevano insegnato a dire sempre signorsì. Rispondere<br />
negativamente al tenente ci sembrava un’infrazione.<br />
– Siete tutti bravi, – concludeva lui. – Meglio così.<br />
Guardate, ragazzi, fra venti giorni incomincerò ad interrogare,<br />
se non avete capito qualcosa fate bene a dirmelo<br />
subito.<br />
Nulla da fare: la paura di pronunciare “no” era troppo<br />
grande e sulla nostra ignoranza si accumulava il silenzio<br />
del dubbio.<br />
La mia testa continuava a riempirsi di parole strane<br />
che imparavo a memoria, senza capirne il senso e avevo<br />
deciso di fare come facevano le vecchie di Sìligo che<br />
nonostante fossero analfabete ripetevano in latino l’Ave<br />
Maria o il Pater noster. Non avevo altra scelta.<br />
Con il passare dei giorni mandare a memoria cose di<br />
cui non capivo il senso e ripeterle al tenente come preghiere<br />
stava divenendo sempre più difficile. Le lezioni<br />
si susseguivano a ritmo incalzante. Non riuscivo più a<br />
contenere le nuove preghiere.<br />
– Oggi – fece il tenente, – vi spiego la legge di Ohm.<br />
È molto importante. Se capite questa legge capirete subito<br />
l’elettrologia. – Si fece alla lavagna e scrisse la formula.<br />
– Come vedete è una semplice moltiplicazione.<br />
– Moltiplicazione? Roba da pazzi. Non ci capisco più<br />
nulla. Una moltiplicazione così io non l’ho mai vista, –<br />
dissi disperatamente nel mio silenzio.<br />
– Avete capito tutti? Se qualcuno non ha capito me lo<br />
248<br />
dica subito. Cercherò di essere più chiaro. Se no, vado<br />
avanti.<br />
Tutti zittirono, come al solito.<br />
Ma io che ero sui banchi dai mormorii sentivo che anche<br />
gli altri non avevano capito. Io non dovevo salvare la<br />
mia perspicacia. Era buio assoluto e sollevai il braccio.<br />
– Di’ pure, Ledda.<br />
– Non ho capito nulla, signor tenente.<br />
– Oh! finalmente uno che ha coraggio!<br />
Fece un riepilogo della lezione che però servì solo<br />
agli altri. Io non l’avrei potuta capire allora in quell’aula.<br />
Simili scene tra me ed il tenente si ripetevano spesso.<br />
La mia ignoranza e la mia inutile volontà di capire servivano<br />
bene alla situazione. Almeno c’era uno che spesso<br />
diceva “no”, che si traduceva in un utile riepilogo,<br />
ma solo per gli altri.<br />
Il tempo passava. Il programma cresceva e io mi stavo<br />
smarrendo in quella selva di argomenti e di leggi. La sera<br />
quando si ritornava nelle camerate, dopo cena, pregavo<br />
qualche amico perché mi spiegasse qualcosa. Ma<br />
un po’ perché non lo sapevano, un po’ per gelosia e per<br />
eliminare un concorrente, nessuno mi “dava ripetizioni”.<br />
Ad alcuni addirittura avevo promesso metà della<br />
decade, ma non c’era nulla da fare. Ognuno lì pensava<br />
solo a se stesso. Un vero problema. Leggevo e rileggevo<br />
le dispense, ma oltre a non capire le leggi e le formule,<br />
non ero in grado nemmeno di capire il senso delle parole.<br />
Di notte, quando tutti dormivano, mi rinchiudevo<br />
nei gabinetti per studiare clandestinamente. Era l’unico<br />
posto dove di notte la luce rimaneva sempre accesa.<br />
C’era sempre molto silenzio. E lì assorto e penando cer-<br />
249
cavo di capire qualcosa e di ricordarmi le spiegazioni<br />
che di giorno ci faceva il tenente. Tutti i miei sforzi però<br />
erano inutili. I miei pianti solitari, le dispense bagnate<br />
dalle lacrime della mia rabbia e il silenzio profondo, interrotto<br />
solo dalle scariche dei WC, non mi potevano<br />
aiutare.<br />
“Chi sa come andrà a finire? Se non supero il corso mi<br />
prosciolgono e dopo i diciotto mesi regolamentari mi rimanderanno<br />
a Baddhevrùstana a fare quello che facevo<br />
prima sotto la furia di mio padre. Ce la devo mettere tutta.<br />
Solo che non so cosa mettere. Se avessi soldi andrei a<br />
ripetizione fuori, la sera, la domenica. I miei compagni<br />
la matematica la sanno, io no. Il corso, ora mi sta interessando.<br />
Se lo finisco, farò come ha detto il comandante<br />
di Siena: a fine ferma ritornerò a Sìligo a riparare le radio.<br />
Ne vale la pena. Sarò unico lì e avrò da lavorare. Altrimenti<br />
mi toccherà rifare il pastore con il pensiero rivolto<br />
ad emigrare altrove. E, poi, la gente di Sìligo me ne<br />
dirà di tutti i colori: Il figlio di Abramo non è riuscito<br />
nemmeno a passare sergente. Bel montone. C’è passato<br />
anche mio padre che non sapeva né leggere né scrivere.”<br />
Era come se li stessi sentendo.<br />
Ora a Roma avevo veramente capito cosa l’esercito<br />
mi avrebbe offerto e volevo sfruttare l’occasione a tutti<br />
i costi. Tra i compagni di corso c’era un certo Toti che<br />
era il più bravo del corso e da civile aveva fatto il radiotecnico<br />
di professione. Il silenzio dei gabinetti mi fece<br />
pensare a lui e nella mia disperazione ora sembrava che<br />
lui si fosse arruolato per aiutare me. Il programma del<br />
corso per lui era un ripasso: una passeggiata. Così come<br />
250<br />
per me erano tutte quelle corse che mi avevano fatto fare<br />
al CAR. La radio la conosceva pezzo per pezzo. Era<br />
uno di quegli appassionati capaci di trascorrere un’intera<br />
notte per smontare e rimontare questa o quell’altra<br />
parte dell’apparecchio solo per la curiosità di vedere o<br />
rivedere come fosse fatta e come funzionasse.<br />
Gli spiegai la mia situazione con le lacrime agli occhi.<br />
– Se sono il più ignorante del corso la colpa non è mia.<br />
Voi avete tutti studiato. A me è qui che mi capita di studiare<br />
veramente per la prima volta.<br />
– Ma come mai ti hanno arruolato senza la terza media?<br />
– Ma non lo so! Ti dico sinceramente che io non sapevo<br />
che ci voleva.<br />
– Per questa specializzazione ci vuole. Hai visto quelle<br />
formule di elettrologia? Sono addirittura matematica<br />
delle scuole superiori.<br />
– Allora? Mi aiuti? Mi fai un’ora di lezione a sera. Ti<br />
do quello che posso.<br />
– Sì. Possiamo provare. Intanto da domani cambi banco.<br />
Ti metti al mio fianco, così ti posso spiegare qualcosa<br />
anche durante la lezione!<br />
La soluzione del mio problema l’avevo trovata. E<br />
mentre gli altri compagni se ne andavano al cinema della<br />
caserma, io e Toti, la sera, ci imboscavamo da qualche<br />
parte per riprendere le nostre lezioni.<br />
Con lui mi aprivo tutto e non mi vergognavo di nulla.<br />
Gli confessavo tutta la mia ignoranza anche nei minimi<br />
particolari. Era <strong>padrone</strong> della materia e mi dava anche<br />
fiducia. E tutte quelle formule per me da solo impenetrabili,<br />
con lui le valicavo. Mi smontava le valvole e i<br />
251
condensatori. Mi faceva vedere e toccare le resistenze e i<br />
trasformatori spiegandomene la funzione. Era veramente<br />
il mio maestro. L’aridità delle lezioni del tenente<br />
con lui scompariva attraverso la pratica. I mostri di<br />
quelle formule magiche che si erano creati nella mia<br />
mente e che io ripetevo solo come preghiere, durante le<br />
interrogazioni svanivano quando vedevo la radio nuda<br />
e palpavo tutti i suoi pezzi pensando alla loro funzione.<br />
Certo, non potevo improvvisare tutto il programma in<br />
una settimana. Ora, però, almeno stavo costruendo ed<br />
ero animato. Solo che nei compiti scritti precedenti avevo<br />
già rimediato due insufficienze.<br />
– Ledda, – mi disse un giorno il tenente in aula.<br />
– Comandi.<br />
– Devi presentarti dal signor capitano.<br />
– Signorsì.<br />
Tutto impaurito uscii dall’aula e mi presentai al comandante<br />
di compagnia come un cane picchiato si ripresenta<br />
al <strong>padrone</strong>.<br />
– Comandi, signor capitano.<br />
– Ah! Sei Ledda? Come mai non studi? – Incominciò<br />
ripetendomi il solito cicchettone riservato a quelli che in<br />
caserma definivano lavativi. – Io sono costretto a mandarti<br />
via dal corso. Lo sai che secondo il regolamento<br />
dopo tre insufficienze per scarso profitto un allievo<br />
viene prosciolto? Subentra come soldato regolare di<br />
leva. Finiti i diciotto mesi ritorna a casa. E poi, stavo<br />
dando un’occhiata ai tuoi scritti. Sono un orrore. Si<br />
leggono solo a pezzi. Non si capisce cosa vuoi dire. Errori<br />
di ortografia a non finire. Non ho mai visto compiti<br />
così confusi.<br />
252<br />
Io mi ascoltavo in silenzio la sua “lezione” con il nodo<br />
alla gola. Tremavo e non riuscivo a rispondergli. Non<br />
ero capace di giustificarmi. Ci pensarono, però, la circostanza<br />
e la necessità.<br />
– Signor capitano, io studio notte e giorno.<br />
– Come notte e giorno? La notte, i miei soldati li faccio<br />
dormire.<br />
– Ma io me ne vado nei gabinetti. C’è la luce.<br />
– Ma è roba da pazzi! Ti dovrei punire anche per questo.<br />
Ma... poi, questo non cambia per nulla la tua situazione,<br />
anzi. Studi anche di notte e sei l’ultimo del corso?<br />
– Io ho solo la V elementare. Quelle formule e molte<br />
altre cose io non le ho mai fatte. Io ancora non so scrivere<br />
correttamente. Gli altri prendono appunti mentre<br />
il tenente spiega. Io non ci riesco a scrivere in fretta.<br />
– Ma, come, non hai la terza media?<br />
– Signornò.<br />
– Impossibile.<br />
Si tuffò sulle sue cartelle e lesse le mie.<br />
– E come è possibile? Come mai ti hanno mandato<br />
qui a fare il corso di radiomontatore? Tu non lo puoi fare.<br />
E tu non potevi dirlo prima?<br />
– Io non ne ho colpa... I superiori...<br />
– Certo! Tu non hai colpa. Ma guarda quante cose<br />
succedono nel nostro esercito. Questa deve essere una<br />
svista. Ora capisco perché scrivi così. Io comunque non<br />
ci posso fare nulla. Prenderai la terza insufficienza e ti<br />
manderò da qualche parte a farti il regolare servizio di<br />
leva.<br />
– Ma signor capitano, io... ora sto andando bene. Sto<br />
incominciando a capire la materia proprio adesso. La<br />
253
prego di darmi ancora un mese di tempo. Ci riuscirò.<br />
Glielo prometto.<br />
– La tua proposta mi commuove, ma tu non potrai fare<br />
di meglio. Ormai il corso è già iniziato da due mesi.<br />
Man mano che passa il tempo, diventa sempre più difficile.<br />
Tu sei rimasto indietro. Non potrai recuperare. E<br />
un corso accelerato, per gente che ha già una certa preparazione.<br />
Ledda. Tu devi ancora imparare a scrivere.<br />
– Ma io ora ho un amico che mi sta aiutando e mi<br />
spiega tutte le cose che non capisco in aula. Le prometto<br />
che ce la farò. Ce la metterò tutta. Ogni sera mi fa<br />
un’ora di lezione.<br />
– Chi è quest’amico?<br />
– Toti.<br />
– Ahm! È molto bravo. Me lo ha detto il tenente. Ma<br />
tu non ci puoi stare. Sei stato arruolato come radiomontatore<br />
per sbaglio, lo capisci?<br />
– Sì, ma, ora, sono qui e durante le vacanze di Natale<br />
mi metto sotto anziché andare in licenza.<br />
– Va bene. Io ti concedo un altro mese. Però devi fare<br />
almeno un compito scritto con la sufficienza. Non credo<br />
che ce la farai. Il corso è al di sopra della tua preparazione.<br />
Ora ritorna in aula. Io attenderò la tua prova.<br />
– Grazie, signor capitano. Comandi.<br />
– Comunque, Ledda, devi considerarti consegnato<br />
per le due insufficienze. Me lo impone il regolamento.<br />
– Signorsì.<br />
Della punizione a me non importava un bel nulla. E<br />
tutto contento ritornai in aula come un cane sguinzagliato<br />
ad inseguire la preda. Ora finalmente potevo giocare<br />
la mia carta: la mia volontà.<br />
254<br />
Ripresi a studiare veramente come un forsennato. La<br />
presenza di Toti mi infuriava e gli stavo dietro come un<br />
cucciolo. E nel silenzio dei gabinetti, ora, proprio come<br />
un cane da caccia ustavo l’interpretazione di quelle formule<br />
che mi aveva dato lui e riuscivo a scovare la preda<br />
da quella selva di paroloni che non avevo mai sentito.<br />
Spesso uscivo in libera uscita con Toti e tra uno svago<br />
e l’altro, io facevo cadere il discorso sempre sulle valvole,<br />
sui circuiti oscillanti, sulle frequenze. Lui non si stufava<br />
mai. Mi spiegava tutto minuziosamente con la logica<br />
dell’esperienza.<br />
– Il tenente, – diceva Toti, – conosce solo la teoria. Se<br />
gli metti davanti una radio guasta, mica te la sa riparare.<br />
– Domani abbiamo il terzo scritto. Se non prendo la<br />
sufficienza il capitano mi manda via.<br />
– Tu sei vicino a me, no? Se ti serve aiuto, sotto voce si<br />
può fare qualcosa. Il tenente lascia un po’ correre. Io ti<br />
metto il mio foglio in modo che tu lo possa leggere. Però<br />
non devi copiare. Devi dire la stessa cosa con altre<br />
parole.<br />
– Sì, va bene, ma io... non riesco a leggere la scrittura<br />
di un altro. La leggo male e solo con calma. In aula bisogna<br />
fare in fretta. Il tuo foglio quindi non mi sarà di<br />
aiuto.<br />
– Allora i risultati te li dirò a voce. Tu moltiplicherai o<br />
sottrarrai e basta.<br />
Così si fece il terzo scritto, decisivo per me. E pensando<br />
affannosamente in sardo e traducendo malamente<br />
in italiano formule e parole grazie alle sbirciate che davo<br />
al foglio di Toti e ai procedimenti che lui mi suggeriva,<br />
riuscii a prendere la sufficienza che mi garantiva di<br />
255
proseguire. Una bella prova che soddisfò inaspettatamente<br />
il capitano e soprattutto Toti, che scocciavo in<br />
modo quasi ossessionante.<br />
Al quarto mese si passò alla pratica. Finalmente quelle<br />
formule finirono. Ci dotarono degli strumenti tecnici<br />
e del materiale e si incominciò a montare la prima radio<br />
a due valvole.<br />
Al tenente subentrò un sergente maggiore che era<br />
molto bravo. E umanamente ci capiva più dell’ufficiale.<br />
Si ricordava ancora delle difficoltà di noi allievi. Con<br />
molta cura disegnò sulla lavagna lo schema pratico di<br />
montaggio così bene che sembrava il plastico di una radio<br />
smembrata. Le varie categorie di componenti erano<br />
distinte da un colore: numerati i loro terminali. Il<br />
nostro lavoro risultò così molto facilitato. Una semplice<br />
saldatura in ordine numerico. La preoccupazione di<br />
ciascuno era quella di far bene le saldature e soprattutto<br />
di non causare contatti tra i vari pezzi. Fare un cortocircuito<br />
significava una insufficienza nella prova e<br />
incorrere nella punizione del capitano che non volevo<br />
più deludere. Del mio caso aveva fatto una cosa a parte.<br />
Con il passare dei giorni, la radiolina nel suo groviglio<br />
di fili e di pezzi cresceva sempre. Io naturalmente<br />
facevo l’attento pappagallo di Toti, che mi controllava<br />
quasi tutto. Finalmente si arrivò a collegare con l’ultimo<br />
numero anche l’ultimo pezzo. L’apparecchio era<br />
completo.<br />
Che lo fosse, però, mi sembrava strano. Nella sua nu-<br />
256<br />
dità mi appariva estraneo all’idea concreta che fino ad<br />
allora avevo della radio. Sia pure di sfuggita l’avevo<br />
sempre vista ed ascoltata dentro il suo involucro.<br />
– Ora, – fece il sergente, – vi concedo un’ora di tempo<br />
per effettuare tutti i controlli che volete. Poi le proveremo<br />
tutte una alla volta e insieme.<br />
L’ora finì in un silenzio raccolto. Tutti intenti a controllare<br />
fili e resistenze: se il contatto lo facevano dove<br />
lo dovevano fare e se non lo facevano dove non lo dovevano<br />
fare.<br />
– L’ora è finita. Inserite la spina nella presa. Ognuno<br />
stia composto, al proprio posto. Sarò io ad accenderle<br />
una per una.<br />
Tutti eseguimmo quell’ordine. Ma quando lui incominciò<br />
banco per banco ad accendere le radio azionando<br />
l’interruttore, la preoccupazione fu generale. C’era<br />
poco da scherzare: la corrente non tollerava il minimo<br />
errore nelle sue rigide leggi. Il sergente aveva già controllato<br />
metà delle radio e metà degli allievi stavano ancora<br />
in ansia. Qualche radio non aveva funzionato; altre<br />
avevano fatto cortocircuito; altre invece avevano<br />
suonato e cantato.<br />
Io stavo lì a fianco di Toti in attesa di sapere cosa<br />
avrebbe fatto la mia. Lui mi aveva controllato molte cose,<br />
ma altre le avevo fatte da solo.<br />
Il sergente si stava avvicinando sempre di più al mio<br />
banco e io fremevo. Finalmente con portamento tranquillo<br />
giunse anche davanti alla mia. Azionò l’interruttore.<br />
Tra il mio stupore ed il mio entusiasmo le sue valvole<br />
si illuminarono e si mise subito a cantare una bella<br />
canzone: nuda così com’era. Mi sembrava impossibile<br />
257
che quei fili potessero cantare, eppure stavano cantando<br />
la mia gioia.<br />
La prova era superata. In un attimo mi sentii come<br />
se avessi digerito tutte quelle formule e come se tutta<br />
l’elettrologia con le sue leggi avesse perso quel valore<br />
magico che per me aveva avuto fino ad allora. La radio<br />
stava funzionando con la sua musica e mi stava riempendo<br />
di orgoglio. E subito nel petto sentii un calore<br />
ed un tremore che mi scosse tutto. Impalato,<br />
mentre il sergente proseguiva nella sua opera, trattenni<br />
le lacrime a stento.<br />
Fu la prima volta che mi accadeva di vincere, mentre<br />
altri avevano perso in quell’aula dove i miei compagni<br />
avevano sghignazzato più volte sul mio affannoso,<br />
asmatico italiano, durante le interrogazioni. Era la<br />
prima prova importante in cui non avevo commesso<br />
errori e non risultai più l’ultimo. Toti mi abbracciò e<br />
da quel giorno fu orgoglioso e fiero di me.<br />
Il corso durò fino a tutto giugno. Il sergente ci insegnò<br />
a leggere gli schemi delle principali radio trasmittenti<br />
e riceventi in dotazione all’esercito. E dopo tanta<br />
tensione, ansia e sofferenza, durante il corso ci fu<br />
un periodo di sollievo per tutti, particolarmente denso<br />
di esercitazioni all’aperto in campagna e sui boschi<br />
dove degli istruttori ci impratichivano nell’effettuare i<br />
contatti tra reparti mobili muniti di radio portatili e<br />
postazioni radio.<br />
Durante queste esercitazioni io approfittavo, come<br />
sempre, per apprendere l’italiano e tutto orecchi mi<br />
imprimevo nella mente la dizione esatta di ogni singola<br />
parola cercando di imitare la cadenza e le pause di<br />
258<br />
quelli che erano più bravi. Come lo stesso comandante<br />
o qualche soldato diplomato o laureato. Esprimere finalmente<br />
a voce alta, in italiano perfetto, quei messaggi<br />
in un bosco più o meno simile a quello di Baddhevrùstana<br />
era un orgoglio inesprimibile. Finalmente tra le<br />
querce, sugheri e tante piante simili a quelle che mi avevano<br />
fatto compagnia nella solitudine di Baddhevrùstana,<br />
dietro il gregge, parlavo in italiano con la gente. Non<br />
avevo più bisogno di parlare alle querce pensando silenziosamente<br />
in sardo. Incominciavo a sentirmi già mezzo<br />
italiano.<br />
A fine giugno l’esame finale. Promosso con 15/20.<br />
L’impresa che mi fece tanto disperare e soffrire divenne<br />
mia. E insieme a quella della fisarmonica che avevo<br />
realizzato quasi da solo a Baddhevrùstana, anche questa<br />
mi penetrò come una fiamma e incominciò a bruciare<br />
la paura che avevo di essere diverso dagli altri. Il primo<br />
passo sociale fuori dal mio campo si sommò alla<br />
conquista che avevo fatto nel bosco e me lo sentivo come<br />
un mucchio di legna già pronta per fare altri fuochi.<br />
A fine corso ci diedero un mese di licenza. Fu il primo<br />
mese di libertà della mia vita. E per la prima volta<br />
dopo quasi un anno da quando consegnai i buoi a mio<br />
fratello Filippo, dopo avere lanciato sul carro frettolosamente<br />
i covoni dell’ultima bica, ritornai a Sìligo. La<br />
famiglia nel frattempo era ritornata in paese. Finalmente,<br />
potevo mangiare e dormire nella casa in cui ero<br />
nato e trascorrere intere giornate ed intere notti nel<br />
mio paese natio. Amici ne trovai pochi. Quasi tutti era-<br />
259
no emigrati. Sìligo mi sembrava invecchiato. I soliti<br />
vecchi tutti i giorni lo attraversavano con i loro somari<br />
per raggiungere i loro campi. E in pieno giorno in paese<br />
c’erano solo le donne. I giovani che non erano emigrati<br />
li potevo vedere appesi sulle pareti del paese, sui manifesti:<br />
ricercati.<br />
Durante la licenza cercai di togliermi una curiosità:<br />
quali erano stati i motivi che avevano indotto mio padre<br />
a tornare con la famiglia in paese? Quel settembre a<br />
Baddhevrùstana per tre giorni divampò il fuoco, ora<br />
sulla capanna ora sul baraccone ora sulla loggia del fieno.<br />
Sia da quello che riuscii a sapere in paese sia dal fatto<br />
che i cani non abbaiarono mai, bisogna dedurre che<br />
responsabile del fatto era la famiglia stessa. E la cosa<br />
più assurda era che il fuoco divampava sotto gli occhi<br />
del patriarca sullo spiazzo a fucile spianato in cerca dei<br />
piromani o comunque dei responsabili. Con particolari<br />
accorgimenti, con corde che si accendevano o con<br />
candele poste nei punti meno impensati quando si consumavano<br />
davano fuoco quasi ad orario stabilito:<br />
quando il patriarca si trovava ad avere la famiglia tutta<br />
immersa nel sonno. In tali frangenti non pensò che responsabile<br />
fosse la famiglia. Sarebbe stato come perdere<br />
la sua dignità. E poi non poteva pensare a una simile<br />
soluzione, convinto come era di esercitare una autorità<br />
assoluta sulla famiglia. Più tardi forse ci avrà pensato,<br />
ma per allora fece più o meno questo ragionamento:<br />
“Soliti dispetti dei vicini invidiosi di quello che ho<br />
fatto: del raccolto... delle pecore... me le volevano bruciare<br />
nel recinto. Ormai la famiglia bene o male l’ho<br />
cresciuta. Stando così le cose, è venuta l’ora di vendere<br />
260<br />
tutto e ritornare in paese. Il bestiame prima che me lo<br />
rubino davvero me lo vendo, cazzo! I soldi me li metto<br />
in banca, cazzo! Ehee! Lì non me li bruciano! Il mio lavoro<br />
non se lo tracanna un miserabile che non l’ha sudato,<br />
cazzo!”<br />
D’altra parte doveva mettere al riparo il gruzzolo per<br />
la sua vecchiaia e agì a mente calda. Con il suo solito fare<br />
titanico incominciò l’opera di demolizione senza accorgersi<br />
che stava distruggendo il suo regno: in un solo<br />
giorno a Baddhevrùstana distrusse e abbandonò quanto<br />
vi aveva fatto nella sua vita scardinando porte e<br />
quanto c’era per portare tutto a Sìligo. Vi lasciò solo i<br />
muri e lasciò Baddhevrùstana sprezzando le sue “creature<br />
morte”.<br />
Con questo stratagemma la famiglia riuscì abilmente<br />
a far passare per abituale “dispetto pastorale” una cosa<br />
che aveva architettato contro il suo tiranno per far cessare<br />
una situazione che non poteva più sopportare e<br />
che ormai non era più giustificata. E per fortuna riuscirono<br />
a snidare il loro <strong>padrone</strong> dalla tana in cui sicuramente<br />
sarebbe rimasto ancora per molto: era il terreno<br />
su cui gli era più facile esercitare il suo comando e probabilmente<br />
avrebbe preferito morirvi da re.<br />
Quando seppi esattamente come erano andate le cose<br />
fui colpito da un solo fatto: dal coraggio dei miei fratelli.<br />
Io allora non sarei riuscito a fare simili cose. La<br />
chimera patriarcale avrebbe soffocato ogni tentativo<br />
sul nascere.<br />
Eppure la mia partenza dopo soli tre mesi aveva rotto<br />
completamente l’equilibrio gerarchico su cui la famiglia<br />
aveva sempre ruotato a senso unico e sicuramente<br />
261
la rivalsa e la vittoria dei miei fratelli fu il frutto delle<br />
mie sconfitte e della mia annosa soggezione all’autorità<br />
patriarcale: nell’inconscio dei miei fratelli fu come se<br />
mi avessero vendicato.<br />
Finita la licenza, il primo periodo in cui durante la<br />
mia vita ebbi l’occasione di giocare (e che bene o male<br />
mi aveva offerto l’esercito), la naja continuò regolarmente.<br />
Come tutti i compagni di corso ritornai alla<br />
Cecchignola. Da lì ciascuno avrebbe preso la via verso i<br />
vari reggimenti in attesa di fare il corso sottufficiali alla<br />
scuola di Rieti. Ognuno sia pure relativamente poteva<br />
scegliersi la sede. A me non andava di finire nel settentrione.<br />
C’era un posto alla scuola di Rieti e fortunatamente<br />
non ebbi concorrenti.<br />
– Nel Reggimento si sta meglio, – dicevano tutti i miei<br />
compagni. Io, però, quel posto me lo presi quasi gelosamente<br />
preferendolo a quello di Gradisca. Dovevo incominciare<br />
gli studi. Avevo bisogno di dirozzarmi e Rieti<br />
me ne offrì tutte le possibilità: era sempre una scuola e a<br />
me andava bene. Fu la mia fortuna. Vi giunsi caporaletto<br />
ancora imberbe e fui assegnato alla Compagnia Comando,<br />
cioè a quella compagnia che nelle caserme è<br />
composta dai cosiddetti “imboscati”: attendenti, militari<br />
d’ufficio, sciacquini, ecc.<br />
Le mie mansioni: garantire la funzionalità del deposito<br />
radio. Siccome era piccolo e poco fornito, la manutenzione<br />
del materiale richiedeva poco tempo. Tutte le<br />
sofferenze e le amarezze che il corso radiomontatore<br />
mi aveva causato alla Cecchignola vennero compensate<br />
dalla serenità di Rieti.<br />
La mattina presto, dopo l’adunata me ne andavo al<br />
262<br />
deposito: una stanza dove stavo sempre solo tra poche<br />
batterie e alcune stazioni radio. Non mi controllava<br />
nessuno. Solo raramente il tenente delle trasmissioni<br />
veniva a fare una ispezione. Le radio, però, non si usavano<br />
mai e naturalmente non potevano guastarsi. Il<br />
mio lavoro si riduceva allora solo a spolverare il materiale<br />
in dotazione.<br />
Il mio deposito, poi, lo ignoravano quasi tutti i superiori.<br />
Era stato messo su poco prima che vi giungessi ed<br />
era un’oasi dove la vita militare non faceva capolino.<br />
Solo gli ordini degli ufficiali e gli schiocchi dei piedi degli<br />
allievi di corso vi giungevano attutiti.<br />
Nella solitudine libera e serena di quel deposito, fortunatamente<br />
ancora ignorato e risparmiato dai rumori<br />
e dagli ordini, concepii il mio grande progetto: lo studio.<br />
La fisarmonica se l’avessi studiata con un maestro l’avrei<br />
suonata come un maestro. La radio se continuo a<br />
studiarla la potrò conoscere quanto Toti.<br />
Con la decade mi comprerò i libri. Qui mi sono fatto<br />
degli amici che hanno fatto il liceo o sono maestri. Come<br />
Toti è riuscito a farmi superare il corso di radiomontatore<br />
loro potranno aiutarmi ad apprendere l’italiano<br />
e tante altre cose. Non posso perdere quest’occasione<br />
che mi offre la caserma. Questi erano i soliloqui<br />
in cui esprimevo la scoperta di poter divenire diverso,<br />
anche se nutrivo ancora un certo disappunto per non<br />
sapermi esprimere con gli altri.<br />
Un giorno il Capitano Federici, comandante della<br />
mia compagnia, mi ordinò di spargere l’insetticida<br />
nelle camerate e nei magazzini infestati dalle formiche.<br />
263
Finita l’operazione tutto sollecito, ritornai dal capitano<br />
e impalatomi sull’attenti, rigido come un tronco<br />
d’albero, gli dissi:<br />
– Ho morto tutte le formiche, signor capitano.<br />
Al che lui, seduto sulla sua scrivania, alzò la testa,<br />
sgranò gli occhi e mi rimbrottò come se avessi insultato<br />
l’italiano.<br />
– Come sarebbe a dire, ho morto le formiche? Tu, hai<br />
ucciso le formiche!<br />
– Signorsì.<br />
– Tu vieni dalle spelonche, Ledda.<br />
– Signorsì.<br />
Altro episodio. Ero caporale di giornata e ispezionando<br />
la camerata trovai una porta con la maniglia rotta.<br />
Era mio dovere fare un rapportino al comandante<br />
in modo che provvedesse alla riparazione. Presi carta e<br />
penna e mi scervellai veramente per buttare giù due righe.<br />
– La maniglia della porta si è tagliata. Firmato cap. G.<br />
Ledda.<br />
Il capitano mi fece chiamare.<br />
– Comandi, signor capitano, – feci appena entrato nel<br />
suo ufficio.<br />
– Il tuo rapporto io non lo capisco. Come fa a tagliarsi<br />
la maniglia della porta? Forse si sarà rotta?<br />
– Sì, è così!<br />
– Ma come fai, a esprimerti così? Cerca di imparare a<br />
parlare e a scrivere. Qui ci sono maestri e letterati, fatti<br />
spiegare qualcosa. Tu dovrai fare il corso sottufficiali a<br />
novembre prossimo e con il tuo italiano non passerai<br />
tanto bene. Cerca di farlo, ma subito, capito?<br />
264<br />
– Signorsì.<br />
Bisognava farlo veramente. Nella Scuola sottufficiali a<br />
Rieti feci conoscenza con un maestro di Poggiobustone,<br />
Ottavio Gentileschi. Un ragazzo simpatico e molto preparato.<br />
Si entusiasmò del mio entusiasmo. Gli faceva un<br />
immenso piacere trasmettere la sua cultura a qualcuno,<br />
in mezzo a tanta inerzia casermesca. Veniva nel mio deposito<br />
per godersi un po’ di silenzio. E incominciammo<br />
le lezioni da zero. Io lo pedinavo dappertutto non<br />
appena nel libro non capivo qualcosa. Ma quell’estate<br />
Ottavio riuscì a sottrarmi all’analfabetismo e a riportarmi<br />
forse anche al di sopra di uno che aveva frequentato<br />
le elementari regolarmente.<br />
– Fai ancora degli errori, ma per il corso sottufficiali<br />
te la caverai. Ora la quinta elementare ce l’hai veramente.<br />
L’analisi logica la conosci bene e la matematica la <strong>padrone</strong>ggi.<br />
Se vuoi, ti seguirò anche durante il corso.<br />
– Sì, certo! Ti pagherò con la decade.<br />
– A me bastano le sigarette.<br />
A novembre tutti i volontari arruolatisi nel luglio del<br />
’58 giunsero a Rieti per fare il corso di sergente, dove io<br />
già stavo da luglio. Vennero anche i miei compagni della<br />
Cecchignola. Rividi Toti, ma fu assegnato a un’altra<br />
compagnia e la nostra amicizia svanì nel caos del corso.<br />
Finalmente rividi anche i compagni sardi del CAR. Di<br />
loro, però, ormai non avevo più bisogno: l’italiano ormai<br />
lo sapevo belare anch’io.<br />
Per tre giorni la caserma formicolò di allievi provenienti<br />
dai vari reggimenti. Le compagnie si riformarono<br />
e anche per noi incominciò il corso sottufficiali. Io, rispetto<br />
a molti altri, ora, partivo in vantaggio: conoscevo<br />
265
l’italiano più di altri pastori sardi, conoscevo l’ambiente<br />
della scuola e il tenente delle trasmissioni mi volle<br />
nella sua compagnia. La caserma ritornò nella sua abituale<br />
temperie militare: squilli di tromba, adunate concitate,<br />
esercitazioni di vario genere. Di nuovo addestramento<br />
formale: marce forzate ed esercizi ginnici come<br />
al CAR.<br />
La caserma echeggiava sotto la marcia dei soldati ora<br />
dell’una ora dell’altra compagnia. Il cortile percosso da<br />
centinaia di piedi rimbombava continuamente degli<br />
ordini dei comandanti: un vero campo battuto da cacciatori<br />
e da cani che inseguivano la selvaggina. Dopo<br />
un piccolo ripasso delle cose che già avevamo fatto al<br />
CAR, incominciò il corso vero e proprio. Le aule erano<br />
belle e spaziose.<br />
Alcuni ancora semianalfabeti, anche se avevano frequentato<br />
la quinta elementare, non ressero al ritmo dello<br />
studio e delle rigide interrogazioni: quasi sfide tra allievo<br />
e superiore.<br />
Per gli ufficiali l’uomo non esisteva. Esistevano solo i<br />
soldati. Gli allievi dovevano finire il programma in tre<br />
mesi. Il crollo dei più arretrati era inevitabile. Ma appena<br />
uno cadeva nel sonno e tonfava sul banco, veniva severamente<br />
punito. Bisognava dare l’esempio. Poco importava<br />
che l’allievo fosse più addormentato del banco<br />
o che talora fosse più saggio mandarlo a dormire invece<br />
di sbatterlo dentro.<br />
Quello squilibrio da disadattato che avevo subito alla<br />
scuola delle trasmissioni, ora alla scuola di Rieti era un<br />
fenomeno generale, per tutti quelli che avevano fatto la<br />
quinta e non erano abituati a studiare.<br />
266<br />
Per me ora era diverso. Grazie allo sforzo fatto alla<br />
Cecchignola e durante le lezioni di Ottavio, mi ero abituato<br />
allo studio. Molte materie avevo incominciato a<br />
studiarle già prima che il corso iniziasse. Il capitano Federici<br />
mi aveva fatto fare un corso di regolamenti ai soldati<br />
della compagnia. E quel corso mi servì per mettermi<br />
in contatto diretto con gli altri: a parlare e a sentir<br />
parlare. Certo era un assurdo. Tra i soldati cui facevo<br />
regolamenti c’erano dei diplomati e dei laureati. Ma io<br />
ero già caporal maggiore. Ero superiore. Avevo i gradi<br />
che mi davano il diritto di far lezione anche ai professori.<br />
Spesso però ero io che mi facevo fare la lezione: facevo<br />
leggere a loro e ne ascoltavo la dizione. Mi facevo<br />
spiegare anche il significato di molte parole. Insomma,<br />
del mio corso di regolamenti avevo fatto una scuola anche<br />
per me, oltre che per gli altri. Non mi importava il<br />
valore di quei regolamenti. Erano scritti in italiano e mi<br />
bastava.<br />
Al corso sottufficiali, mi presentai con le zanne affilate<br />
e come un cinghiale inferocito potevo irrompere dappertutto<br />
in quel groviglio di materie.<br />
Alle mie interrogazioni, ora, i compagni non ridevano<br />
più. Le mie risposte erano pronte e concise.<br />
Un giorno un capitano che ci faceva regolamenti si<br />
mise a bombardare l’aula di domande. Alla fine colpì<br />
un amico, pastore come me.<br />
– Che cosa è la bandiera?<br />
Lui scattò sul banco, ma dovette rimanere impalato<br />
con la bocca spalancata. E, con i polmoni sani e con la<br />
lingua normale, non riuscì a pronunciare la risposta.<br />
Il capitano, irrigiditosi nella sua divisa e pieno di bal-<br />
267
danza, esplose in un rimbrotto tipicamente militare.<br />
– Sei un deficiente. Imbecille. È inammissibile. Presentati<br />
immediatamente all’ufficiale di picchetto. Che<br />
ti sbatta dentro. Tre giorni di rigore. Forza, esci subito!<br />
E questo, – continuò, rivolto a noi, – valga per tutti. Io<br />
sono buono e caro, ma certe cose non le tollero. Come<br />
si fa a ignorare il significato simbolico della bandiera?<br />
Potete dimenticarvi i nomi delle vostre madri, quello<br />
dei vostri padri, dei vostri fratelli, ma non il significato<br />
della bandiera che è “il simbolo della patria”: la nostra<br />
madre comune. Lo avete capito? La bandiera va rispettata<br />
e salutata. Tutti salutano la bandiera. Essa saluta<br />
solo il capo dello stato.<br />
In tre mesi di corso i sardi ingoiarono più notizie e<br />
dati di quanti non ne avessero sentito dagli altri pastori<br />
o appreso alle scuole elementari dei loro paesi. Il corso<br />
finì a dicembre. Fummo promossi quasi tutti, e a Natale<br />
ognuno poté ritornare al paese natio per dimostrare<br />
ai propri paesani che era sergente.<br />
Ora mentre a tutti i miei compagni di corso sembrava<br />
di aver toccato il cielo con le dita, io non provai nessun<br />
entusiasmo. La promozione non suscitò in me la solita<br />
boria degli ex pastori, degli ex vegetali in divisa. Come<br />
avevano sentito dire sempre agli anziani del proprio<br />
paese, avevano risolto i loro problemi. In me era successo,<br />
però, qualcosa di cui non riuscivo allora a prevedere<br />
le conseguenze. I galloni non significarono nulla.<br />
Anzi mi ripugnavano.<br />
Ora non me la sentivo più di restare quello che ero divenuto.<br />
Volevo divenire altro: conquistare quel mondo<br />
che in divisa avevo conosciuto fuori della caserma. I<br />
268<br />
galloni produssero in me una reazione negativa e sconfortante:<br />
li vedevo già come il simbolo dell’accettazione<br />
incondizionata di uno stato che mentre prima mi<br />
aveva fatto crescere come un vegetale, ora, mi voleva<br />
come un carnivoro. Avevo addirittura paura dei galloni.<br />
Avrebbero potuto condizionare tutta la mia vita sotto<br />
il loro “misterioso” prestigio.<br />
Ritornato dalla licenza di nuovo a Rieti, non indossai<br />
i gradi come fece subito un compagno di corso, rimasto<br />
anche lui alla scuola di Rieti. Sapevo di essere già sergente<br />
con decorrenza dal primo gennaio 1960, ma fino<br />
a metà mese continuai ad aggirarmi per la caserma coi<br />
gradi di caporal maggiore.<br />
Il “mio” maggiore, in cui un giorno ebbi la sfortuna<br />
di imbattermi, mi rimbrottò energicamente.<br />
– Come mai lei non ha ancora indossato i galloni di<br />
sergente?<br />
– Non ho ricevuto nessun ordine ufficiale della mia<br />
promozione. Il capitano non mi ha detto nulla.<br />
– La sua promozione è apparsa sull’ordine del giorno<br />
da oltre una settimana. Non se lo è letto?<br />
– Signornò.<br />
– Dovrei punirla per questo. L’ordine del giorno è il<br />
giornale della caserma. Va letto tutti i giorni. Lei deve<br />
essere orgoglioso della promozione. La sua indifferenza<br />
mi sorprende. Ora vada di corsa ad indossare i galloni.<br />
– Signorsì.<br />
Era inutile. Anch’io ormai ero un sergente. Dovetti<br />
indossare i gradi e giurare fedeltà alla Repubblica italiana<br />
e al suo Capo...<br />
269
“Ma allora quella legge ora sono anch’io. Ho giurato<br />
di difenderla. Sono come gli ufficiali. Anche loro hanno<br />
fatto lo stesso giuramento.<br />
L’esercito difende quella legge. Dunque quella legge<br />
è anche l’esercito. Ma allora io sono un boia sociale.<br />
Debbo uccidere chiunque violi quella legge. Ecco che<br />
cosa sono diventato.” Diedi uno sguardo alla mia divisa,<br />
a quei galloni. Mi scossi, ma non potevo più togliermeli.<br />
Erano cuciti bene. Avessi potuto trasformarmi in<br />
servo pastore, in quel momento, lo avrei fatto subito.<br />
Mi sembrava che l’unica cosa più umana fosse quella di<br />
morire di fame e uscire al più presto da quella divisa.<br />
“Accettare la pagnotta per essere il servo di quella legge.<br />
Io non lo sapevo. Gli anziani... Bei consigli mi hanno<br />
dato. Ormai è troppo tardi. D’ora in poi, farò in modo<br />
di servirla il meno possibile, solo il tanto per non farmi<br />
sbattere dentro. La vita militare non mi interessa. Di ritorno<br />
a Sìligo, ora, non posso fare il radiotecnico. Il corso<br />
che ho fatto è una teoria e per imparare un mestiere ci<br />
vuole altro. I superiori ci dissero che l’avremmo imparato.<br />
Propaganda. La mia strada per diventare un uomo<br />
la troverò nello studio. E uscirò al più presto da questa<br />
palude di sangue venduto dove noi siamo le rane e i canti<br />
sono gli ordini ululati qua e là: concerti di pazzia.<br />
I miei compagni sono felici di essere dentro questa<br />
divisa. E qui tutti ti dicono: io sono un sergente, io sono<br />
un capitano. Va bene. Io strumentalizzerò questa divisa.<br />
Mi pagano e avrò i mezzi per studiare.”<br />
Tuttavia per me l’esercito rappresentò la prima fase<br />
di socializzazione. La vita con gli altri la conobbi lì e l’italiano<br />
ho incominciato a parlarlo come lingua dell’ar-<br />
270<br />
ma: come strumento per impormi alla truppa dando<br />
ordini e per eseguirli sottoposto ai superiori. Ora però<br />
il giuramento, la sua formula, mi squarciarono il velo:<br />
mi ero allontanato dai campi anche per divenire libero,<br />
per non sottostare più all’autorità di mio padre, e non<br />
per sottomettermi a un’altra autorità.<br />
E mentre questo strano processo di socializzazione<br />
per gli altri compagni non fu altro che un passaggio di<br />
subordinazione e di nuova sottomissione, per me ora<br />
che avevo già preso coscienza di poter divenire ancora<br />
diverso, quella socializzazione embrionale fu la scintilla<br />
della mia “rivoluzione”.<br />
Gli studi fatti con Ottavio e quelle nozioni che apprendevo<br />
piratescamente dai soldati per la caserma,<br />
sbloccarono una situazione che negli altri rimase avvolta<br />
dai gradi e dalle relative comodità che i gradi offrivano.<br />
La fortuna di incontrare soldati laureati e amici risvegliarono<br />
in me il desiderio di apprendere: i galloni<br />
non mi fagocitarono.<br />
Mi comprai i libri per la terza media e continuai a studiare<br />
sempre nel mio deposito, quando di notte tutta la<br />
caserma dormiva nella sua ignoranza sociale, quando<br />
la boria dei superiori era assopita, innocua come la fame<br />
delle cavallette sul pascolo che non possono mangiare.<br />
Di giorno, se non ero di servizio, rincorrevo qualche<br />
soldato “letterato”. Mi facevo spiegare la sintassi,<br />
la grammatica, la matematica: tutto quello che non capivo.<br />
Spesso queste reclute si scocciavano per la mia invadenza.<br />
Ero sempre un sergente, portavo un grado che<br />
alla truppa non va molto a genio. Alla fine, però, riusci-<br />
271
vo sempre a conquistarli. Spiegavo loro la mia situazione<br />
e le mie intenzioni. E allora trovavano una ragione<br />
per sentirsi utili. Con loro mi aprivo. Ed essi facevano<br />
altrettanto quando sapevano che ero lì non per far carriera,<br />
ma solo per circostanze storiche. Allora mi aiutavano<br />
veramente. E come invaso da una furia, piombavo<br />
ora su un soldato ora su un altro: per le caserme d’Italia<br />
“rubavo”, come un pirata di professione, la cultura<br />
fresca che vi portavano le reclute. E nella tetra caligine<br />
della caserma, che rimbombava di ordini e di insulti,<br />
riuscivo rabbiosamente a trovare forza e concentrazione.<br />
Tutto orecchi sorbivo tutto quello che i miei amici<br />
sapevano e mi spiegavano.<br />
Fui trasferito a Pisa, assegnato al laboratorio radio<br />
del 3° reg. di artiglieria contraerea. Il reggimento pullulava<br />
di cannoni che mi facevano rabbrividire. Ma tra<br />
quell’apparato bellico ebbi la fortuna di incontrare un<br />
superiore molto umano: il comandante del laboratorio,<br />
il sergente maggiore Buquicchio, di Bitonto.<br />
La radiotecnica non mi attirava più da quando la lasciai<br />
alla Cecchignola. Certo, con lui avrei potuto divenire<br />
anche un bravo radiotecnico. Era molto bravo sia<br />
in teoria che in pratica. Inoltre al laboratorio c’erano<br />
militari di leva di mestiere. Ma la scelta ormai l’avevo<br />
fatta. E Buquicchio, vista la mia ostinatezza, mi concedeva<br />
di intanarmi nel magazzino che avevo trasformato<br />
in uno studio. E durante le ore di servizio potevo studiare.<br />
In caso di ispezione diceva: – Ledda sta facendo<br />
l’inventario del materiale in magazzino.<br />
272<br />
Insomma, mi copriva le spalle. Mi voleva bene come<br />
a un fratello. Nella mia batteria, poi, ebbi la fortuna di<br />
incontrare Franco Manescalchi, un maestro che era anche<br />
un poeta. E mi aiutò moltissimo come tanti altri. La<br />
parlata pisana, poi, mi aiutò notevolmente ad apprendere<br />
l’italiano.<br />
Nel 1961 presentai la domanda per sostenere l’esame<br />
di terza media alla scuola “Renato Fucini” di Pisa. Avevo<br />
23 anni. L’unica difficoltà che incontrai fu la prova<br />
di disegno dal vero: un paesaggio con una civetta accovacciata<br />
non ricordo dove. Sembrava fatto per me. Civette<br />
ne avevo viste tante, ma l’ornato non avevo nemmeno<br />
pensato di prepararmelo. Negato completamente.<br />
Fatto il disegno geometrico con le proiezioni ortogonali,<br />
in cui me la cavavo abbastanza bene, strappai<br />
con astuzia alla compagna di banco il suo foglio con il<br />
paesaggio e la civetta già bene abbozzata.<br />
– Rifattelo, – bisbigliai. – Io non ci riesco: tempo ce<br />
n’è abbastanza.<br />
La ragazza, intimidita dalla mia invadenza, per fortuna<br />
non urlò. Il professore non se ne accorse. E con quel<br />
foglio tra gli artigli mi guardavo la civetta. La cosa era<br />
fatta. Mi limitai solo a mettere in risalto le linee e le ombre.<br />
La consegnai al professore e uscii esultante.<br />
Il risultato lo seppi nei pressi di Ravenna, dove il mio<br />
reggimento si era trasferito per fare le esercitazioni del<br />
campo estivo. Sommerso dai cespugli e dagli spari dei<br />
cannoni alla manica dell’aereo che passava sulla costa,<br />
nella mia postazione radio, cercavo di studiare. Mi stavo<br />
leggendo Il fuoco di D’Annunzio. Il contenuto non<br />
mi diceva nulla, ma le parole nuove che vi andavo tro-<br />
273
vando mi incuriosivano e con il vocabolario alla mano<br />
cercavo sempre di penetrarne il significato. Ogni giorno<br />
un elenco di parole nuove che conservavo e che imparavo<br />
a memoria.<br />
– Sei stato promosso, – mi disse Buquicchio, presentandosi<br />
alla mia postazione.<br />
– Hai preso sette in italiano e sette in latino. Bravo.<br />
Non sei contento?<br />
– Sì! Ma questa promozione è il primo gradino di<br />
quello che voglio fare.<br />
– Perché. Vuoi continuare ancora?<br />
– Sì. A tutti i costi!<br />
– Mah! Io penserei a sistemarmi. Prenderei moglie e<br />
penserei alla carriera. Ma, se vuoi continuare, ti aiuterò<br />
ancora. Però devi pensare di più alle radio. Mica debbo<br />
fare tutto io.<br />
La promozione che mi affrancava ufficialmente dall’analfabetismo<br />
e dalla comune ignoranza dei miei colleghi<br />
ex vegetali, non mi entusiasmò: per me era una<br />
cosa scontata. Avevo lavorato sodo e già stavo pensando<br />
all’anno successivo. Certo, mi stimolò e mi incitò.<br />
Mi diede sicurezza e maggior fiducia nelle mie risorse.<br />
E mi fece anche riflettere.<br />
“Hai visto che ci riesco anch’io a studiare: a fare quello<br />
che molto tempo fa e a tempo giusto ha fatto il figlio<br />
di Thiu Laréntu? Non è vero che sanno studiare solo i<br />
figli dei leoni. Glielo farò vedere, io, al Capitano Federici:<br />
l’uomo delle spelonche sarà capace anche di imparare<br />
le cose che lui ha imparato e altre che lui ignora anche<br />
se è vissuto sui banchi! Glielo dimostrerò io cosa<br />
sono le spelonche.”<br />
274<br />
La musica, il corso di radiomontatore e la terza media<br />
erano ormai i tre pilastri su cui potevo costruire<br />
l’edificio delle mie ambizioni; la laurea in lettere. Mi<br />
avrebbe fermato solo la natura con la malattia o con la<br />
morte.<br />
Ritornati dal campo estivo da Ravenna, dove per la<br />
prima volta e sempre grazie all’esercito, avevo avuto la<br />
possibilità di abbronzarmi al mare, mi comprai i libri<br />
necessari per quarta e quinta ginnasio e così ai miei studi<br />
si aggiunse il greco che già avevo incominciato a studiare<br />
insieme al programma di terza media.<br />
Gli altri sottufficiali erano invidiosi della mia promozione.<br />
Il fatto che io studiassi durante il tempo libero<br />
(domeniche, giorni festivi e durante la libera uscita,<br />
mentre loro se ne andavano a puttane) procurava loro<br />
un tremendo fastidio. Quella promozione e lo studio<br />
mi rendevano diverso da loro: non ero solo un sergente.<br />
E il mio entusiasmo genuino per lo studio veniva avvertito<br />
come un corpo estraneo nella caserma: urtava<br />
contro la loro sete di comando. E tutti boriosi della posizione<br />
sociale in cui li poneva il grado, come padroni<br />
sulla truppa scagliavano, ad insulti continui, i regolamenti<br />
che avevano imparato a memoria come preghiere<br />
alla scuola di Rieti. Con la truppa non familiarizzavano<br />
mai: riuscivano a dominarla solo punendo e consegnando<br />
i soldati. Altra arma non potevano avere.<br />
Una volta mi volli burlare dei sergenti. C’era da fare<br />
un’esercitazione. A ciascun sergente della Batteria venne<br />
affidata una squadra. Si doveva compiere nel minor<br />
tempo possibile un percorso tra le campagne del pisano.<br />
Si doveva passare, servendoci della carta topografi-<br />
275
ca, su tre punti obbligati dove c’era la postazione che ci<br />
faceva firmare un rapportino e constatava il passaggio.<br />
Io sapevo che nella mia squadra c’era un geometra e<br />
uno studente universitario. Appena dettero il via alla<br />
mia squadra, incaricai il geometra e lo studente di seguire<br />
il percorso sulla carta e di individuare la via più<br />
breve possibile. Mi misi alla testa dei compagni e a ritmo<br />
sostenuto passammo su tutte le postazioni e tra lo<br />
stupore dei superiori spuntammo sul punto dove eravamo<br />
partiti. Il tempo fu il migliore in assoluto: il secondo<br />
impiegò quasi un’ora più della mia squadra. Degli altri<br />
nemmeno a parlarne. Dovettero spedire camionette da<br />
tutte le parti per ritrovarli: i sergenti nonostante avessero<br />
geometri o diplomati stavano vanamente da soli decifrando<br />
il percorso e marciando in senso sbagliato dando<br />
ordini e consegnando anche i diplomati che si erano<br />
azzardati a far loro qualche giusta osservazione. Da<br />
quel giorno i rapporti con i sergenti divennero meno<br />
cordiali. E quando rientravano dalla libera uscita verso<br />
mezzanotte se mi trovavano sul tavolo dove mi avevano<br />
lasciato tanto per reagire alla mia ostinatezza, mi raccontavano<br />
le loro avventure: – Stasera mi sono fatto una<br />
scopata che non finisce mai... una bona che fa risuscitare<br />
anche i morti... Altro che studiare su quel tavolo. Te<br />
ne stai sempre lì. Ma perché non te ne esci e ti diverti<br />
come facciamo tutti. – E qualche altro compagno di camera<br />
quasi con l’intenzione di smontarmi: – Se io avessi<br />
studiato così, a quest’ora mi sarei già diplomato!<br />
Io li lasciavo cantare. Tra me e la vita militare non c’era<br />
più nulla da scoprire: per loro esistevano la caserma<br />
e le puttane.<br />
276<br />
A fine autunno nella mia Batteria giunse Rodolfo di<br />
Campi Bisenzio, anche lui arruolatosi volontario come<br />
me, sia pure per motivi diversi.<br />
Anche in lui, più o meno per gli stessi motivi, era già<br />
avvenuta una crisi di coscienza dopo che aveva vissuto<br />
la vita militare. Aveva frequentato la seconda liceo classico<br />
al “Galileo Galilei” di Firenze. Suo padre, però,<br />
che era fruttivendolo, fallì e non lo poté mantenere negli<br />
studi. Per non pesare sul babbo, Rodolfo, non trovando<br />
un lavoro immediato, si arruolò.<br />
Dormiva nella mia cameretta. Eravamo in quattro.<br />
Nella cameretta subito avvenne uno strano processo,<br />
una specie di reazione chimica per affinità sociale. I<br />
quattro elementi si fusero in due composti: io e Rodolfo<br />
e gli altri due: il grano da una parte e la paglia dall’altra.<br />
Finalmente non ero più solo. Potevo dialogare e parlare.<br />
Le cose che ci accomunavano erano tante: l’avversione<br />
a un militarismo antipopolare, la consapevolezza<br />
di essere finiti in quella caserma solo per disorientamento<br />
sociale, la privazione della scuola, che anche per<br />
lui era divenuta una preda irraggiungibile.<br />
E senza che me ne accorgessi, lui fu contagiato dal<br />
mio entusiasmo per lo studio, in cui riuscii a coinvolgerlo.<br />
In breve anche in lui si risvegliarono propositi e<br />
disegni già sepolti. Ben presto divenimmo amici inseparabili.<br />
E a me, in base quasi ad un egoistico calcolo di<br />
sopravvivenza, balenò di convincerlo a studiare con<br />
me. La differenza di studio, però, mi bloccava. “Lui ha<br />
fatto la seconda liceo. Io solo la terza media. Come faccio<br />
a studiare con lui?”<br />
277
Decisi di ricorrere all’astuzia. Già lui spontaneamente<br />
mi correggeva le versioni, i temi che stavo facendo<br />
per il ginnasio. E quando, spontaneamente, si decise a<br />
studiare insieme, per paura che lui non studiasse più<br />
con me, gli dovetti dire una bugia:<br />
– Io ho solo la quinta ginnasio. Tu invece...<br />
– Che cosa importa? Tu traduci quanto me. E poi, io<br />
mi ripasso il programma. Debbo riprendere. Tu sei più<br />
fresco.<br />
– Va bene. Io ci sto.<br />
E con la paura che scoprisse la verità, ci si mise al lavoro.<br />
La sera la cameretta rimaneva libera. Gli altri due<br />
sergenti se ne andavano in libera uscita. Noi si rimaneva<br />
a tradurre greco e latino o a fare letteratura italiana.<br />
Debbo essergli molto riconoscente. Per tradurre era<br />
molto più bravo di me e mi aiutava. Anche se lui sosteneva<br />
il contrario, ha poca importanza. Certo era il mio<br />
entusiasmo che lo aveva riavvicinato ai libri, ma chi teneva<br />
l’aratro era lui. Io mi limitavo solo ad incitare i<br />
buoi. In tutti i casi successe che anche lui in poco tempo<br />
si trasformò in un sergente studente.<br />
Un giorno scrissi a mio padre comunicandogli la mia<br />
intenzione di congedarmi e di continuare gli studi fino<br />
alla laurea. La lettera incominciava così:<br />
Carissimo padre,<br />
Pisa, 15 marzo 1962<br />
è la prima volta che ti scrivo, visto che ci pensa sempre<br />
la mamma a scrivere. C’è una ragione perché ora debba<br />
scrivere a te. Come sai, l’anno scorso ho superato gli<br />
278<br />
esami della terza media e ho scoperto lo studio. Ho scoperto<br />
che anche quelli che tu chiami agnelli possono<br />
studiare, anzi debbono. Ora mi sto preparando per gli<br />
esami di quinta ginnasiale, che conto di affrontare il<br />
prossimo giugno in <strong>Sardegna</strong>. Ma devo prima di tutto<br />
metterti al corrente di un’altra scoperta, molto più importante.<br />
Qui mi sono scoperto un morto sociale e un<br />
boia civile, schierato contro di te e contro i miei stessi<br />
fratelli, contro i pastori e contro i poveri. Tu stesso sin<br />
da quando ero bambino, a Baddhevrùstana, mi parlavi<br />
sempre di agnelli e di leoni. Bene, ora so esattamente chi<br />
sono. Dei leoni mi parlavi come di gente felice: qui infatti<br />
lo sono tutti, a cominciare dai carnivori più piccoli,<br />
dai sergenti. Io però, secondo la tua morale, dovrei essere<br />
almeno una volpe, circondata da greggi e pollai. Invece<br />
mi sento un erbivoro costretto a mangiare carne.<br />
Questa lettera sbalordì mio padre, che non rinunciò<br />
a tuonare per via epistolare. Mi scrisse appunto per<br />
spiegarmi che avevo avuto la fortuna di diventare volpe,<br />
e per farmi sapere cosa pensava della mia decisione:<br />
“Se ti congedi diventerai selvaggina.”<br />
L’ultimo mese di naja sembrava interminabile. Gli<br />
ordini non li sopportavo più. Darne mi sembrava assurdo.<br />
Le adunate, sempre uguali sotto l’incalzare delle<br />
stesse formule, mi sembravano riti insensati.<br />
Finalmente venne anche l’ultimo giorno di naja. Firmai<br />
il congedo nervosamente. Subito, però, mi sentii<br />
placido e restituito a me stesso. Con quello scarabocchio<br />
fu come se fossi rinato a nuova vita. Entrai nella<br />
279
mia cameretta. Mi strappai di dosso la divisa, mi misi<br />
gli abiti civili e uscii dalla caserma più leggero di un uccello.<br />
Rimisi piede a Sìligo l’8 maggio del 1962.<br />
La sera mio padre fece ritorno dal lavoro. E senza<br />
nemmeno salutarmi scoppiò in un temporale di paternali.<br />
– Da <strong>padrone</strong> ti sei fatto servo. Eri cacciatore. Ora sei<br />
selvaggina... la più misera e la più esposta: la più ricercata<br />
e la più vulnerabile. Che cosa intendi fare ora?<br />
– Mi sto preparando per la quinta ginnasio. L’esame è<br />
a giugno.<br />
– Ginnasio! Una parola che non mi imbroglia. Stai<br />
attento. Potresti finire male. Tu hai fatto il passo più<br />
lungo della gamba. Prima o poi cadrai e non sarò certo<br />
io a rialzarti. Te l’ho scritto. Qui c’è solo fame. La campagna<br />
è abbandonata da tutti. Sto tribolando notte e<br />
giorno per camparmi. Non voglio mangiare dal peculio<br />
familiare, anzi, se ci riesco lo vorrei accrescere e conservarlo<br />
ai tuoi fratelli, intatto. Tu qui non sei gradito. La<br />
tua permanenza in casa è un problema che riguarda<br />
tutta la famiglia. E io non voglio lamentele.<br />
– Per un mese sono ancora pagato. L’esame è prossimo.<br />
Debbo pensare solo a prepararmi.<br />
Fui uno scandalo anche per la gente di Sìligo.<br />
– Il figlio di Abramo! Se n’è ritornato! A studiare!<br />
Ma che cosa si è messo in testa? Ha conosciuto solo il<br />
culo della pecora, come noi, e vuole fare come i figli di<br />
don Pedru e di Thiu Laréntu, ora che ha visto il continente.<br />
Crede di essere diventato qualcuno? Io gli piscio<br />
in faccia.<br />
280<br />
– Ma è roba da pazzi. Se me lo avessero raccontato, io<br />
non ci avrei creduto: congedarsi per studiare.<br />
– Ora studierà la fame che lo aspetta.<br />
– E pensare che ne avevo un buon concetto di quel<br />
ragazzo. Era divenuto sergente nonostante Abramo lo<br />
avesse svezzato a Baddhevrùstana tra lo sterco delle pecore.<br />
– Eh! Sai com’è! A uno quando sta bene gli prude il<br />
culo e vuole cambiare posto.<br />
– Con la sua posizione, poteva già entrare nella famiglia<br />
più rispettabile e anche più ricca di Sìligo. Poteva<br />
bussare ad ogni porta: aspirare a qualsiasi ragazza. Ora,<br />
invece...<br />
– E perché non ci prova, mio figlio, a congedarsi? Gli<br />
spacco la testa, gli spacco.<br />
– Quello si è montata la testa. Vedremo che cosa sarà<br />
in grado di fare. Io, per parte mia, dico che farà la fine<br />
di tanti altri espulsi dalle forze dell’ordine: diverrà alcolizzato<br />
e consumerà tristemente i suoi giorni nelle<br />
bettole tra un bicchiere e l’altro.<br />
– Naturale, quelli che hanno provato la vita cittadina<br />
non si adattano più alla nostra. Lui vuole studiare. È<br />
una scusa per incominciare la vita oziosa aspettando<br />
che gli altri lo mantengano.<br />
Ora non ero più sergente. Sìligo per me divenne subito<br />
un mare in tempesta e mi sbatteva continuamente<br />
in faccia i cavalloni della sua morale. E per non sentire<br />
né subire gli attacchi di quella tempesta, di mattino presto,<br />
me ne andavo nelle campagne vicine (a thiu Burròne,<br />
a Littu o a Pala Montèddha) e mi infrattavo con i<br />
miei libri.<br />
281
La campagna, nella sua solitudine, in quella mia primavera<br />
sconsolata, ritornò, come quando ero a Baddhevrùstana,<br />
a costituire l’unica realtà e sembrava comprendere<br />
le mie esigenze offrendomi il suo silenzio fecondo.<br />
Con i libri spalancati, disteso dentro i cespugli,<br />
mi nascondevo per non essere turbato né visto dalla<br />
gente e studiavo con la rabbia in corpo meditando come<br />
una volpe. Soffrivo da solo e cercavo di ribattere alle<br />
sentenze di mio padre e dei pastori anziani.<br />
“Quando ero schierato contro di loro mi stimavano e<br />
mi ammiravano. Ora che sono con loro mi disprezzano<br />
e mi sfuggono come letame. Per loro ora, io, sono solo<br />
uno scandalo vivente: unu perdulàriu (un vagabondo).<br />
Dimostrerò loro che sono in torto. Se mi va bene il colpo<br />
a giugno, avrò già qualcosa in mano: avrò il cucchiaio<br />
con cui essi si mangeranno tante affermazioni<br />
sbagliate sul mio conto. Qui sono tutti contro di me,<br />
come se avessi ucciso mezzo paese. I discorsi sul mio<br />
caso riempiono le vie e l’agro di Sìligo. Ma io non me ne<br />
andrò senza tentare. Io non li temo i pastori arrabbiati.”<br />
I giorni mi passavano nell’angoscia della promozione<br />
a tutti i costi. Sempre solo. I vecchi li avevo contro e i<br />
giovani che avevo conosciuto erano volati via. I pochi<br />
studenti che c’erano allora non li conoscevo, né avrei<br />
potuto fare amicizia con loro. Mi consideravano sempre<br />
un pastoraccio. Io, d’altra parte, non potevo avvicinarli.<br />
Una specie di odio di classe me lo impediva.<br />
I “rumori” che più mi davano fastidio e mi facevano<br />
rabbia, però, non erano le reazioni dei pastori anziani,<br />
che avevo conosciuto sin da piccolo e che mi rimproveravano<br />
solo per mettermi sulla “retta via del bene”, ma<br />
282<br />
quelle della gente più abbiente del paese, quella che allora<br />
poteva mandare i propri figli a scuola.<br />
– Anche un pastore adesso vuole entrare nel liceo.<br />
Ah! Ah! Ah! Ma è roba da pazzi. Uno che ancora puzza<br />
di pecora. Ma dove siamo arrivati?<br />
Francamente, quando venni promosso, speravo che<br />
l’ambiente nei miei confronti divenisse comprensivo e<br />
finalmente mio padre giustificasse la mia disubbidienza.<br />
Invece capitò il contrario. Gli anziani di nuovo mi rigurgitarono<br />
addosso le loro sentenze e non mi dettero<br />
credito. E stranamente la mia promozione affilò la lama<br />
della loro morale scatenando un processo di invidia<br />
indefinita che allora non capivo.<br />
– Lui è figlio di un pastore e deve seguire la strada di<br />
tutti, non quella dei ricchi. Lui deve lavorare e sudare<br />
in culo e nei coglioni, tutti i giorni, come facciamo noi,<br />
cazzo! E chi è lui?<br />
– Poi, alla sua età! Ha già 24 anni. Lo studio si fa da<br />
piccoli.<br />
Per mio padre, poi, dovevo andarmene. Sulle prime<br />
non mi si scagliò contro fisicamente per darmi il dispaccio.<br />
Era chiaro, però, che stava aspettando o che me<br />
ne andassi spontaneamente o che si presentasse l’occasione<br />
per litigare. Aspettava un pretesto per mandarmi<br />
via.<br />
Dall’8 maggio erano già passati quattro mesi. Avevo<br />
riparato le materie, ma stavo ancora a casa. La situazione<br />
stava per precipitare. Fino alla promozione, lui si limitò<br />
solo a farmi dei ragionamenti vaghi e forse mi voleva<br />
lasciar sfogare nella bocciatura, sicuramente pro-<br />
283
fetizzata da tutti. Alla fine la promozione fu una brutta<br />
notizia. Fu come se fosse nato qualcosa che gli dava fastidio<br />
e che lui non riusciva più a dominare. Fu come il<br />
primo responso che sbagliava nella sua vita e non poteva<br />
dirmi semplicemente: – Lo studio non è fatto per te.<br />
Sei stato bocciato. Cercati un lavoro. Stattene per conto<br />
tuo. – Tutta l’estate cantò con i suoi discorsi per portarmi<br />
sulla “retta via”: alla disperazione. Io, però, lo lasciavo<br />
cantare, giorno per giorno, come le cicale. Così,<br />
quando seppe della mia promozione non si seppe trattenere.<br />
Fu il primo scontro verbale: l’introduzione alla<br />
zuffa.<br />
– Ora che intendi fare?<br />
– La prima e la seconda liceo classico, per il prossimo<br />
giugno.<br />
– Io ti dico che sei sulla via sbagliata. Te lo dico per il<br />
tuo bene. Cercati un lavoro. Io ne ho le tasche piene.<br />
Non puoi continuare a stare qui. I tuoi fratelli si lamenteranno<br />
e io debbo difendere i loro interessi.<br />
I rapporti si stavano irrigidendo sempre di più e a<br />
casa non si poteva più studiare. L’unica cosa era andarsene,<br />
ma non sapevo dove. Per il momento trovai<br />
la soluzione a Sìligo. Un amico mi concesse le chiavi di<br />
una catapecchia dove avevo allestito il mio studio clandestino.<br />
Lì era il mio rifugio. A casa ci andavo di rado,<br />
quando mio padre era nei suoi campi. Con lui cercavo<br />
di non incontrarmi. Non potevo concedermi di essere<br />
turbato. La promozione mi aveva stimolato a perseverare<br />
e non potevo desistere. Sentire i suoi discorsi era<br />
come sentire le campane del campanile. Non mi dicevano<br />
nulla di nuovo. E nel silenzio stantio che calava<br />
284<br />
dal solaio di tanto in tanto mi facevo il punto della situazione.<br />
“Lui mi dice di andarmene. Ma dove? Per raggiungere<br />
la meta l’unico modo è quello di restare qui. Che cosa<br />
ci rimette lui? Un piatto di minestra. Altro non riuscirei<br />
a prendergli. Lui, però, la pensa diversamente:<br />
ha paura che lo derubi. L’ho visto rinforzare le serrature<br />
del granaio e della cantina. Non lascia più nulla in giro.<br />
Ha rinchiuso anche il fienile, anche quello. Quando<br />
è in casa sta sempre escogitando misure di sicurezza:<br />
Per i ladri, dice alla mamma, ma si vede benissimo cosa<br />
ha in mente, da quale paura è corroso. La sua cintura di<br />
cuoio ora sferraglia di chiavi a destra e a manca, custode<br />
di immani tesori, e senza il suo tintinnio non si sente<br />
tranquillo.<br />
Ha messo in guardia anche la mamma. Ha paura che<br />
io la raggiri. Che lei gli rubi un sacco di grano o altro<br />
per mantenermi agli studi. Sicuramente durante i suoi<br />
lavori nei campi sarà assalito e tempestato da pensieri<br />
terribili e lancinanti. È come se io fossi dentro il suo<br />
cervello. Sicuramente mi vedrà intento a forzare le sue<br />
robuste serrature del granaio con l’aiuto della mamma.<br />
Mi vedrà curvo su qualche sacco di frumento o su qualche<br />
damigiana d’olio o di vino. Sinceramente non so<br />
come fare. Siamo tutti e due in lotta: ciascuno per difendere<br />
la propria furia di essere.”<br />
Così un giorno spinto più del solito dalla paura delle<br />
mie supposte piraterie frumentarie, bussò alla mia catapecchia.<br />
Ero solo e chino sui libri. Il suo volto tradiva<br />
285
palesemente l’imbarazzo del fatto che mi doveva dire<br />
qualcosa di importante.<br />
Com’era suo carattere non riuscì a fingere né a contenere<br />
la sua preoccupazione che gli lessi subito negli occhi<br />
torvi. E senza preamboli né indugi, il suo temperamento<br />
focoso gli fece esplodere quel che aveva dentro<br />
non appena mise piede nello studio.<br />
– Sono venuto a dirti che ho paura che tu mi stia nascondendo<br />
qualcosa. Tu stai seguendo una strada sbagliata<br />
da cui ho cercato più volte di distoglierti. La tua<br />
è una fissazione. Chi sei tu a pretendere di laurearti? I<br />
tuoi fratelli stanno lavorando per conto proprio e mandano<br />
anche qualcosa a casa. Tu, invece, sei inattivo e devi<br />
spendere i soldi per i libri e per le esigenze della tua<br />
età. Te ne stai tutto il giorno in paese e io so che ci sono<br />
molte cose che ti possono tentare e deviare. Le cattive<br />
compagnie in breve tempo ti possono rovinare, anzi, se<br />
continui così rovinerai anche noi, i tuoi fratelli e la famiglia.<br />
Tutti hanno da ridire sul tuo congedo. La gente<br />
se ne sta ridendo. Sei la beffa del paese. Prima che sia<br />
troppo tardi, ti conviene cercarti un lavoro qualsiasi<br />
per il momento, in attesa di andartene via da Sìligo, come<br />
stanno facendo tutti i giovani. Puoi fare il bracciante<br />
o quello che vuoi. Non puoi startene così senza far<br />
nulla, senza produrre.<br />
– Lascia da parte l’onore della famiglia, che non si rovina<br />
con il congedo. E i miei fratelli stanno facendo del<br />
loro meglio, ma lasciali da parte anche loro. Di’, piuttosto,<br />
quello che pensi dentro. Perché non lo confessi e<br />
hai quasi vergogna? Ti fa paura dirmi che io sono un ladro<br />
in casa tua?<br />
286<br />
– Sì, chi non lavora è un ladro.<br />
– D’accordo. Giustissimo.<br />
– Io ho paura che tu faccia qualcosa per corrompere<br />
tua madre. Chi non lavora è capace di tutto: è un essere<br />
da scartare.<br />
– Ma io sto lavorando anche troppo. Studio otto o nove<br />
ore al giorno per recuperare il tempo perduto, per<br />
cercare di darmi qualcosa che a suo tempo avresti dovuto<br />
darmi tu. Non ci hai mai pensato a questo?<br />
– Io ti ho fatto grande. Ti ho allevato e campato fino a<br />
ventun anni e non ho nessun scrupolo in proposito. Il<br />
mio dovere l’ho fatto.<br />
– Tu mi hai rovinato fino a ventun anni. Mi hai sfruttato<br />
ed usato fino a ventun anni, e hai fatto lo stesso con<br />
i miei fratelli. Cosa, naturalmente, che hanno fatto tutti<br />
i pastori. Ma se guardi bene tu hai allevato forse la famiglia<br />
più ignorante di Sìligo. Nessuno ha potuto frequentare<br />
regolarmente le scuole elementari, mentre<br />
avresti potuto fare altrimenti. Ci hai esiliato a Baddhevrùstana.<br />
– Io non avevo la possibilità di mandarvi a studiare né<br />
a te né ai tuoi fratelli. E ho lavorato come un dannato<br />
per sostentarvi e per sfamarvi.<br />
– Nessuno mette in dubbio che tu abbia lavorato, anzi,<br />
si può dire che tu abbia lavorato anche troppo, ma<br />
non per sostentarci, come dici tu.<br />
– E allora?<br />
– Allora? Tu è vero che hai lavorato, ma ci hai anche<br />
fatto lavorare con la smania di arricchirti. E questo non<br />
lo puoi negare. Hai prestato e presti soldi a tutto il parentado<br />
con alti interessi.<br />
287
– Questo l’ho fatto e lo faccio per il bene della famiglia.<br />
– Le femmine, quasi tutte analfabete le hai esasperate<br />
nel lavoro dei campi e in pratica le hai costrette a servire<br />
sin dai quindici anni, prima a Sassari, poi a Roma e<br />
ora a Genova. Non hai fatto nulla di più del più povero<br />
bracciante del paese. Anzi, tu hai fatto qualcosa di peggio.<br />
Prendevi loro una buona parte del mensile e te lo<br />
mettevi in banca. Spesso, anzi, l’hai dato in prestito come<br />
stai continuando a fare.<br />
– Il loro mensile lo prendo per metterlo in banca per<br />
conto loro.<br />
– Per conto tuo.<br />
– Non è vero. E dato che ci siamo, ti dico che loro<br />
possiedono qualcosa, mentre tu non possiedi nulla.<br />
– Che ne sai tu? A te, certo, non ho mai mandato una<br />
lira. Sapevo che non ne avevi bisogno. Tu hai un grande<br />
debito verso di noi e non potrai mai pagarlo: siamo tutti<br />
ignoranti. E ti dico di lasciarmi, di non intralciarmi la<br />
strada ora che l’ho trovata. È inutile che cerchi di sviarmi.<br />
La mia strada è quella giusta e te lo farò vedere.<br />
Non perdere altro tempo a riaprire vecchie ferite.<br />
– Tu! Finirai male. Io non ti aiuterò. Non farò parzialità,<br />
io. Non ho fatto studiare gli altri e tanto meno, ora,<br />
potrò far studiare te. Ormai sei fuori e io non posso dare<br />
a te più che agli altri.<br />
– Con la scusa della parzialità, tu, ti sei sempre messo<br />
al coperto. Anche quando mi hai allontanato dalla scuola,<br />
dalle elementari, hai tirato in ballo la scusa della parzialità.<br />
Troppo facile: “Se incomincio a far studiare lui,<br />
dovrò poi anche far studiare gli altri.” Non te le ricordi<br />
288<br />
queste parole? Ora, io, non ti chiedo la tua parzialità.<br />
Sarebbe come se ti dicessi di ricostituire la famiglia e ridarle<br />
quello che le avresti potuto anche dare. Non ti<br />
chiedo questo. Ti chiedo solo di lasciarmi lavorare in<br />
pace.<br />
– Tu parli di lavoro. Dove è il tuo prodotto? Che cosa<br />
lavori? Tu stai rubando il pane che mangi. Qui, tu sei<br />
un ladro. Se non te ne vai un giorno o l’altro...<br />
– Finalmente l’hai detto che sono un ladro! Per fortuna<br />
che riesco a controllarmi. Diversamente...<br />
– Diversamente che cosa?...<br />
– Lasciamo perdere. Non ho bisogno dei tuoi soldi.<br />
Durante i quattro anni di naja ho risparmiato mezzo<br />
milione e se li saprò dosare mi basteranno per finire il<br />
liceo. Che non ti derubi ne puoi stare certo. Se vuoi, anzi,<br />
ti posso pagare tutto.<br />
– Non ho bisogno dei tuoi soldi.<br />
– Questo lo sapevo. Tu, però, devi capire che debbo<br />
restare qui, a Sìligo, per finire gli studi.<br />
– Io voglio che tu te ne vada via al più presto.<br />
– Tu non puoi impedirmi di starmene a Sìligo: posso<br />
anche fare a meno di venire nella casa che tu dici tua,<br />
mentre l’hai accresciuta e rifatta con il nostro lavoro. E<br />
poi, me lo sai dire come fai ad aver paura che ti possa<br />
derubare quando tu hai sprangato tutto come se a casa<br />
ci fossero i ladri veramente. Spiegamelo! Come farò io<br />
a rubarti il grano, l’olio e l’avena, quando non fai altro<br />
che rinforzare e controllare l’efficienza delle tue serrature<br />
e ascoltarti lo sferragliare delle chiavi che ti porti<br />
addosso. Le conoscerai già tutte, una per una, al suono.<br />
Che paura hai?<br />
289
– Te lo ripeto per l’ultima volta. La casa non è tua, ma<br />
è anche dei tuoi fratelli. Se non cambi idea ci azzufferemo<br />
davvero o ti farò cacciar via dai carabinieri.<br />
E invocando la legge, disorientato da tutto il discorso<br />
e dalla mia reazione, mi voltò le spalle e uscì con i pugni<br />
chiusi. E irrigidito nel corpo sbatacchiò la porta dopo<br />
avermi mostrato le zanne come per creare uno squillo<br />
minaccioso della sfida che aveva rimandato a tempo<br />
più opportuno.<br />
Quello scontro chiarì molte cose. Servì a schierarci<br />
dentro in maniera definitiva e a delineare le irriducibili<br />
posizioni di ciascuno. E nell’attesa dello scontro mi facevo<br />
spesso l’esame di coscienza.<br />
“Tutto il paese, con mio padre in testa, qui, mi definisce<br />
un pazzo. Per loro è una follia che io studi. Io, però,<br />
mi sento moralmente tranquillo: sto facendo passi da<br />
gigante. Sono in movimento, io, mentre loro non si accorgono<br />
di essere fermi come le rocce e le loro montagne.<br />
Il sole si leva ogni giorno. Gli anni passano e il sole<br />
li ritrova sempre nello stesso punto. Ed è per questo<br />
che parlano in quel modo. Che colpa ne ho io se lui è<br />
schiacciato dall’incubo che io lo derubi? Peggio per lui<br />
che lo pensa! Lui non ha nessun diritto di disorientarmi<br />
da una strada che sto percorrendo bene. Perché me<br />
ne debbo andare via da Sìligo? Per liberarlo dalla sua<br />
malattia? No. È una libertà che non posso concedergli.<br />
Io resto qui, resto. Qui debbo riscuotere tutto quello<br />
che lui non mi ha potuto dare. Sìligo non è suo ed è assurdo<br />
che lui pretenda che me ne vada. A costo di alloggiare<br />
da nonna o da zio Gellòn che me lo ha anche<br />
detto, ma io sto qui.<br />
290<br />
Questi patriarchi hanno fatto solo due cose nella loro<br />
vita: ubbidito prima e comandato dopo. E vogliono<br />
che le cose rimangano sempre così. Altrimenti è come<br />
se al posto dell’aria avessero il fuoco. Il peculio è il loro<br />
corpo. Il comando è i loro polmoni, l’ubbidienza è la<br />
loro aria. E lui ora si sente mancare il respiro perché<br />
non è rispettato da me. Presto risolverà la questione. Si<br />
sente morire e vuole vivere.”<br />
La questione non poteva risolversi a parole. Lui, anzi,<br />
si era sforzato a parlare nella sua lingua cercando di<br />
persuadermi a intraprendere la strada del lavoro concreto,<br />
lontano da Sìligo, in modo che dileguasse per<br />
sempre l’incubo che io lo derubassi. Ogni sua parola,<br />
ora però aveva le ali tarpate. La mia inaspettata promozione,<br />
per lui, fu un duro colpo, una poderosa incornata<br />
che lo aveva stordito e messo in crisi.<br />
Bisognava dunque sfoderare le sue armi. Parlare con<br />
la sua vera lingua, con la forza e la colluttazione con cui<br />
mi aveva sempre domato e con cui aveva sempre visto<br />
domare i ribelli. Le sue armi le conoscevo anche troppo<br />
bene, e mi stavo preparando ad affrontarle. Mi resi impenetrabile.<br />
Fiutavo e me ne stavo zitto, cercando di<br />
dilazionare al massimo lo scontro ormai inevitabile.<br />
Lui però aveva teso la rete per indurmi alla rissa, a uno<br />
scontro fisico dove sperava, come succedeva a Baddhevrùstana,<br />
che il timore reverenziale giocasse a suo favore.<br />
E certo in uno scontro rabbioso gli sarebbe stato più<br />
facile buttare giù tutto e regolare i conti a modo suo.<br />
Un pomeriggio di settembre, lui, come tante altre<br />
volte, mi chiese di aiutarlo a buttar giù il solaio della ca-<br />
291
sa che stava ampliando e mi si presentò perentoriamente<br />
come al solito.<br />
– Vieni a darci una mano. Tuo fratello Giacomo è ancora<br />
piccolo.<br />
– Mi dispiace, ma ti stai abituando male. Io debbo fare<br />
le mie cose e te lo devi mettere in testa. Tu mi vuoi coinvolgere<br />
nel lavoro, ma io non posso. Ti ho aiutato abbastanza<br />
tutta l’estate: ho mietuto con te, abbiamo imballato<br />
il fieno insieme e tante altre cose. Ora è giunto il<br />
momento di mettere un limite preciso alle tue richieste.<br />
Debbo rispettare i miei programmi. Quando verrà giugno<br />
tu non potrai aiutarmi nell’esame e se andrò male<br />
tu sarai il primo a riderci sopra. Quando posso, volentieri,<br />
ma stasera non mi è possibile.<br />
Per il momento tutto finì lì. Era la prima volta che gli<br />
dicevo no quando mi chiedeva aiuto. E preso così alla<br />
sprovvista tracannò l’amaro. Mi voltò le spalle e si fece<br />
sul lavoro con Giacomo e con la mamma. Era evidente<br />
che il mio rifiuto gli rimaneva nello stomaco e che non<br />
lo poteva digerire.<br />
Di sera, quando staccò, come al solito irruppe in casa<br />
come un leone affamato e con il solito atteggiamento<br />
autoritario e quasi di sfida come per rinfrescare agli altri<br />
l’autorità e la dimensione del suo potere. Una volta<br />
in casa, come a tutti i patriarchi, gli dava enormemente<br />
fastidio che altri facesse qualcosa per conto proprio. Al<br />
massimo si poteva fare solo qualcosa che diceva lui e a<br />
cui prendesse parte da protagonista. Altrimenti al suo<br />
ingresso bisognava starsene in silenzio o andarsene via<br />
come quando alcuni rapaci volan via dalla carogna, all’arrivo<br />
improvviso e fragoroso di un rapace solitario,<br />
292<br />
ma più selvaggio e più forte. Il suo ingresso in casa turbava<br />
sempre il clima familiare come il raglio di Pacifico<br />
agghiacciava l’atmosfera giocosa di Baddhevrùstana e<br />
poneva termine ai nostri trastulli. A furia di botte, di<br />
schiaffi e di urla iraconde, ci aveva abituati a starcene<br />
composti, ad ascoltare la parola della sua autorità o il<br />
silenzio della sua potenza. Questo lo aveva fatto sempre<br />
a Baddhevrùstana e al mio ritorno notai che continuava<br />
a farlo anche a Sìligo. Ora però mi dava fastidio.<br />
La casa mi sembrava una caserma e non me la sentivo<br />
più di accettare quelle regole.<br />
Neanche a farlo apposta, mi trovò in cucina, intento<br />
ad ascoltare la radio. Com’era sua abitudine subito si<br />
sciacquò le mani alla meglio con un fare frettoloso, come<br />
se si stesse sfogando per qualcosa che non gli andava.<br />
Naturalmente, dal suo comportamento concitato,<br />
dal suo indugiare più del solito nel lavamano, fiutai il<br />
suo disappunto. Era in attesa impaziente che io spegnessi<br />
la radio. E quasi per contenere qualcosa che gli stava<br />
per esplodere insisteva nel lavarsi le mani buttandosi<br />
l’acqua sulle braccia, dimenandosi, con la speranza che<br />
magari sparissi. Io, al contrario, studiavo il suo comportamento.<br />
E per la cucina si poteva udire la parola<br />
della sua potenza offesa. Io non spensi la radio né me<br />
ne uscii, come avevo fatto tante altre volte. Sarebbe stato<br />
come darmi per vinto. La casa rimase come la trovò.<br />
Io da una parte e la radio che cantava dall’altra. E ascoltandomelo<br />
e soppesandomelo cercavo di intercettare il<br />
soliloquio che andava facendo agitando le mani nell’acqua<br />
prima e sfregandole violentemente poi sull’asciugamano,<br />
quasi lo volesse strozzare. “Questo sta spa-<br />
293
droneggiando. Sta invadendo il campo. Ha dimenticato<br />
i limiti del suo terreno. È ora di finirla con questo intruso<br />
prepotente. Bisogna dargli una lezione per il suo<br />
bene e anche per quello dei suoi fratelli, prima che li<br />
porti alla rovina. Gli chiedo di aiutarmi e trova sempre<br />
la scusa dello studio. Prima mi rispettava. Ora, invece,<br />
guardatelo lì. Quando entro io è come se entrasse un<br />
somaro. Prima che si convinca di essere il <strong>padrone</strong>, bisogna<br />
fargli ricordare che qui il <strong>padrone</strong> sono solo io.<br />
Sennò questo prima o poi mi mette sotto.”<br />
Eppure nella sua smania di esplodere, ora, c’era qualcosa<br />
che lo intralciava e gli impediva di dar fuoco alle<br />
sue ragioni. E in quel momento nel suo intimo forse<br />
preferiva che io avessi spento la radio che stava lì, modulando<br />
musica tanto dolce quanto amaro e lancinante<br />
era il fiele che rodeva tutto il suo essere come una pezza<br />
di formaggio marcio corrosa dai vermi. Al massimo della<br />
tensione, si fece sul tavolo e come fosse stata una sua<br />
serva, urlò alla mamma di mettergli da mangiare. Agguantò<br />
la sedia e vi si calò. In un attimo il piatto fu ricolmo.<br />
La mamma uscì e lui si fece sotto. Inforcò il cucchiaio<br />
e si mise a mescolare il cibo. Tutta quella fame iniziale<br />
sembrava gli fosse passata. C’era qualcosa che gli<br />
impediva di divorare la preda mentre qualcuno gli stava<br />
davanti disinvolto e incurante della sua presenza. Quella<br />
musica, poi, sembrava gli stesse soffocando la gola. Si<br />
produceva anch’essa contro la sua volontà. Si voltò di<br />
scatto. Diede uno sguardo alla radio che musicava soavemente,<br />
ma io continuai a rimanere impassibile. Riguardò<br />
il piatto, ma non riusciva a mangiare. E seduto<br />
in mezzo al tavolo esplose come una mina:<br />
294<br />
– Spegni la radio, svelto! – fece porgendosi la prima<br />
cucchiaiata alla bocca come per dare più solennità e<br />
eseguibilità al suo ordine, per farlo apparire come una<br />
cosa già bell’e fatta. – Io sono stanco, non sono uno<br />
sfaccendato come te, io. Spegni, spegnila.<br />
– Io ordini così non ne eseguo più. Se non ti va di sentirla<br />
ti alzi e te la spegni. A me piace sentirla.<br />
La mia reazione, esplosa con la stessa aria di sfida del<br />
suo ordine, lo rattrappì e lo rese tutt’una cosa con il tavolo,<br />
il piatto e il cucchiaio che stava svuotando. Per un<br />
attimo rimase come inchiodato alla sedia quasi quelle<br />
mie parole fossero un peso calatogli addosso improvvisamente.<br />
Un peso che non poteva reggere.<br />
Accostò di scatto i gomiti al piatto. Mise la mano sul<br />
tavolo e si rizzò di colpo. La sedia gli cadde dietro e prese<br />
il volo per avventarmisi contro. L’occasione era giunta.<br />
Come un forsennato posseduto dalla sua furia si spostò<br />
sulle gambe deformato, truce. I nervi del collo gli si<br />
erano dilatati, la faccia livida. Istintivamente agguantò<br />
il primo legno che gli capitò sotto mano, uno di quei<br />
pali che era solito mettere a sostegno delle piantine da<br />
frutto, e mi venne incontro.<br />
– Lascia questa casa. Vattene. Salta la porta e non rimetterci<br />
più piede, sennò ti sfregio per la vita. Sparisci<br />
e che i miei occhi non ti vedano più.<br />
Le vene a fior di pelle delle sue braccia tese e i nervi<br />
del suo collo gonfi dalla rabbia stuzzicarono il mio coraggio<br />
e decisi di affrontarlo. Era ora di ammansire tanta<br />
strapotenza con la stessa lingua che lui conosceva. In<br />
un baleno per la testa mi passò tutta la violenza subita<br />
nel passato. Io non ero più io. La mia coscienza mi parlò<br />
295
epentinamente di fronte a quella roccia morale schierata<br />
per schiacciarmi. La radio continuava a suonare.<br />
Lui era lì e vibrava il palo. Io però mi sentivo un gigante,<br />
come se tutta la violenza subita si fosse trasformata in<br />
forza e in furia dentro di me. E non fuggii come avevo<br />
fatto sempre e come lui sicuramente si aspettava che facessi.<br />
– Se sei un uomo e se hai coraggio fatti avanti. Vieni.<br />
Su. Qui non siamo a Baddhevrùstana, dove sfogavi la<br />
tua bontà quando eri contento e la tua rabbia su di me<br />
quando le cose ti andavano male e mi picchiavi a sangue<br />
anche senza colpa. Dài. Hai paura? Forza, togli<br />
fuori i coglioni, non ce li hai più?<br />
Lui rimase sbalordito dalla mia reazione. Da quattro<br />
anni non mi conosceva più. E per la prima volta quel<br />
mostro del comando che lo portava a travolgere gli altri<br />
dovette rannicchiarsi dentro di lui come un rettile prima<br />
di avventarsi contro l’avversario.<br />
– Ti trovi in difficoltà? Vieni, vieni che te lo faccio vedere<br />
io come è il nuovo modo di comportarsi con la gente.<br />
Se mi tocchi, stasera te le spunto veramente quelle<br />
corna da toro selvatico. Su.<br />
Ritirarsi ormai non era possibile. Il mostro che portava<br />
dentro non glielo poteva permettere. E con il passare<br />
degli attimi quel mostro lo fece sragionare e me lo spinse<br />
contro per giocare le due uniche carte che aveva di<br />
fronte: vincere come sempre o farsi picchiare per avere<br />
una ragione valida e plausibile di fronte a tutti per cacciarmi<br />
via.<br />
– Io non ti temo, – gli fece urlare la terribile chimera<br />
della sua morale da cui era dominato. – Prima di cadere<br />
296<br />
sotto di te, morirò. Non ho paura di un intruso nella<br />
mia casa.<br />
– E neanche io ho paura di te nella casa in cui sono<br />
nato.<br />
Allora prese la rincorsa e vibrò il colpo da assestarmi<br />
in testa. Mi tuffai su di lui avvicinandomi il più possibile,<br />
a testa bassa, per schivare il bastone e lo disarmai.<br />
– Brutta bestia, – urlò ancora con il coro dei suoi sentimenti<br />
avvelenati una volta disarmato.<br />
– Hai poco da urlare. Siamo noi due soli, qui, come<br />
quando eravamo a Baddhevrùstana, – gli dissi rabbiosamente,<br />
tenendolo per il gherone della camicia e guardandolo<br />
fisso negli occhi.<br />
Gli diedi uno spintone e lo cacciai indietro con la<br />
speranza che l’avesse finita. Ma evidentemente il mostro<br />
lo rodeva e lo fece ritornare alla carica. Trovatosi<br />
senza bastone, divenne più rabbioso di prima. Avanzò<br />
impetuosamente e si produsse in una disordinata scarica<br />
violenta di schiaffi a man rovescio e di pugni, convinto<br />
di vincere l’incontro. Io gli stavo sempre davanti<br />
e controllavo la situazione. Per non picchiarlo schivavo<br />
i suoi colpi indietreggiando e facendo più volte il giro<br />
della stanza. Solo un suo schiaffo riuscì a raggiungermi<br />
mentre tentavo di aggrapparlo al petto e al bavero<br />
della camicia con tutta la forza e la rabbia che avevo<br />
in corpo. Gli detti un nuovo scossone brusco e secco.<br />
Fece una specie di capriola e andò a finire su un lettino.<br />
Tutto scosso si rialzò e mi si presentò come un gladiatore<br />
beffato dalle circostanze, a petto nudo. Della<br />
camicia gli era rimasto solo il colletto abbottonato intorno<br />
al collo. La sua furia era ancora irriducibile. Mi<br />
297
si avventò ancora di nuovo, invitandomi al combattimento.<br />
– Perché mi sfuggi? Perché indietreggi? Dài, perché<br />
non picchi?<br />
– Cosa vuoi, picchiarci? La vedi questa mano? Ti potrei<br />
fracassare le mandibole. Ma, tu, a me non mi freghi.<br />
Perché dovrei picchiarti? Non ce n’è bisogno. Sarebbe<br />
troppo comodo per te. Ti piacerebbe poter dire<br />
agli altri: “mio figlio mi ha picchiato” per cacciarmi via<br />
di casa. No! Questo non lo avrai. Non ci cado nella tua<br />
trappola.<br />
Il trambusto e le grida rabbiose raggiunsero finalmente<br />
la mamma e le mie sorelle che in quei giorni erano in<br />
ferie. E subito scesero nello scantinato dove si svolgeva<br />
il dramma patriarcale, dove due culture, rocciose ambedue,<br />
si stavano scontrando. Si avvinghiavano e si<br />
guardavano: si leggevano e rileggevano annullandosi a<br />
vicenda. Non potevano né sommarsi né sottrarsi. Erano<br />
incommensurabili tra di loro e si stavano scontrando<br />
solo sul piano istintuale. Invano le donne cercarono<br />
di separarci e di calmarci. Non c’era nulla da fare. Alla<br />
vista delle donne, anzi, mio padre trovò una ragione di<br />
più per battersi. E come un pugile, sempre a petto nudo,<br />
mi veniva incontro. Avvelenato, con gli occhi quasi<br />
bianchi dalla rabbia, ritentò di nuovo con furbizia. Ma<br />
non mi feci ingannare. E anche l’ultima carta non gli<br />
fruttò un bel nulla. Sono rimasto per tutto l’incontro in<br />
grado di fiutare e anticipare tutte le sue mosse, abili e<br />
quasi fraudolente. Le donne piangevano, disperate. La<br />
mia ribellione improvvisa fu per loro un trauma. Le<br />
due mie sorelle mi tenevano per le braccia, mentre mia<br />
298<br />
madre agguantava mio padre come meglio poteva. A<br />
me, purtroppo, bastava uno scossone per rendermi libero.<br />
Solo mia madre, robusta, pesante e disperata,<br />
qualche volta riusciva ad avere ragione del toro già<br />
stanco. Tra le braccia delle mie sorelle io leggevo e rileggevo<br />
i brani più oscuri della vita di tutta la famiglia.<br />
– Hai comandato troppo. Sei rimasto orfano sin dai<br />
dodici anni. I tuoi fratelli ti hanno lasciato a te stesso.<br />
Da tua madre sei stato anche coccolato. Non ti ha messo<br />
mai nessuno le mani addosso. E sarebbe ora che qualcuno<br />
te le mettesse per farti riflettere e comprendere<br />
cosa significano i colpi e le percosse con cui ti sei fatto<br />
sempre temere. Hai comandato troppo e sarebbe ora<br />
che tu la finissi. Siamo cresciuti tutti come tuoi schiavi:<br />
con la paura della tua persona... E i miei fratelli, ancora,<br />
si trasportano la tua terribile autorità... A me, ora, per<br />
fortuna non fai più paura. L’ho distrutta nel mio cervello.<br />
E tu per me ora sei solo un uomo come me e come<br />
tanti altri e come tale ti rispetto.<br />
– Io sono il <strong>padrone</strong>, qui. Sono tuo padre.<br />
– Tu non sei <strong>padrone</strong> di niente e del padre me ne sbatto.<br />
Io di padre non ne voglio, del sangue me ne frego.<br />
Io sono al di sopra della parentela. Molti, senza che il<br />
sangue c’entrasse, mi hanno aiutato più di te in questi<br />
ultimi anni e altri sono pronti a farlo. Ti rispetto solo<br />
come uomo. Ma se cerchi di assalirmi te lo impedisco<br />
con questi artigli. E se non basta, ti assalgo e ti strozzo.<br />
Infuriato salii le scale e ridiscesi con le cinquecentomila<br />
lire tra le mani.<br />
– Se le vuoi te le do. Prenditele, – gli dissi sbattendogliele<br />
addosso a più riprese. – I soldi sono l’unica cosa<br />
299
che ti rende tranquillo. Toh! Toh! Còntatele! Sei felice<br />
solo quando conti soldi! Toh! Còntateli!<br />
– Non voglio i tuoi soldi, ma la tua fuga. Fuggi, vattene!<br />
– Non me ne vado, io. Non me ne andrò. Chiama pure<br />
i carabinieri. Le tue forze non riusciranno più a mettermi<br />
in fuga. Qui sento che ci debbo restare. Ci ho lavorato<br />
tanto quando mi usavi come un attrezzo. Ora ho<br />
bisogno di restarci e ci resto. Non è una mia colpa se ho<br />
bisogno di questo. E ora che ti ho dimostrato che non<br />
ce la fai più a picchiarmi, se ti va ti concedo anche di<br />
sfogarti sul mio corpo. Toh! Io mi sdraio per terra. Vieni.<br />
Picchiami. Calciami. Fammi quello che vuoi come<br />
facevi prima. Solo così mi potrai picchiare. Perché non<br />
lo fai?<br />
Quando mi vide steso per terra, pronto a ricevere il<br />
suo furore sconfitto e rintuzzato davanti agli altri figli<br />
su cui voleva ancora comandare, non ebbe il coraggio<br />
di toccarmi. Avvilito e smontato si ritirò in silenzio e si<br />
rinchiuse nella sua stanza.<br />
Tutti si rimase allibiti e sconvolti da quanto era avvenuto.<br />
I miei fratelli senza parola. Io di colpo, vittima della<br />
situazione, avevo vergogna di quello che avevo osato e<br />
trovai scampo nella fuga. Prima di uscire di casa una<br />
paura angosciosa che il babbo stesse escogitando qualche<br />
stratagemma per costringermi ad andarmene, mi<br />
assalì. Per precauzione scrutai dalla toppa della sua<br />
stanza.<br />
Lo vidi seduto sul letto. Il volto quasi arroventato se<br />
lo teneva con la destra al mento. I suoi occhi erano fissi:<br />
rimuginava qualcosa in un silenzio sconvolto da<br />
300<br />
mille pensieri con i sintomi della lotta e della sconfitta.<br />
Il suo meditare tanto raccolto quanto concitato mi coinvolse<br />
e mi scosse fortemente. E, impalato lì davanti<br />
alla sua porta, mi passò per la mente quasi come un<br />
terribile presentimento il dramma di thiu Elia contro<br />
Forìca, che lui a Baddhevrùstana mi aveva raccontato<br />
più volte. In quel momento mi sembrò che il conturbato<br />
silenzio del suo raccoglimento lo stesse disponendo<br />
affannosamente a una tremenda decisione: se accettare<br />
il ruolo di sconfitto o agguantare la pistola e ottenere<br />
con l’arma ciò che non aveva potuto ottenere con le<br />
braccia e con l’autorità. Scappare mi sembrava la cosa<br />
più naturale.<br />
Mio padre non estrasse la pistola né il fucile, come<br />
spesso aveva visto fare in casi analoghi e come avevo tutte<br />
le ragioni per temere che facesse. Io continuai a rimanere<br />
in casa. La convivenza, ora, era impossibile. Non<br />
ci si poteva più rivolgere la parola. Ci sentivamo in colpa<br />
tutti e due. Nello scontro ci eravamo denudati veramente<br />
l’uno di fronte all’altro. La rabbia aveva distrutto<br />
ogni timore e ogni tabù e ciascuno aveva detto all’altro<br />
cose sempre trattenute nel proprio intimo. Ora avevamo<br />
vergogna di rivestirci e l’orgoglio ci impediva di<br />
rinnegare quello che ci eravamo scagliato contro. Ci<br />
eravamo scontrati troppo violentemente. La mia ribellione,<br />
però, lo aveva turbato. Per la prima volta una lezione,<br />
inaspettata, a furia di spinte e urti penetrò nella<br />
sua natura rocciosa e vi lasciò una eco nella lingua che<br />
lui conosceva bene. La sentì più volte e la capì. La bufera<br />
lo scosse come un albero con i suoi frutti in boccio e<br />
per quella stagione restò infruttuoso. Avendolo privato<br />
301
dei suoi frutti, la bufera lo ridusse al silenzio e per qualche<br />
tempo lo mise in crisi.<br />
I giorni passavano e tutto quel senso di colpa, di vergogna<br />
e di paura insieme mi si stava dissipando nella<br />
lettura dei libri.<br />
Riuscii a rivedere mio padre fuori dal trambusto di<br />
quella rissa. La sua figura terribile, che fino ad allora<br />
aveva smorzato ogni mio slancio vitale, la rividi avulsa<br />
da me come qualcosa che non mi poteva più raggiungere.<br />
Inoltre mi rividi Gavino, senza nessun complesso<br />
per essermi opposto a mio padre. Mi sentii libero. Solo<br />
che rimanere a casa non mi sembrava più naturale.<br />
La mattina lui se ne andava a lavorare sul campo. Il<br />
mio io allora si calmava. Gli umori scossi e alterati dalla<br />
sua presenza sedimentavano finalmente. Divenivo di<br />
nuovo lucido e sereno e potevo riprendere lo studio. La<br />
sera, di nuovo il suo ritorno mi turbava. Gli umori mi si<br />
riagitavano e tanti pensieri mi turbinavano per la testa.<br />
La mia serenità si intorbidiva come l’acqua sporca di<br />
un secchio scosso. I sedimenti venivano a galla. Lo studio<br />
non era più possibile. Appena metteva piede sull’uscio<br />
io, nella mia stanza, chino sui libri, me lo rivedevo<br />
dimenarmisi intorno: ogni sera rivivevo il dramma che<br />
avevo vinto fisicamente e solo per il momento, ma che<br />
continuavo a perdere ogni sera. Con la mamma, che si<br />
era accorta della cosa, ci si mise d’accordo per sbloccare<br />
la situazione. E dato che incontrarci faceva male a<br />
tutti e due, non mi facevo più ritrovare in casa al suo ritorno.<br />
Spesso mangiavo prima del suo arrivo sotto la<br />
302<br />
paura di sentire i tacchi dei suoi scarponi e vedermelo<br />
piombare in cucina. In genere, però, a quell’ora me ne<br />
uscivo per Sìligo. Mia madre mi conservava il cibo in<br />
un posto stabilito e sul tardi al rientro potevo mangiare<br />
tranquillo. Lui aveva studiato le mie abitudini e se ne<br />
andava a letto presto. Anche lui cercava quindi di evitarmi.<br />
Mi capitava di rimuginare, in lunghi silenzi, sulle implicazioni<br />
del dramma che la mia famiglia stava vivendo.<br />
Mi sforzai di immaginarmi integrato nell’ambiente<br />
di Sìligo e allora mi sembrò naturale che ai pastori succedesse<br />
come ai cani quando il <strong>padrone</strong> serve da mangiare<br />
nel secchio abituale. Mi sembrò, anzi, strano che<br />
non avessi considerato prima la situazione da questo<br />
punto di vista: rivedevo quei cani famelici tesi a divorare<br />
a gara e a strapparsi di bocca il cibo e mi immedesimavo<br />
a tal punto che la casa ormai mi pareva un immenso<br />
secchio dal quale io, benché subalterno, non<br />
volevo staccarmi. Il comportamento dei cani, impazienti<br />
e voraci, rispecchiava perfettamente quello dei<br />
servi. E mio padre, come ogni pastore, era vissuto sempre<br />
a contatto col mondo degli animali e aveva finito<br />
per accettare come propria questa forma di vita animalesca.<br />
Aveva visto sempre il cane più grosso digrignare<br />
i denti e i cani subalterni allontanarsi dal secchio secondo<br />
un ordine temporale che rispecchiava esattamente<br />
l’idoneità alla lotta di ogni singolo cane. L’ordine sociale<br />
del pastore coincideva con un intimo ordine divenuto<br />
biologico. Contravvenire alle leggi del padre equivaleva,<br />
dunque, a negare l’ordine naturale e immutabile<br />
delle cose.<br />
303
Tutto suggeriva che se volevo farmi crescere ali capaci<br />
di volare dovevo farmele spuntare altrove, tanto più<br />
che l’ambiente sociale col quale dovevo quotidianamente<br />
fare i conti era concorde nel definire una follia quella<br />
che per me era una rinascita. Dopo lunghe riflessioni<br />
ebbi ancora una impennata, sentii il bollore di una rigenerazione<br />
che non volevo più dilazionare e decisi di allontanarmi<br />
dal secchio paterno. Prima di andare in congedo,<br />
un commilitone, maestro elementare, mi aveva<br />
suggerito un modo di proseguire gli studi, se avessi voluto<br />
realizzare i miei progetti: avrei potuto insegnare in<br />
un istituto privato di Salerno. In un certo senso rischiavo<br />
di tornare a fare il sergente, sia pure con abiti civili,<br />
ma accettai la sfida e partii per Salerno.<br />
304<br />
NOTIZIA SUL TESTO
1. Il testo di questa edizione di <strong>Padre</strong> <strong>padrone</strong> (qui a seguito<br />
siglata M, Il Maestrale) si fonda su quello della Rizzoli (R,<br />
Milano, “Piccola Biblioteca La Scala”, 1998) 1 . Non riprende<br />
la prima edizione Feltrinelli (F, con sottotitolo L’educazione<br />
di un pastore, Milano, “Franchi Narratori”, 1975; poi<br />
“Universale Economica”, 1982) dato che l’autore vi era già<br />
intervenuto in vista di R, anche se con lievi modifiche. Fra<br />
queste notiamo alcune aggiunte (i numeri indicano le pagine<br />
delle rispettive edizioni):<br />
F R M<br />
69 nella sua lingua 75 nella sua lingua abituale 92<br />
80 che mi prude 87 che mi prude ancora 107<br />
102 il binomio 111 il binomio Gavino-natura 137<br />
1 <strong>Padre</strong> <strong>padrone</strong> è accompagnato nell’edizione Rizzoli da Recanto (pp.<br />
264-275), scritto in cui Ledda esperisce i primi risultati compiuti della sua<br />
solitaria ricerca di una lingua nuova; Recanto è preceduto da un discorsodialogo<br />
sulla Morte della lingua euclidea (pp. 251-262) e seguito da un<br />
Glossario (pp. 277-278).<br />
307
sostituzioni:<br />
F R M<br />
9 eva 10 erba 11<br />
13 su guíle 13 su cuìle 17<br />
88 buttones 95 cozzònes 2 117<br />
92 Furia di cazzo 99 Fùria de mincra 123<br />
non rispetta nulla! libera nos domine! 3<br />
semplici correzioni:<br />
F R M<br />
110 Beledu 119 Melédu 147<br />
113 mannàjos 123 mannùjos 152<br />
Per questa via si comprende che un’auspicabile edizione<br />
critica di <strong>Padre</strong> <strong>padrone</strong> dovrà tener conto sia di una fase genetica<br />
del testo, attraverso le copie d’autore fino alla prima<br />
stampa F (con una sotto-fase correttoria editoriale), sia di<br />
una fase evolutiva che da F passa per R e giunge alla presente<br />
edizione (in questa seconda fase rientrerebbe anche<br />
un esemplare di F, mostratomi dall’autore, con correzioni<br />
ed aggiunte autografe mai approdate alla stampa e che Ledda<br />
neppure oggi ha inteso considerare).<br />
2 Varianti lessicali sarde.<br />
3 Interessante ritorno al sardo, condito di latino ecclesiastico d’uso popolare;<br />
perché di ritorno si tratta: alla lingua soggiacente alla scrittura in<br />
italiano.<br />
308<br />
2. Verificata quindi la conformità del testo all’edizione<br />
Rizzoli, si è comunque ritornati ad F per sanare semplici<br />
sviste di R oppure accogliendo ripensamenti dell’autore<br />
circa innovazioni già volute in R rispetto ad F.<br />
Segnalo:<br />
R F M<br />
89 Nel primo periodo io 82 Nel primo periodo io, 110<br />
che non ero né forte che non ero né forte<br />
né furbo subivo né furbo, subivo<br />
126 aguzzava le roncole 116 aguzzava le roncole, 156<br />
le scuri le scuri<br />
192 l’Italiano 177 l’italiano 4 238<br />
3. Un altro punto su cui vale la pena soffermarsi riguarda<br />
le novità testuali di questa edizione. Si tratta intanto di semplici<br />
correzioni di lezioni comuni a F e R, quando non di<br />
veri e propri errori che R ha ereditato da F (ci limitiamo a<br />
rinviare alle pagine di questa edizione; evitiamo di segnalare<br />
la correzione di semplici trascorsi di stampa):<br />
F + R M<br />
thiantina 19 Thiantìna<br />
da sa ferula 30 dae sa férula<br />
da s’ammuttu 30 dae s’ammùttu<br />
di sos ruos 43 de sos ruos<br />
bizzabile 88 bizzàdile<br />
4 R: 192 due occorrenze, 194, 196, 206; F: 177 due occorrenze, 178,<br />
181, 190; M: 238 due occorrenze, 240, 243, 255.<br />
309
mesu mundu 82 Mesu Mundhu 5<br />
idda noa 82 Iddha Noa<br />
dell’abbigliamento 105 dall’abbigliamento<br />
sempre sulla piazza 158 sempre sulla pezza<br />
dae issa istulas 160 dae issas istùlas<br />
diventato. 270 diventato.”<br />
Appena più consistenti dal punto di vista variantistico due<br />
aggiunte volute dall’autore:<br />
F + R M<br />
– E it’est! 143 – E it’est! (Che c’è!)<br />
insieme a Gellòn 220 insieme a zio Gellòn<br />
e due sostituzioni lessicali:<br />
F + R M<br />
cabizzale 145 cabidàle<br />
messera 151 messe<br />
Segnaliamo infine: una ri-sardizzazione («cazzo» > «cazzu»<br />
M 111); due correzioni su un ricorso di dialetto di Porto<br />
Torres di zio Gellòn («Inògghe» > «Inògghi» M 221; «arruol’»<br />
> «arruolà» M 221); la correzione di una forma vocativa<br />
in contesto non vocativo («Giommarì» > «Giommarìa»<br />
M 124, in «Per il servo Giommarìa era la prima volta»); una<br />
piccola messa a punto fonosintattica («est dinghende» ><br />
5 Altra occorrenza: M, 181. Microtoponimo con maiuscole già in R e F:<br />
cfr. M, 189.<br />
310<br />
«este dinghènde» M 134) 6; una altrettanto lieve sottolineatura<br />
grafica («Sì la ringrazio» > «Sì La ringrazio» M 130) 7.<br />
4. Gavino Ledda ci tiene alla sostanza e alla forma di quel<br />
suo primo discorso narrativo che è <strong>Padre</strong> <strong>padrone</strong>, non per<br />
adesione incondizionata alla specifica qualità di quella parola<br />
romanzesca ma per fedeltà alla storia del testo e al Gavino<br />
Ledda che lo ha prodotto poco meno di trent’anni fa.<br />
Ci tiene: con tutte le incoerenze, gli usi oscillanti nella scrittura<br />
del sardo allora affrontata, come egli afferma, «con coscienza<br />
fonetica ma non fonologica».<br />
Pochissime dunque le oscillazioni sanate in questa edizione.<br />
Si è giusto preferito riportare «oiu» (p. 145) alla forma<br />
«oju» seguendo le altre due occorrenze del testo («oju»<br />
p. 183; «ojos» p. 103). I pochi ricorsi di k (es.: «kìbberas»<br />
p. 30; «tónkinos» p. 92) sono stati sostituiti con ch, soluzione<br />
già ampiamente maggioritaria. Il termine «theraccu» (p. 127,<br />
149), con th, è stato riportato alla forma «teràccu», con t<br />
(cfr. «teràcca» p. 178; «teràccos» p. 200). Seguendo un preciso<br />
desiderio dell’autore abbiamo sempre segnato con ddh<br />
/ dh il suono cacuminale della d (es.: «Baddhevrùstana»<br />
passim), fatta eccezione per «Ledda». Tutte le altre numerose<br />
oscillazioni restano invariate.<br />
Un altro desiderio d’autore, già manifestato nella preparazione<br />
dell’edizione Rizzoli ma solo parzialmente soddisfatto<br />
in quella sede, riguarda l’accentazione delle parole sarde. In<br />
6 Per puntellare la sonorizzazione intervocalica in «dinghènde» da ‘tinghende’.<br />
7 Ci si appoggia sulle altre maiuscole di cortesia che figurano nello stesso<br />
passo.<br />
311
questo caso l’intervento è stato sistematico e ha interessato<br />
tutte le condizioni in cui il sardo si presenta: a) in corsivo fra<br />
parentesi tonde (come ama riferire Ledda: chiuse «in sa<br />
mandra» [nel recinto] correlato grafico di una lingua imprigionata);<br />
b) in tondo senza alcuna marca grafica (compresa<br />
la micro-toponomastica ed altri nomi propri); c) nelle citazioni<br />
poetiche. Non fanno eccezione gli italianismi in contesto<br />
linguistico sardo.<br />
I principi seguiti nell’accentazione sono semplici, pensati<br />
in aiuto al lettore e non sono sfiorati da istanze normative.<br />
L’accento si esprime sulle parole tronche (poche, es.: «aió»)<br />
e su tutte le parole con più di due sillabe. Non si pone l’accento<br />
sui bisillabi, che s’intendono sempre accentati sulla<br />
prima ad eccezione dei bisillabi che presentano vocali solo<br />
grafiche, come «giùghes» (giù-ghes, p. 17). Per quanto detto<br />
si emendano rispetto alle edizioni precedenti gli accenti posti<br />
su alcuni bisillabi, es.: «rìu» («riu» p. 82) o «Rùzu» («Ruzu»<br />
p. 83). L’accento è sempre grave (à è ì ò ù), ma si usano é<br />
ed ó con accento acuto quando si presentano chiuse (per metafonesi).<br />
312<br />
Giancarlo Porcu<br />
Settembre 2003<br />
INDICE
INDICE<br />
7 <strong>Padre</strong> <strong>padrone</strong><br />
307 Notizia sul testo
Volumi pubblicati:<br />
Tascabili . Narrativa<br />
Grazia Deledda, Chiaroscuro<br />
Grazia Deledda, Il fanciullo nascosto<br />
Grazia Deledda, Ferro e fuoco<br />
Francesco Masala, Quelli dalle labbra bianche<br />
Emilio Lussu, Il cinghiale del Diavolo (2 a ristampa)<br />
Maria Giacobbe, Il mare (ristampa)<br />
Sergio Atzeni, Il quinto passo è l’addio<br />
Sergio Atzeni, Passavamo sulla terra leggeri<br />
Giulio Angioni, L’oro di Fraus<br />
Antonio Cossu, Il riscatto<br />
Bachisio Zizi, Greggi d’ira<br />
Ernst Jünger, Terra sarda<br />
Salvatore Niffoi, Il viaggio degli inganni (2 a edizione)<br />
Luciano Marrocu, Fáulas (2 a edizione)<br />
Gianluca Floris, I maestri cantori<br />
D.H. Lawrence, Mare e <strong>Sardegna</strong><br />
Salvatore Niffoi, Il postino di Piracherfa<br />
Flavio Soriga, Diavoli di Nuraiò (2 a edizione)<br />
Giorgio Todde, Lo stato delle anime<br />
Francesco Masala, Il parroco di Arasolè<br />
Maria Giacobbe, Gli arcipelaghi (ristampa)<br />
Salvatore Niffoi, Cristolu<br />
Giulio Angioni, Millant’anni<br />
Luciano Marrocu, Debrà Libanòs<br />
Giorgio Todde, La matta bestialità (2 a edizione)<br />
Sergio Atzeni, Racconti con colonna sonora e altri «in giallo»<br />
Marcello Fois, Materiali
Maria Giacobbe, Diario di una maestrina<br />
Giuseppe Dessì, Paese d’ombre<br />
Francesco Abate, Il cattivo cronista<br />
Gavino Ledda, <strong>Padre</strong> <strong>padrone</strong><br />
Salvatore Niffoi, La sesta ora<br />
Narrativa<br />
Salvatore Cambosu, Lo sposo pentito<br />
Marcello Fois, Nulla (2 a edizione)<br />
Francesco Cucca, Muni rosa del Suf<br />
Paolo Maccioni, Insonnie newyorkesi<br />
Bachisio Zizi, Lettere da Orune<br />
Maria Giacobbe, Maschere e angeli nudi: ritratto d’un’infanzia<br />
Giulio Angioni, Il gioco del mondo<br />
Aldo Tanchis, Pesi leggeri<br />
Maria Giacobbe, Scenari d’esilio. Quindici parabole<br />
Giulia Clarkson, La città d’acqua<br />
Paola Alcioni, La stirpe dei re perduti<br />
Poesia<br />
Giovanni Dettori, Amarante<br />
Sergio Atzeni, Due colori esistono al mondo. Il verde è il<br />
secondo<br />
Gigi Dessì, Il disegno<br />
Roberto Concu Serra, Esercizi di salvezza<br />
Serge Pey, Nierika o le memorie del quinto sole<br />
Saggistica<br />
Bruno Rombi, Salvatore Cambosu, cantore solitario<br />
Giancarlo Porcu, La parola ritrovata. Poetica e linguaggio in<br />
Pascale Dessanai<br />
FuoriCollana<br />
Salvatore Cambosu, I racconti<br />
Antonietta Ciusa Mascolo, Francesco Ciusa, mio padre<br />
Alberto Masala - Massimo Golfieri, Mediterranea<br />
I Menhir<br />
Salvatore Cambosu, Miele amaro<br />
Antonio Pigliaru, Il banditismo in <strong>Sardegna</strong>. La vendetta barbaricina<br />
Giovanni Lilliu, La civiltà dei sardi<br />
Giulio Angioni, Sa laurera. Il lavoro contadino in <strong>Sardegna</strong><br />
In coedizione con Edizioni Frassinelli<br />
Marcello Fois, Sempre caro<br />
Marcello Fois, Sangue dal cielo<br />
Giorgio Todde, Lo stato delle anime<br />
Marcello Fois, L’altro mondo<br />
Giorgio Todde, Paura e carne
Finito di stampare<br />
nel mese di ottobre 2003<br />
dalla Tipolitografia ME.CA. - Recco GE


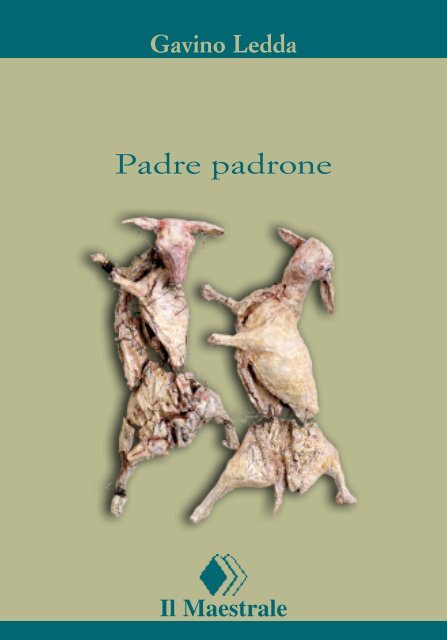



![[PDF] untitled - Sardegna Cultura](https://img.yumpu.com/51061213/1/177x260/pdf-untitled-sardegna-cultura.jpg?quality=85)

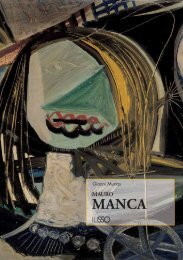



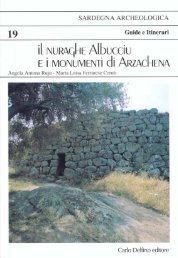

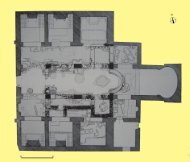
![[PDF] Cagliari, citt romana di Karales - Sardegna Cultura](https://img.yumpu.com/50065895/1/184x260/pdf-cagliari-citt-romana-di-karales-sardegna-cultura.jpg?quality=85)